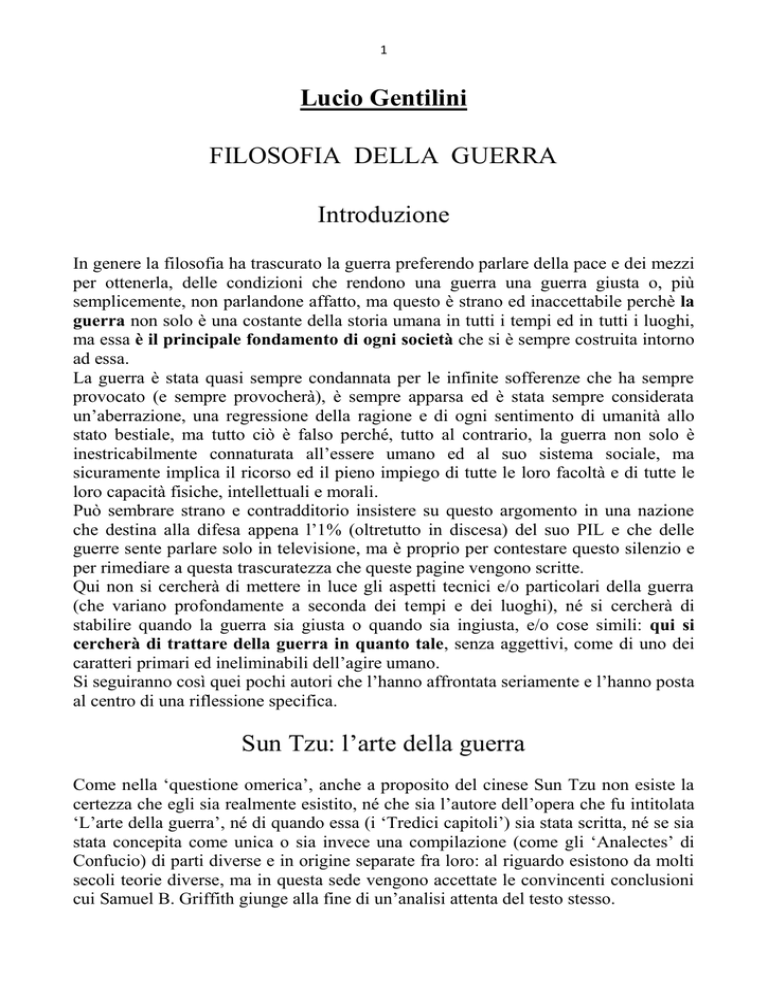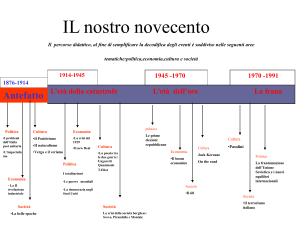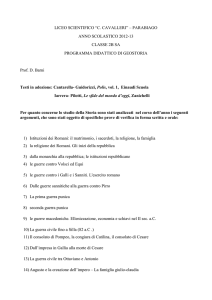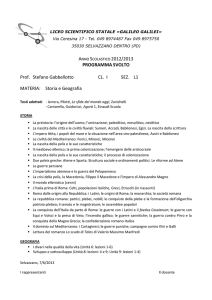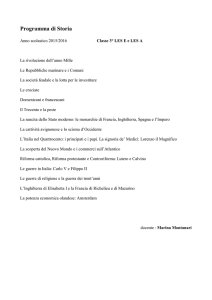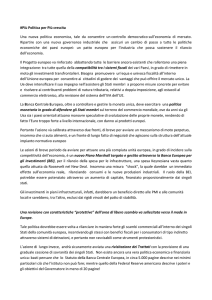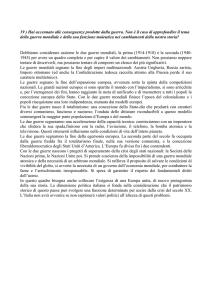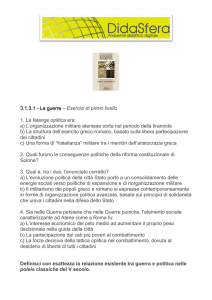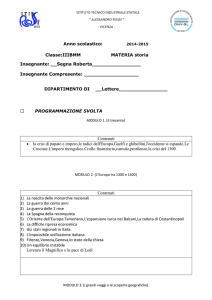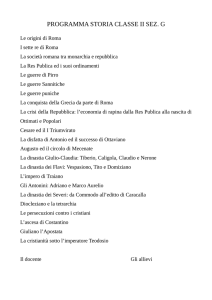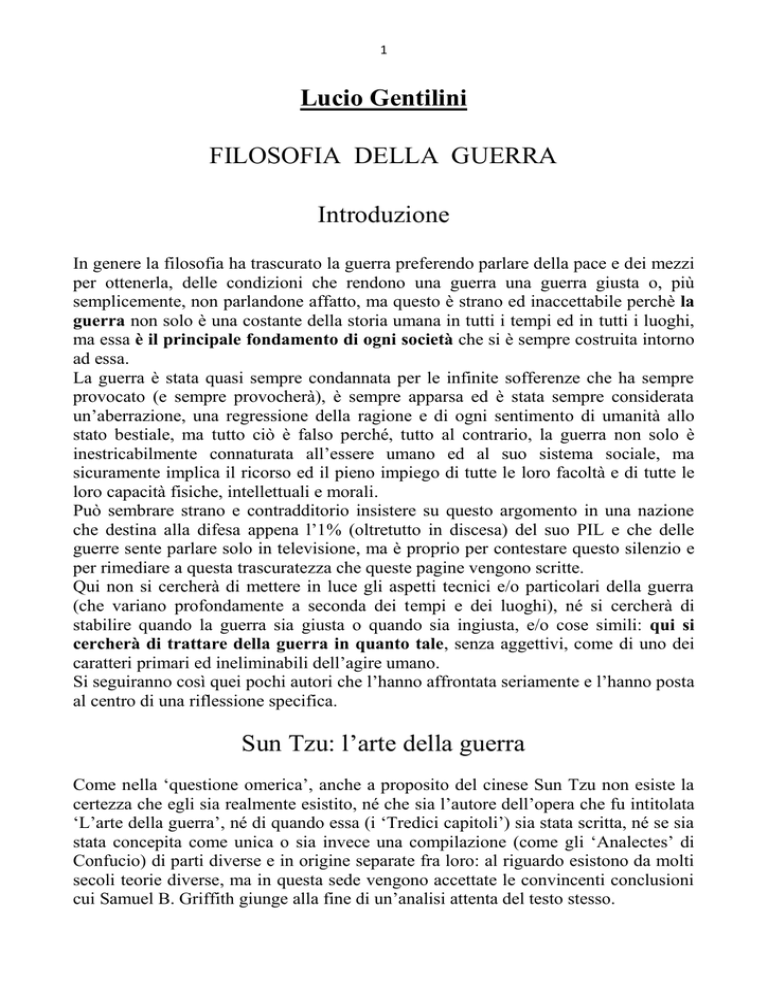
1
Lucio Gentilini
FILOSOFIA DELLA GUERRA
Introduzione
In genere la filosofia ha trascurato la guerra preferendo parlare della pace e dei mezzi
per ottenerla, delle condizioni che rendono una guerra una guerra giusta o, più
semplicemente, non parlandone affatto, ma questo è strano ed inaccettabile perchè la
guerra non solo è una costante della storia umana in tutti i tempi ed in tutti i luoghi,
ma essa è il principale fondamento di ogni società che si è sempre costruita intorno
ad essa.
La guerra è stata quasi sempre condannata per le infinite sofferenze che ha sempre
provocato (e sempre provocherà), è sempre apparsa ed è stata sempre considerata
un’aberrazione, una regressione della ragione e di ogni sentimento di umanità allo
stato bestiale, ma tutto ciò è falso perché, tutto al contrario, la guerra non solo è
inestricabilmente connaturata all’essere umano ed al suo sistema sociale, ma
sicuramente implica il ricorso ed il pieno impiego di tutte le loro facoltà e di tutte le
loro capacità fisiche, intellettuali e morali.
Può sembrare strano e contradditorio insistere su questo argomento in una nazione
che destina alla difesa appena l’1% (oltretutto in discesa) del suo PIL e che delle
guerre sente parlare solo in televisione, ma è proprio per contestare questo silenzio e
per rimediare a questa trascuratezza che queste pagine vengono scritte.
Qui non si cercherà di mettere in luce gli aspetti tecnici e/o particolari della guerra
(che variano profondamente a seconda dei tempi e dei luoghi), né si cercherà di
stabilire quando la guerra sia giusta o quando sia ingiusta, e/o cose simili: qui si
cercherà di trattare della guerra in quanto tale, senza aggettivi, come di uno dei
caratteri primari ed ineliminabili dell’agire umano.
Si seguiranno così quei pochi autori che l’hanno affrontata seriamente e l’hanno posta
al centro di una riflessione specifica.
Sun Tzu: l’arte della guerra
Come nella ‘questione omerica’, anche a proposito del cinese Sun Tzu non esiste la
certezza che egli sia realmente esistito, né che sia l’autore dell’opera che fu intitolata
‘L’arte della guerra’, né di quando essa (i ‘Tredici capitoli’) sia stata scritta, né se sia
stata concepita come unica o sia invece una compilazione (come gli ‘Analectes’ di
Confucio) di parti diverse e in origine separate fra loro: al riguardo esistono da molti
secoli teorie diverse, ma in questa sede vengono accettate le convincenti conclusioni
cui Samuel B. Griffith giunge alla fine di un’analisi attenta del testo stesso.
2
Secondo Griffith l’opera è frutto del lavoro di un’unica mente e fu composta in Cina
fra il 400 e il 320 a.C., cioè all’epoca dei Regni Combattenti (453-221 a.C.) che
precedette l’unificazione del paese (appunto nel 221 a.C.) da parte di Shig Huang Ti,
il fondatore della dinastia Han: essa tuttavia raggiunse per la prima volta l’Occidente
solo nel 1772 (ad opera di un missionario gesuita francese che la portò da Pechino),
nel periodo in cui l’Europa era affascinata dalla cultura, dall’arte, dal pensiero e
insomma da tutto ciò che proveniva dalla Cina, solo di recente ‘scoperta’.
In ogni caso ‘L’arte della guerra’ è un classico del pensiero e come tale i suoi
insegnamenti vanno al di là del tempo e del luogo in cui furono scritti: essi valgono
per se stessi e come tali verranno qui presi in considerazione.
I
‘La guerra è un affare di importanza vitale per lo stato, la provincia della vita e della
morte, la strada che porta alla sopravvivenza o all’annientamento. E’ indispensabile
studiarla a fondo’: così comincia ‘L’arte della guerra’ di Sun Tzu e l’incisività stessa
di queste frasi comunica immediatamente che per l’autore la guerra non è
un’attività fra le altre, bensì quella da cui tutte le altre dipendono: infatti ‘la
vittoria è l’obiettivo principale della guerra’ e senza la vittoria tutto è perso.
Tutta l’opera di Sun Tzu è impegnata così ad illustrare come la guerra dev’essere
combattuta, ma, anche se molti suoi insegnamenti sono validissimi ancor oggi (25
secoli dopo!), non riguardano però la filosofia della guerra: quel che invece è
filosoficamente interessante è che Sun Tzu non spende nemmeno una parola sulle
cause della guerra né ad interrogarsi se e quando essa va combattuta e quali sono i
motivi che la rendono giusta - e proprio di questo gli va reso merito.
Intendiamoci: certamente ogni società non può non prendere in considerazione le
motivazioni che le rendono accettabile la guerra perché esse fanno parte della sua
cultura e della sua stessa identità: in uno studio storico esse vanno quindi chiarite ed
esposte, ma sono visioni di parte, scuse e/o menzogne perchè in ogni guerra ogni
società si ritiene nel giusto, pretende di aver la ragione dalla sua parte e invoca
sempre il suo dio perché l’aiuti e la sostenga nel terribile sforzo.
Dal punto di vista filosofico non esistono insomma ragioni universali o addirittura
metafisiche che diano ragione a uno e torto all’altro dei contendenti, nè esiste un
codice universale sul quale valutare le motivazioni dei contendenti: si deve
ringraziare Sun Tzu che ci libera definitivamente da tutte le pseudoproblematiche
sulla guerra ‘giusta’ perché tanto – ripetiamo – ognuno dei belligeranti si ritiene nel
giusto e pretende di aver ragione.
In un mondo in cui tutti hanno ragione ovviamente non ce l’ha nessuno e, oltretutto,
al giorno d’oggi l’Occidente ha addirittura cambiato il suo linguaggio per
autoassolversi ed autogiustificarsi quando muove guerra: le terribili tempeste di
bombardamenti sulle città le chiama ‘missioni umanitarie’; le occupazioni militari di
intere nazioni dice che avvengono per ‘portarvi libertà e democrazia’; le invasioni e
le distruzioni sostiene che le attua per scopi benefici ed ispirati ai più alti ideali;
inorridisce di fronte alle reazioni di chi si difende con le armi (tanto inferiori!) che ha
3
e giudica questi comportamenti inammissibili e ‘terroristici’; l’ONU è sempre dalla
parte del più forte (USA e Occidente) e le Chiese (tutte) al massimo sospirano ma
continuano a sostenere la parte cui appartengono i loro fedeli solo per i quali
piangono quando cadono uccisi.
Sun Tzu ci risparmia queste ipocrisie ed è un merito grande.
La guerra si fa quando conviene farla e la ragione dell’aggredito non vale niente
(come anche quella dell’aggressore) e non solo perché ognuno accusa l’altro di essere
il responsabile della guerra stessa (che a parole nessuno naturalmente dice di aver
voluto), ma perché in guerra contano solo le tattiche e le strategie che portano alla
vittoria. Null’altro importa.
Grande lezione questa di Sun Tzu, ma ciò non vuol dire che l’elemento psicologico
e/o morale non conti.
II
In realtà il morale della truppa e della popolazione dello stato in guerra hanno
grandissima rilevanza perché solo quando ambedue sono davvero convinte di quel
che stanno facendo allora l’enorme sforzo bellico può essere sostenuto e gli uomini
riescono a dare il meglio di sé accettando di sopportare i durissimi sacrifici che esso
impone: ecco allora che la politica interna dev’essere improntata alla fiducia fra
governanti e governati, che lo stato dev’essere amministrato con giustizia e che i
comandanti dell’esercito devono essere stimati, creduti (ed anche temuti).
Tutto ciò, per quanto importante sia per il benessere della società stessa, è anche
condizione necessaria perchè una guerra venga vinta e Sun Tzu ritiene questo asserto
tanto di per sé evidente che sull’argomento non ha altro da aggiungere.
III
Altre condizioni per la vittoria sono la perfetta conoscenza del territorio e del terreno
(cui l’esercito deve aderire come l’acqua su una superficie), quella della disposizione
delle forze dell’avversario (che permetta di sfruttarne i punti deboli), e infine
un’efficiente organizzazione logistica: a sua volta tutto ciò presuppone un sistema
informativo accurato e preciso, e quindi agenti segreti e doppiogiochisti che abbiano
anche il compito di seminare zizzania nella società e nel governo nemici.
Più volte poi Sun Tzu ripete che ‘tutta l’arte della guerra si fonda sull’inganno’: il
nemico va portato a credere il falso circa i movimenti delle truppe, la loro consistenza
e la loro disposizione (perché evidentemente commetterà allora errori fatali), così,
grazie ancora una volta al sapiente lavoro di agenti segreti oltre che a manovre di
dissimulazione, bisogna fornirgli informazioni errate.
Bisogna cercare di dividere le truppe del nemico per colpirlo quando e dove è più
debole, sorprenderlo e sapersi adattare con rapidità ai continui cambiamenti dello
scenario e della situazione sul campo.
4
IV
Tenendo sempre presente che ‘la vittoria è l’obiettivo principale della guerra’,
bisogna che la guerra stessa sia rapida: ‘non s’è mai visto che una guerra
prolungata abbia favorito uno stato’ perché i costi diventano eccessivi, le truppe e le
società si stancano e il loro morale cala.
Bisogna che tutto sia stato predisposto con attenzione: ‘comandare … è una questione
di organizzazione’ e quest’ultima dev’essere davvero ben curata perché ‘un esercito
vittorioso lo è prima di cercare la battaglia’.
Nel Novecento le guerre si sono protratte invece per anni e anni, nel Duemila anche
per oltre un decennio, con spese devastanti per i bilanci e con le società spossate ed
esasperate: Sun Tzu deplorerebbe condotte simili e sicuramente le imputerebbe a
calcoli sbagliati o addirittura non fatti, ad informazioni lacunose ed errate, insomma
ad errori madornali - ed avrebbe pienamente ragione.
Secondo Sun Tzu ‘in guerra la miglior politica è prendere lo stato intatto’ e
‘catturare l’esercito nemico è meglio che distruggerlo’ e ciò non solo per motivi
umanitari: tutte queste sono infatti risorse e ricchezze che vanno preservate ed
utilizzate a proprio vantaggio.
‘Vostro scopo dev’essere prendere intatto ‘tutto ciò che è sotto il Cielo’. In questo
modo le vostre truppe resteranno fresche e la vostra vittoria sarà totale’ raccomanda
Sun Tzu, ma nei nostri tempi le guerre sono invece bombardamenti spaventosi,
distruzioni e devastazioni che farebbero inorridire il saggio generale cinese: al giorno
d’oggi la guerra è infatti un affare per l’industria che la prepara, che rifornisce le
truppe in azione e che ricostruisce tutto quello che è stato dissennatamente distrutto.
Oggi si vive nella società del consumo, dello spreco e della produzione continua, un
mondo addirittura volgare rispetto a quello fondato sull’armonia di Sun Tzu per il
quale la preservazione dell’esistente e delle forze umane era importantissima e
fondamentale: la sua grande lezione è stata completamente trascurata da chi 24 o 25
secoli dopo ha trascinato il mondo in vere e proprie insensate orge di morte e di
distruzione – una dimenticanza costata carissima all’umanità.
Von Clausewitz: guerra assoluta e guerra reale
Il prussiano Karl von Clausewitz (1780-1831) che a 13 anni ebbe il battesimo del
fuoco ed a 14 era già ufficiale iniziando così una carriera che l’avrebbe portato ai più
alti livelli, si forgiò nelle guerre anti-napoleoniche e dopo Jena (1806) fu prigioniero
in Francia per un anno: quando nel 1812 la Prussia si dovette alleare con Napoleone e
partecipare all’invasione della Russia egli non esitò ad entrare nell’esercito dello zar
ed a combattere (anche a Borodino) contro gli aggressori (prussiani compresi!),
riuscendo in seguito a portare dalla parte della Russia stessa altre truppe prussiane.
Von Clausewitz dimostrò insomma di essere capace di scegliere il fronte per il quale
combattere (a costo di farlo contro il suo stesso paese!).
5
Rientrato in Prussia, dal 1813 partecipò alla guerra di liberazione nazionale antifrancese, l’anno seguente fu reintegrato nell’esercito prussiano e dopo aver
partecipato alla battaglia di Ligny fu fra coloro che occuparono Parigi: il resto della
sua vita vide la prosecuzione della brillante carriera militare e la stesura (durata 12
anni) del suo capolavoro cui comunque von Clausewitz non potè dare la forma
definitiva perché morì improvvisamente di colera prima di essere pronto a darlo alle
stampe.
‘Della guerra’ venne così pubblicato postumo nel 1832 (sessant’anni dopo l’arrivo in
Europa de ‘L’arte della guerra’ di Sun Tzu) grazie all’interessamento della moglie e
di amici che sistemarono le numerose carte che egli aveva lasciato.
Von Clausewitz fu uomo d’intelletto oltre che d’azione ed il suo capolavoro è un
classico del pensiero, un altissimo sforzo per comprendere filosoficamente la
guerra.
I
Von Clausewitz afferma risolutamente che ‘la guerra … nasce sempre da una
situazione politica e viene provocata solo da uno scopo politico’ che ‘continua a
costituire elemento precipuo per la sua condotta’.
La guerra non è insomma un’attività a se stante, né una volta scoppiata possiede
capacità autonoma di direzione perché essa dipende invece dagli scopi e dalle
esigenze politiche che l’hanno provocata: ‘la politica si estrinseca attraverso tutto
l’atto della guerra’; ‘la guerra non è che una parte del lavoro politico, e non è perciò
affatto una cosa a sé stante’ e ‘il lavoro politico non cessa per effetto della guerra …
ma continua a svolgersi nella sua essenza, qualunque sia la forma dei mezzi di cui si
vale’.
E non basta ancora perché secondo von Clausewitz ‘la guerra non è … solamente un
atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento
politico, una sua continuazione con altri mezzi’: questo riconoscimento (nel 1827
sintetizzato in ‘la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi’) è ancor
oggi celeberrimo, una definizione ovunque accettata ed ammirata per la sua
chiarezza, concisione, evidenza e (apparente) semplicità, eppure essa non risulta del
tutto convincente.
Secondo questa definizione sembrerebbe infatti che la vita normale di uno stato
proceda in genere (più o meno) pacificamente, ma anche che ogni tanto ciò non sia
più possibile e/o sufficiente e che allora il ricorso alla guerra divenga inevitabile:
anche Lenin (‘Il fallimento della II Internazionale’, 1915) fece propria questa
definizione - affermando che anche Marx ed Engels l’avevano condivisa - ma con
l’aggiunta ‘(precisiamo: con la violenza)’ per cui anche secondo lui quando la
politica non riesce ad ottenere quello che vuole senza il ricorso alle armi si affida
allora alla forza e muove guerra: lo scopo dunque non cambierebbe ma
cambierebbero i mezzi impiegati per raggiungerlo.
6
II
Eppure sembra più logico pensare invece che i due termini vadano invertiti e che sia
invece la politica ad essere la continuazione della guerra con altri mezzi.
Avrebbero avuto insomma ragione Hobbes (1588-1679) ed Hegel (1770-1831).
Secondo il primo gli uomini avevano formato le società e vi erano entrati per
sopravvivere in sicurezza, così che la sopravvivenza stessa di queste loro società
implicava la necessità costante di difendersi e di svilupparsi, cioè di offendere: da ciò
derivava ogni azione dello stato, cioè la politica, così che cercare di essere forti e
armati era la struttura intima, primaria e fondamentale di ogni nazione o gruppo
sociale. Per Hobbes lo stato di guerra era insomma continuo ed ineliminabile e gli
stati non si combattevano con le armi solo quando ciò non era per loro conveniente.
Per Hegel lo stato si realizzava pienamente e raggiungeva il culmine delle sue
potenzialità e del suo valore proprio in guerra, tanto che una pagina di storia (il
gigantesco ed onnicomprensivo sviluppo dello spirito del mondo) senza una guerra
per lui era una pagina bianca.
Certamente è di gran lunga preferibile raggiungere i propri fini senza il bisogno di
ricorrere alle armi; ovviamente i fini devono essere possibili e comunque
proporzionati all’eventuale sforzo bellico e la miglior difesa è la dissuasione grazie
alle proprie forze militari, ma … tutto ciò non è forse guerra?
Von Clausewitz ha indubbiamente ragione quando riconosce che la guerra è intessuta
di politica, che i suoi scopi sono interamente politici e che è dunque un atto
fondamentalmente politico, ma rimane il fatto che è la politica ad essere nata dalla
guerra e che la politica stessa è inconcepibile al di fuori di questa prospettiva: la pace
non è insomma la condizione normale che ogni tanto viene interrotta dalla guerra,
perché la pace è solo la non-convenienza al ricorso alle armi e in se stessa non esiste
(se non nei libri dei filosofi).
Si pensi pure che lo sviluppo della civiltà è il tentativo di risolvere i problemi senza
ricorrere alle armi, ma si consideri anche che senza queste non ci sarebbe nemmeno
la trattativa stessa!
Appare sicuramente più conveniente e più produttivo trovare sistemi per armonizzare
i vari interessi, cercarne di comuni e favorirsi reciprocamente in vista di un’utilità
collettiva, ma tutto ciò può funzionare solo se ogni partecipante è in grado di
infliggere danni pesanti a chi eventualmente lo attaccasse perchè quando qualcuno
pensa invece che per lui sia più conveniente ottenere quello che vuole con la forza
allora attacca e scoppia una nuova guerra, nel qual caso o ci si difende o ci si arrende.
Probabilmente von Clausewitz penserebbe che qui si tratta di una sottigliezza teorica
inutile che non produce nessun cambiamento nella realtà concreta delle cose: posto
infatti che la guerra è politica, che importa allora quale delle due abbia la
primogenitura logica e storica sull’altra?
Ciò è sicuramente vero, ma la filosofia deve fornire comunque il quadro generale
della realtà e dunque questa specificazione è importante se vogliamo capire il mondo
in cui viviamo nella sua struttura più riposta ed originaria.
7
III
Sia come sia, von Clausewitz inizia comunque il suo lungo trattato chiedendosi
innanzitutto da vero filosofo che cos’è la guerra e risponde che ‘La guerra è … un
atto di forza che ha per scopo costringere l’avversario a sottomettersi alla nostra
volontà’, aggiungendo subito che ‘sono … gli errori risultanti da bontà d’animo
quelli maggiormente perniciosi’ perché ‘colui che impiega tale forza senza restrizione
… acquista il sopravvento sopra un avversario che non faccia altrettanto e gli detta di
conseguenza la propria legge’: ‘la guerra, per la propria essenza, non si ispira a criteri
di umanità’; ‘abbattere il nemico è lo scopo della guerra; annientare le forze armate è
il mezzo per raggiungere lo scopo della guerra; e ciò tanto nell’attacco che nella
difesa.’
La guerra in se stessa, come tale, non muta col progredire della civiltà che
semplicemente ne modifica solo la forma ed il modo in cui essa viene combattuta: la
guerra era e rimane insomma un ‘atto di violenza’, ‘un atto di forza all’impiego della
quale non esistono limiti’: la sua è una ‘energia frantumatrice’.
Nonostante nella sua vita von Clausewitz abbia scelto da che parte combattere, nella
sua opera invece - come del resto Sun Tzu – non si mette nemmeno a cercare motivi
che rendano la guerra giusta né vi accenna mai perché ogni stato ovviamente
combatte per motivi che ritiene giusti: egli non si interroga poi su come vivere in
pace con gli altri stati perché secondo lui la pace si ottiene solo con la vittoria e col
conseguente dominio del nemico sconfitto.
Von Clausewitz non si nasconde che la guerra è violenza, morte, sangue, distruzione
e sofferenza: al contrario, la guerra è trattata senza che mai vengano taciute tutte le
sue terribili necessità e tutto il dolore che provoca nei combattenti e nelle popolazioni
civili coinvolte.
Egli però non mostra mai il minimo interesse per l’orrore e le tragedie che una guerra
comporta né nelle sue pagine traspare la benchè minima compassione per chi è
trascinato e stritolato nel vortice di un conflitto: in esse non compare mai nemmeno la
più piccola descrizione degli orrori di uno scenario di guerra e tutto viene invece
analizzato con la più calma, lucida e fredda razionalità.
Ognuno dei molteplici e numerosissimi aspetti della guerra è studiato col massimo
distacco di chi calcola probabilità, costi, pesi, ecc. come se parlasse di cose senza vita
e non di esseri umani: dato che l’unico scopo della guerra è la vittoria, vanno allora
individuati solo i mezzi più adatti per il suo conseguimento senz’altra considerazione
che la loro utilità e validità rispetto al raggiungimento del fine.
Quella di von Clausewitz è insomma l’assoluta indifferenza di chi si limita a contare
e a calcolare.
Non stupisce quindi che egli non parla mai - nemmeno per minimo accenno o per
trascurabile inciso - di religione, dimostrando così il completo laicismo di chi fa
affidamento unicamente sulle forze e sulle risorse umane, le uniche da prendere in
considerazione in caso di guerra.
Dopo aver risposto alla domanda (filosofica) su che cos’è la guerra all’inizio
dell’opera ed averne esaminato i tanti aspetti nello svolgimento dei suoi numerosi
8
capitoli, alla fine di essa (dopo oltre 770 pagine!) von Clausewitz (vero filosofo)
ritorna però proprio su questo fondamentale concetto (squisitamente platonico)
dell’essenza della guerra: il suo capolavoro inizia e finisce dunque con l’illustrazione
di questa idea - perchè essa è di importanza capitale.
Von Clausewitz chiama così ‘guerra assoluta’ il suesposto concetto di guerra, la
risposta alla domanda ‘cos’è la guerra?’, la guerra nella sua essenza profonda, la
guerra pura ed ideale nella sua necessità, specificando che nella ‘forma assoluta della
guerra … non vi è che un sol risultato: il risultato finale.’
IV
Un trattato sulla guerra deve entrare però anche nel campo ben più problematico della
realtà concreta dove ad essere combattuta è la ‘guerra reale’, molto più complicata
della logica, semplice e lineare guerra assoluta: nel mondo storico concreto infatti una
miriade di ostacoli, attriti, incomprensioni, limiti, errori, ecc. sono ‘la causa per cui la
guerra [reale] diviene tutt’altra cosa da quello che dovrebbe essere secondo il suo
concetto fondamentale: diviene un prodotto bastardo, una sostanza priva di intima
coesione’.
Anche se dunque nella realtà concreta la guerra non può svilupparsi secondo la sua
essenza teorica, per von Clausewitz quest’idea dev’essere però ugualmente e
completamente chiara e presente quando si pensa alla guerra (o la si prepara e
conduce) per far sì che nell’azione pratica ci si possa avvicinare al suo concetto (cioè
alla sua perfezione) nel maggior e miglior modo possibile: ‘tutte queste conseguenze
[dell’interferenza di fattori estranei nella guerra reale], la teoria deve riconoscerle. Ma
è tuttavia suo dovere partire dal concetto-base della forma assoluta della guerra’;
accade così che le ‘sue [della guerra] forme reali … se ne [dalla guerra assoluta]
allontanano più o meno’ così che ‘la guerra può essere più o meno “guerra” ’.
‘La guerra reale non è mai una tendenza così conseguente, così rivolta verso
l’estremo, come dovrebbe essere secondo l’idea originaria; essa non è che una mezza
misura implicante intima contraddizione e pertanto non può seguire completamente
leggi proprie: essa è il frammento di un altro complesso, e questo complesso è la
politica. La politica, servendosi della guerra, evita tutte le conclusioni rigorose che
l’essenza di questa comporterebbe’: oltre all’impossibilità generale di far
corrispondere la guerra reale al suo concetto, ad ogni tipo di scopo politico
corrisponde quindi anche un diverso tipo di guerra (più o meno violenta, più o meno
ad oltranza, ecc.) mentre la sua conclusione dipende evidentemente anche dall’entità
delle forze che ognuno dei contendenti è in grado di mettere in campo e dai prezzi
che è disposto a pagare.
In conclusione insomma, secondo von Clausewitz in ogni guerra lo scopo è
contemporaneamente diverso (perché diversi sono gli scopi politici) ma anche lo
stesso perché ‘si tratta sempre ed unicamente di abbattere l’avversario’ ‘fino a che
anche la volontà del nemico non sia domata’.
9
Poco più di un trentennio dopo von Moltke e Bismarck avrebbero messo pienamente
in pratica gli insegnamenti di von Clausewitz colpendo decisamente al cuore il
nemico con le loro brillanti guerre-lampo contro l’Austria e contro la Francia.
V
Secondo von Clausewitz il concetto filosofico di guerra assoluta dev’essere dunque
tenuto sempre presente come linea-guida di tutte le nostre azioni in questo campo,
ma, oltre a ciò, visto che la guerra reale è uno sviluppo della politica, è facile
comprendere anche che ‘appena … la politica diviene grandiosa e rigorosa, lo diviene
anche la guerra [reale], per assurgere fors’anche fino all’altezza in cui … giunge alla
sua forma assoluta.’
E fu proprio questo che successe: ‘si potrebbe dubitare che l’idea che abbiamo del
suo [della guerra] carattere assoluto possa avere qualche valore pratico, se non
l’avessimo vista realizzarsi precisamente ai giorni nostri con una compiutezza
assoluta’: la guerra infatti ‘ha assunto, con Bonaparte, la sua forma assoluta.’
Tutta la riflessione di von Clausewitz riposa sulla convinzione che con la rivoluzione
francese la guerra era entrata in una fase nuova ed aveva assunto caratteri del tutto
inediti (seppur in parte anticipati da Federico II (1740-86)) rispetto a quelle
combattute fino a quel momento: la rivoluzione francese aveva infatti
burrascosamente infranto tutti gli schemi dell’ancièn regime e la nuova società che ne
era nata aveva esaltato ed unito come non mai le forze popolari, giunte così ad un
livello di coscienza politica e di partecipazione attiva alla vita pubblica tali da
permettere al governo di raccogliere e di mobilitare come non mai tutte le loro
energie - e ciò era avvenuto ovviamente anche in campo militare.
Mentre ‘durante il XVIII secolo … la guerra era ancora un affare che interessava il
solo governo. La nazione vi partecipava solo come cieco strumento’, ‘nel 1793 …
improvvisamente la guerra era ridivenuta una questione di popolo’ così che ‘da quel
momento i mezzi impiegabili, gli sforzi possibili, non ebbero più un limite
conosciuto’ perchè grazie ‘all’efficacia di una leva in massa e ad un popolo in armi
… è naturale che tutti gli attriti … vengano a ridursi ad un minimo, e che tutte le fonti
di aiuto siano a portata ed abbondanti’.
I mutamenti sociali e politici erano stati dunque decisivi per la nascita di un nuovo
tipo di guerra: non solo infatti l’esercito era diventato molto più numeroso, ma i
soldati erano stati anche educati agli scopi della guerra rivoluzionaria e da passivi
esecutori di ordini si erano trasformati in combattenti convinti di avere un ruolo attivo
nel suo svolgimento e di star facendo la storia, mentre le carriere nell’esercito erano
divenute fulminee ed i gradi si conquistavano sul campo per i meriti riconosciuti
durante l’azione.
Questa nuova guerra era poi stata elevata ai suoi massimi livelli da Napoleone (che
von Clausewitz chiama sempre Bonaparte) - ‘il condottiero più risoluto che mai sia
esistito’, ‘il dio stesso della guerra’ - il cui genio militare aveva potentemente
contribuito alle stupefacenti affermazioni della nuova forza rivoluzionaria sui campi
di battaglia: ‘dacchè tutto questo complesso si fu perfezionato nelle mani di
10
Bonaparte, questa forza militare appoggiata a tutta la potenza della nazione attraversò
l’Europa infrangendo ogni resistenza’ - e costrinse le altre nazioni a reagire con
mezzi adeguati e simili.
Il punto fondamentale di tutta l’analisi di von Clausewitz è tuttavia che questo
radicale mutamento della guerra (‘l’elemento della guerra, sbarazzato da ogni
barriera convenzionale, irruppe con tutta la sua naturale violenza. Ragione essenziale
di ciò, la partecipazione dei popoli a questi grandi interessi politici’) non fu un
semplice adeguamento delle forme e della condotta della guerra (reale) alle nuove
condizioni sociali e politiche, ma fu invece la miglior realizzazione pratica del
concetto (filosofico) di guerra assoluta che mostrò così di essere non tanto il
risultato di uno sforzo del pensiero, ma una chiarificazione della realtà stessa:
‘dall’epoca di Bonaparte la guerra, divenendo dapprima per l’una parte e poi per
l’altra una causa nazionale, cambiò interamente natura; o piuttosto si avvicinò molto
alla sua essenza originaria, alla sua perfezione assoluta. I mezzi impiegati non ebbero
più limiti’; ‘sono le ultime guerre che hanno reso possibile alla teoria di adempiere a
questo compito [definire il concetto filosofico di guerra assoluta] in modo efficace.
Senza questi esempi ammonitori della potenza distruttrice dell’elemento scatenato, la
teoria griderebbe invano nel deserto: nessuno crederebbe possibile ciò che tutti hanno
visto recentemente’; ‘la guerra ha anch’essa subito modificazioni profonde nella sua
essenza e nelle sue forme, sì da ravvicinarle al carattere assoluto. … esse sono nate
sia in Francia sia nel resto dell’Europa.’
Continui sono così gli esempi e le analisi delle campagne napoleoniche, e soprattutto
di quella di Russia del 1812 in cui si riassunsero ed arrivarono al loro culmine tutte le
novità e le radicalità della sconvolgente era militare nella quale l’Europa intera era
improvvisamente entrata: la campagna di Russia del 1812 fu infatti la più compiuta
guerra di annientamento mai realizzata.
Se dunque le guerre degli anni 1792-1815 resero vivo ed avvicinarono alla realtà
concreta il concetto teorico di guerra assoluta, per von Clausewitz (testimone diretto
degli eventi) tuttavia quest’ultimo si materializzò e realizzò pienamente in tutta la sua
radicalità soprattutto nella campagna di Russia del 1812, quando (ripetiamolo)
l’annientamento raggiunse la sua forma più compiuta e definitiva e la guerra
reale venne così a coincidere con la guerra assoluta.
Chiarito il concetto di guerra assoluta ed indicata la sua realizzazione più compiuta
nelle guerre scoppiate in seguito alla rivoluzione francese e soprattutto con
Napoleone, von Clausewitz si chiede però anche se la guerra (reale) d’ora in avanti si
sarebbe mantenuta su questi livelli di partecipazione popolare e di totale distruzione
dell’avversario oppure se le società europee sarebbero tornate a lasciar fare la guerra
ai loro governi ed a subirla (in forma però attenuata!) più o meno passivamente:
‘Resteranno le cose sempre così … oppure si ristabilirà nuovamente un isolamento
fra i governi da un lato e i loro popoli dall’altro?’
Egli non potè evidentemente rispondere e solo il prosieguo della storia avrebbe
mostrato che ambedue le strade sarebbero state percorse.
11
VI
Nel trattare la guerra reale von Clausewitz dà prova di tutta la sua competenza e
conoscenza dell’argomento: dalla sua lunghissima e completa analisi emerge quanto
la guerra reale è un processo lungo e complesso nel quale tutte le forze a disposizione
vengono messe in campo ed impiegate in un’infinità di modi a seconda della
situazione di partenza, dei suoi sviluppi nei vari settori, del terreno, delle risorse a
disposizione, della conoscenza del nemico, delle sue manovre, dell’opportunità
tattica, ecc., mentre anche il caso e la fortuna, oltre alle capacità dei contendenti,
hanno un ruolo di rilievo, tanto importante che von Clausewitz conclude che ‘di tutti i
rami dell’attività umana, la guerra è quello che più rassomiglia a una partita con le
carte da gioco’ (!).
Altro fattore importantissimo della guerra è il famoso morale delle truppe (e della
società da cui esse provengono) - da cui deriva il loro coraggio e la loro perseveranza
- che è fondamentale in un contesto in cui il pericolo, le fatiche, i disagi, l’incertezza,
la paura, ecc. sono continui: visto infatti che ‘la guerra … è lotta …, le energie
morali non possono essere escluse, giacchè lo stato dell’animo esercita la più decisiva
influenza sulle forze combattenti’.
Questi sono gli unici sentimenti che von Clausewitz prova, dei quali si accorge, che
tratta diffusamente ed ai quali attribuisce un’importanza estrema.
Lungi dall’essere barbarie, la guerra è insomma un atto estremamente razionale,
ramificato e complicato che richiede grandi intelligenze e competenze: la guerra
spazia dalla preparazione e dall’addestramento alla logistica, dai servizi alle
conoscenze tecniche in un’enorme quantità di campi e di attività, e tutto infine va
dominato ed organizzato da un centro direttivo unico e superiore.
Una dottrina completa della guerra per von Clausewitz è tuttavia impossibile anche
perchè il continuo modificarsi della situazione e la costante insorgenza
dell’imprevisto necessitano di decisioni per le quali è richiesto un indefinibile talento
naturale del tutto particolare e senza del quale il comandante supremo è destinato alla
sconfitta: ‘per effetto di una semplice intuizione dello spirito … avviene … la
maggior parte delle cose che si fanno in guerra’; il ‘condottiero … deve in certo qual
modo congetturare’; i ‘grandi capitani … dalla loro altezza scorgono con un colpo
d’occhio l’insieme delle cose’.
Ecco allora che ‘il punto di vista libero ed elevato del condottiero, il suo modo
semplice di concepire le cose, l’immedesimazione della sua persona nell’atto della
guerra costituiscono a tal punto, in modo completo, il nocciolo di ogni buona
condotta di guerra, che solo in questo modo grandioso è concepibile la libertà di
spirito necessaria per dominare gli avvenimenti [bellici]senza venirne sopraffatti.’
Capacità (anche improvvisazione) e responsabilità crescono ovviamente col crescere
del comando finchè ai massimi livelli sono poi indispensabili esperienza, doti
eccezionali di carattere e l’assoluta disponibilità all’adattamento cui le circostanze
mutevoli ed impreviste costringono continuamente.
Oltre che di una mente ordinatrice di prim’ordine, von Clausewitz dà continua prova
di grande ampiezza di giudizio e contemporaneamente di possedere una vastissima
12
quantità di informazioni: nulla rimane fuori dalla sua indagine mentre il suo
equilibrio, la sua profondità e la completezza del suo esame nel gestire una materia
così vasta ed articolata sono semplicemente straordinari.
La panoramica della guerra che egli sa offrire al lettore lo conquista e desta in lui la
più sincera e meritata ammirazione.
VII
In un esame così approfondito ed esaustivo come quello che von Clausewitz fa della
guerra non poteva mancare il riferimento a quella che oggi chiamiamo ‘guerriglia’ e
che lui chiama invece ‘guerra di popolo’: essa si verifica quando non è più l’esercito
nazionale che combatte, ma, appunto, è il popolo che si arma e che resiste ad un
esercito invasore.
Quando insomma ‘la popolazione comincia a prendere parte alla lotta fino
all’elevatissimo grado in cui, come in Spagna [1808-14] la guerra è condotta
precipuamente dal popolo in armi, si comprende che non si tratta più soltanto di
un’accentuazione dell’assistenza popolare [all’esercito nazionale], bensì di una vera
nuova potenza.’
E’ evidente che le bande di partigiani e di guerriglieri non potrebbero mai affrontare
il nemico in campo aperto perché ne verrebbero irrimediabilmente travolte: esse
invece devono rendere impossibile la vita degli invasori i quali se rimangono uniti
sono invincibili ma possono controllare soltanto una piccola parte del paese occupato,
mentre se si disperdono diventano invece deboli e vulnerabili: l’esercito invasore
dev’essere insomma avvolto da una popolazione ostile ed agguerrita e ‘quanto
maggiore è il contatto in cui essa [la guerra di popolo] si mantiene coll’esercito
avversario, dunque quanto maggiormente esso esercito si allarga, tanto maggiore sarà
l’efficacia della guerra di popolo. Essa, al pari di una fiamma che lentamente si
propaghi, distrugge le basi della saldezza dell’esercito nemico’, così ‘l’incendio si
propaga come in una brughiera e, in definitiva, raggiunge il terreno sul quale
l’avversario si basa, invade le sue linee di comunicazione, corrode i nervi vitali della
sua esistenza.’
I partigiani sono sostenuti dalla popolazione tutta, aggrediscono i reparti isolati,
sanno poi sparpagliarsi immediatamente per raggrupparsi altrettanto velocemente in
vista del prossimo colpo.
E’ evidente che la guerra di popolo ha dei costi umani spaventosi, ma non sono questi
che preoccupano von Clausewitz che, al solito, non li prende mai in consideazione.
Un aspetto della guerra di popolo cui von Clausewitz accenna soltanto è poi che un
popolo in armi è un popolo che obbedisce solo a se stesso, dunque è inevitabilmente
un popolo rivoluzionario che non può non suscitare apprensione ed opposizione in
tutti i conservatori i quali infatti sono contrari alla guerra di popolo perchè
giustamente ‘la considerano come un mezzo rivoluzionario altrettanto per l’ordine
sociale interno proprio quanto per il nemico’.
13
Ai tempi di von Clausewitz questo era un problema che poteva essere solo
faticosamente immaginato, ma nel secolo seguente avrebbe avuto invece una
rilevanza tanto grande da mutare il carattere della guerra (reale) stessa.
VIII
La guerra di cui Von Clausewitz parla con tanta competenza era pur sempre quella
dei suoi tempi, quella combattuta con eserciti regolari da stati europei che avevano
raggiunto sostanzialmente lo stesso livello tecnologico.
Egli si chiede allora come raggiungere ed assicurarsi quella superiorità che in caso di
guerra garantisca la vittoria, e risponde che, dato che le condizioni materiali erano
sostanzialmente le stesse in tutta Europa e che il genio militare di un condottiero è un
imprevisto ed imprevedibile dono della natura, bisognava allora puntare sulle
importantissime qualità morali, le uniche che permettono ad una nazione di
sviluppare e valorizzare tutte le sue potenzialità e le sue energie e ad un esercito di
sopportare le terribili durezze che la guerra impone e di possedere quella costanza e
quel coraggio di credere e di perseverare fino alla vittoria: è insomma lo spirito che
fa la differenza.
‘Ai nostri giorni gli eserciti si rassomigliano talmente per armamento,
equipaggiamento ed addestramento, che … all’infuori del talento del comandante
supremo … che dipende interamente dal caso, il solo fattore atto a confermare una
superiorità notevole ad un esercito è l’abitudine alla guerra.’
‘Lo spirito d’audacia può essere proprio di un esercito sia perché procede dalla
nazione stessa, sia perché è stato generato da una guerra fortunata sotto un capo
ardito: nel secondo caso, però, verrà inizialmente [in una nuova guerra ] a mancare.
Ora, ai nostri tempi, non esiste altro mezzo che la guerra, e la guerra condotta
audacemente, per sviluppare lo spirito nazionale in questa direzione. E’ questo il solo
rimedio contro il rammollirsi dei caratteri, contro le tendenze alla comodità verso cui
è tratta ogni nazione che aumenta il proprio benessere ed estende le proprie relazioni
commerciali. Solo quando il carattere nazionale e l’abitudine alla guerra siano in
relazione reciproca e si sostengano a vicenda, una nazione può sperare di occupare
una posizione stabile nel mondo politico’.
Ripetutamente von Clausewitz assegna quindi la massima importanza alle
caratteristiche guerriere di un popolo perché senza di esse la guerra non si vince ed
anzi ci si indebolisce progressivamente: una nazione deve essere abituata alla
guerra, educata alla guerra, preparata alla guerra e, soprattutto, combattere
molte guerre.
Solo in questo modo si forgia lo spirito guerriero di un popolo, solo così lo si rende
forte e invincibile, maschio e potente, sobrio e determinato, audace e resistente.
E’ appena il caso di ricordare che von Clausewitz scriveva negli anni in cui Hegel
teneva le sue famose lezioni di filosofia della storia in cui campeggiavano le gesta
grandiose dello spirito del mondo e che oltre mezzo secolo dopo Nietzsche avrebbe
profetizzato la futura società degli oltreuomini, di coloro cioè che, sereni e terribili
guerrieri (dello spirito), sarebbero stati in grado di cogliere e di accettare la logica ed
14
inevitabile conseguenza (per gli spiriti forti) della morte di Dio ed avrebbero quindi
abbattuto la morale cristiana e tutti i suoi derivati democratici e socialisti (cioè
pacifisti) in vista della gioiosa e terribile affermazione della loro volontà di potenza.
Un secolo dopo il fascismo ed il nazismo avrebbero fatto propria questa
valorizzazione ed esaltazione clausewitziane della guerra (di conquista) e puntato
apertamente a quella formazione del carattere dell’intera società in senso militare e
bellicista raccomandata dal grande generale prussiano: è questo un punto che i suoi
numerosi ammiratori sembrano trascurare con troppa disinvoltura mentre è la logica
conclusione di tutto il suo pensiero.
La concezione marxista della guerra
Il marxismo ritiene che il motore della storia sia l’economia e che dunque la struttura
di una società sia il tipo di economia che in essa vige: a sua volta ogni tipo di
economia divide la società in classi a seconda del ruolo svolto nella produzione, ma
la divisione fondamentale è quella fra i detentori dei mezzi di produzione (i padroni)
e coloro che li utilizzano per produrre (gli sfruttati).
E’ evidente che queste due classi sono antagoniste ed in contraddizione fra loro dato
che i loro interessi (la ripartizione del prodotto sociale) sono inevitabilmente
contrapposti e conflittuali: non a caso lo stesso ‘Manifesto del partito comunista’ di
Marx ed Engels si apre proclamando che ‘la storia di ogni società esistita fino a
questo momento è storia di lotte di classi’ e che dunque la lotta di classe è la logica
della storia stessa.
Tutto il complesso e multiforme andamento storico e politico di una società deriva ed
è comprensibile solo a partire dall’ineliminabile conflittualità (più o meno latente) fra
le classi sociali in contrapposizione fra loro: tutto il mondo dello spirito (politica,
giurisprudenza, ogni manifestazione della cultura e della mentalità, ecc.) è
sovrastruttura che esprime ad un livello astratto precisi interessi economici (cioè è
una ideologia) dai quali gli derivano i suoi contenuti particolari.
Il comunismo si prefisse di giungere all’abolizione delle classi sociali mediante una
rivoluzione che risolvesse finalmente tutte le fratture e le contraddizioni sociali e
realizzasse così un mondo di liberi e di uguali.
Questi poverissimi e limitatissimi cenni bastano però a farci comprendere perché
scoppi e cosa sia la guerra in una prospettiva marxista: la guerra è la difesa o la
ricerca di precisi interessi economici da parte delle classi padronali (naturalmente
al governo) che non riescono più a mantenere ed a gestire (o ne hanno di nuovi) senza
far ricorso alle armi.
Il marxismo riesce a spiegare ogni fenomeno storico muovendo dagli interessi
economici delle classi padronali al potere e anche la guerra non fa dunque eccezione,
ma è evidente che gli sfruttati non hanno il minimo interesse alla guerra di cui
oltretutto devono sopportare tutti i pesi e tutti i costi: essi, inquadrati in eserciti che
riproducono pienamente le divisioni sociali, devono andare ad uccidere e a morire per
favorire gli interessi dei loro sfruttatori, (più o meno) spinti dai valori e dall’ideologia
15
dei loro padroni stessi che cercano di convincerli che una guerra riguarda tutta la
società, lo stato, la nazione, e che è una missione collettiva di tutto il popolo.
Per il marxismo la guerra è insomma solo un momento acuto della costante lotta del
padronato per assicurarsi maggiori e migliori profitti: in guerra lo sfruttamento dei
lavoratori ovviamente cresce a dismisura (sui luoghi di lavoro e al fronte) seppur
mascherato dalla propaganda nazionalistica, dalla retorica patriottica e dai richiami
all’eroismo ed ai valori militaristici … mentre fucilazioni, codici militari di guerra e
tribunali militari contribuiscono grandemente al mantenimento della disciplina.
Si comprende facilmente dunque perché Marx, Engels e Lenin concordassero
pienamente con von Clausewitz che ‘la guerra è la prosecuzione della politica con
altri mezzi’, visto che per loro il suo scopo era sempre lo stesso, interessi economici e
profitti del padronato, e cambiavano solo i mezzi per raggiungerlo ed assicurarselo.
Per i marxisti gli sfruttati non hanno invece patria (il famoso internazionalismo
proletario), essi sono fratelli solo degli altri sfruttati ed hanno per nemici solo coloro
che tolgono loro il frutto del loro lavoro e li fanno vivere in uno stato di alienazione:
la loro vera guerra è insomma solo la rivoluzione che ponga termine a questo stato
di vera e propria disumanità.
Quando scoppiò la prima guerra mondiale Lenin fu netto e deciso nel respingerla e
denunciarla per quel che realmente era, anche se dovette assistere al completo
fallimento della Seconda Internazionale quando i socialisti francesi ed i socialisti
tedeschi si schierarono a fianco dei loro governi ed andarono a combattersi senza
quartiere nei crudeli carnai delle trincee, proprio loro (e non solo) che per un
venticinquennio erano stati seduti l’uno a fianco dell’altro a denunciare le malefatte
del capitalismo ed a preparare la futura era socialista.
I
Quando i marxisti salirono al potere e fondarono l’URSS la prospettiva in cui
considerare la guerra naturalmente cambiò e si verificò un particolarissimo connubio:
dopo che l’autonomia e l’indipendenza delle repubbliche che erano nate dal
disfacimento della Russia erano state bruscamente soffocate e l’impero zarista era
stato riconquistato (almeno in Asia), Stalin continuò a portare avanti la politica
imperiale precedente ma la giustificò con la necessità di diffondere e rafforzare la
rivoluzione.
Tutti i comunisti del mondo dovevano stringersi intorno all’URSS e difenderla contro
le minacce che le venivano dal mondo capitalistico che la serrava da ogni parte: il
fallimento dell’URSS avrebbe significato infatti una sconfitta gravissima anche per
l’intero movimento comunista internazionale (che per parte sua trovava appoggio e
protezione proprio nell’unico stato in cui era al potere).
La vera patria dei lavoratori (sic) e dei comunisti era l’URSS ed era a lei che essi
dovevano la loro fedeltà, di qualunque altro stato fossero ed in qualunque altro stato
vivessero: era lei che dovevano difendere e sostenere contro tutti i suoi nemici,
compresi i propri governi.
16
Stalin ed i suoi successori praticarono sempre la più aperta politica di potenza
imperiale contraddicendo completamente il messaggio di liberazione che pure il
marxismo rappresentava, ma sapevano di poter contare sul pieno e convinto sostegno
del movimento comunista internazionale: qualsiasi politica l’URSS portasse avanti la
giustificava infatti col richiamo alla rivoluzione e colla necessità di sventare le
manovre ed i complotti della reazione e del capitalismo perennemente assetato di
profitti e di denaro (altrui).
Il movimento comunista internazionale non si oppose mai a nessuna guerra offensiva,
invasione di stati, soffocamento di popoli, che l’URSS portò avanti: esso giudicò
sempre che era lei la vittima o che agiva a fin di bene, rispolverando ed adattando alla
bisogna tutta l’ideologia colonialista che pure condannava decisamente (negli altri).
Era tuttavia evidente che la politica dell’URSS era la continuazione di quella zarista e
che le sue guerre in nulla differivano da quelle degli aborriti capitalisti (se non nella
propaganda).
Anche gli altri stati che divennero comunisti (Cina innanzitutto) dopo la rivoluzione
non mutarono certo la loro politica estera nè il loro atteggiamento verso la guerra
(anzi, divennero ancor più espansionisti e bellicisti): anch’essi però la rivestirono
della loro stucchevole propaganda.
In conclusione, la concezione marxista della guerra ha avuto senso solo fino al 1917:
dopo si è trasformata in rozza ipocrisia, in apologia dell’Unione Sovietica, nello
sperticato appoggio ad ogni sua aggressione e cioè nel fanatismo di chi si rifiutava di
riconoscere per quel che erano anche le realtà più evidenti dell’espansionismo dei
nuovi stati comunisti.
Marinetti: guerra sola igiene del mondo
Il 20 febbraio 1909 su un editoriale del ‘Figaro’ Filippo Tommaso Marinetti (18761944) pubblicò il manifesto del Futurismo dando inizio e vita ad una corrente
letteraria, artistica, ma anche politica, che si sarebbe diffusa in tutta Europa
(soprattutto in Russia) e che sarebbe presto diventata una delle manifestazioni più
caratteristiche dei suoi tempi dei quali seppe esprimere ed interpretare genialmente le
tumultuose novità.
Marinetti sosteneva che il prodigioso sviluppo scientifico e tecnologico (la cosiddetta
‘seconda rivoluzione industriale’) aveva ormai trasformato l’intera vita dell’Europa
(dominatrice allora di interi continenti) il cui spirito però non si era ancora adeguato a
questa radicale trasformazione e che dunque era tempo di procedere decisamente in
questa direzione: ‘Il Futurismo si fonda sul completo rinnovamento della sensibilità
umana avvenuto per effetto delle grandi scoperte scientifiche’.
Arte, letteratura e insomma tutto il pensiero europeo erano infatti ancora legati ai
canoni ed alla mentalità di un passato coltivato con cura e dedizione, ma in questo
modo sfuggivano completamente le enormi possibilità che ora invece si offrivano
all’uomo moderno, potente come mai era stato e proiettato verso realizzazioni fino a
quel momento addirittura inconcepibili.
17
Si doveva insomma adeguare il pensiero alla realtà ormai rivoluzionata dalla
scienza e dalla tecnica (‘Dopo il regno animale, ecco iniziarsi il regno meccanico’).
Un po’ come quando nel XV e XVI secolo si era continuato a coltivare il classicismo,
a scavare nelle polverose biblioteche monastiche all’affannosa ricerca di testi classici
e si era ammirato in modo incondizionato l’antichità mentre interi continenti e popoli
sconosciuti venivano intanto scoperti e panorami impensabili si offrivano ai
navigatori ed agli esploratori che avevano varcato i confini del mondo, anche nel
nuovo XX secolo tutto si era messo tumultuosamente in movimento mentre la cultura
era rimasta paciosamente rivolta al passato e sembrava non essersi accorta di nulla
(!): ‘l’uomo completamente avariato dalla biblioteca e dal museo, sottoposto ad una
logica e ad una saggezza spaventose, non offre assolutamente più interesse alcuno’ e
bisognava allora spezzare e distruggere questa incomprensibile e perniciosa attitudine
alla tranquilla e soddisfatta contemplazione del passato.
In questa sede non sono in esame le radicali novità in campo artistico e letterario
proposte dal Futurismo e basterà dunque segnalare che esso fu una furiosa negazione
(teorica ma anche pratica) della vita quieta che si pasceva del passato,
inconcepibilmente inconsapevole delle rivoluzionarie novità del presente e delle
straordinarie possibilità del futuro: ‘Il presente non mai come in questi tempi apparve
staccato dalla catena genetica del passato, figlio si sé stesso e generatore formidabile
delle potenze future’ così che ‘gli uomini ridiventano mitici!’.
Marinetti ed i suoi compagni si scatenarono così nella contestazione di tutti i canoni
letterari, artistici, filosofici (e politici!) esistenti e nell’elaborazione di nuove forme
espressive che fossero finalmente in grado di cogliere le straordinarie novità dei
tempi moderni e di essere a loro adeguati.
Il Futurismo si proponeva un ‘acceleramento della vita’ (esso aveva un vero e proprio
culto per la velocità), professava ‘orrore di ciò che è vecchio … e del quieto vivere’
puntando tutto al contrario su ‘moltiplicazione e sconfinamento delle ambizioni e dei
desideri umani’.
Alla base di tutto ciò stava il riconoscimento che ‘l’uomo moltiplicato dalla
macchina’ aveva aumentato a dismisura (e più ancora l’avrebbe fatto in futuro) le sue
possibilità d’azione, ma avrebbe potuto raggiungere ed oltrepassare tutti i confini che
fino a quel momento l’avevano fermato solo se avesse spezzato le catene che lo
avvincevano ancora alla tradizione e al passato: nel ‘Futurismo … la volontà di
distruggere e di rinnovare è tutto’ e bisognava allora assestare ‘pugni schiaffi e calci
in faccia ai passatisti’.
I
Non è possibile cogliere la dirompente e trascinante energia che Marinetti (la
‘caffeina d’Europa’) infondeva nelle sue opere incendiarie se non leggendole e
lasciandosi prendere dalla loro freschezza e frenesia, ma fin dall’inizio esse
tracimarono dall’arte e dalla letteratura e fecero tutt’uno con una nuova proposta
politica - e questa nuova politica futurista (che l’Italia avrebbe dovuto intraprendere
al più presto) aveva come sua strategia e suo mezzo principale la guerra.
18
Marinetti incitò alla ‘distruzione!’ dell’esistente proclamando fin dal 1909 ‘l’odio per
ogni forma politica pacifista’ e ‘l’esecrazione dell’Austria’ visto che ‘serva è più che
mai l’Italia al Pangermanesimo’ (che con la Triplice Alleanza bloccava l’Italia e
assicurava equilibrio e stabilità alla vecchia Europa decrepita): tutto si teneva nella
visione futurista perché è ovvio che il radicale cambiamento così tanto auspicato e
bramato si sarebbe potuto realizzare solo attraverso l’abbattimento del vecchio ordine
e l’instaurazione di un sistema politico che, dinamicamente aperto al futuro, si
basasse sull’intraprendenza, la novità, il continuo sorpasso fichtiano di limiti e di
ostacoli, il raggiungimento di obiettivi sempre nuovi e sempre possibili per chi li
avesse davvero compresi e voluti.
E tutto ciò sarebbe stato possibile solo con la guerra.
II
Gli anni in cui Marinetti fondò il Futurismo furono comunque gli anni in cui l’intera
Europa era percorsa da fremiti di insoddisfazione, di rifiuto della stabilità soddisfatta,
di ricerca della potenza e di un acceso sentimento - giudicato ‘irrazionalista’ – di
esaltazione dell’azione di cui si sentiva il bisogno prepotente: l’Europa era appena
uscita dalla straordinaria avventura della conquista dell’Africa e dell’Asia, aveva così
allargato i confini del proprio dominio come mai le era accaduto nella sua storia
millenaria, ma ciò, invece di soddisfazione, tutto al contrario aveva acuito un senso di
competizione e di ostilità fra gli stati che si avvertivano l’uno minaccia e limite
soffocante dell’altro.
La filosofia di Nietzsche aveva già profondamente presagito l’imminente arrivo di
una nuova era improntata dalla trasvalutazione di tutti i valori, dalla lotta e
dall’autoaffermazione ottenuta grazie alla liberazione ed al trionfo della celeberrima
volontà di potenza: in Italia Gabriele D’Annunzio aveva fatto propria (seppur a modo
suo) questa filosofia esaltando la figura del superuomo libero da ogni impaccio nel
suo insopprimibile diritto al dominio ed all’affermazione di sé.
A Firenze nel dicembre 1910 Enrico Corradini fondò l’Associazione Nazionalistica
Italiana (o Partito Nazionalista) che propugnava l’unione di tutti gli italiani e la
necessità di espansione e di conquista cui essi avevano diritto ma che sarebbero stati
possibili solo se essi si fossero sentiti un popolo, fuso insieme e coeso: come
riconosce Francesco Gaeta, in questa prospettiva ‘la guerra diventava la suprema
manifestazione dello spirito e della potenza della nazione’ e ‘l’immagine più alta
della nazione non era … il parlamento, ma l’esercito, perché il parlamento era i
‘partiti’, cioè la divisione della nazione’.
Nazionalisti e futuristi erano ambedue frutto dello sviluppo industriale dell’Italia, ma
essi aborrivano Giovanni Giolitti, lo statista che aveva realizzato al meglio proprio
questo sviluppo!
L’Italia di Giolitti era giudicata infatti ‘Italietta’, cioè uno stato che si accontentava,
che pensava in piccolo e che voleva vivere comodamente, che non aveva ambizioni,
che non voleva correre pericoli, che non sapeva osare, che pensava solo al benessere
materiale e che voleva essere lasciato in pace.
19
Fu così in questa temperie politica e spirituale che Giolitti acconsentì comunque alla
guerra di Libia (1911-12), ma fu con lo scoppio della prima guerra mondiale che la
situazione si mise decisamente in movimento con l’accanito scontro fra interventisti e
neutralisti (dall’estate del 1914 alla tarda primavera del 1915).
III
Nazionalisti e futuristi furono naturalmente tutti ardenti interventisti, ma nel caso di
Marinetti il discorso fu molto più generale perché fu in quei mesi bollenti che egli
intitolò ‘Guerra sola igiene del mondo’ una serie di suoi interventi e questo titolo
era già tutto un programma.
Secondo Marinetti occorreva una ‘modificazione della concezione della guerra,
diventata il collaudo sanguinoso e necessario della forza di un popolo’ tanto che
‘l’Italia dovrà essere impavida, accanitissima, elastica e veloce come uno
schermidore, indifferente ai colpi come un boxeur, impassibile all’annuncio di una
vittoria che costasse cinquantamila morti, o anche all’annuncio di una disfatta’.
Si è visto che già von Clausewitz aveva richiamato la necessità che un popolo venisse
costantemente tenuto in guerra perché questo era l’unico modo per forgiarne il
carattere e dargli dunque la superiorità sui nemici, ma nel caso di Marinetti c’era però
di più: per Marinetti infatti la guerra era lo strumento principe non solo per affermare
la potenza dell’Italia nel mondo, ma soprattutto per gestire quello stravolgimento
spirituale che avrebbe dovuto fare finalmente del popolo italiano un popolo futurista.
Von Clausewitz era stato insomma un conservatore mentre Marinetti, un secolo dopo,
un rivoluzionario, così se per il primo il problema era solo di essere vincitori in un
mondo che comunque continuava a rimanere uguale a se stesso, dal secondo invece
la guerra era intesa soprattutto come distruggitrice di equilibri e di tradizioni, di
sistemi consolidati, di abitudini e di consuetudini, insomma di tutta quella società che
guardava, immobile ed immobilizzata, al passato.
Ecco perché Marinetti definì ‘la guerra, Futurismo intensificato’, perché la guerra
distruggeva per rigenerare, liquidava i pavidi e gli incerti, forgiava i forti e gli
ardimentosi, mobilitava tutte le energie e tutte le risorse, era l’affermazione più
importante dell’azione, del cambiamento, della rivoluzione e dell’accettazione della
sfida del futuro.
Un futurista pacifista sarebbe stata insomma una contraddizione di termini.
IV
I futuristi furono dunque tutti ardenti interventisti e Marinetti fu più volte arrestato
(una volta anche insieme a Mussolini): essi partirono tutti volontari per il fronte e
Marinetti fu anche ferito (all’inguine) dimostrando così di non limitarsi alle parole ed
alla propaganda. All’inizio del 1918 (quando in guerra durava ancora!) egli pubblicò
il ‘Manifesto del partito futurista italiano’ col quale proponeva che la guerra (una
volta vinta) fosse seguita da un forte rinnovamento del sistema politico secondo le
esigenze dei tempi nuovi e rivoluzionari ormai in pieno svolgimento.
20
Marinetti voleva ‘una Italia libera forte, non più sottomessa al suo grande Passato’ e
un ‘nazionalismo rivoluzionario’ che prevedesse fra l’altro l’ ‘educazione patriottica
del proletariato’, cioè l’inserimento anche della classe operaia - protagonista
essenziale della produzione industriale - nei ranghi della nuova nazione rinnovata e
cementata dalla guerra.
Nulla era trascurato da Marinetti che per permettere ed attuare lo slancio creatore
della nuova Italia chiedeva l’ ‘abolizione di molte Università inutili e
dell’insegnamento classico’, la ‘ginnastica obbligatoria con sanzioni penali’, ‘scuole
di coraggio’, la ‘abolizione del Senato’ (roba da vecchi), la riduzione a 22 anni
dell’età per divenire deputati, la ‘trasformazione del Parlamento mediante un’equa
partecipazione di industriali, di agricoltori, di ingegneri e di commercianti’, il
suffragio universale per uomini e donne, ‘un anticlericalismo d’azione, violento e
reciso, per sgomberare l’Italia e Roma dal suo medioevo teocratico’ (bisognava
‘svaticanare l’Italia’) e tutta una serie di altre misure (come il ‘divorzio facile’ e
‘l’avvento graduale del libero amore’) che velocizzassero la vita del paese e che
erano tutte improntate al rinnovamento, all’abbattimento delle tradizioni del passato,
alla continua mobilitazione di tutte le energie della società che, liberate e libere da
ogni vincolo e costrizione, potessero così proseguire sempre più veloci sulla strada
del futuro.
Ancor oggi, un secolo dopo, la travolgente e focosa passione di Marinetti risulta
contagiosa e sprona al movimento ed all’azione: egli propugnava un popolo unito ed
affratellato dalla guerra che cementava la sua unità e la sua forza anche e soprattutto
mediante l’abitudine alla guerra (intesa in senso puramente clausewitziano) che
avrebbe dovuto penetrare in tutte le fibre della società come forza distruttrice del
passatismo (ormai senza più radici nell’era industriale) e apertura entusiastica al
futuro già iniziato.
In un primo momento le ardenti previsioni di Marinetti sembrarono però
completamente errate: l’Italia uscita dalla guerra risultò ancora più divisa di prima e
visse quattro anni di convulsioni e scontri interni finchè con la marcia su Roma
Mussolini e il Fascismo non salirono al potere.
Marinetti che era stato al fianco di Mussolini fin dalla campagna interventista,
partecipò poi alla fondazione dei Fasci di combattimento (il 23 marzo 1919 in piazza
San Sepolcro), definì il duce ‘il primo futurista d’Italia’ e lo seguì fino a Salò (anche
se morì prima di dover assistere al crollo definitivo del Fascismo).
V
Nell’adesione di Marinetti (e in genere dei futuristi) al Fascismo non si deve
comunque scorgere un abbandono delle proprie posizioni o una conversione al verbo
mussoliniano perché in realtà fu Mussolini ad aver adottato (o comunque a
condividere) molte delle posizioni del Futurismo: l’unione del popolo italiano, la
rivoluzione nazionale, l’educazione patriottica del proletariato, il rinnovamento della
classe dirigente, l’anticonformismo e l’amore per l’azione furono infatti tratti
21
caratteristici del Fascismo (e soprattutto di quello della ‘prima ora’) che Marinetti
aveva anticipato e che erano parti essenziali anche del Futurismo (politico).
Il Fascismo fu la volontà di sanare tutte le fratture della società italiana
sopprimendone la causa fondamentale, il rivoluzionarismo di sinistra e le
rivendicazioni delle classi lavoratrici, verso le quali si mostrava comprensione solo
però in un quadro di stabilità sociale - e anche questo era un obiettivo pienamente
condiviso da Marinetti (e in genere dai futuristi).
Certamente colla trasformazione del fascismo da movimento a regime molti accordi e
molte concessioni furono fatte nei confronti di tutto l’establishment del vecchio stato
liberale e cattolico, ma è inevitabile che le tutte rivoluzioni subiscano (e non possano
non subire) un processo di mediazione e di adeguamento a quella realtà che pure
inizialmente volevano distruggere.
Soprattutto però il fascismo fu conseguenza della prima guerra mondiale e della
vittoria: esso avrebbe sempre mantenuto il carattere bellicista della nazione in armi
che attraverso una serie di guerre (Libia (la seconda), Etiopia, Spagna, Albania e
infine la seconda guerra mondiale) intendeva far nascere l’ ‘uomo nuovo’ abituato ed
anzi entusiasta dell’impegno militare per la conquista di spazi sempre più grandi e
gloriosi: anche – e forse soprattutto – questa natura del Fascismo lo avvicinava al
Futurismo fino a farli praticamente coincidere.
VI
In realtà la politica estera del Fascismo era stata comunque interamente mutuata dal
Nazionalismo e la tesi di Luigi Salvatorelli e di Francesco Gaeta secondo cui non fu il
Fascismo ad inglobare il Nazionalismo (nel 1923), ma proprio l’esatto contrario,
appare interamente condivisibile dato che il primo era nato e si era sviluppato per
motivi ed interessi di politica esclusivamente interna.
Se Mussolini non fosse salito al potere il Futurismo sarebbe diventato una
interessante tendenza semplicemente e solamente letteraria ed artistica e il
Nazionalismo sarebbe rimasto uno dei tanti movimenti di minoranza: Mussolini
riuscì a comporre queste due politiche (che condividevano comunque la stessa idea
clausewitziana di un sempre rinnovato ricorso alla guerra per la formazione ed il
consolidamento della nazione in armi) e a fonderle con alcune istanze socialiste a
proposito dell’elevazione (materiale e spirituale) delle classi lavoratrici e soprattutto
col vecchio stato sabaudo cui infuse nuova linfa e cui diede nuovi obiettivi.
E’ notissimo come l’applicazione di questa politica causò morte ed inaudite
sofferenze finchè finì in tragedia e quanto sangue costò la fondazione della
Repubblica Italiana su basi finalmente razionali.
Il concetto clausewitziano di guerre continue per forgiare il carattere di un popolo e
di una nazione mostrò nei fatti di essere un’aberrazione del pensiero: gli assurdi
disastri degli esaltati allievi del generale prussiano ci tolgono il fastidio di spendere
parole per contestarlo e per riconoscerlo come il vaneggiamento di uno squilibrato.
22
Freud: la guerra come liberazione di Thanatos
Le atroci violenze della prima guerra mondiale costrinsero Sigmund Freud (18561939) a modificare profondamente la psicanalisi che egli aveva fondato con tanto
successo (e con tanto scandalo) un quindicennio prima: non è questa la sede per
analizzare la rivoluzionaria teoria di Freud e basterà allora dire che fino a quel
momento il grande scopritore dell’inconscio e del meccanismo della sua interazione
con la vita cosciente e con quella morale aveva ritenuto che in esso agisse, e
premesse con forza per la sua realizzazione, un unico principio che egli aveva
chiamato Eros.
Secondo Freud questo ribollente, cieco, amorale ed irrazionale istinto fondamentale
era di natura sessuale (in senso lato) e tendeva unicamente alla gratificazione della
sue pulsioni entrando così in urto con la concretezza ed i condizionamenti della realtà
esterna e, soprattutto, coi divieti della morale e della religione che lo bloccavano o
quantomeno ne permettevano la soddisfazione solo se incanalato in comportamenti
socialmente accettabili e ‘corretti’: la mancata o limitata soddisfazione di questo
principio del piacere portava così a conflitti psicologici di ogni genere causando
frustrazione, sofferenza, disturbi e vere e proprie malattie (anche gravi).
Erano queste le nevrosi, lacerazioni anche profonde della psiche umana (con possibili
conseguenze anche somatiche) che si verificavano però a livello inconscio così che il
paziente sofferente non riusciva nemmeno a comprendere la natura del suo malessere
e del suo dolore.
Oltre ad una spiegazione e ad una cura per questa nuova malattia, Freud aveva
comunque offerto anche tutta una nuova spiegazione della natura (psicologica)
dell’uomo stesso facendo sparire il confine fra ‘normalità’ e ‘malattia’ (nessuno
poteva dirsi ‘sano’!), sfatandone e distruggendone alla radice ogni precedente
spiegazione e concezione, e infine negando con forza qualsiasi pretesa della religione.
La psicanalisi si proponeva insomma di spiegare l’intero meccanismo del
funzionamento psichico dell’individuo.
Data la natura sessuale (in senso lato) dell’Eros (l’istinto fondamentale dell’uomo
connaturato in lui fin dalla più tenera infanzia) ed il riconoscimento della sua natura
assolutamente amorale ed irrazionale, la psicanalisi aveva suscitato rifiuto e scandalo:
Freud aveva potuto facilmente dar conto anche di queste reazioni ma adesso, con la
necessità di spiegare lo spaventoso spettacolo offerto dalla prima guerra mondiale, la
sua teoria dovette affrontare uno sviluppo che la rese ben più ‘pessimistica’, terribile
e devastante.
Ora il problema era infatti comprendere e dar conto della ferocia scatenata e della
violenza senza freni dei combattenti, compito che l’analisi psicanalitica, così com’era
stata impostata fino a quel momento, non in grado di assolvere ed andava quindi
allargata e completata: fu così che nel 1915 Freud scrisse ‘Considerazioni attuali sulla
guerra e sulla morte’, un’opera breve ma fondamentale per la comprensione della
guerra stessa.
23
I
Freud condivise lo sconcerto per l’improvviso scoppio di una nuova guerra europea –
e di dimensioni così gigantesche! - che sconvolgeva tutte le previsioni di pace e di
sviluppo che erano apparse così logiche e così confortanti fino a quel momento,
quando l’Europa dominava interi continenti ed appariva saldamente avviata sulla
strada di un vorticoso progresso scientifico e tecnologico, della crescita industriale,
dell’aumento dei consumi, del trionfo del liberalismo e del miglioramento della
qualità della vita: ‘si osava sperare che almeno le grandi nazioni dominatrici della
razza bianca – alle quali era affidata la missione di guidare il genere umano … sarebbero riuscite a sanare i loro malintesi e conflitti di interessi senza ricorrere alla
guerra’ scrisse Freud, invece questa tanto celebrata ‘Belle époque’ era crollata in un
batter d’occhi ed i carnai delle battaglie e delle trincee superavano ogni
immaginazione in una guerra che ‘distrugge tutto ciò che trova sul suo cammino’.
Freud comunque non volle entrare nel campo dell’analisi storica e si limitò così a
fornire l’interpretazione psicanalitica della guerra o, meglio, del comportamento
umano in guerra – e questa è davvero tanto semplice quanto terribile.
II
Secondo Freud ‘la parte più intima e più profonda dell’uomo è composta da tendenze
di natura elementare … tese alla soddisfazione di … bisogni primitivi’ e ‘tutte le
tendenze riprovate dalla società come cattive … fanno parte di queste tendenze
primitive’: l’educazione ed il condizionamento sociale compiono così ogni sforzo per
reprimerle e/o indirizzarle verso obiettivi accettabili e favorevoli allo sviluppo della
società stessa e dello stato, ma il successo apparentemente ottenuto nel civilizzare e
nel rendere inoffensivo l’individuo fa sì che ‘noi tendiamo a giudicare l’uomo
‘migliore’ di quanto in realtà sia’.
Questa è tuttavia un’illusione perché tale successo in realtà è superficiale in quanto le
tendenze primitive non possono scomparire: ‘quanto di primitivo vi è nella nostra
vita psichica è imperituro’.
Ciò che è realmente accaduto è che ‘la nostra società civile … ha abituato un gran
numero di persone ad ubbidire, a conformarsi alle condizioni della vita civile, senza
che la loro natura partecipi a questa obbedienza’ tanto che ‘l’individuo … potrebbe
essere considerato un ipocrita, anche se egli non ne è assolutamente cosciente.
Indubbiamente, la nostra attuale civilizzazione … si basa su questa ipocrisia e …
subirebbe cambiamenti profondi se gli uomini volessero cominciare a vivere secondo
la loro realtà psicologica’.
Secondo Freud l’individuo viene insomma addomesticato fin dalla nascita e il senso
di colpa che conseguentemente prova se compie azioni vietate (come quelle violente)
è praticamente un riflesso pavloviano: ‘la nostra coscienza … è, per la sua origine,
‘angoscia sociale’, e niente di più’.
Ora, in guerra tutto questo scenario si capovolge perché ‘lo Stato in guerra si
permette tutte le ingiustizie, tutte le violenze’ e dunque libera l’individuo dal senso
24
di colpa che altrimenti gli deriverebbe dalle azioni che compie in guerra: avviene
così che ‘laddove viene a mancare il biasimo da parte della collettività, cessa la
compressione degli istinti malvagi, e gli uomini si abbandonano ad atti di crudeltà, di
perfidia, di tradimento e di brutalità, che, a giudicare solo dal loro livello di
civilizzazione, si sarebbero creduti impossibili’.
III
Tutto ciò è facilmente comprensibile se si tiene presente che oltretutto l’uomo per sua
natura non pensa alla propria morte ed ha sempre compiuto ogni sforzo per
allontanarne il pensiero: ‘il nostro inconscio … cioè gli strati più profondi della
nostra coscienza … non crede alla possibilità della propria morte’ che così ‘non trova
nessun punto d’appoggio nei nostri istinti’ mentre ‘troviamo assolutamente naturale
la morte di stranieri e di nemici, infliggiamo loro la morte volentieri’ perché ‘nei
nostri desideri inconsci noi sopprimiamo … tutti quelli che si trovano sul nostro
cammino’ tanto che ‘a giudicare dai nostri desideri ed auguri inconsci noi non siamo
che una banda di assassini.’
La conclusione di tutto ciò è semplice: ‘la guerra … ci indica negli estranei dei
nemici che bisogna eliminare’.
IV
Freud scoprì insomma che nell’inconscio oltre a Eros è presente ed agisce anche
un altro istinto che egli chiamò Thanatos (‘morte’ in greco) e che la guerra non fa
altro che liberarlo visto che non solo lo stato e la società non ne vietano più la
completa emersione, ma anzi l’incoraggiano e lo premiano punendo chi si rifiuta di
adempiere a questo compito.
L’educazione ed il condizionamento sociale in tempo di pace negano e capovolgono
la natura omicida dell’uomo, ma la guerra a sua volta nega e capovolge questa
negazione e questo capovolgimento: essa in qualche modo rimette le cose a posto,
cioè libera l’individuo e lo fa riappacificare con questa sua intima realtà
psicologica togliendogli tutti gli artificiali sensi di colpa ed annullandone la
coscienza (superficiale ed impostagli dall’esterno).
La conclusione di Freud è allora una domanda davvero terribile ed altrettanto amara:
‘dato che le guerre sono pressappoco inevitabili, non faremmo bene a piegarci di
fronte a questa situazione, ad adattarci ad essa? Non faremmo bene a convenire che
dal punto di vista psicologico, il nostro atteggiamento nei confronti della morte, quale
deriva dalla nostra vita civilizzata, va oltre le nostre forze, e che per noi sarebbe
meglio … piegarci di fronte alla verità … ? … In questo modo …avremmo il
vantaggio di essere sinceri con noi stessi e di renderci nuovamente sopportabile la
vita.
25
V
Alla luce del riconoscimento da parte di Freud delle innate ed ineliminabili pulsioni
omicide e distruttive di Thanatos assume infine un significato molto più profondo
l’invito e l’auspicio di von Clausewitz a che uno stato sia continuamente preparato
alla guerra, ragioni sempre in termini di guerra, combatta molte guerre e, insomma,
sia costantemente allenato alla guerra: secondo il grande generale ciò avrebbe
permesso di conseguire quella superiorità sul nemico che il livello tecnologico degli
armamenti non poteva assicurare (dato che era sostanzialmente lo stesso in tutte le
nazioni europee), ma ora questa superiorità morale che egli propose di raggiungere
appare molto più comprensibile.
Secondo von Clausewitz un popolo ed un esercito liberi dai freni inibitori delle
pastoie di un’etica tranquillamente pacifista, pronti a rischiare la vita e, soprattutto, ad
uccidere ed a distruggere senza provare i sensi di colpa e quei rimorsi che la ‘civiltà’
oppone a simili comportamenti, possono operare in guerra con ben maggiore
efficacia e determinazione; essi possiedono infatti il vantaggio decisivo di essere stati
educati ad un altro tipo di valori e di sentimenti, a quell’indole guerriera che
insistendo sul coraggio, sul sacrificio, sulla sopportazione delle durezze e dei disagi,
sulla brama di gloria e di vittoria, sola permette il risveglio ed il pieno dispiego di
tutte le energie necessarie in guerra.
Freud completa questo quadro: egli afferma infatti che qui si tratta di risvegliare e di
liberare la natura più riposta, più vera e più sincera dell’uomo e che quindi il progetto
di von Clausewitz fa perno sulla reale natura dell’individuo: l’antica sapienza di SunTzu secondo cui la guerra deve basarsi il più possibile sull’intelligenza ed essere il
meno possibile distruttrice appare qui del tutto abbandonata a tutto vantaggio dello
scatenamento (certamente anch’esso controllato dalla ragione) di Thanatos in modo
da conseguire sempre maggiore potenza e schiacciare senza pietà il maggior numero
di nemici.
Dopo che già Nietzsche aveva cantato la trasvalutazione di tutti i valori e profetizzato
l’avvento dell’oltreuomo, innocente e determinatissimo abbattitore di tutti gli ostacoli
sul suo cammino, Marinetti, i futuristi, i nazionalisti, il fascismo ed il nazismo
avrebbero fatto tesoro di queste indicazioni e di questi indirizzi, avrebbero proposto
ed insistito sulla formazione dell’ ‘uomo nuovo’, sereno e spietato combattente
educato alla lotta ed alla sopraffazione, maschio e spregiudicato conquistatore e
dominatore: il risultato furono le guerre mondiali e nessuno potrà mai convincermi
che in ciò siano potute risiedere liberazione e felicità.
VI
Tornando comunque alla domanda di Freud (che sicuramente esprime comunque il
suo sgomento di fronte alle notizie dal fronte), è davvero strano che egli se la ponga
perché essa è in contrasto con uno degli assunti fondamentali della psicanalisi stessa e
risulta dunque concettualmente sbagliata.
26
E’ infatti parte fondamentale del pensiero di Freud il riconoscimento (del resto
evidente) che la psiche umana non è certamente composta solo dalle pulsioni, dalle
tendenze e dagli istinti che affollano l’Es e che premono per la loro soddisfazione, ma
anche dall’Io (la razionalità) e dal Super-Io (la moralità): la soddisfazione integrale
dell’Es non è quindi possibile e addirittura, se pure avvenisse, porterebbe alla
dissoluzione della personalità stessa (più o meno come avviene in Kurtz di ‘Heart of
Darkness’ di Conrad).
All’uomo non è semplicemente possibile raggiungere l’appagamento totale delle
proprie spinte interne non solo per le indubbie e soffocanti censure sociali che lo
condannano così alla sofferenza ed alla frustrazione, ma in base alla sua stessa natura
che evidentemente non può sfuggire alle concrete e reali condizioni dell’esistenza
stessa (compito dell’Io) e non può non darsi delle regole di comportamento (compito
del Super-Io): la nostra vita si gioca insomma su questo equilibrio precario fra le tre
componenti della nostra psiche e non sull’impossibile liberazione integrale dell’Es.
Certamente è auspicabile la massima soddisfazione possibile (appunto: possibile)
delle nostre pulsioni, ma su questo punto esiste però una differenza tra la liberazione
dell’Eros e quella di Thanatos: mentre la prima (che pure può confluire nella seconda
e viceversa) apporta libertà e piacere ed è insomma innocua, anzi benefica, la seconda
ha effetti del tutto distruttivi e dunque il suo controllo è assolutamente ben più
necessario ed ha (e non può non avere) un ben altro peso.
Ammettiamo pure che l’uomo non è certo ‘buono’ e che tendenzialmente è anzi un
assassino e un distruttore; che in guerra questa sua natura può liberarsi ed egli può
così dar sfogo alle sue pulsioni più intime … ma davvero gli converrebbe vivere
così?
Non aveva ragione invece il vecchio Hobbes quando propose che per gli uomini è di
gran lunga più vantaggioso rinunciare alla loro violenza per vivere sicuri ed in modo
produttivo?
Certo Freud afferma che qui si tratta di tendenze ineliminabili, ma davvero non è
proprio possibile riuscire ad indirizzarle verso scopi positivi (costruttivi) anziché
negativi (distruttivi)?
VII
Diciotto anni dopo, nel 1933, in un celebre carteggio con Freud anche Albert Einstein
(1879-1955) si dichiarò convinto ‘che l’uomo, dentro di sé, tenda all’odio e alla
distruzione. In tempi normali questa passione è allo stato latente, si manifesta soltanto
in circostanze particolari, ma è relativamente facile richiamarla e affidarla al potere
delle psicosi collettive’.
Egli chiese così lumi al padre della psicanalisi che gli confermò subito che ‘Lei ha
esposto … l’essenza del problema’ in quanto ‘assumiamo che esistano due tipi di
istinti nell’uomo: quelli che conservano ed uniscono, che chiamiamo ‘erotici’ … e, in
secondo luogo, gli istinti a distruggere e a uccidere’. Chiarito che ‘ognuno di questi
istinti è altrettanto indispensabile del suo opposto’, ‘non vi è alcuna probabilità che
noi riusciamo a sopprimere le tendenze aggressive dell’umanità … la completa
27
repressione delle tendenze aggressive dell’uomo non è in questione; tutto quel che
possiamo fare è di cercare di spostarle verso un canale che non sia quello della
guerra’.
In quest’occasione però Freud mostrò comunque un qualche cauto ottimismo rispetto
a quanto aveva sostenuto nel 1915: egli riconobbe infatti che ‘lo sviluppo culturale
dell’umanità è stato in progresso fin dai tempi immemorabili’ e che ‘le modificazioni
psichiche che accompagnano questo processo di mutamento culturale … consistono
nel progressivo rifiuto dei fini istintivi e nella degradazione delle reazioni istintive. …
Ora, la guerra si scontra maggiormente contro la disposizione psichica impostaci
dallo sviluppo culturale’ e dunque all’interno dell’uomo stesso si starebbe formando
un’opposizione psicologica alla guerra che starebbe modificando la natura umana
stessa!
Certamente i tempi di questo processo sarebbero stati ancora molto lunghi ma ne era
comunque prevedibile una conclusione: ‘quanto dovremo attendere prima che tutti gli
altri uomini diventino pacifisti? Impossibile dirlo, ma la speranza … di por fine alla
guerra in un prossimo futuro non è chimerica’.
Schmitt: la nuova guerra ‘discriminatoria’
La vita del famoso giurista della politica e docente universitario Carl Schmitt (18881985) fu segnata dal nazismo e dalla guerra: fin dal 1 maggio 1933 Schmitt si iscrisse
infatti al partito nazista, divenne così Consigliere di Stato in Prussia, ottenne la
cattedra di Diritto pubblico a Berlino e fu nominato presidente dell’Unione dei
giuristi nazionalsocialisti: dopo la ‘notte dei lunghi coltelli’ (il massacro dei capi
delle SA il 30 giugno 1934) egli perse però parecchie simpatie negli ambienti del
regime dato che continuava a sostenere il primato dello stato rispetto al popolo (ed al
partito stesso), ma approvò ugualmente le ‘leggi di Norimberga’ (che nel 1935
cancellarono i diritti civili degli ebrei) ed accentuò addirittura il suo antisemitismo.
Nel 1936 sulla rivista delle SS fu tuttavia accusato di opportunismo e nel 1937 un
rapporto riservato del partito nazista tacciò la sua dottrina di ‘romanità’ (cioè, ancora
una volta, di riconoscere la preminenza dello stato): pur ormai marginalizzato dal
partito, Schmitt riconobbe tuttavia la necessità per la Germania di uno ‘spazio vitale’,
giustificò così l’espansionismo militaristico del Terzo Reich e sostenne la guerra
esaltando le vittorie di Hitler.
Arrestato dagli alleati nel 1945, fu internato in un campo di concentramento e nel
1946 fu imputato nel processo di Norimberga dove però riuscì a difendersi
dimostrando che i suoi scritti erano stati soltanto analisi teoriche.
Prosciolto dalle accuse, si ritirò a vita privata a Plettemberg, la sua città natale, dove
trascorse i suoi ultimi quarant’anni di vita.
28
I
In questa sede quel che interessa della vastissima produzione di Schmitt è ciò che
riguarda la sua riflessione sulla guerra, e dunque non si può che partire da ‘Il concetto
politico’ (1927) in cui egli afferma che la politica non si fonda su principi e su valori
morali (del tutto trascurabili ed inefficaci), ma sulla fondamentale distinzione
amico-nemico: sulla scorta di Hobbes, anche Schmitt ritiene infatti che gli uomini
siano naturalmente aggressivi e pericolosi e che dunque il motivo decisivo per cui
essi si uniscono nello Stato (e diventano così amici) è la necessità di difendersi dagli
altri raggruppamenti umani (i, potenziali o reali, nemici).
Per Schmitt ‘la storia del diritto internazionale è una storia del concetto di guerra. Il
diritto internazionale non è altro che un ‘diritto di guerra e di pace’’: la politica nasce
insomma dall’antagonismo con l’altro, con lo straniero, ma naturalmente ciò non
significa automaticamente che tutti i conflitti debbano essere risolti con la guerra
visto che molti di essi possono essere risolti invece anche senza arrivare allo
spargimento di sangue.
Sulla scorta di Hegel, Schmitt afferma inoltre che l’entità politica fondamentale,
sovrana e con la quale si identifica il popolo, è lo Stato, superiore a ogni altra
aggregazione politica o sociale che come tale può esistere solo al suo interno: ogni
altro raggruppamento (classi, gruppi sociali antagonistici, partiti, associazioni, ecc.)
possono dunque esistere ed agire solo finchè non mettono in pericolo l’ordine legale e
politico stabilito dello Stato.
Il ruolo ed il compito fondamentale dello Stato è garantire ordine e sicurezza ed è per
questo che è nato: sovrano è colui che ha il potere di stabilire chi è amico e chi è
nemico e quindi solo lo Stato può determinare chi è il nemico (e promuovere la
guerra).
Il potere dello Stato è insomma il potere originario e solo allo Stato appartiene
dunque lo ius belli: esso organizza gli amici per affrontare la minaccia proveniente
dai nemici.
Le decisioni a livello internazionale sono decisioni di guerra perché in definitiva tutte
si risolvono sempre sullo stabilimento di chi è amico e di chi è nemico: un mondo da
cui fosse esclusa la possibilità della guerra sarebbe privo allora della distinzione
amico-nemico e quindi della politica stessa.
In casi estremi lo Stato può poi stabilire se c’è e chi è un nemico interno, cioè
dichiarare che c’è un gruppo che minaccia l’esistenza dello Stato stesso, e adottare
quindi tutte le misure necessarie: nel caso in cui il contrasto amico-nemico interno
allo Stato degenerasse in conflitto armato fra gruppi, allora lo Stato non sarebbe più
l’entità politica superiore e ne seguirebbe la guerra civile nella quale ogni gruppo
farebbe valere una propria distinzione amico-nemico.
Si comprende dunque perché quando nel 1933 il partito nazista si impadronì del
potere Schmitt accettò il nuovo regime come legittimo e celebrò Hitler come Führer,
capo e guida della nazione e responsabile di tutte le decisioni: l’unità dello Stato era
stata salvata dalla guerra civile e c’era un sovrano che poteva decidere chi era amico
e chi era nemico.
29
II
Questa gestione e questo appannaggio della guerra da parte dello Stato si erano
tuttavia affermati piuttosto di recente.
Secondo Schmitt infatti fu con la pace di Westfalia (che nel 1648 concluse la guerra
dei Trent’anni) che venne finalmente abbandonato il concetto medievale della guerra
‘giusta’, cioè della guerra che doveva avere una ‘giusta causa’ se voleva essere
legittima: era questo un principio di chiaro sapore religioso (cristiano) che cercava di
giustificare in senso morale il ricorso alla violenza ed all’uccisione e di risolvere così
un evidente e grave problema di coscienza.
La guerra dei Trent’anni era stata una guerra terribile e devastante nella quale era
morto almeno 1/3 della popolazione tedesca: ancor oggi è considerata l’ultima guerra
di religione ed i contemporanei evidentemente pensarono che non si poteva
continuare a lasciar gestire le guerre a chi, proclamandosi dalla parte del giusto, di
conseguenza non poneva e non trovava limiti alla sua ansia di annientare il nemico e
si sentiva così legittimato a perpetrare i peggiori eccessi - con prevedibili e gravissimi
risultati.
Dopo Westfalia la direzione e la gestione della guerra passò così nelle mani dello
Stato che abbandonò la pericolosissima pretesa che una guerra per essere combattuta
doveva essere ‘giusta’: le guerre divennero affari di Stato e vennero combattute fra
Stati che non dovevano dare spiegazioni a nessuno (ognuno aveva ovviamente le sue)
se e quando decidevano di entrare in guerra.
Per Schmitt questo passaggio fu un vero e proprio ‘capolavoro della ragione umana’
che produsse il ‘miracolo’ di far cessare le guerre di sterminio perché la guerra
cominciò allora ad essere finalmente condotta con razionalità e non con la pretesa di
trovarsi dalla parte del bene contro il male: il nemico, anche se sconfitto, veniva
rispettato perché ogni Stato accettava l’esistenza degli altri Stati cui riconosceva pari
dignità alla propria.
Dopo Westfalia lo Stato gestì la guerra come un suo problema e, appunto, come un
suo affare, agendo di conseguenza con sensatezza: la guerra divenne sobria ed
equilibrata perché cominciò a seguire il rapporto costi/benefici e a riflettere sugli
scopi da raggiungere e sui mezzi che era più sensato adottare per conseguirli.
André Glucksmann (‘La force du vertige’, parte VII) analizzò il passaggio dal
concetto di guerra giusta a quello di guerra moderna dal punto di vista filosofico e
non più da quello storico come aveva fatto Schmitt: secondo il filosofo francese
furono infatti i ‘giuristi classici’ che ‘inventando un diritto di guerra che chiamarono
naturale’ abbandonarono il ‘concetto cristiano di guerra giusta … di millenaria durata
(da sant’Agostino ai discepoli di san Tommaso d’Aquino)’ e così facendo operarono
un vero e proprio (felice e fruttuoso) capovolgimento dell’impostazione del
problema, una vera e propria benefica rivoluzione filosofica.
I filosofi giusnaturalisti del XVII secolo (Grozio, Bodin, Montaigne, Gentili,
Pufendorf) si accorsero infatti che ‘pretendendo di regolare la nostra condotta pratica
sulle massime non equivoche di un Bene universalmente valido, sbagliamo. Nella
30
peggiore delle ipotesi prigionieri di un qualunque fanatismo. Nella migliore, nei
problemi di coscienza, vissuti come deliziosamente insolubili’ e così abbandonarono
decisamente tale impostazione (cristiana) stabilendo che ‘il diritto è il buon diritto
non perché è il diritto del Bene … ma perché limita il potere del male’: ‘il diritto
definisce la giustizia in senso negativo, esso non dice ciò che conviene fare … ma
qualifica ciò che deve essere evitato’ e insomma il diritto naturale dei classici è
negativo nel senso che non mira ad un bene da raggiungere, ma a un male da limitare:
‘per il classicismo europeo la lotta per la giustizia è la lotta contro l’ingiustizia’.
Così anche ‘le guerre devono essere negativamente giuste’ e ‘finite le guerre sante, il
solo diritto alla guerra è quello di difendersi’: anche ‘la pace si presenta ‘negativa’
come assenza di guerra’.
Come si vede, Glucksmann completa e rafforza il discorso di Schmitt mostrando
l’aspetto filosofico della svolta operata dopo Westfalia: il giusnaturalismo (o
classicismo) dell’età moderna nacque precisamente per chiudere l’epoca delle guerre
di religione e per trovare un altro fondamento alla convivenza civile in Europa.
Lo stato e la sua diplomazia si affermarono così come conquiste laiche e razionali che
dovevano porre un freno al dilagante fanatismo religioso ed alle sue inquisizioni e
montagne di cadaveri, ma secondo Glucksmann la crisi e l’abbandono di questa felice
filosofia classica si verificarono purtroppo già il secolo successivo, quando i
‘nostalgici di una definizione ‘positiva’ del bene comune, dell’intesa e della pace
cosmica’ riuscirono a riprendere la direzione del pensiero europeo.
Mentre ‘il diritto classico … mirava a colpire lo slancio del fanatismo tagliandone le
radici persuasive che lo nutrivano’ e i classici ‘non si affaticavano in dispute sul bene,
a loro bastava esporre minutamente i mali con scrupolosa distinzione’, già alla fine
del Settecento invece ‘buoni apostoli vennero … ad insegnare come saltare
matematicamente, dialetticamente o religiosamente gli abissi [che il diritto naturale
aveva] svelato insorpassabili’: nuove filosofie proposero motivi e contenuti per agire
in vista di scopi e valori ultimi ed indiscutibili … e in questo modo si ripropose
dunque anche la guerra giusta con tutta la ferocia del fanatismo: ‘si annuncia[ro]no
… la pace definitiva – fondata su una benevolente ‘legge di natura’ e sull’Amore per
il genere umano – e le guerre dichiarate ‘definitive’ perché lasciate alla loro palese
inumanità’.
III
Per Schmitt invece questo miglioramento, questa limitazione, questa
razionalizzazione e questa vera e propria umanizzazione della guerra, vera conquista
della civiltà europea, venne negata e messa in crisi molto più tardi della rivoluzione
francese, e precisamente dalla dichiarazione di guerra del presidente statunitense
Wilson il 2 aprile 1917.
Wilson infatti giustificò l’entrata degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale
affermando che la guerra navale della Germania era una guerra indiscriminata contro
tutti, insomma ‘contro l’umanità’, e che dunque la Germania era nemica del genere
umano: secondo Schmitt con questa presa di posizione Wilson negò che la guerra in
31
corso fosse una ‘normale’ guerra fra Stati e, attribuendo a se stesso il diritto di
stabilire in modo assoluto chi aveva ragione e chi aveva torto, di fatto reintrodusse il
concetto di guerra ‘giusta’, additando la Germania come il nemico universale che
stava dalla parte del male contro il bene.
Nasceva (o rinasceva) il concetto discriminatorio di guerra che, discriminando
appunto fra i partecipanti allo scontro e rifiutando una ‘valutazione paritaria di
entrambi i contendenti’, faceva sì che il nemico non poteva più essere rispettato
perché combatteva (o aveva combattuto) dalla parte sbagliata ed era quindi solo un
criminale: la guerra assumeva così i caratteri della crociata sovrastatale e
sovranazionale.
Secondo Schmitt una svolta così profonda nel concetto di guerra non si era certo
prodotta improvvisamente ed era invece prosecuzione e conseguenza di quella
politica di espansione universalistica degli USA i quali, abbandonata la ‘dottrina
Monroe’ del 1823 (‘l’America agli americani’, cioè il riconoscimento del proprio
ruolo in uno spazio definito), fin dalla fine dell’Ottocento con la guerra ispanoamericana e poi con la presidenza di Theodore Roosevelt si erano arrogati il potere ed
il diritto di stabilire - per tutti! - dove stava la giustizia nelle controversie
internazionali e quindi la conseguente pretesa di essere legittimati ad intervenire
dovunque nel mondo.
Wilson faceva compiere a questa nuova strategia americana per l’egemonia planetaria
un poderoso passo avanti: egli giustificava il progetto imperiale degli USA
radicandolo in valori e principi universali di cui essi si autoproclamavano portatori ed
interpreti e di cui pretendevano di avere il monopolio (!).
Tutto ciò implicava evidentemente che la guerra non era più regolabile e regolata
dagli Stati, che l’Europa perdeva il suo ruolo centrale nella storia del mondo e,
soprattutto, che grazie al concetto di guerra ‘giusta’ le ragioni degli Stati e dei loro
popoli non contavano più di fronte all’unica verità annunciata da Washington: la
vecchia Europa doveva cedere il passo alla giovane e scalpitante nuova America
portatrice di una giustizia che si pretendeva universale e al di sopra di tutti, ma che in
realtà esprimeva la volontà americana di conseguire un vero e proprio dominio
planetario.
Per il momento tuttavia Wilson non riuscì nel suo intento: nel 1937 Schmitt scrisse
infatti che ‘Se di fronte a tali pretese giuridiche globali si verificasse … il caso di una
guerra mondiale totale contro un avversario sufficientemente forte che conduce una
guerra ‘ingiusta’, allora questo Stato, con la forza della sua resistenza, imporrà il
mantenimento del vecchio concetto di guerra, ovvero la non discriminazione
giuridica’ e proprio questo era successo nella ‘guerra mondiale del 1914-1918
condotta contro la Germania. Nonostante tutti i tentativi di trasformarla in una
‘esecuzione’ internazionale contro il governo tedesco, distinto dal popolo tedesco, e
nonostante tutte le altre discriminazioni contro la Germania, la guerra è comunque
rimasta, grazie alla resistenza del popolo tedesco, una guerra di tipo classico’.
32
IV
Nonostante ciò Wilson mantenne fede alla sua impostazione iniziale e pensò di aver
coronato il suo progetto di giustizia mondiale patrocinando a Versailles la nascita
della Società delle Nazioni, il nuovo organismo sovranazionale che aveva il compito
di dirimere le controversie internazionali e di imporre così la giustizia evitando le
guerre: tuttavia la Società delle Nazioni fallì miseramente e non è difficile
comprenderne il motivo.
Albert Einstein espresse in proposito tutto il suo più che motivato scetticismo
quando nel 1933 concluse che ‘questo tribunale internazionale [la SdN] è incapace di
far eseguire le sue sentenze, ed è grandemente soggetto al fatto di vedere sviate le sue
sentenze da pressioni di tipo extragiuridico. … Attualmente siamo ben lontani dal
disporre di una qualsiasi organizzazione sovranazionale in grado di conferire una
autorità incontestabile alle sentenze e di ottenere un’obbedienza assoluta
all’applicazione delle stesse’.
Sigmund Freud nello stesso anno concordò che ‘non c’è che un modo valido di por
fine alla guerra e questo è la creazione … di un controllo centrale al quale spetti
l’ultima parola di ogni conflitto di interessi. Per questo sono necessarie due cose:
primo, la creazione di questa corte suprema di giustizia; secondo, il conferimento ad
essa di una forza esecutiva adeguata. Se questo secondo requisito non si adempie,
anche il primo diventa inutile. … La Lega delle Nazioni … assolve la prima
condizione; ma non la seconda. Non ha alcuna forza a sua disposizione’.
I due grandi pensatori hanno evidentemente ragione e non desta così nessuna
meraviglia dunque che la Società delle Nazioni non potè fermare Hitler con le sue
continue violazioni dei trattati di pace né Mussolini quando invase l’Etiopia: con la
sua mancanza di forza essa avrebbe infatti potuto offrire soltanto copertura giuridica
a chi volesse intervenire - e nessuno allora volle farlo.
Norberto Bobbio (1909-2004) nel 1966 tornò sul problema ed individuò i punti
deboli della teoria della guerra giusta: secondo lui questa sarebbe il tentativo di
assimilare la guerra ad una sorta di procedura giudiziaria, la quale a sua volta consta
dei due processi di cognizione e di esecuzione della sentenza.
Ora, a proposito della cognizione è manifestamente impossibile assicurare la certezza
dei criteri di giudizio e l’imparzialità di chi giudica dato che ogni partecipante al
conflitto è in grado di motivare il suo comportamento e che nessuno può ergersi al di
sopra delle parti in lotta; circa l’esecuzione della sentenza (cioè una guerra) la
situazione è ancora peggiore perché un conflitto armato non si vince certo perchè si
ha ragione!
Tutto all’opposto, in realtà succede invece che mentre ‘una qualsiasi procedura
giudiziaria è istituita allo scopo di far vincere chi ha ragione … il risultato della
guerra è proprio l’opposto: è quello di dar ragione a chi vince’.
E non basta ancora perché mentre ‘lo scopo principale di una procedura giudiziaria
… è la restaurazione dell’ordine costituito … molto spesso … le guerre che appaiono
giuste all’opinione pubblica più avanzata non hanno affatto lo scopo di conservare lo
status quo, ma di sovvertirlo’ e ‘di fronte a una guerra concepita come rivoluzione la
33
distinzione fra guerre giuste e guerre ingiuste non ha più alcuna ragione d’essere: …
la rivoluzione è sempre, per definizione, ingiusta’ perché vuol cambiare proprio il
tipo di giustizia vigente!
V
Tornando comunque a Schmitt, risulta fin troppo facile contestarne la ricostruzione
storica: se infatti è vero che con Westfalia nacque in Europa la diplomazia e che gli
Stati presero a gestire la guerra come un loro affare (spesso per affermare la propria
potenza) spogliandola dalle motivazioni religiose (che accendendo gli animi fino al
fanatismo la rendevano particolarmente sanguinosa) Schmitt assolutizza però questa
svolta e la carica di significati davvero eccessivi trascurando (incredibilmente) tutta
una serie di eventi che smentiscono apertamente le sue affermazioni.
Dopo Westfalia le continue guerre di Luigi XIV, lungi dall’essere moderate e
contenute, sottoposero infatti l’Europa a sfibranti sacrifici e, se le guerre di
successione che caratterizzarono il Settecento furono effettivamente limitate, non
importa certo scomodare von Clausewitz per riconoscere (come fa Glucksmann) che
quelle napoleoniche furono invece dei veri cataclismi che imposero alla conduzione
della guerra un ritmo, un passo ed una scala tali che stupirono ed atterrirono i
contemporanei che dovettero ben presto imparare ad adattarsi a questo nuovo corso
bellico.
Le guerre dell’Ottocento furono sicuramente meno numerose e più contenute, ma gli
orrendi carnai della prima guerra mondiale non possono certo essere imputati agli
Stati Uniti né alla loro pretesa di essere i portatori della guerra ‘giusta’!
Oltretutto, dopo la sua conclusione gli Stati Uniti si ritirarono entro i loro confini e,
pentiti di essere intervenuti nel 1917, non entrarono nemmeno nella Società delle
Nazioni (voluta da Wilson!) e seguirono una politica isolazionista - comportamento
questo ben diverso, anzi opposto, alle intenzioni che invece Schmitt attribuisce loro
con così tanta convinzione ed efficacia.
Gli USA furono poi trascinati nel secondo conflitto mondiale di cui non erano certo
responsabili mentre le raccapriccianti montagne di cadaveri, la Shoah, gli spaventosi
annientamenti di paesi e città, le distruzioni senza fine e tutti gli inenarrabili orrori di
quel conflitto sono evidentemente da attribuire soprattutto al Terzo Reich ed ai suoi
alleati e non certo alla guerra discriminatoria degli USA!, ma Schmitt – lungi dal
condannare uno scempio di queste dimensioni o rivedere le sue posizioni - si esaltò
addirittura per le vittorie di Hitler e dopo il 1945 non si sarebbe mai pronunciato sul
nazismo (!) nei quarant’anni che visse ancora.
Vien da chiedersi insomma che senso ha perdere tempo a commentare e a criticare
una ricostruzione così mal fatta e così palesemente lacunosa e contraddittoria, e la
risposta è che, nonostante tutto, Schmitt ha invece anche qualcosa di importante da
dire.
34
VI
Innanzitutto va rimarcato che anche Schmitt riconosce, anzi, dà addirittura per
scontato, che la guerra non si può eliminare e che dunque è costruttivo ed
opportuno prevedere un sistema che, senza la pretesa di cancellarla, sia però in grado
di limitarla, razionalizzarla e umanizzarla: Sun Tzu sarebbe stato sicuramente
d’accordo, visto che anche lui con la sua antica sapienza aveva raccomandato di
evitare al massimo i maltrattamenti, le distruzioni e le uccisioni perché inutili ed anzi
controproducenti, mentre von Clausewitz sicuramente no, visto che per lui scopo
della guerra era l’annientamento puro, semplice e radicale del nemico.
VII
Il valore e l’interesse dell’analisi di Schmitt risiedono però soprattutto nella lucidità
con cui egli riuscì a prevedere ed a mettere a fuoco la logica del nuovo imperialismo
americano, quella vera e propria vocazione messianica con cui dopo la seconda
guerra mondiale gli USA giustificarono la loro crescente penetrazione in ogni angolo
del pianeta in cui poterono, riuscirono e pretesero di essere presenti e sempre
legittimati ad intervenire.
Per comprendere l’analisi di Schmitt bisogna così tornare alla proclamazione da parte
di Wilson della nuova politica bellica (discriminatoria) e, soprattutto, a quel suo
sviluppo e coronamento che fu la Società delle Nazioni.
A prima vista lo scopo della Società delle Nazioni era il migliore che si potesse
immaginare - impedire la guerra - ma nella realtà le cose stavano in modo differente,
anzi opposto: questo alto consesso sovranazionale che pretendeva di bandire la guerra
e di pronunciarsi sulle controversie internazionali che intendeva risolvere in base agli
alti ideali e principi di giustizia, mancava infatti di un giudice e gli Stati Uniti
arrogarono a sé questo ruolo (come Wilson già aveva fatto chiaramente intendere
motivando nel modo che si è visto l’entrata in guerra degli USA).
Sempre in base alla logica della guerra discriminatoria, a Versailles (Wilson
partecipò alle trattative di pace dall’inizio alla fine) la guerra d’aggressione (tedesca)
fu definita ‘crimine internazionale’ e furono i delegati americani che chiesero la
consegna dei suoi responsabili perché venissero processati, appunto, come criminali
di guerra (esattamente come sarebbe avvenuto ventisei anni dopo a Norimberga e a
Tokyo).
All’opposto di quando le guerre erano regolate dagli Stati, ora i responsabili di una
guerra dichiarata illegale non avevano infatti più giustificazioni né diritto ad alcun
tipo di protezione - e nel 1946 l’ONU avrebbe definitivamente ratificato questo
nuovo concetto di guerra.
Dopo un inizio simile Schmitt previde allora che in futuro sarebbe stata proprio
questa la logica e la giustificazione dell’imperialismo americano che vide profilarsi
con chiarezza all’orizzonte: una volta autodefinitisi giudici supremi del bene e del
male, essi sarebbero stati ipso facto ingiudicabili ed avrebbero preteso di imporre
ovunque la loro giustizia dei vincitori.
35
Schmitt riteneva che solo gli Stati potessero gestire la guerra in forma responsabile e
che dunque si sarebbe dovuto lasciarla nelle loro mani: strappargliela per affidarla ad
organismi sovranazionali (di fatto agli USA) significava annullarli in quanto tali e
trasformare così la guerra in una ‘guerra civile mondiale’ in una situazione di
incontrollabile anarchia generalizzata.
Schmitt previde insomma l’avvento di ‘guerre globali’ che non sarebbero potute
essere che di annientamento del nemico, incarnazione del torto e del male contro i
portatori (gli Stati Uniti) del giusto e del bene: secondo lui le guerre del futuro
sarebbero state ‘totali’ ma, per quanto devastanti, queste guerre sarebbero state
definite ‘giuste’ ed anzi ‘umanitarie’ perché condotte contro i nemici dell’umanità,
verso i quali ovviamente non ci sarebbe più potuta essere alcuna forma di rispetto.
Non ci sarebbe stato più posto per gli Stati e per le loro ragioni nè gli Stati avrebbero
gestito più le guerre in base ad un principio di reciprocità (riconoscendo cioè i motivi
di ogni contendente).
Schmitt vide giusto e la sua teoria è ancor oggi pienamente valida.
La strabordante potenza industriale ed economica degli Stati Uniti richiese che la loro
presenza si estendesse senza limiti e fornì loro i mezzi materiali e militari necessari
per realizzarla: ove le soluzioni ‘pacifiche’ non erano più sufficienti essi fecero (e
fanno) disinvoltamente ricorso alla guerra, ma la novità fu, appunto, che essi
presentarono (e presentano) tutte le loro guerre come combattute in difesa
dell’umanità e per il suo stesso bene.
Nella loro lotta al comunismo, al terrorismo, per l’affermazione della democrazia e
dei diritti civili, ecc., gli Stati Uniti hanno sempre ripetuto che ciò che li guidava (e li
guida) era (ed è) una vera e propria missione per il bene comune (che – guarda caso!
– coincideva coi loro interessi): le guerre degli USA sono state (e sono) tutte
‘umanitarie’, combattute cioè per il bene dell’umanità intera, ma Schmitt aveva già
denunciato per tempo che ‘l’intervento umanitario … ‘denazionalizza’ la guerra,
ovvero … abolisce la guerra tra Stati per ‘internazionalizzarla’, e cioè per
trasformarla in una guerra civile.’
Perché gli Stati Uniti potessero perseguire una politica simile fu necessario che
nascessero e si affermassero istituzioni sovranazionali (come la Società delle Nazioni
e poi l’ONU) all’interno ed in nome delle quali essi si arrogarono il diritto di stabilire
cos’era giusto e cos’era sbagliato, spogliando così gli Stati della gestione autonoma
dei loro affari e, soprattutto, della guerra: nel 1937 Schmitt scrisse così che ‘il
concetto discriminatorio di guerra … viene istituzionalizzato con l’ausilio della
distinzione, propria della Società delle Nazioni, tra guerre lecite e guerre illecite: in
questo modo si giunge a scardinare l’ordinamento internazionale finora vigente, ma
… così viene soltanto avanzata una nuova pretesa di dominio mondiale’.
Una volta stabilito ed imposto il concetto di guerra ‘giusta’ per gli Stati Uniti fu
infatti facile impadronirsene ed impiegarlo per assumere il ruolo di portatori del bene
contro il male ed isolare e screditare così il nemico di turno, colpirlo, sconfiggerlo e
magari farlo processare da una corte internazionale una volta fatto prigioniero.
Nel mio ‘Stati Uniti d’America: espansione ed imperialismo di una democrazia in
armi’, parte terza e quarta (cui si rimanda) sono state ripercorse le tappe di questa
36
nuova politica medievale in cui gli USA hanno sempre preteso (e pretendono) di
essere i giudici supremi ed inappellabili, naturalmente a loro volta ingiudicabili (e da
chi?), sempre dalla parte della ragione e al di sopra di ogni sospetto.
Per il trionfo del loro programma di affermazione planetaria essi dovettero scontrarsi
a lungo con l’URSS e col comunismo, sconfitto il quale hanno proceduto ancora più
speditamente rifiutando sempre di porsi sullo stesso piano dei loro nemici di turno
fino ad arrivare a chiamarli ‘impero del male’, ‘asse del male’ ed a stilare addirittura
elenchi di ‘stati-canaglia’ che bisognava estirpare dalla comunità internazionale per il
suo stesso bene.
Schmitt comprese con grande anticipo questo unilateralismo americano, questa
pretesa di una loro indiscutibile superiorità morale, questa svolta nel concetto stesso
di guerra che egli chiamò ‘guerra discriminatoria’ (o ‘concetto discriminatorio di
guerra’) perché, appunto, il nemico non veniva più riconosciuto come tale, ma
discriminato, squalificato ed accusato in modo inappellabile di essere un criminale
che andava definitivamente e semplicemente distrutto: una volta confermato questo
principio, strappata cioè la guerra dalla gestione degli Stati, essa ha perso così ogni
reciprocità, i contendenti non sono più posti sullo stesso piano e verso di loro non c’è
più alcun rispetto.
A causa di questo ‘superamento del politico’ (la dissoluzione dello Stato) la guerra è
tornata così ad essere incontrollata e combattuta non fino alla sconfitta del nemico,
ma fino al suo annientamento: ‘la nozione di discriminazione … distrugge una teoria
ordinatrice del diritto internazionale … fino ad oggi [1937] efficace, senza che al suo
posto subentri qualcosa d’altro che sia alternativo a una pretesa universalistica che
distrugga Stati e popoli’.
Schmitt getta insomma luce sull’aspetto giuridico della nuova guerra americana ed
offre così una preziosa chiave di lettura dei tempi che stiamo ancor oggi vivendo: già
nel 1937 egli affermò che con il venir meno del freno degli Stati erano cadute le
barriere frapposte da questi alla hobbesiana guerra di tutti contro tutti così che oggi
‘si presenta … una nuova epoca storica, con nuove e più aspre guerre.’
Anonimous condivide pienamente l’analisi di Schmitt e usa parole di fuoco per
contestare questa politica nata con Wilson: ‘oggi [2004] non c’è dovere più grande
cui gli americani devono ottemperare per la loro nazione e per i loro posteri che
abbandonare finalmente il sordido lascito dell’internazionalismo di Woodrow Wilson
– che ha inzuppato il ventesimo secolo in molto o in più sangue di ogni altro ‘ismo’’.
Mao: la guerra rivoluzionaria di popolo
Una grande novità nella concezione e nella condotta della guerra venne inaugurata
nel XX secolo dai partiti comunisti dei paesi non-industrializzati quando stavano
ancora preparando la rivoluzione o lottando per la conquista del potere: si trattò della
‘guerra di popolo’ o ‘guerriglia’ che già in epoca moderna, nel 1808, era stata
intrapresa dagli spagnoli contro l’occupazione napoleonica del loro paese e di cui
parla anche von Clausewitz.
37
Chi esplicitò e teorizzò per primo le caratteristiche di questa guerra particolare fu
Mao Tse-tung (1893-1976) il grande capo della rivoluzione cinese, l’unificatore della
Cina, il suo liberatore dal dominio e dall’oppressione straniera, ma anche il folle
sanguinario fanatico che una volta al potere impose al suo paese le assurdità del
‘grande balzo in avanti’ e della ‘rivoluzione culturale’ che costarono alla Cina decine
di milioni di morti, arretratezza, fame, miseria e la spietata dittatura del suo
comunismo radicale e allucinatorio.
Solo alla sua morte la Cina potè cominciare a rimettersi sulla strada della razionalità
iniziando così quello straordinario corso che oggi l’ha resa il gigante con cui tutti
devono fare i conti.
In questa sede verranno esaminate la tattica e la strategia della guerra di popolo che
Mao seppe teorizzare e dirigere fino al completo successo finale.
I
Il 18 settembre 1931 il Giappone iniziò la sua facile invasione della Manchuria (la
grande regione all’estremo nord-est della Cina) che ben presto trasformò nello statofantoccio del Manchukuò e dove potè così instaurare una politica di rapina e di
sfruttamento: in quel periodo il PCC era stato marginalizzato e ridotto a mal partito
dal Kuomintang (il partito nazionalista al potere) di Chiang Kai-shek che, dopo
averlo espulso fin dal 1927 dalle città, stava conducendo massicce campagne di
accerchiamento per annientarlo anche nelle campagne.
Riconoscendo di non poter resistere alla quinta campagna di accerchiamento, Mao
dall’ottobre 1934 al luglio 1935 guidò i suoi seguaci nella ‘lunga marcia’ (12mila
km.) fino alla periferica regione settentrionale dello Shaanxi, ma proprio allora, di
fronte all’aggravarsi della situazione in Europa in seguito all’ascesa di Hitler e del
nazismo, al VII Congresso del Comintern (l’Internazionale Comunista) Dimitrov
lanciò la nuova strategia dei Fronti Popolari.
Abbandonando la dissennata logica del ‘socialfascismo’ secondo cui i comunisti
erano contro tutti gli altri partiti (dai socialisti ai fascisti!) ora l’Internazionale
rovesciava completamente questa sua impostazione e proponeva invece l’alleanza dei
comunisti con tutti gli antifascisti in funzione, appunto, della lotta al nazifascismo:
Mao aderì subito a questa nuova linea e si alleò al Kuomintang per combattere contro
il Giappone che, dopo l’incidente del ponte Marco Polo (7 luglio 1937), diede inizio
all’invasione della Cina anche a sud della Grande Muraglia.
Oltre a ciò, Mao e il PCC vollero costruire un polo alternativo a quello del
Kuomintang per collegare, unire e dirigere tutti coloro che erano disposti a resistere
all’invasore ben comprendendo che ‘la chiave per guidare la guerra nazionale
rivoluzionaria anti-giapponese fino alla vittoria è spiegare, applicare e sostenere il
principio ‘indipendenza ed iniziativa [del PCC] all’interno del fronte unito’.’
Così contro gli invasori giapponesi i nazionalisti e i comunisti combatterono due
guerre largamente distinte e separate, ma mentre il Kuomintang aveva dalla sua lo
stato e l’esercito regolare, Mao, i comunisti e i loro alleati potevano contare solo sui
38
loro militanti e sul sostegno (più o meno volontario) che potevano ottenere dagli
abitanti delle zone da loro ‘liberate’.
La tattica e la strategia rivoluzionaria della guerra di popolo nacquero dunque in una
situazione disperata, quando era il popolo stesso che doveva organizzarsi per resistere
all’invasore.
II
Per affrontare il temibile e spietato esercito giapponese quello del Kuomintang, pur
forte di 2 milioni di uomini, non era assolutamente sufficiente mentre le truppe dei
comunisti di Mao, limitate di numero e male armate, erano un esercito solo di nome:
sulla carta dunque il Giappone sembrava destinato alla vittoria, ed infatti potè
avanzare velocemente ed occupare città e zone industriali (macchiandosi di atroci
brutalità), eppure Mao riuscì ad individuare la strategia e la tattica giuste per resistere.
Mao riconobbe la chiave del successo nella mobilitazione rivoluzionaria del popolo e
nel suo coinvolgimento nella lotta: la guerra di popolo che Mao propose ed attuò si
fondeva ed era tutt’uno con la rivoluzione tanto che per tutta la durata
dell’occupazione giapponese i suoi rapporti col Kuomintang furono sempre tesi, ed
anche conflittuali, pur nella comune lotta contro l’invasore.
La guerra rivoluzionaria di popolo non era una guerra tradizionale (come quella che
combatteva il Kuomintang) non solo per i mezzi che impiegava, ma anche e
soprattutto perché faceva parte invece della rivoluzione stessa: mentre infatti il
difensore in una guerra tradizionale (come quella combattuta dal Kuomintang) vuole
semplicemente respingere l’invasore e tornare così alla situazione (più o meno)
precedente, la guerra di popolo punta al contrario anche al rovesciamento del vecchio
regime e dunque vede la sconfitta dell’invasore come un momento ed un passaggio
nella generale e ben più complessa strategia rivoluzionaria.
Ciò era d’altra parte inevitabile: il coinvolgimento dell’intera società nella guerra e la
richiesta dei pesantissimi sacrifici e delle mille sofferenze che questo comportava non
potevano non prevedere anche una radicale trasformazione dell’intero assetto sociale.
Questa linea politica venne chiaramente spiegata da Mao e rispondeva in pieno alla
sua rivisitazione della filosofia dialettica (vedi la mia ‘La filosofia della storia di
Mao’) secondo la quale c’è un ordine di priorità e una tempistica diversa nella
risoluzione delle varie contraddizioni che nel tempo muovono la storia ed agitano la
società e che possono essere risolte solo una alla volta.
III
‘Il partito [comunista cinese] partì dal presupposto che la Cina aveva la forza per
resistere all’aggressione e che alla fine avrebbe trionfato. La sorgente ultima di questa
forza era il vasto numero della popolazione’ (e, va aggiunto, anche la vastità stessa
del territorio cinese) e dunque ‘solo mobilitando ed organizzando la popolazione la
Cina avrebbe potuto resistere al potente nemico’.
39
Era così necessario creare ampie ‘zone libere’ e liberate alle spalle ed ai fianchi
dell’esercito giapponese che avanzava e da qui organizzare una guerriglia mobile per
insidiarlo, disarticolare le sue linee di comunicazione e sorprenderlo ogni volta che se
presentassero le condizioni: nelle zone libere poi andava intrapresa tutta una serie di
riforme che cominciassero ad intaccare le struttura ancora semi-feudale della Cina e
migliorassero le condizioni dei contadini.
Come si è detto, resistenza e rivoluzione erano due momenti della stessa azione
politica.
Mao affermò che ‘nonostante avesse grandi capacità militari, il Giappone era un
paese relativamente [alla Cina] piccolo, scarso di risorse umane e di risorse belliche,
finanziarie e materiali, e non poteva sopportare una lunga guerra’ (e previde
facilmente che la guerra sarebbe stata lunga).
‘Avendo truppe in numero limitato, i giapponesi potevano controllare solo le città e le
linee di comunicazione, mentre nella vasta campagna e nei piccoli paesi il loro
dominio era debole’: così per quanto avanzasse, vincesse battaglie ed occupasse città
e aree industriali, l’esercito giapponese si trovò sempre di fronte quello regolare
cinese del Kuomintang mentre da ogni lato le formazioni partigiane comuniste (o
guidate dai comunisti) gli impedivano di consolidare veramente le sue conquiste e le
zone libere e liberate crescevano di numero ed in estensione rendendo le truppe
comuniste sempre più forti e con ranghi sempre più folti.
E’ ovvio che ciò comportò frequenti ostilità dei comunisti con il Kuomintang che
mentre era costretto a ritirarsi davanti ai giapponesi comprendeva bene che i suoi
‘alleati’ stavano portando avanti la rivoluzione anche contro di lui: non mancarono
così gli scontri e gli attacchi al PCC ma l’emergenza della guerra contro il Giappone,
volenti o nolenti, non poteva non avere la precedenza.
Il Giappone fu sconfitto ed espulso, dopo altri quattro anni di guerra civile il
Kuomintang fu a sua volta sconfitto ed espulso e Mao potè fondare la Repubblica
Popolare Cinese.
L’esempio cinese sarebbe stato seguito in Europa nella Resistenza alle occupazioni
del nazifascismo e soprattutto in Asia, in Africa e in America Latina, continenti in cui
la guerriglia sarebbe diventata spesso un fenomeno endemico e si sarebbe sostituita
alla guerra tradizionale travagliando per anni e anni interi stati e aree geografiche:
quando il nemico che si vuole abbattere è troppo forte in campo aperto è questa infatti
l’unica opzione praticabile.
Sulla guerra rivoluzionaria di popolo ci sono da fare però almeno due considerazioni.
IV
Innanzitutto è evidente che la guerra rivoluzionaria di popolo si fonda e presuppone il
(più o meno) convinto sostegno e la (più o meno) decisa partecipazione della società
civile alla lotta: Mao afferma che il partigiano deve potersi muovere fra la
popolazione civile come il pesce nell’acqua, ma ciò comporta costi umani spaventosi
perché l’invasore si sente costantemente in mezzo al nemico e sa che per isolare e
battere i guerriglieri deve far terra bruciata intorno a loro.
40
La guerra rivoluzionaria di popolo coinvolge completamente la popolazione civile
che inevitabilmente subisce ogni sorta di violenze, di devastazioni e di uccisioni: chi
si pone sulla strada della guerra rivoluzionaria di popolo sa che questo popolo sarà
chiamato a pagare un altissimo tributo di sangue, un costo che non sarà possibile
risparmiargli.
Data la situazione disperata in cui si trova un popolo quando è invaso, è più che
comprensibile che questo raccapricciante prezzo venga giudicato inevitabile e,
oltretutto, in Cina i giapponesi ricorsero fin dall’inizio a comportamenti di incredibili
ferocia e brutalità (che raggiunsero l’apice nell’infernale ‘stupro di Nanchino’), ma in
nessuno degli scritti di Mao si trova traccia di questo aspetto della guerra
rivoluzionaria di popolo e questo silenzio rivela quanta indifferenza egli provasse per
i costi umani della rivoluzione.
Né fu il solo: le guerre condotte per l’affermazione del comunismo sono state tutte
combattute senza riguardo alcuno per le perdite e per le sofferenze della società civile
ad ulteriore testimonianza dell’assoluta convinzione e dell’inflessibile determinazione
che animavano i rivoluzionari.
Non c’è quindi da stupirsi se una volta al potere i comunisti continuarono a non
tenere in alcuna considerazione le vite dei loro concittadini, sia in guerra sia nella
costruzione della nuova società per la quale evidentemente nessun prezzo da pagare
era ritenuto troppo alto.
V
Altro aspetto fondamentale della guerra rivoluzionaria di popolo è che essa è riuscita
a vincere con le sue sole forze soltanto a Cuba negli anni Cinquanta del secolo
scorso: in tutti gli altri casi essa ha potuto avere successo perché era condotta
nell’ambito di una guerra tradizionale in cui due eserciti si scontravano.
Se i giapponesi non fossero stati impegnati contro il Kuomintang e poi contro gli
Stati Uniti (e l’Inghilterra) Mao e i comunisti (aiutati e sostenuti per di più
dall’Unione Sovietica) non avrebbero mai potuto vincere e questo vale per la
Resistenza antinazifascista e per ogni altra guerra rivoluzionaria di popolo a partire
da quella spagnola contro Napoleone: la guerriglia può tormentare un esercito
invasore e creargli in vuoto intorno ma quest’ultimo può essere veramente sconfitto
solo da un altro esercito (come già von Clausewitz aveva riconosciuto).
Ciò non significa tuttavia che la guerra rivoluzionaria di popolo non sia
ugualmente importantissima perché essa come si è già visto è in realtà una fase e un
momento imprescindibile della rivoluzione: essa prepara il popolo alla rivoluzione,
lo educa alla lotta, lo organizza in forme nuove, lo tempra e ne seleziona la classe
dirigente per il nuovo corso storico che intende affermare.
L’Europa post-bellica uscì trasformata dalla Resistenza in senso politico, morale,
civile, in una parola, spirituale, ma i partigiani non avrebbero mai potuto sconfiggere
gli eserciti del nazifascismo con le loro forze militari così risicate e limitate.
41
La guerra rivoluzionaria di popolo segna dunque un momento di altissima elevazione
del popolo che l’intraprende e che merita il pieno riconoscimento del suo vero e
proprio eroismo, ma solo un esercito può sconfiggere un altro esercito.
La guerra assurda
Come risulta anche dal mio ‘Stati Uniti d’America: espansione ed imperialismo di
una democrazia in armi’ (parte terza e quarta) nell’era atomica la guerra è diventata
assurda, un vero rompicapo logico la cui soluzione è impossibile e che ha reso
paradossale la storia dell’ultimo mezzo secolo.
I termini del problema sono notissimi: una guerra termonucleare può portare alla
completa estinzione dell’umanità e questa novità (assoluta in tutta la storia del
mondo!) ha condotto a tutta una serie di contraddizioni.
Questa guerra infatti non può essere combattuta perché la sua escalation
porterebbe all’estinzione del genere umano; in essa dunque non può esserci un
vincitore ed anche la superiorità assicurata dal ‘primo colpo’ durerebbe il brevissimo
lasso di tempo prima dell’immancabile, uguale e contraria ritorsione dell’aggredito.
Questo riconoscimento (addirittura banale) annulla d’un colpo tutto il pensiero
militare precedente sul senso, sul significato e sulle modalità della guerra, comprese
tutte le considerazioni possibili sui modi per conseguire la vittoria: il concetto stesso
di guerra atomica – una guerra che non si può nemmeno iniziare, nè combattere nè
tantomeno vincere - è illogicità pura.
Nonostante ciò, subito dopo la conclusione della seconda guerra mondiale le due
superpotenze (e non solo loro) si scatenarono ugualmente in una travolgente (e
costosissima) corsa agli armamenti nucleari che li moltiplicò a dismisura, tanto che
per cancellare l’umanità intera (e non solo lei) dalla faccia della Terra sarebbe bastato
l’impiego di una frazione sempre più piccola di tali ordigni: insomma, nel momento
in cui e perché le due superpotenze avevano raggiunto (e superavano continuamente)
un’immensa ed incalcolabile capacità militare fino a poco prima nemmeno
immaginabile, proprio per questo erano impossibilitate ad agire e rimanevano
paralizzate nel cosiddetto ‘equilibrio del terrore’ o ‘dissuasione’.
La pace era imposta alle due superpotenze nucleari dalla loro stessa forza per cui esse
potevano minacciarsi quanto volevano, aumentare fuori di ogni sensatezza le loro
armi nucleari, … tanto non potevano farvi ricorso!!!
Questa situazione, già di per sé così paradossale ed assurda, era poi resa (se possibile)
ancor più grottesca da altre due inevitabili conseguenze.
La prima era che, se USA e URSS non poterono scontrarsi direttamente, di fatto però
tutte le altre guerre gestite e/o sostenute da loro scoppiarono ugualmente e
continuarono ad essere combattute come prima, cioè con armi non-nucleari: dato
infatti che le armi nucleari non potevano essere impiegate era come se non
esistessero!
La seconda era che, oltre al fatto che un errore, un malinteso, un calcolo sbagliato, un
azzardo o la follia di qualche politico poteva pur sempre far scoppiare davvero la
42
guerra atomica e portare all’olocausto finale dell’umanità, i mezzi e gli strumenti per
la nostra estinzione erano minacciosamente branditi (ed aumentati) in continuazione:
l’umanità viveva insomma ‘sull’orlo dell’abisso’ e questo clima da fine del mondo
diffondeva un profondo, sottile e pervasivo sentimento di angoscia.
Questo sentimento di assurdo e di spaesamento, di incomprensibilità e di impotenza,
di vanità e di aleatorietà della vita a causa dell’onnipresente e continuamente
incombente minaccia nucleare è affine a quello esistenzialistico nei confronti
dell’esistenza umana stessa e dunque sono i parametri di questa corrente filosofica
quelli più utili ed adatti per comprendere e sentire la precarietà dell’era atomica.
I
Karl Jaspers (1883-1969), uno dei filosofi più rappresentativi dell’esistenzialismo,
lo riconosce con facilità: ‘La situazione originaria dell’uomo è che noi ci troviamo al
mondo, e non sappiamo di dove veniamo e dove andiamo. Questa situazione è resa
nota, diversamente da quanto prima lo fosse, con la possibilità dell’autodistruzione
totale.’
Nell’era atomica per toccare con mano l’impalpabilità dell’esistenza - con la morte
come suo momento più vero e caratterizzante – non è necessario leggere libri di
filosofia e riflettere sull’insostenibile leggerezza dell’essere, basta infatti rendersi
conto che sulla testa di ognuno pende una quantità di esplosivo capace di ucciderlo
molte volte e che capi politici lontani possono decidere in qualsiasi momento di
sganciarlo.
Ma il parallelismo fra esistenzialismo ed era atomica si spinge molto più avanti:
come noi nella nostra vita (inautentica, direbbe Heidegger) rifiutiamo di compiere
una riflessione totale su noi stessi e sulla nostra natura nè pensiamo alla (nostra)
morte, concentrati come siamo solo sul quotidiano e sulla vita di tutti i giorni, così
facciamo nei confronti della minaccia atomica: ‘come … il sano dimentica che deve
morire … forse così ci comportiamo anche noi di fronte alla bomba atomica’ perché
‘c’è il pericolo … che [questo pensiero] renda la vita insopportabile’ (esattamente
come quello della (nostra) morte!), così ‘non si vorrebbe neppure pensare un tale
pensiero’ ma ‘quale concetto volutamente cieco della vita! … è come seguire il
contegno dello struzzo’.
Tutto al contrario, secondo Jaspers se vogliamo invece operare per sperare di trovare
una qualche via d’uscita dalla minaccia atomica ‘la prima cosa da fare è oggi
accrescere l’angoscia … dei popoli perché cresca fino a diventare una potenza
sopraffacente … che produca uomini di stato ad essa adeguati’: ‘solo qualora la
coscienza del fatto nuovo giungesse ad influenzare la vita, anche la consueta politica
… potrebbe mutarsi in una nuova politica, all’altezza della minaccia distruggitrice’.
Forse la speranza di Jaspers venne almeno in buona parte realizzata perché se per un
certo periodo (come in generale a proposito dell’esistenza) anche in politica i pensieri
(ed i comportamenti) preferirono dimenticare l’abisso sul cui stretto bordo l’umanità
si trovava e si continuò a produrre armi nucleari ed a minacciarne l’impiego …
43
finalmente nei primi anni Settanta e soprattutto alla fine degli anni Ottanta le due
parti concordarono un massiccio ed impressionante disarmo.
Il motivo di questi trattati e di questa ritrovata razionalità era comunque semplice: si
erano prodotte troppe e costosissime armi che, inutili perché inutilizzabili, di
conseguenza erano diventate un peso ed un impaccio sempre più insopportabile!!!
Al giorno d’oggi comunque la minaccia atomica sembra svanita anche se il numero di
ordigni nucleari rimasto (e non solo agli USA e all’URSS) è più che sufficiente a
cancellare ancora varie volte l’uomo dalla faccia della Terra: l’assurdità dunque
continua (seppur su scala molto minore) e con essa quella di vivere come se tale
minaccia non ci fosse (o non ci fosse più) … e quella che forse essa non c’è e non c’è
mai stata per davvero visto che un’arma inutilizzabile in realtà non è nemmeno
un’arma!
In ogni caso riflettere anche per un attimo su tutte queste follie fa comprendere subito
che Jaspers ha sicuramente ragione quando riconosce che solo l’esistenzialismo può
esprimere tutta l’ assurdità dell’era e della minaccia atomica.
II
Martin Heidegger (1889-1976) inserisce la sua riflessione sull’era atomica nel più
ampio contesto della sua analisi, condanna e rifiuto della modernità - del resto uno
dei temi centrali di tutta la sua speculazione.
Secondo Heidegger l’Occidente ha smarrito se stesso (o, meglio, si è caratterizzato
come tale) fin da quando Platone e Aristotele hanno fatto trionfare la loro concezione
della metafisica distruggendone la corretta impostazione precedente: prima di loro
infatti la verità era consistita nell’alétheia, cioè nell’auto-disvelamento della realtà e
nel suo spontaneo rivelarsi all’uomo, mentre con Platone essa divenne la
conoscenza dell’oggetto da parte del soggetto (l’uomo).
Da allora questa contrapposizione soggetto-oggetto non avrebbe fatto altro che
svilupparsi dispiegandosi per tutta la storia della filosofia occidentale e culminando
nel pensiero moderno (soprattutto ad opera di Galilei) finchè con Hegel l’oggetto
stesso del pensiero divenne addirittura anch’esso pensiero: la realtà insomma era tale
in quanto posta dal soggetto ed essa così ne dipese sempre di più finchè Nietzsche
arrivò alla logica conclusione che allora era il soggetto (l’uomo o l’oltreuomo) a
creare (liberamente ed artisticamente) i valori e la realtà stessa.
Secondo Heidegger da Platone in poi scienza e tecnica procedettero dunque sul
binario della metafisica occidentale che fa della natura un oggetto-per-l’uomo, ma in
questo modo per 24 secoli l’Essere ed il suo senso andarono perduti: essi non vennero
più nemmeno immaginati da un pensiero che celebrava i suoi massimi trionfi nella
scienza (fondata sulla contrapposizione soggetto-oggetto) la quale a sua volta si era
venuta identificando sempre più con la tecnica, cioè con la capacità di agire da
padroni sulla natura e di trasformare il mondo a proprio piacimento.
Per secoli e secoli tutti i sempre più potenti ritrovati della scienza e della tecnica
(culminati nell’era atomica) sono stati ottenuti sviluppando sempre lo stesso
programma di dominio e di impossessamento della natura e le continuamente
44
nuove conquiste tecnologiche sono così solo sviluppi e conferme della medesima
impostazione metafisica, seppur su scala accresciuta ad ogni passo: anche USA e
URSS (Heidegger scriveva negli anni Cinquanta) non erano altro se non ‘sinistra
frenesia della tecnica scatenata e dell’organizzazione senza radici [nell’Essere]’.
Questo oblio dell’Essere ha sradicato l’uomo e l’ha gettato nel nulla angoscioso
della sua esistenza inautentica così che egli è ormai del tutto incapace ed
impossibilitato di trovare fini e valori per decidere e dirigere davvero il mondo.
Il pensiero è diventato ormai solo la serie di operazioni logiche per poter agire da
padroni sull’oggetto e nel vuoto angoscioso in cui si è ridotta l’esistenza dell’uomo,
perso nel nulla della sua inautenticità, non si medita più: in questo mondo dominato
dalla tecnica ‘l’uomo è ‘la più importante delle materie prime’’.
Nonostante tutta la volontà di dominio e di potenza esaltata, celebrata e pretesa
dall’uomo, è invece la tecnica che in realtà procede per conto suo a briglia sciolta,
liberamente e ciecamente: ‘la potenza della tecnica che dappertutto, ora dopo ora, …
incalza, avvince, trascina l’uomo di oggi [1955] … è cresciuta a dismisura e
oltrepassa di gran lunga la nostra volontà, la nostra capacità di decisione, perché non
è da noi che procede’.
‘Nessun gruppo di uomini … ha il potere di frenare o di dirigere il corso storico
dell’era atomica. … L’uomo dell’era atomica, allora, potrebbe trovarsi, sgomento e
inerme, in balia dell’inarrestabile strapotere della tecnica, e ciò accadrà senz’altro se
l’uomo di oggi rinuncia a gettare in campo, in questo gioco decisivo, il pensiero
meditante contro il pensiero calcolante’.
Questa per Heidegger è davvero una partita decisiva perché ‘questo calcolare domina
completamente la volontà’ nel senso che l’uomo, vagante nel nulla ed autosradicato
dall’Essere perché non medita più, non può dunque scegliere nulla, così che ogni
novità non può che seguire il corso, cieco e completamente irresponsabile, imposto al
mondo dalla tecnica: ‘si crede che i capi … si arroghino ogni cosa e dispongano tutto
secondo il loro capriccio. In realtà, essi sono la conseguenza necessaria del fatto che
… il vuoto [di Essere] … esige un unico ordinamento … In vista di ciò devono essere
predisposti e apprestati uomini che possano essere usati per la direzione’; ‘tutti i tipi
di stato sono solo uno strumento di direzione fra altri. Poiché la realtà consiste
nell’uniformità del calcolo pianificabile’, ciò ‘esclude anticipatamente che le
differenze dell’elemento nazionale e dei popoli siano ancora fattori essenziali’.
Ciò del resto non è una novità: ‘le ‘guerre mondiali’ e il loro carattere di ‘totalità’
sono già conseguenze dell’abbandono dell’essere’.
La filosofia di Heidegger volle divenire allora la reazione a questa caduta e a questa
perdita e si concentrò così sulla ricerca dell’Essere e del suo senso, delle vie insomma
per riportare l’uomo alle sue vere radici in modo da renderlo finalmente padrone di se
stesso e del suo destino.
Era questa la partita decisiva per le sorti dell’umanità stessa: ‘l’uomo si trova su
questa terra in una situazione pericolosa. Per quale motivo? Soltanto perché da un
momento all’altro potrebbe scoppiare una terza guerra mondiale che avrebbe per
conseguenze il completo annientamento dell’umanità e la devastazione della terra?
No. Nell’era atomica che sta iniziando, un pericolo ancora più grande ci minaccia …:
45
la rivoluzione della tecnica che ci sta travolgendo nell’era atomica potrebbe riuscire
ad avvincere, a stregare, a incantare, ad accecare l’uomo, così che un giorno il
pensiero calcolante sarebbe l’unico ad avere ancora valore, ad essere effettivamente
esercitato. … Allora l’uomo avrebbe rinnegato … il suo carattere più proprio: la sua
essenza pensante. E’ necessario pertanto salvare l’essenza dell’uomo, è necessario
tener desto il pensiero’.
III
E’ semplicemente patetico commentare il cumulo di sciocchezze che Heidegger
sforna con tanta drammaticità, ma, d’altra parte, in queste pagine egli è stato
ricordato solo per la sua grande (ed inspiegabile) notorietà.
E’ senz’altro giusto da parte sua insistere che la tecnica deve essere un mezzo che la
società usa e che non dev’essere invece lei ad imporci la sua logica, nè basta
insomma poter fare una cosa per doverla fare come se fosse inevitabile (perché
diviene inevitabile solo se non ci mettiamo nelle condizioni di essere noi a decidere),
ma i meriti di Heidegger si fermano qui: a parte questa (banale) esortazione, tutto il
resto della sua lunghissima e complicatissima filosofia è il delirio libresco e
l’allucinazione maniacale di chi ha vissuto (e pensato!) chiuso in una biblioteca
scambiata per il mondo e per la realtà.
Risalire a Platone e far derivare tutta la nostra storia da lui; considerare tutto il
cammino dell’Occidente come il logico sviluppo della sua concezione della
metafisica; non solo non comprendere il rischio dell’olocausto nucleare, ma ritenerlo
un problema secondario di fronte a quello di impedire la vittoria definitiva del
pensiero calcolante; invocare in tono misterico, allusivo, ispirato ed iniziatico,
l’Essere e il suo senso senza specificarne mai nemmeno un carattere costitutivo, ecc.;
sono solo stucchevoli bizzarrie di un filosofo che capì tanto della vita da aderire fin
dall’inizio al nazismo e che per gli oltre trent’anni che visse dalla fine della guerra
non seppe né volle dire una parola su di esso.
Certamente fu meno compromettente discettare dell’oblio dell’Essere che di
Auschwitz: se infatti anche i campi di sterminio non furono (come tutto) che uno dei
tantissimi frutti dell’abbandono dell’Essere e del suo senso a che serviva parlarne in
particolare?
Ed Heidegger come potè mai sostenere seriamente che una terza guerra mondiale
(termonucleare) sarebbe stata davvero scongiurata solo quando l’umanità si fosse
aperta all’Essere e si fosse così liberata dal pensiero calcolante (perché era questo il
vero pericolo!!!) e dal dominio della tecnica (che ci ha tolto dalla fame e dal bisogno
fornendoci un benessere prima inimmaginabile ma in cui comunque non sta certo la
vera felicità, raggiungibile solo nel ritrovamento dell’Essere)?
Non ha davvero senso continuare a prendere sul serio affermazioni come queste.
Clemenceau disse una volta che la guerra era una cosa troppo seria per lasciarla fare
ai generali: che questo avvertimento valga anche per la filosofia da non lasciare ai
filosofi come Heidegger!!!
46
IV
Arthur Koestler (1905-83), ebreo ungherese trapiantato in Inghilterra, fu uno
scrittore di argomenti storico-politici ed ebbe sempre un forte interesse per la scienza:
quando affronta il tema della prospettiva della guerra nucleare - e riflette sulla natura
della guerra stessa - anche lui prova comunque una profonda angoscia, seppur lontana
da considerazioni filosofiche (con cui non aveva familiarità).
Dopo aver fortemente paventato il nazifascismo e dopo aver dato per scontata
l’avanzata del comunismo sovietico in tutta Europa negli anni Cinquanta, nelle sue
opere degli anni Settanta (‘The Heel of Achilles’ e ‘Janus - A Summing Up’) esprime
tutto il suo timore per l’inevitabilità di un olocausto nucleare: ‘fin da Hiroshima
l’intera umanità si trova a vivere colla prospettiva della sua propria estinzione in
quanto specie biologica’ perché per la prima volta nella storia era la sopravvivenza
della razza umana stessa ad essere seriamente minacciata, situazione mai esistita e
nemmeno immaginabile fino a pochissimi decenni prima.
Koestler è molto impressionato da questo nuovo e terribile scenario e, come gli era
sempre capitato in passato, mentre sente tutta l’ imminenza del pericolo vede però
che la società continua invece a vivere normalmente come se il problema non
esistesse nemmeno e non esita ad autodefinirsi una Cassandra: ‘solo una piccola
minoranza è consapevole che da quando il vaso nucleare di Pandora è stato aperto la
nostra specie vive in un tempo preso a prestito’.
Che fare dunque?
‘Il primo passo verso una possibile cura è una diagnosi corretta’ sulla natura della
guerra stessa, risponde Koestler, e questa diagnosi corretta consiste nel
riconoscimento che l’uomo è l’unico essere che uccide sistematicamente i membri
della propria specie, quindi quella umana ‘è una specie aberrante, sofferente per un
malfunzionamento biologico, con uno specifico disordine comportamentale che la
differenzia da tutte le altre specie animali’: cinque sono punti in cui questo aberrante
disordine comportamentale, particolare della sola specie umana, si manifesta:
1) ‘il sacrificio umano … è un rituale diffuso’ in quanto ‘queste pratiche sorsero
indipendentemente [l’una dall’altra] nelle civiltà più diverse’;
2) ‘la debolezza dei freni inibitori contro l’uccisione di un appartenente alla stessa
specie’;
3) lo ‘stato di guerra permanente con le sue sotto-variabili della persecuzione di
massa e del genocidio’: la ‘legge della jungla consente di depredare altre specie ma
vieta la guerra all’interno della propria … [e] l’homo sapiens è l’unico a violare
questa legge’;
4) ‘la permanente quasi-schizofrenica separazione fra ragione e sentimento’;
5) ‘l’impressionante sintomatica disparità … fra i poteri dell’intelletto quando
vengono applicati al padroneggiamento dell’ambiente e la loro impotenza se applicati
alla conduzione delle vicende umane’.
Koestler nota inoltre che - anche come conseguenza del lunghissimo periodo che ogni
membro della razza umana deve passare nelle mani degli adulti, accudito, protetto,
educato ed allevato senza essere in alcun modo autosufficiente - ‘una delle
47
caratteristiche centrali della condizione umana è questa irrefrenabile capacità e
bisogno di identificazione con un gruppo sociale e/o un sistema di credenze che è
indifferente alla ragione, indifferente al proprio interesse e persino alle esigenze
dell’autoconservazione’: ed è precisamente questa caratteristica a far sì che ‘il
problema con la nostra specie non è un eccesso di aggressività per la propria
affermazione, ma un eccesso di autotrascendente devozione, … di amore
disinteressato per la propria tribù, nazione, dinastia, chiesa o ideologia’.
Le guerre sarebbero dunque atti d’amore perché, paradossalmente, ‘il problema
della nostra specie non è l’eccesso di aggressività, ma di devozione’, molto più
pericoloso perché ‘l’identificazione con il gruppo implica sempre il sacrificio delle
facoltà critiche individuali e l’aumento del suo potenziale emotivo’.
Questo bisogno e questa capacità di identificazione fanno sì che l’homo sapiens creda
e si leghi a simboli, valori, dottrine, ecc., cioè a messaggi e a parole: dunque ‘le
guerre sono combattute per delle parole. Esse sono l’arma più letale dell’uomo’ e
‘il linguaggio è … la minaccia principale alla nostra sopravvivenza’ visto che ‘agisce
come potente forza coesiva all’interno del gruppo e come altrettanto potente forza
divisiva fra gruppi.’
V
L’aspetto davvero originale – e fortemente discutibile – dell’analisi di Koestler
risiede però nella causa di questa anomalia e di questo eccezionale comportamento
dell’uomo che secondo lui consisterebbe nella particolare evoluzione biologica
della specie umana (!): ‘nelle ultime esplosive fasi dell’evoluzione biologica
dell’homo sapiens qualcosa è andata storta’ perché ‘la corteccia cerebrale degli
ominidi nell’ultimo mezzo milione di anni si è evoluta ad una velocità esplosiva …
[e] le nuove strutture non si sono integrate propriamente con quelle filogeneticamente
più vecchie’, quelle cioè che l’homo sapiens ha in comune coi rettili e coi mammiferi
primitivi.
La parte emotiva e istintiva del cervello dell’homo sapiens (quella più vecchia) non
sarebbe dunque in accordo nè in armonia con quella razionale (quella più recente) che
non riuscirebbe così a controllarla: secondo Koestler questa sfasatura spiegherebbe
perché allo strepitoso successo della scienza e della tecnica (la ragione quando agisce
da sola) corrisponde la paralisi, l’irrazionalità e l’arretratezza del comportamento
umano, dell’etica e della morale, cioè del rapporto dell’uomo coi membri della sua
stessa specie (l’impotenza della ragione nei confronti dell’emotività).
‘L’homo sapiens è una specie biologica aberrante, un errore evolutivo’ perché le due
parti del suo cervello – quella razionale e quella emozionale - e del suo sistema
nervoso si sono formate ed evolute in periodi differenti così da non essere coordinate
né armonizzate fra loro: secondo Koestler una simile mancanza, per quanto grave,
non deve poi stupire perché, d’altra parte, ‘l’evoluzione ha compiuto molti errori …
Per ogni specie esistente centinaia in passato sono perite; l’archivio fossile è il bidone
dei rifiuti dei modelli scartati dal Progettista-Capo.’
48
Riassumendo: per Koestler la guerra scoppia come atto d’amore e di devozione per
qualcosa che va ben al di là dell’individuo in armi e ‘i disastri causati dagli eccessi
dell’autoaffermazione individuale sono quantitativamente trascurabili [se] paragonati
al numero di ammazzati ad maiorem gloriam, [cioè] per una disinteressata devozione
a una bandiera, a un leader, a una fede religiosa o a una convinzione politica … La
tragedia dell’uomo non nasce dalla sua aggressività, ma dalla sua devozione a ideali
che lo trascendono’.
Questa devozione è poi ascrivibile al fatto che ‘l’infante umano è soggetto a un
periodo di impotenza e di dipendenza totale dagli adulti più lungo [di quello delle
altre specie] … Questa prolungata esperienza può essere alla radice della pronta
sottomissione dell’adulto all’autorità e della sua quasi-ipnotica suggestionabilità a
dottrine ed a comandamenti etici – della sua brama di appartenenza, di
identificazione con un gruppo o con un sistema di pensiero.’
A sua volta ‘l’identificazione con un gruppo comporta sempre un certo sacrificio
delle facoltà critiche degli individui [parte più recente del cervello] che lo
costituiscono e un aumento del loro potenziale emozionale [parte più vecchia]’, e
questa imperfetta evoluzione del cervello umano rende la sua parte più recente
incapace di controllare razionalmente gli impulsi emotivi che risiedono nella sua
parte più antica.
VI
Dati questi presupposti, sembrerebbe proprio che le guerre siano inevitabili e che
anche quella nucleare non potrà che scoppiare con la sua catastrofica conseguente
cancellazione della specie umana (e non solo) dalla faccia della Terra, ma in realtà,
dopo tanto pessimismo, Koestler intravede anche una possibile via d’uscita.
Il suo discorso è semplice: se la vera e profonda causa della guerra è che nell’uomo la
neo-corteccia cerebrale – sede della ragione – non controlla né si integra né si
armonizza con le parti del suo cervello formatesi in precedenza (e in comune col
resto del mondo animale) – sede dell’emotività -, se insomma tale causa è di ordine
biologico e fisiologico, beh, allora anche il rimedio non potrà che essere biologico e
fisiologico (!).
‘Dobbiamo cercare una cura per la schizofrenia endemica della nostra natura’ e ‘la
cura non è al di là del raggio d’azione della biologia contemporanea’: essa consisterà
in ‘quella combinazione di ormoni o di enzimi benefici che dovrebbe risolvere il
conflitto fra le vecchie e le recenti strutture nel cervello [umano] fornendo alla neocorteccia il potere di controllare gerarchicamente i più bassi centri arcaici [del
cervello stesso]’.
Il ragionamento insomma è questo: se l’emotività (che ha sede nelle vecchie parti del
cervello) sfugge al controllo della ragione (che ha sede nelle nuove) e se questo
sfuggire produce comportamenti aberranti come le guerre (atti d’amore e di dedizione
dovuti al lungo periodo di dipendenza dell’infante umano dagli adulti), per evitare
queste ultime sarà del tutto inutile far leva sulla ragione che, così com’è, è impotente,
ma bisognerà invece metterla in grado di poter controllare impulsi ed emotività.
49
Infine, visto che quest’impotenza della ragione è di ordine evolutivo e biologico, si
dovrà agire allora a livello biologico: ‘se bisogna salvare la nostra specie malata, la
salvezza non verrà dalle risoluzioni dell’ONU e dai summit diplomatici, ma dai
laboratori biologici. E’ ragionevole che una malfunzione biologica richieda un
correttivo biologico.’
Alla domanda ‘sarà possibile cambiare i fondamentali delle emozioni inducendo
mutamenti molecolari nelle sostanze biologicamente attive nel cervello?’ Koestler
risponde affermativamente: egli è moderatamente fiducioso che un traguardo del
genere – questa sorta di Viagra della parte razionale del cervello - sia alla portata
della scienza del Novecento e chiarisce che ‘quel che propongo non è la castrazione
dell’emotività ma la riconciliazione di emotività e ragione … non un’amputazione,
ma un processo di armonizzazione’ (ottenuta con trattamenti biologici).
VII
A parte ogni ovvia considerazione sulla mutazione del funzionamento del cervello
umano indotta ed ottenuta con procedimenti medico-biologici - procedimenti da
rifiutare assolutamente! -, il discorso di Koestler non appare comunque convincente
perché – molto stranamente - trascura troppi fatti che smentiscono la sua teoria: se
infatti le guerre sono frutto di amore e di dedizione mal controllati dalla ragione, se in
queste catastrofi l’aggressività umana gioca un ruolo del tutto secondario, se
insomma in guerra l’uomo è mosso da stimoli emotivi positivi, seppur eccessivi e non
gestiti razionalmente, come mai proprio in tempo di guerra la ragione celebra trionfi
facendo progredire con tanto vigore scienza e tecnologia? Si deve forse concludere
che in guerra sarebbe l’emotività che sottometterebbe la ragione?
E poi: che dire della schiavitù e dello sfruttamento?
Nell’opprimere i suoi simili l’uomo non ha conosciuto (né conosce) limiti e ne ha
sempre abusato (e ne abusa) senza freni: si può davvero sostenere che anche in questi
infiniti casi di violenza sfrenata la molla fondamentale sia stata (e sia) l’amore e la
dedizione al proprio gruppo o ai propri convincimenti? O non è ben più evidente che
questa ferocia, costante ed istituzionalizzata in tutti i tempi e in tutti i luoghi, era (ed
è) frutto dell’aggressività dell’uomo e del suo interesse squisitamente personale?
Anche ammesso che guerra da una parte e schiavitù e sfruttamento dall’altra siano
fenomeni diversi, non sembra comunque in alcun modo sensato sostenere che la loro
radice sia completamente differente, addirittura a livello biologico.
In conclusione, l’analisi di Koestler coglie sicuramente un aspetto caratteristico della
guerra, ma lo assolutizza in modo del tutto arbitrario: tale analisi risulta insomma
monca e azzardata e conseguentemente neanche il rimedio proposto può essere preso
in seria considerazione.
Se un rimedio alla guerra è possibile, sembra insomma più sensato cercare dottrine
favorevoli all’integrazione fra i gruppi, valori – e interessi concreti! - che possano
essere condivisi più o meno universalmente, parole che uniscano i popoli in modo da
indirizzare quel sentimento di devozione che Koestler ha individuato e su cui insiste
50
tanto verso l’umanità nella sua interezza piuttosto che verso la piccola parte cui si
appartiene.
VIII
Come Heidegger, anche il filosofo francese (nato nel 1937 da genitori ebrei austriaci)
André Glucksmann nella sua prima opera, ‘Le discours de la guerre’ (1967), negò
che la minaccia atomica fosse quella novità radicale che faceva entrare il mondo in
un’era del tutto nuova e che sconvolgeva ed annullava tutto il pensiero politicomilitare precedente.
Per illustrare questa sua convinzione egli innanzitutto chiarì e definì il concetto stesso
di guerra: ‘la guerra è … stupida …, è ‘annientamento naturale, … devastazione
furiosa’. Essa ‘illustra la rivincita della natura sulla cultura, dell’inorganico
sull’organico, della morte sulla vita … La guerra non ha significati nascosti, essa
manifesta quel che è, una … assenza di senso.’
La guerra non è mai divenuta più sensata o più umana – né avrebbe mai potuto: essa
in sé è sempre rimasta ricerca del puro annientamento del nemico ed addirittura,
come aveva sostenuto von Clausewitz, con la svolta imposta dalla rivoluzione
francese e da Napoleone essa era diventata illimitata nei mezzi e nei fini, cioè
terroristica, e si era quindi avvicinata ed aveva realizzato al meglio la sua stessa
essenza.
Oltre a ciò, Glucksmann accettò poi il corollario di Hegel secondo cui è proprio sulla
guerra che ‘la società costruisce il suo stato’ perché è la guerra che unisce nella prova
suprema gli individui dispersi nei loro interessi particolari (e conflittuali) nella società
civile: col passaggio dalla moralità all’eticità è lo stato che dà unità alla società, ma
senza la guerra esso non nascerebbe mai (e la società rimarrebbe sempre un ammasso
di individui scollegati e chiusi nell’egoismo dei loro interessi particolari) perché è in
guerra che trionfa il comune interesse, il comune destino e il comune sforzo a rischio
della propria vita: ‘la guerra sola permette ad un popolo di superare le sue
contraddizioni morali, economiche e sociali: … essa dissolve le opposizioni più
solidificate … Lo stato regna allora grazie al ‘potere del sacrificio’.’ E ancora: ‘dalla
guerra nasce un ordine, sia interiore che esterno, e non può nascere che da essa’.
Ecco allora che ‘La guerra è la vera ragion di Stato. Senza di essa un popolo non è
un popolo’: ‘la guerra nella vita di un popolo è … la scoperta di sé’ perché ‘nella
guerra, nello scontro mortale e nella rivoluzione … la volontà è universale in quanto
… la morte non lascia fuori nulla.’
La bomba atomica si inserisce pienamente in questa visione clausewitziana ed
hegeliana così estremizzata della guerra proprio perchè la sua forza annientatrice
corrisponde perfettamente alla più intima natura della guerra stessa: con la bomba
atomica la guerra ha raggiunto la perfezione della sua essenza … esattamente
come Hegel e von Clausewitz avevano pensato avesse fatto con Napoleone! I
rispettivi contemporanei giudicarono Napoleone e la bomba atomica allo stesso
modo: per la loro radicalità ambedue infatti parvero incarnare definitivamente
l’essenza stessa della guerra (cioè il puro e semplice annientamento).
51
IX
Dopo aver mostrato insomma che il concetto di guerra estrema era già stato formulato
più di un secolo prima di Hiroshima, per Glucksmann l’era atomica non
rappresentava poi veramente una novità anche sotto un altro aspetto.
Era vero infatti che per la prima volta nella storia una guerra (termonucleare) non
poteva essere combattuta perché ciò avrebbe rischiato di spazzar via l’umanità intera,
ma, d’altra parte, proprio queste impasse ed impossibilità richiedevano che d’ora
in avanti il pianeta venisse organizzato in modo unitario e gestito razionalmente:
‘il riconoscimento del possibile annullamento del mondo rende di per se stesso
necessario un ordine universale’.
Questo per Glucksmann era un punto importantissimo: una sistemazione politica
finalmente razionale della società era stata infatti pensata per secoli da tanti filosofi
(Glucksmann ricorda il ‘Leviatano’ di Hobbes (1651) e la ‘Fenomenologia dello
spirito’ di Hegel (1806)) che avevano elaborato progetti ideali di una comunità
ordinata e perfetta che ora - proprio grazie alla minaccia nucleare!!! – avrebbe potuto
concretamente realizzarsi addirittura a livello mondiale!
L’extrema ratio strategica coincideva perfettamente con la summa ratio politica o,
meglio, l’extrema ratio strategica cessava di esistere come tale e si trasformava in
necessità politica!
Oltre che a proposito della realizzazione dell’essenza della guerra, per Glucksmann la
situazione creatasi dopo Hiroshima (1945) ricordava pienamente quella riconosciuta
da Hegel (e da Goethe) dopo Jena (1806) anche come premessa e garanzia di ordine e
razionalità politica.
Napoleone era apparso allora ad Hegel come la personificazione della storia stessa
del mondo la quale con la ‘pax napoleonica’ aveva compiuto un passo fondamentale
sulla strada della razionalità del reale (e della realtà della ragione): dopo Hiroshima la
nuova fase della storia del mondo era invece la ‘pax americana’, ma era pur sempre
lo stesso modello politico di ordine universale che veniva riproposto, come aveva
sostenuto lo stesso Henry L. Stimson quando, informando subito dopo la morte del
presidente Roosevelt (aprile 1945) il successore Truman del ‘progetto Manhattan’ (la
costruzione delle prime bombe atomiche), aveva osservato che ‘se risolveremo il
problema dell’utilizzo giudizioso dell’arma [atomica] avremo la possibilità di
condurre il mondo in uno stato di perfezione nel quale potranno essere salvaguardate
la pace universale e la nostra civiltà’.
La terribile minaccia (reale) diveniva fondamento dell’ordine (ideale): ‘il destino del
mondo è nelle ‘nostre’ mani’; ‘la bomba piega il furore guerriero’ e, giunto ‘sul
margine dell’abisso, il mondo deve trovare la sua unità e la sua sicurezza’.
Per Glucksmann insomma proprio l’incombente minaccia dell’apocalisse nucleare
era la miglior garanzia della realizzazione di quell’ordine e di quella pace
sognati per secoli dai filosofi!
52
Glucksmann: logica della dissuasione nucleare
A prima vista queste affermazioni di Glucksmann possono sembrare il disinvolto ed
elegante esercizio verbale di chi ricorre e si aggrappa ai filosofi del passato per
negare - chissà perché - l’evidente e sconvolgente novità della guerra nucleare e che stranamente - non vede che fra Napoleone e la bomba atomica c’è l’incolmabile e
decisiva differenza che due secoli fa la popolazione del pianeta Terra non corse alcun
rischio di estinzione (nessuno se l’immaginò nemmeno) né in secondo luogo che la
minaccia atomica non ha reso il mondo più ordinato e razionale perché tutto è
continuato invece come e peggio di prima (gli arsenali nucleari impedirono solo lo
scontro diretto fra USA e URSS, comunque un risultato di non poco conto).
Si tratterebbe però di un’impressione sbagliata perché in realtà Glucksmann non si
limita certo ad inserire la guerra (o non-guerra?) termonucleare in un ordine mentale
precedente (come fa anche Heidegger), bensì considera ed analizza anche la politica
che scaturì da tale situazione e cioè la dissuasione nucleare.
I
Nell’era atomica le due super-potenze sono diventate talmente forti da non potersi
affrontare direttamente: ‘la difesa fondata sulla minaccia di una risposta illimitata ad
un attacco illimitato’ non è possibile perché porterebbe all’estinzione dell’umanità.
Duplici sono allora le conseguenze di questa nuovissima e sconvolgente situazione:
innanzitutto, fra USA e URSS si è imposta una vera e propria ‘dissuasione
reciproca’ dal ricorrere alle armi nucleari (impossibili da usare) col risultato che
nell’era atomica ‘lo scopo della strategia è divenuto necessariamente negativo,
difensivo’ in quanto ognuno dei due avversari minaccia l’altro di ritorsione nucleare
massiccia in caso venga aggredito: ma in questo modo allora ‘la vittoria ha perso il
suo significato tradizionale’ perché, dato che in una guerra atomica non ci possono
essere vincitori, l’unico successo consiste nell’impedire all’altro di scatenarla per
primo!
In secondo luogo, Glucksmann si contraddice perché dopo aver sostenuto che la
bomba atomica porta necessariamente a quell’ordine tanto sperato dai filosofi,
afferma poi che la dissuasione fra le due super-potenze è invece un (chiamiamolo
così) gioco - un confronto-scontro - estremamente complesso ed articolato che
tuttavia non può che essere condotto in modo limitato per conseguire obiettivi
limitati: impossibilitati ad andare fino in fondo (lo scontro diretto), i due antagonisti
si devono allora accontentare di bloccarsi reciprocamente e possono aspirare solo a
risultati sempre parziali e provvisori.
La dissuasione consiste allora nel passaggio da una crisi ad un’altra e una crisi è il
tentativo di mettere l’avversario di fronte ad un fatto compiuto (ovviamente
vantaggioso per chi l’ha prodotto) più l’inevitabile reazione ad esso: avviene così che
‘i rapporti di forza perdono la loro purezza metallica trasformandosi in rapporti di
53
rischio, l’arma assoluta sbriciola la grande battaglia senza rimpiazzarla. Essa
polverizza l’universo napoleonico’.
‘Il riferimento alla ‘grande battaglia’ governa il pensiero classico della pace come
quello della guerra. La minaccia nucleare li sconvolge, una stessa architettura … di
concetti che dirigono l’insieme delle relazioni internazionali si trova
improvvisamente decapitata. Sostituto della battaglia, la crisi incide meno
chiaramente, essa non può risolversi che in un’altra crisi perché l’idea stessa di un
pareggiamento dei conti il gran giorno del pagamento in contanti è sospeso. … la
crisi … perpetua ed introduce uno stato di né guerra né pace’.
La conclusione di tutto ciò è che ‘il tempo della dissuasione non è orientato (né verso
una pace totale, né verso una guerra definitiva)’ e che ‘la dissuasione organizza mezzi
offensivi … a scopo … difensivo’ giocando sempre sul filo del rasoio perché in ogni
crisi un’escalation che sfugga di mano e divenga incontrollata è pur sempre una
deriva possibile (‘ogni crisi … può scatenare l’olocausto’).
Compito degli strateghi americani (Glucksmann non può prendere in esame quelli
sovietici che mantenevano segrete le loro analisi) fu allora quello di offrire un
‘ventaglio completo … di possibilità, non di realtà, [così che] le loro conclusioni non
regolano la necessità di un calcolo univoco … [e] si afferma [invece] una produzione
di scenari’: ‘il discorso della dissuasione si costituisce come logica del probabile’ la
cui ‘incertezza è sovrana [data] la natura del suo oggetto’: anche Kissinger riconobbe
che ‘ci troviamo immersi in un processo interminabile e non nella ricerca di una
destinazione ultima’ in quanto ‘la dissuasione non è assolutamente una teoria della
decisione … [e] le condotte che essa analizza … non sono in alcun modo e in nessun
grado decisive’.
‘Dissuasione = indecisione’ ma ‘la dissuasione … non è e non può essere la logica
sicura che ha per oggetto avvenimenti semplicemente probabili … è [invece] una
logica verosimile del verosimile, l’arte di discutere senza concludere rigorosamente.
Con questa discussione essa sviluppa la subtilitas; l’elegantia’.
Come la retorica fin dai tempi di Gorgia e degli scolastici medievali, la dissuasione
opera in scenari sempre cangianti e spesso imprevedibili e diviene così l’arte di
valutare tutte le possibilità, di misurare tutte le forze e di prevedere tutte le
possibili mosse: già von Clausewitz aveva affermato che la guerra era l’attività più
simile al gioco a carte mentre adesso lo stesso paragone si può fare per tutto il
complesso delle crisi ognuna delle quali deve però rimanere limitata per non sfociare
in una guerra (nucleare).
Glucksmann può concludere allora che ‘per Clausewitz la guerra era la continuazione
della politica con altri mezzi. Se fosse vissuto nei nostri tempi avrebbe osservato che
la politica è divenuta la continuazione della guerra con altri mezzi’ perché è la guerra
(impossibile) che deve necessariamente cedere il campo a pratiche diverse come le
‘minacce graduali’ e le ‘risposte flessibili’ tenendo costantemente ben presente il
‘punto di arresto’ in modo da saper ‘valutare il troppo (rischio di guerra nucleare
esagerata) ed il troppo poco (rischio di avvantaggiare l’avversario) nell’impiego delle
forze e delle minacce’.
54
‘La guerra perde la sua autonomia se la strategia militare non può essere concepita
come la scienza della vittoria militare … e … la strategia militare è divenuta la
diplomazia della violenza’. ‘Il calcolo strategico diventa un calcolo politico’.
‘La strategia nucleare unifica l’insieme delle condotte strategiche … essa realizza un
principio di unità che rende ogni guerra limitata e localizzata il caso particolare di
uno scontro globale’ ma ‘la strategia nucleare non può enunciare nessuna regola … e
… quando propone un ‘rischio calcolato’ non calcola niente … è la politica che, alle
sue spalle, calcola, agisce e decide’.
L’epoca della dissuasione è caratterizzata insomma dall’incertezza, dalla
precarietà della situazione, da uno status quo che in realtà è in continuo
movimento - ma anche fondamentalmente sempre lo stesso.
II
Glucksmann afferma che ‘la crisi di Cuba (autunno 1962) è considerata da tutti
l’esempio più trasparente di una strategia di dissuasione nucleare’, strategia che
‘cessava di essere un’astrazione’ .
Si vide allora con chiarezza infatti che ‘la superiorità nel campo degli armamenti
nucleari … non basta[va] più, la cosa importante [era] l’uguaglianza del terrore’: la
coesistenza pacifica diveniva lo sbocco inevitabile del rapporto fra le due superpotenze impossibilitate a combattersi e le cui forze non aveva senso si accrescessero
(anche se lo facevano continuamente).
Secondo Glucksmann ‘la lezione della crisi cubana è permanente’ perché essa
‘mostra i meccanismi di tutte le crisi’ e che ‘nell’era termonucleare il momento della
verità è la crisi, non la guerra’.
III
‘La dissuasione … cioè … guerra limitata’, non pace sostiene Glucksmann: la
dissuasione riesce ad evitare la guerra termonucleare ma non le guerre limitate
(‘centotrenta conflitti con dozzine di milioni di morti’) che evidentemente non
possono venir combattute che con mezzi tradizionali, ma come limitare queste guerre
limitate? Come stabilire la soglia insorpassabile dello scontro? Insomma: fino a che
punto le due super-potenze possono combattersi senza rischiare l’olocausto nucleare?
Tenuto anche conto che più che conoscere le forze dell’avversario nell’era atomica
bisogna valutarne soprattutto i piani e le intenzioni, l’unica soluzione possibile a
questo problema è la trattativa con tutte le sue varianti, metodi e risorse, e la
trattativa presuppone dialogo costante.
I due nemici mortali sono e devono restare continuamente in contatto fra loro e fu
estremamente rivelatore di questo aspetto della questione il fatto che questa necessità
fu avvertita proprio durante la crisi dei missili a Cuba, quando i due contendenti si
resero conto che avevano bisogno di comunicare costantemente fra loro ed istituirono
allora il famoso ‘telefono rosso’.
55
I due avversari sono in trattativa costante e giocano così la loro ininterrotta partita
sullo scacchiere internazionale: essi si affrontano e si combattono senza interruzione,
ben attenti però a non lasciare che la situazione sfugga loro di mano (essa non può e
non deve degenerare fino al punto di non ritorno) e sottoponendo a negoziato ogni
mossa che fanno.
‘Le guerre limitate si limitano fra di loro’ e ‘la strategia diviene così la
determinazione dei rapporti fra differenti rapporti di forza’.
‘La condotta strategica è irriducibilmente risky behavior … in cui il razionale e
l’irrazionale sono … indiscernibili’.
Glucksmann: elogio delle armi nucleari
Fino a questo punto Glucksmann non ha fatto altro che riepilogare sull’equilibrio del
terrore che caratterizzò la ‘guerra fredda’: esso è sempre stato unanimamente
giudicato a dir poco angosciante (e gli armamenti nucleari dei ritrovati infernali), ma
Glucksmann sull’intera questione esprime invece un giudizio molto più articolato e
(come sempre) decisamente originale e controcorrente.
In ciò consiste il suo vero contributo alla discussione.
I
Innanzitutto, secondo Glucksmann oltre al fatto che grazie ad esse ‘la sicurezza
internazionale sembrerebbe garantita’, soprattutto però le armi nucleari conducono
una grande e benefica operazione di verità sulla guerra (‘il primo effetto dei
missili è un effetto di verità’ e ‘il missile è un’arma di verità’) perchè costringono
tutti a guardare finalmente in faccia la realtà della guerra ed a non potersi più illudere
ed ingannare sul suo significato (‘io sono la prima arma veramente psicologica’ dice
il missile e ‘la mia prima carica è spirituale. Le mie prime vittime i vostri tabù’).
‘Ben condotta, la dissuasione rivela il volto nascosto della guerra, … essa mostra in
grande quello che ogni guerra effettua in dettaglio … Essa offre occhi per il disastro’:
‘la dissuasione … costringe al faccia a faccia con la guerra nella sua verità’ e
Glucksmann le fa così dire che ‘io non sono né buona né cattiva, … io sono vera’.
In secondo luogo, l’equilibrio del terrore è tanto più benefico e positivo in quanto in
Europa occidentale pone finalmente termine agli stermini in nome delle
ideologie.
Inevitabilmente, la possibilità dell’olocausto dell’intera umanità non solo impedisce
(finalmente!) di mentire ma annulla anche quella logica delle ideologie che, a partire
dalla crociata di Wilson (vedi Schmitt), per tutto il Novecento hanno difeso e
sostenuto ogni sorta di massacri, dipinti come operazioni per la liberazione e la
purificazione dell’umanità, avvenuti dunque a fin di bene e per un futuro migliore.
Torna qui potente il tema di fondo dei ‘nuovi filosofi’ (fra i quali Glucksmann venne
arruolato), quella radicale denuncia delle ideologie che legittimarono e giustificarono
gli orrori degli universi concentrazionari del Novecento: esse accecarono le menti
56
prima delle coscienze e quando non poterono negare le orribili conseguenze che esse
stesse avevano prodotto, allora le falsificarono dipingendole come missioni benefiche
per l’umanità e riuscendo così a spacciare quegli inferni per paradisi!!!
Con la dissuasione ciò non è più possibile: essa è infatti un concetto (e una pratica)
negativo che – come presso i giusnaturalisti del XVII secolo - non ha valori e ideali
da proporre in nome dei quali si possa quindi sterminare (‘la giustizia dissuasiva non
si presenta come un bene che si stacca e si volge contro un male’) e che, rendendo la
guerra impossibile, costringe i nemici al dialogo (‘la dissuasione è l’intesa di coloro
che non si intendono’).
Glucksmann fa così dire ad un missile nucleare che ‘dissuasione si oppone a
persuasione. Io apro uno spazio in cui le ragioni della forza non sono assolutamente
più costrittive in quanto la violenza delle ragioni si blocca, impotente ad imporre
assenso. Ecco perché i persuasi di tutti i colori mi aborriscono, io rendo indeterminate
le loro azioni più radicali. … I tempi delle crociate sono finiti’ come sono ‘finite le
gioiose cavalcate che promettono la felicità dell’umanità attraverso lo sterminio
incondizionato dei suoi nemici’.
Insomma, conclude il missile, ‘grazie a me la necessità di una pace si manifesta
continuamente’.
Glucksmann è talmente convinto del ruolo assolutamente salutare svolto dai missili
(che rendono impossibile il successo della logica totalitaria in Europa occidentale)
che dopo l’annuncio di Reagan sulla possibilità di abbattere in volo i missili nucleari
(le cosiddette ‘guerre stellari’) e dunque di rendere l’America inviolabile, arriva a
concludere che ‘se … gli Stati Uniti e l’URSS diventano nuclearmente intoccabili, se
… l’Europa occidentale viene inclusa nello scudo antimissile americano, la catastrofe
arriva subito: la dissuasione si azzera e nel vecchio continente sono permesse tutte le
avventure coi mezzi ‘classici’ di un inaudito potere distruttore. … Il giorno che [la
dissuasione] fallirà non avremo abbastanza lacrime per piangerla’ (!!!)
II
Dopo i totalitarismi del Novecento e lo scatenamento di tutta la loro follia
Glucksmann sottolinea dunque i lati positivi dell’equilibrio del terrore – unica
garanzia di pace e di impedimento della follia del totalitarismo - ed espresse
questa sua valutazione favorevole anche ai tempi della crisi degli euromissili durante
la quale con ‘La force du vertige’ (1984) prese apertamente posizione contro il
pensiero pacifista e contro gli oppositori della strategia NATO: i fatti erano noti ma
Glucksmann li riepilogò ugualmente per tutti coloro che preferivano ignorarli.
Il 28 ottobre 1977 il cancelliere tedesco (socialdemocratico) Schmidt denunciò che
l’URSS aveva silenziosamente schierato in Europa i temibili missili SS 20 a testata
nucleare multipla proprio mentre le discussioni sulla riduzione degli armamenti
nucleari si stavano intensificando (!): ‘fino a quel momento i due campi avevano
schierato lungo la cortina di ferro missili già nucleari, sia tattici, a corto raggio,
limitati al campo si battaglia, sia strategici … I missili di prima categoria non
arrivavano ai centri di gravità (capitali, stati maggiori) [e] … non erano decisivi. …
57
La seconda categoria di missili avrebbe comportato l’annientamento … senza vinti e
vincitori’, ma ora questi ‘missili ‘a medio raggio’ stravolgevano la situazione
strategica precedente e per la prima volta rendevano concrete le condizioni sufficienti
per una totale nuclearizzazione dei conflitti continentali’ (cioè limitati all’Europa).
‘A differenza delle armi tattiche, gli SS 20 possono colpire tutti i centri nervosi
dell’Europa occidentale … A differenza dei missili intercontinentali strategici la loro
estrema precisione … garantisce un urto selettivo, detto perfino chirurgico, che
permette la decapitazione del sistema di difesa avversario senza radere al suolo
popolazione e ricchezze. La loro mobilità inoltre … li rende quasi invulnerabili. …
Terza caratteristica essenziale, la portata strettamente continentale delimita
chiaramente un teatro di operazioni: essa copre tutta l’Europa ed essa soltanto’.
‘Nessuno dei numerosi esperti e strateghi ufficiali aveva avuto presentimento
dell’evento’ e ‘l’Europa si svegliò di soprassalto all’ombra di missili in grado di
annichilirla’.
Dopo che nella primavera 1979 il SALT 2 firmato da Breznev e da Carter aveva
semplicemente ignorato questo nuovo tipo di missile (!), fu allora il nuovo presidente
Reagan che volle parare il colpo sia proponendo che anche gli USA schierassero in
Europa nuovi missili tattici (soprattutto i Pershing 2), sia ammettendo apertamente la
conseguente possibilità di una guerra nucleare limitata (all’Europa).
In realtà la proposta di Reagan non era una novità per gli strateghi della NATO che
già oltre vent’anni prima non avevano escluso che in Europa potesse essere condotta
una guerra con armi nucleari senza che questa ne oltrepassasse i confini, ma né
questo né – soprattutto! - il fatto che erano stati i sovietici che con lo schieramento
degli SS 20 avevano reso possibile una guerra nucleare limitata nel continente impedì
che dal movimento pacifista fosse invece proprio Reagan ad essere additato
all’opinione pubblica occidentale come un guerrafondaio incosciente ed uno
scriteriato che giocava in modo irresponsabile coi destini dell’Europa e del mondo.
Incalzata da Reagan, la NATO scelse infatti di ‘equilibrare la capacità degli SS 20
sovietici di aprire e gestire una guerra limitata in Europa con una capacità analoga’ in
modo da ‘equilibrare una minaccia geopolitica specifica con la contro-minaccia
appropriata’ attirandosi però opposizioni diffuse in tutto l’Occidente tanto che
‘l’ondata delle contestazioni ha assunto proporzioni tali da costituire ormai una sfida
fondamentale al sistema strategico stabilito in Europa dopo la seconda guerra
mondiale. Infatti rifiutando l’arma nucleare i ‘movimenti per la pace’ mettono
direttamente in discussione la dissuasione cioè il fondamento stesso della sicurezza’.
Glucksmann si impegnò attivamente in difesa della decisione di schierare i Pershing
2 in Europa occidentale e combattè decisamente i pacifisti, i filo-sovietici e gli stessi
sovietici che si trovavano tutti uniti nella condanna e nel rifiuto degli euromissili
americani, ne smontò gli argomenti e denunciò le falsità contenute nella loro
propaganda.
58
III
Innanzitutto egli affrontò i pacifisti convinti, quelli che a prescindere da ogni altra
considerazione fondano il loro pensiero sull’amore per la pace come valore assoluto
fine a se stesso: ‘‘Io amo la pace’ è una dichiarazione d’intenti così obbligante che …
riguarda tutte le dichiarazioni di guerra’, tuttavia ‘questa ‘pace’ non esprime nessuna
preferenza per il tale o tal altro genere di vita’, in modo che Glucksmann può
concludere ironicamente che ‘nessuno può rimproverare all’amore di essere cieco’.
Ciò che rende insomma inaccettabile il pacifismo è che dovendo scegliere fra libertà
e vita esso opta sempre, preventivamente e sistematicamente, per la seconda a scapito
della prima: ‘colui che afferma ‘niente è più importante della pace’ si sottomette …
all’intimazione definitiva. Egli invita la terra intera a sacrificare credenze, glorie ed
ideali sull’altare della Vita, egli postula in essa un Bene supremo’.
Dato che fra libertà e vita sceglie la seconda, il pacifista accetta così di vivere da
schiavo: egli preferisce ‘annullare tutto quello che fa amare la vita in nome della vita’
senza riuscire a comprendere che ‘non c’è pace senza libertà’ e che ‘una pace a tutti i
costi vale per definizione meno di niente’ perchè ‘l’uomo … trova ragioni per vivere.
Le difende. Esse diventano per lui ragioni per cui morire’, così che ‘il prezzo della
vita qualche volta è la morte’ in quanto ‘esiste una morte peggiore della morte’ e
‘possiamo perdere più dell’esistenza’.
IV
Ma Glucksmann spinge lo scontro coi pacifisti molto più a fondo: seguendo
l’impostazione di tutta la ‘nuova filosofia’ egli ne rivela infatti i malsani fondamenti
ideologici e li coinvolge nella denuncia della cecità e della malafede della sinistra.
Secondo lui il pacifismo degli anni Ottanta aveva le sue radici nel principio di
Adorno secondo cui ‘Hitler ha imposto agli uomini un nuovo imperativo categorico:
pensare ed agire in modo che Auschwitz non si ripeta, che nulla di simile giunga’:
dopo questa prima decisa presa di posizione antiautoritaria fu poi la volta di quella
sulla decolonizzazione quando anche lì ‘abbiamo spezzato la complicità dei
carnefici’, ma dopo di ciò la sinistra si perse.
Innanzitutto tacque e tace sulle colpe del comunismo: ‘da sessant’anni un orco
concentrazionario [il comunismo] divora i nostri simili a milioni’: ‘l’URSS
interviene, reprime, uccide, fa sciamare la sua dittatura su tutti i continenti’ ma non
riceve nessuna condanna da parte di chi ha sempre visto torti e malefatte solo
dall’altra parte.
Dell’URSS non si parla e questa ‘ignoranza riposa su una volontà di ignorare’ mentre
la stessa rimozione si ripropone a proposito del silenzio, o della giustificazione, o
della comprensione, per gli orrori operati dai decolonizzati nel mondo decolonizzato
stesso: ‘solo un’infusione di cretinismo fa immaginare che il mondo decolonizzato ha
mantenuto le promesse della decolonizzazione’.
Questo unilateralismo della sinistra nel denunciare sempre e solo l’Occidente si
ripropone imperterrito nel mondo pacifista: ‘i pacifisti si danno un bersaglio,
59
l’armamento occidentale, sul quale fanno convergere l’insieme delle loro azioni’
perché per loro ‘lo ‘sterminismo’ [è] la fase suprema dell’imperialismo fase suprema
del capitalismo’.
A questo insostenibile unilateralismo se ne accompagna poi un altro, ‘la
focalizzazione sull’armamento nucleare – consacrato come ostacolo principale alla
felicità universale … Bloccate la minaccia della distruzione di massa, fermate la
corsa agli armamenti, la fame sparisce dai cinque continenti e le libertà fioriscono
nelle dittature che coprono i tre quarti delle terre abitate. Il pacifismo … fa girare il
mondo intorno alla Bomba’.
Secondo i pacifisti ‘la pace … disarma le dittature, dissolve gli odi, blocca i genocidi
e fa rifluire su se stessa la marea delle attività belliche che monta crescente … fin dal
neolitico!’ perché per loro ‘l’estirpazione del nucleare’ è ‘l’alfa e l’omega della
concordia universale’: insomma: ‘il pacifismo rimpiazza le ideologie dell’ultimo
secolo … diventa la nuova ideologia e la risposta a tutto’.
Nel pacifismo allora ‘un suicidio intellettuale precede quello politico’ perché con
la riduzione del male alla sola bomba (occidentale) si annulla ogni riconoscimento di
tutti i terribili mali che affliggono il mondo da sempre e che se taciuti continueranno
più e peggio di prima.
V
Entrando nello specifico dopo queste premesse generali, Glucksmann facilmente
osserva che ‘sono gli SS 20 che rendono materialmente possibile una guerra nucleare
limitata in Europa, ma nei cervelli pacifisti sono i propositi di Reagan espressi
qualche anno più tardi che soli hanno introdotto la sinistra eventualità!’
Dato che l’URSS non compare mai nelle loro denunce e nelle loro condanne, i
pacifisti si oppongono ai Pershing 2 ma non agli SS 20 che li hanno preceduti e ne
sono la causa (!): il pacifismo ‘si alza contro l’installazione futura dei missili
americani in Europa più che contro gli ordigni sovietici che già minacciano’ (e contro
i quali non ebbe niente da dire quando furono installati)!
Visto poi che ai pacifisti premeva tanto la pace, ebbene, nei primi anni Ottanta era
‘l’URSS [che] presenta[va] … la forma finalmente trovata di una società sulla strada
della pacificazione totale’, ma era anche il triste e notissimo universo
concentrazionario e per questo andava assolutamente rifiutata e combattuta altrimenti
‘disarmandosi di fronte alla più stabile e moderna tirannia l’Europa direbbe addio alla
sua volontà democratica, alla sua passione anticoloniale’: ‘non vi parlo del gulag
esistente fin d’ora sulla maggior parte dell’Eurasia, io vi ricordo soltanto il diritto che
hanno quegli europei [cioè noi] che per il momento sfuggono a questo sistema di
difendersi a qualunque prezzo – sì, a qualunque prezzo – contro una simile minaccia’;
‘una ragione … essenziale fonda la volontà dissuasiva sul diritto di difendersi …
costi quel che costi’.
Per Glucksmann la situazione degli anni Ottanta era la stessa di quella degli anni
Quaranta quando ‘Einstein … e Thomas Mann … sollecitarono gli Stati Uniti a
produrre al più presto l’arma terribile. Essi non ignoravano che Hitler stava
60
fabbricando questa bomba e che era capace del peggio. Perché del peggio? Perché era
capace di sterminare etnie e di costruire i campi. … Osereste rispondere a Einstein:
piuttosto Hitler che il nucleare?’
Insomma: senza gli euromissili americani ‘come tenere a distanza un sistema
concentrazionario? ... [Con essi] ci si premunisce contro l’estensione di Auschwitz e
dei suoi succedanei. Conoscete altri rimedi preventivi?’
Precisamente ‘questa preferenza antidispotica – ed essa soltanto – fonda[va]
l’installazione di missili contro-minaccianti [quelli sovietici] sulla riva orientale
dell’Atlantico’ e Glucksmann ribadì nel modo più chiaro che la minaccia nucleare
sovietica andava contrastata a tutti i costi e con tutti i mezzi disponibili:
‘preferisco rischiare di soccombere con un bambino che amo in uno scambio di
Pershing 2 e di SS 20 piuttosto che immaginarlo trascinato verso qualche Siberia
planetaria’; ‘colla mia famiglia preda dell’arcipelago nazista nella memoria dovrei
accettare che mio figlio subisca l’arcipelago sovietico?’
Su questo punto Glucksmann è terribilmente lucido e radicale e ‘La force du vertige’
si conclude con queste parole:
‘Abbiamo il diritto di prendere in ostaggio donne, figli, figli dei figli, sull’intero
pianeta? Possiamo minacciare le popolazioni civili, noi compresi, di apocalisse? Una
civiltà continua ad essere tale se rischia consapevolmente la sua estinzione per
sopravvivere? Questa è la più filosofica, la più seria, la più comune domanda che la
semplice attualità pone.
La risposta, non se ne dispiacciano le coscienze troppo tranquille, è sì’.
VI
Al di là dell’opposizione di principio dei pacifisti, gli oppositori degli euromissili
americani mossero comunque altre numerose obiezioni al loro schieramento e
Glucksmann le contestò tutte.
La prima e più importante sosteneva che lo schieramento degli euromissili americani
era un ulteriore passo della corsa agli armamenti nucleari che aveva da tempo
oltrepassato la soglia del razionale e del ragionevole: data ‘la capacità di uccidere più
volte … dei rispettivi arsenali’ ‘a che pro disputare la superiorità nucleare relativa su
un terreno limitato …?’ ‘Non c’è del ridicolo nel brandire armi di cui si intende fare
il minor uso possibile?’
Secondo Glucksmann quest’obiezione (fatta ancora una volta solo alla NATO e non
all’URSS) non teneva conto del reale motivo dell’installazione degli SS 20 sovietici:
‘il primo impiego di un’arma … è d’intimidazione’ così ‘la strategia europea di
Andropov … non fa la guerra ma mette alla prova la determinazione dei leaders e
delle popolazioni, tenta una battaglia mentale’.
‘I missili mirano innanzitutto ai cervelli. Le grandi battaglie di oggi sono
essenzialmente mentali. Un’invasione … tutto si gioca prima di essa. Se i russi …
invadessero l’Europa occidentale, sarebbe perché avrebbero giudicato possibile la
spedizione, stimando che gli europei non si difenderebbero fino al termine funesto.
61
Essi avrebbero vinto prima di agire, la loro passeggiata militare, ben abbellita di
milioni di cadaveri, eseguirebbe una sentenza già pronunciata, raccoglierebbe un
bottino acquisito in precedenza. I russi occuperebbero quando non avrebbero più
bisogno di occupare per dominare’.
Ecco allora che ‘l’installazione dei Pershing 2 … priva i russi di un mezzo di
pressione’ e se non ci fosse risposta agli SS 20 per Andropov sarebbe davvero
‘difficile resistere alle molteplici tentazioni che un’Europa disarmata offrirebbe … di
cedere alle sue ‘pacifiche’ esigenze’.
Questo fu il punto fondamentale e il fulcro di tutto il ragionamento di
Glucksmann ma ciò non toglie che egli avesse ancora altre considerazioni da fare ed
altre obiezioni cui ribattere.
Secondo lui un equilibrio di forze solo convenzionali in Europa sarebbe ‘folle’ perché
‘lo spazio che separa la linea del fronte dall’oceano Atlantico è troppo limitato per
permettere di assorbire lo shock in caso di attacco a sorpresa, pur condotto con mezzi
‘convenzionali’ ma con tutte le risorse dell’alta tecnologia’: per fermare un attacco
convenzionale con forze solo convenzionali bisognerebbe semmai che queste ultime
fossero molte volte superiori a quelle attaccanti (ipotesi irrealizzabile) e comunque
‘una terza guerra … ‘convenzionale’ … significherebbe … la fine del vecchio
continente’.
In conclusione: ‘se l’Europa occidentale non è difesa nuclearmente non è difesa
per niente’.
Un’ulteriore obiezione affermò che con l’installazione dei Pershing 2 ‘gli americani
… usano … missili europei senza esporsi direttamente’ e, insomma, che Reagan
aveva deciso di scaricare sull’Europa, e sull’Europa soltanto, i costi di una guerra
nucleare appunto limitata.
Per Glucksmann questa obiezione non sta in piedi perché ‘poco importa da dove
arriva la freccia … è chi l’ha scoccata che va punito’, così se ‘gli americani
distruggono Mosca … poco importa se … il lancio strategico … parte da un
sottomarino o da rampe installate sui cinque continenti’, perché ovviamente la
rappresaglia e l’escalation sarebbero – né non potrebbero non essere - esattamente
sempre le stesse.
Un ultimo motivo di opposizione insisteva sul fatto che l’installazione dei Pershing 2
avrebbe potuto far scoppiare una guerra nucleare limitata (in Europa) molto più
facilmente di una guerra totale al che Glucksmann ribattè che questo faceva parte di
‘una strategia dello spavento che cerca di ottenere … una decerebrazione che preceda
o renda inutile la decapitazione militare’: la differenza fra una guerra nucleare
limitata e una totale per gli europei consisterebbe infatti soltanto nel fatto che nel
primo caso la morte arriverebbe qualche minuto prima che nel secondo, ma sempre
morte sarebbe e si può morire una volta sola.
62
VII
Glucksmann considerò anche che la Cina di Mao rifiutò e si oppose alla logica della
dissuasione e delle guerre limitate e convenzionali nell’ambito dello status quo
(l’equilibrio del terrore nucleare).
Tutto il pensiero strategico di Mao si incentrò infatti sulla politica perché secondo lui
in guerra e nella rivoluzione è il popolo che decide e che conta, costi quel che costi
e la guerra duri quel che deve durare (egli fu sempre completamente indifferente ai
sacrifici ed alle sofferenze che la guerra e/o la rivoluzione comportavano).
Secondo lui una volta imboccata la strada giusta, corretti i propri errori ed imparato
dal nemico, bisognava continuare indefinitamente fino alla vittoria che non sarebbe
potuta mancare: ‘il problema della rivoluzione cinese fu risolto con la guerra di lunga
durata’ ed il suo successo confermò Mao nella giustezza della sua strategia.
In quest’ottica andavano considerati anche gli armamenti nucleari che per quante
morti e devastazioni avessero pur potuto infliggere alla Cina (allora potenza nonnucleare) in nessun modo sarebbero potuti divenire la chiave della vittoria su di essa:
la famosa affermazione del 1946 ‘la bomba atomica è una tigre di carta’ ben esprime
questa ferrea convinzione di Mao secondo cui in una guerra e in una rivoluzione il
fattore decisivo risiede nel popolo e solo nel popolo.
Per Mao in guerra o nella rivoluzione ‘il fattore decisivo è l’uomo e non il materiale.
Il rapporto di forze si determina non solo con quello delle potenze militari ed
economiche, ma anche con quello delle risorse umane e delle forze morali. Il fattore
uomo non umanizza la guerra ma lo radicalizza’ infatti ‘i cinesi sono nuclearmente
disarmati ma non c’è miglior sordo di chi non vuol sentire’, così secondo loro una
volta intrapresa una guerra (o la rivoluzione) non si può tornare indietro né fermarsi
di fronte ad alcun ostacolo: ‘colui che brucia i ponti dietro di sé non contratta più e
pone l’avversario … di fronte al tutto o niente’.
Tutto al contrario dell’URSS (che condivise in pieno con gli USA la strategia della
dissuasione) ‘il ragionamento che governa la strategia cinese non è … la logica della
dissuasione’ e ‘la tesi della tigre di carta … consiste nel mettere in gioco i fattori che
frenano l’utilizzo dell’arma nucleare’: visto che ‘chi conduce una guerra di lunga
durata può impedire che un avversario tecnicamente superiore prenda possesso del
territorio – ma non di annientare puramente e semplicemente il territorio ed i suoi
abitanti’, ‘per far … cedere [i cinesi] bisognerà atomizzare un quinto dell’umanità’,
cioè ammazzarli tutti, ma è dubbio che ciò sia politicamente, moralmente e
giuridicamente accettabile, sostenibile e fattibile.
La radicalità (il fanatismo?) di Mao è stupefacente e lo rende un nemico
pericolosissimo perché pronto a tutto ed inflessibile nella sua tensione verso la
vittoria totale (unico risultato accettabile), ma la realtà delle sue imprese fu piuttosto
diversa da questo modello ideale perché, come già aveva affermato von Clausewitz e
si è già visto nel paragrafo dedicato a Mao, la guerra di popolo da sola non basta e
infatti non bastò nemmeno a Mao.
Si è già ricordato che se il Giappone non avesse invaso la Cina Chiang kai-Shek
sarebbe riuscito ad eliminare il PCC, del resto già estremamente provato e comunque
63
sostenuto dall’URSS; mentre il PCC combatteva contro il Giappone adottando la
strategia della guerra di lunga durata gli invasori nipponici erano impegnati contro
l’esercito regolare cinese e dal 1941 anche contro gli Stati Uniti; dopo che l’URSS
volle concludere la guerra di Corea la guerra di Corea venne conclusa, piacesse o no
a Mao.
Questo non può significare dimenticare l’inesorabile decisione con cui i comunisti
cinesi, coreani, vietnamiti, cambogiani, si comportarono nelle guerre e nelle
rivoluzioni che combatterono; i prezzi immensi che furono sempre disposti a pagare
per compensare la loro inferiorità tecnologica e bellica; la sicurezza incrollabile nella
giustezza della loro missione: su questo punto la differenza con l’URSS è davvero
notevole, anzi incolmabile.
L’URSS era infatti pur sempre un paese europeo che riconobbe che la dissuasione
nucleare era una strategia inevitabile e l’unica politica praticabile: non così i
comunisti asiatici che a noi possono apparire senz’altro scriteriati esaltati ma che
percorsero fino in fondo la strada che avevano imboccato.
VIII
Glucksmann giudicò la dissuasione un dato ormai costante e stabilito della storia e,
come si è visto, ne fu un acceso sostenitore perchè la considerò foriera di pace ed
insuperabile ostacolo al risorgere dei regimi totalitari concentrazionari e
guerrafondai.
La visione di Glucksmann fu tuttavia a sua volta unilaterale: egli interpretò con
favore ogni mossa dell’Occidente che giudicò sempre e solo difensiva; le colpe
dell’Occidente per lui appartenevano tutte ad un passato con cui i conti erano stati
chiusi; vide nell’URSS (e nel comunismo) solo male e volontà aggressiva e
repressiva; ecc. ecc..
La sua analisi storica risulta così del tutto squilibrata ed incentrata sul pericolo
totalitario comunista che egli paventa e combatte con passione chiudendo però a sua
volta gli occhi sulle colpe e malefatte dell’Occidente che per lui era sufficiente
tenesse duro contro il comunismo.
IX
Glucksmann sviluppò con grande competenza e vastità di argomentazioni il periodo
della dissuasione nucleare al tempo della guerra fredda: quando scrisse l’opera
nessuno poteva immaginare che pochissimi anni dopo, già alla fine degli anni
Ottanta, le due super-potenze avrebbero proceduto a massicci e storici disarmi, ma è
proprio anche per questo che nella sua opera il tempo e l’atmosfera della guerra
fredda furono colti meglio e vennero analizzati ed esposti con maggior efficacia.
Essi furono vissuti, per così dire, dal di dentro.
Solo in forma del tutto teorica Glucksmann ammise, una volta sola e di sfuggita, che
all’età della dissuasione ‘esiste una via d’uscita. Una sola. La dissuasione fallirà se
sparirà un dissuasore, o due, o tutti’.
64
Ebbene fu esattamente questo che accadde cinque anni dopo la pubblicazione de ‘La
force du vertige’, quando l’URSS dopo tutta una serie di convulsioni sarebbe
improvvisamente crollata cogliendo tutti di sorpresa.
Ancora una volta - come sempre imprevedibile - la storia correva più veloce della
filosofia ed apriva nuovi scenari sui quali bisognava ricominciare a pensare da capo.
Si apriva l’età della globalizzazione, una nuova fase del cammino della storia
dell’uomo - e con essa una nuova guerra e un nuovo tipo di guerra.
Il dibattito sul mondo post-bipolare
Il crollo dell’Unione Sovietica ed il disfacimento del suo impero sia interno che
esterno giunsero inaspettati e sconvolsero profondamente il mondo intero per il quale
iniziava improvvisamente una nuova era che ben presto si sarebbe caratterizzata
come ‘globalizzazione’.
I mutamenti furono a dir poco traumatici e profondi: essi si fecero sentire in ogni
angolo del pianeta costringendo tutti a fronteggiare la nuova ed inattesa realtà.
Al vasto dibattito che seguì l’avvento della nuova era parteciparono molti autori e
studiosi: in questa sede verranno prese in esame le posizioni più significative e la cui
fama è più diffusa.
I
Francis Fukuyama (n. 1952), senior researcher presso la Rand Corporation,
scienziato politico, docente universitario e titolare di vari incarichi anche presso il
Dipartimento di Stato USA, con la notissima ‘La fine della storia e l’ultimo uomo’
(1992) fu il primo a tentare un bilancio della nuova situazione e del suo significato
profondo riproponendo senza esitazioni quella filosofia storicistica che fin dal
secondo Novecento era stata ormai abbandonata.
Lo storicismo è la filosofia che ritiene che la storia sia storia universale (cioè storia
del mondo intero) e che essa proceda incessantemente sulla strada dello sviluppo e
del progresso lungo un percorso necessario: soprattutto dopo gli orrori delle guerre
mondiali l’ottimismo di fondo che anima una filosofia del genere era sembrato
francamente improponibile, ma Fukuyama continua invece a vedere nello
svolgimento degli eventi la progressiva realizzazione di un processo unico e
costantemente teso al miglioramento.
Lo storicismo afferma che noi viviamo dunque nel migliore dei mondi possibili non
perché, come aveva sostenuto Leibniz, Dio non può che volere il meglio per un
mondo che rimane comunque imperfetto (come già aveva sostenuto Sant’Agostino),
ma perché tutto vi accade necessariamente (tutto accade come deve accadere e come
non può non accadere) secondo un ordine che tende al bene ed allo sviluppo, seppur
scontrandosi (e superando) con difficoltà ed ostacoli di ogni genere.
Secondo Fukuyama questo processo della storia universale non era poi un progresso
all’infinito come aveva immaginato Fichte ma, come aveva invece sostenuto Hegel,
65
aveva una vera e propria fine: per Hegel questa fine era stato il raggiungimento della
completa autocoscienza dello spirito assoluto (avvenuto nella sua filosofia) mentre
dal punto di vista storico-politico (lo spirito oggettivo) essa si era realizzata nello
stato prussiano post-napoleonico dei suoi tempi, mentre per Fukuyama il processo
riguarda solo il campo della storia e così la sua fine è avvenuta in un ben preciso
sistema sociale, politico ed economico, il capitalismo liberaldemocratico, che a sua
volta si è affermato e compiuto al meglio negli Stati Uniti.
Insomma: sia per Hegel che per Fukuyama il momento culminante e terminale della
lunga e necessaria evoluzione storica dell’intera umanità era ed è il sistema politico
vigente nel loro stato ai loro tempi e questo risultato era ed è stato finalmente
raggiunto dopo che questo loro stato era ed è uscito vincitore dallo scontro contro un
grande e terribile nemico – Napoleone in un caso e l’URSS nell’altro.
E’ evidente che queste autocelebrazioni lasciano il tempo che trovano e possono
servire semmai ad illustrare i sentimenti di coloro che escono trionfatori dopo una
dura prova, ma per comprendere appieno il discorso di Fukuyama è necessario
prendere in considerazione anche le motivazioni che lo conducono a questa
conclusione.
Come Comte aveva sostenuto che l’attività fondamentale dell’uomo erano la
conoscenza e la spiegazione dei fenomeni naturali, così anche secondo Fukuyama
l’unica attività umana che è costantemente cumulativa e progressiva è
(oggettivamente) lo sviluppo della scienza e della tecnica: Comte aveva poi affermato
che l’organizzazione politica derivava le sue forme e i suoi modi da questa primaria
attività, ed anche Fukuyama sostiene che lo sviluppo costante della scienza e della
tecnica comporta un analogo sviluppo della storia umana dovuto al continuo aumento
(qualitativo e quantitativo) della produzione di beni e della capacità di soddisfazione
dei bisogni (che crescono insieme alla possibilità di essere soddisfatti).
Dato questo assunto, così come Comte aveva esaltato il progresso industriale dei suoi
tempi, anche Fukuyama conclude facilmente che lo sviluppo tecnico-scientifico si
realizza al meglio nel sistema liberalcapitalistico occidentale (e non nel sistema
comunista) che a sua volta può esprimere in pieno ed al meglio tutte le sue
potenzialità nell’attuale epoca liberista e globalizzata.
L’inevitabile vittoria del sistema liberalcapitalistico sul suo ultimo nemico, il
comunismo, ha comportato così anche la fine della storia nel senso che ormai esso
non potrà che procedere realizzandosi ed affermandosi sempre più definitivamente: il
mondo descritto da Fukuyama appare così ordinabile e ordinato a seconda del grado
di sviluppo del sistema liberalcapitalistico (e conseguentemente delle economie) nei
vari paesi, tutti giudicabili con un unico metro di valutazione e collocabili lungo
un’unica scala.
Sarebbe questo il nuovo ‘pensiero unico’ - di cui Fukuyama è sicuramente uno dei
maggiori rappresentanti – quello cioè capace di ragionare su un solo modello e di
servirsi di una sola tipologia di valori (quelli occidentali), nuovo letto di Procuste con
cui gli altri sistemi possono essere solo confrontati (e rifiutati).
66
Non varrebbe nemmeno la pena di prendere in considerazione la tesi di Fukuyama
(qui riassunta in modo estremamente succinto) se essa non avesse avuto il successo
clamoroso in tutto il mondo che ebbe.
Dal punto di vista filosofico essa non dice nulla perchè è evidente (e assolutamente
inutile) sostenere che qualsiasi cosa sia accaduta ha avuto motivi per accadere e che
questi motivi sono stati necessari perché accadesse; è del tutto fantasioso concludere
che esisterebbe dunque un piano ed un disegno superiori che guiderebbero fin
dall’inizio gli eventi in una direzione precisa; ed è infine infondato ed arbitrario
proclamare che il fine ultimo di questa unica ed organica storia universale sarebbe
stato finalmente raggiunto: nella posizione di Fukuyama si trovano riuniti insomma
gli errori concettuali degli storicisti (la legittimazione a posteriori del fatto compiuto
e l’impossibilità di esprimere giudizi su un processo proclamato inevitabile e
necessario) e le miserie dei conservatori (tutto è perfetto così com’è e nulla deve
cambiare).
Dal punto di vista storico i silenzi e le omissioni di Fukuyama sono talmente grandi
da risultare incredibili: tacere sull’imperialismo occidentale e particolarmente
americano e sulle mille tensioni che costellano il mondo del XXI secolo e limitarsi
così a considerare il mondo globalizzato solo come un insieme di economie che
competono liberamente e pacificamente sul mercato unificato è una sciocchezza su
cui non ha davvero senso soffermarsi.
Purtroppo però non si tratta qui di un discorso semplicemente inutile o ignorante
perché sono proprio autori come Fukuyama a fornire il sostegno ideologico alle
politiche aggressive ed invasive degli USA (e dell’Occidente in genere), a proclamare
la superiorità degli occidentali su tutti gli altri popoli del mondo che risultano così
sempre arretrati ed in ritardo e dunque bisognosi di ‘spinte’, di ‘aiuti’ e di (più o
meno violenti) interventi ed intrusioni.
Quello di Fukuyama è insomma l’ultimo aggiornamento della solita (sempre più
insopportabile) pretesa dell’Occidente di avere il diritto e il dovere di portare
dovunque i propri valori, religione, progresso, sviluppo, civiltà, libertà, diritti civili,
democrazia, ecc. ecc., mentre invece è del tutto evidente che vuole semplicemente
mettere le mani sulle risorse e sui territori degli altri.
II
Samuel P. Huntington (1927-2008), politologo, consigliere dell’Amministrazione
Carter, direttore degli Studi Strategici e Internazionali di Harvard, fondatore di
‘Foreign Policy’, nel 1993 rispose al libro di Francis Fukuyama coll’articolo ‘Scontro
di civiltà?’ (ma questa ormai famosa definizione non era sua) cui nel 1996 seguì il
libro ‘Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale’.
Huntington si oppone all’ingenua ed ideologica convinzione che dopo la guerra
fredda la sola scelta e l’unica alternativa possibile per tutti i popoli e gli stati del
mondo siano ormai la liberaldemocrazia
ed i valori dell’Occidente: ben
diversamente, secondo Huntington l’ordine internazionale bipolare colla sua
intrinseca costrizione a schierarsi da una parte o dall’altra aveva congelato e bloccato
67
spinte e tensioni preesistenti, aveva imposto alleanze o contrapposizioni innaturali,
aveva semplificato un mondo ben più complesso e diviso ed aveva avuto insomma un
effetto distorsivo sull’evoluzione della storia di molta parte del pianeta (si potrebbe
aggiungere che anche il comunismo aveva prodotto semplificazioni e
riorganizzazioni dello spazio politico e molto spesso (più o meno imposte) forzature).
Fu così inevitabile che il crollo dell’URSS e la fine del comunismo e del bipolarismo
non generarono un mondo più unito ed armonico grazie al trionfo ed all’affermazione
di un modello unico di civiltà (e di pensiero), ma permisero invece la riemersione di
quelle linee di divisione che correvano e corrono non tanto o non solo fra stati,
quanto fra quei raggruppamenti umani di lenta formazione e di lunga durata che sono
le civiltà (occidentale, ortodossa, latino-americana, islamica, indù, cinese,
giapponese, buddhista e africana).
Dopo la divisione bipolare del pianeta (ma andrebbe aggiunto anche dopo la fine del
colonialismo e con la crisi degli stati di fronte all’internazionalizzazione dei mercati)
per Huntington oggi sta riaffiorando insomma quella storia profonda e radicata che
sono le civiltà, ben più fondative, resistenti ed importanti di ogni altra divisione
politica (come gli stati) perché in loro si è formata e riposa la vera identità dei popoli
e delle persone: si tratta insomma di un vero e proprio trionfo dello spirito sulla
materia e il mondo di oggi va riacquistando così la sua varietà, la sua complessità …
ma anche tutte le sue conflittualità.
L’intero pianeta è destinato a dividersi lungo le linee di confine delle civiltà con
conseguenti collaborazione fra simili ed inimicizia (più o meno forte) fra dissimili:
‘la mia ipotesi è che la fonte di conflitto fondamentale nel nuovo mondo in cui
viviamo non sarà sostanzialmente né ideologica né economica. Le grandi divisioni
dell’umanità e la fonte di conflitto principale saranno legate alla cultura. Gli stati
nazionali rimarranno gli attori principali nel contesto mondiale, ma i conflitti più
importanti avranno luogo tra nazioni e gruppi di diverse civiltà. Lo scontro di civiltà
dominerà la politica mondiale. Le linee di faglia tra le civiltà saranno le linee sulle
quali si consumeranno le battaglie del futuro’.
Corollario di questa teoria e che secondo Huntington è poi in corso una vera e propria
de-occidentalizzazione del mondo destinata ad ampliarsi sempre di più a causa della
crescita demografica dei popoli delle altre civiltà ed allo sviluppo economico della
Cina, dell’India e del Sud-Est asiatico (e non solo): nei paesi non-occidentali infatti
‘via via che il processo della modernizzazione [tecnologica e produttiva] aumenta …
il tasso di occidentalizzazione si riduce e la cultura autoctona torna ad emergere. In
seguito, l’ulteriore modernizzazione finisce con l’alterare gli equilibri di potere tra
l’Occidente e la società non occidentale, alimenta il potere e l’autostima di quelle
società e rafforza in esse il senso di appartenenza alla propria cultura’.
Queste tesi di Huntington parvero riecheggiare la tenebrosa profezia del ‘tramonto
dell’Occidente’ di Oswald Spengler, ma in realtà sembra più sensato riconoscere che
per Huntington il pianeta – pur globalizzato - sta tornando al multipolarismo ed al
multiculturalismo pre-coloniale e che l’Occidente sta tornando a rioccuparvi il posto
(ridotto) che gli compete.
68
Secondo Huntington è tempo insomma che l’Occidente riconosca di essere
semplicemente una fra le altre civiltà e non l’unica e l’universale (e quindi col diritto
di dominare): la politica della continua interferenza con le altre civiltà per impor loro
la propria basata su democrazia e diritti umani va dunque finalmente abbandonata
(anche perché, aggiungiamo noi, imporre con la forza la democrazia e i diritti umani
è una palese contraddizione e/o un evidente pretesto).
Per Huntington l’Occidente dovrebbe invece limitarsi a difendere entro i propri spazi
la propria identità ed i propri valori che non sono, né prevedibilmente saranno mai,
universalmente condivisi.
Il discorso di Huntington (fin qui estremamente sintetizzato) è senz’altro ben più
accettabile del patetico fervorino di Fukuyama, ma purtroppo anch’esso è fortemente
riduttivo rispetto alla complessità del nuovo scenario internazionale e basteranno
pochi esempi e poche considerazioni per rendersene conto.
Innanzitutto, la modernizzazione (tecnologica e industriale) del mondo è stata opera
dell’Occidente che ha così imposto al resto del pianeta almeno questa (estremamente
rilevante) parte della sua civiltà: le altre otto civiltà oggi non esistono più se non
mescolate e fuse con quella degli ex-dominatori (dunque sono completamente diverse
da quel che furono) e l’esistenza del mercato globale con tutti i suoi annessi e
connessi sta lì a dimostrarlo.
Huntington tenta di distinguere fra occidentalizzazione e modernizzazione
(‘l’Occidente era Occidente prima di essere moderno’), ma questa è un’affermazione
che non ha semplicemente senso perché una civiltà non è fatta di parti separabili;
perché la modernizzazione poteva nascere solo in Occidente e ne compie e realizza la
civiltà; e perché prima di modernizzarsi l’Occidente non era Occidente (se non in
senso geografico).
In secondo luogo, una delle nove civiltà identificate da Huntington è quella africana,
ma proprio i conflitti fra i popoli africani sono particolarmente violenti e sanguinari;
un’altra è quella ortodossa e proprio in questa primavera 2014 Ucraina e Russia sono
in uno stato di tensione acuta e sull’orlo di una guerra dalle conseguenze
imprevedibili; un’altra ancora è quella islamica ma soprattutto in questi ultimi anni
nel mondo islamico si sono scatenate lotte interne durissime e guerre civili come
quelle attualmente in corso in Libia e soprattutto in Siria.
Si potrebbe continuare, ma questi semplicissimi e banali accenni sono prove evidenti
che le linee di frattura sono ben più numerose, complesse e soprattutto disordinate di
quelle riconosciute e catalogate da Huntington: la conclusione è che non è possibile
riassumere lo stato del mondo in un’unica teoria ed ogni caso va analizzato in se
stesso.
III
Joel Kotkin, newyorkese di nascita ma docente di sviluppo urbano in California e
titolare di ulteriori incarichi, condivide sostanzialmente l’analisi di Huntington e
ritiene infatti che i ‘legami tribali – razza, etnia e religione -’ stanno diventando tanto
69
più importanti dei confini fra stati da fargli prevedere ed immaginare per la metà del
XXI secolo una completa ridistribuzione e divisione della popolazione mondiale in
nuove aree geopolitiche ridisegnate secondo queste appartenenze.
Ahmet Davutoglu, cattedratico divenuto ministro degli esteri turco, ritiene che il suo
paese (ma è questo un discorso che riguarda tutti) non deve certo costruire barriere
alle sue frontiere ma integrarsi progressivamente con sempre più popoli e stati in una
rete di rapporti e relazioni fondati sulla cultura e sull’economia che lui chiama
‘profondità strategica’.
In ambedue gli autori torna ancora una volta il concetto di superamento dei confini
nazionali grazie al riconoscimento della loro crescente irrilevanza in un mondo in cui
riaffiorano sempre più evidenti i legami profondi e secolari che hanno unito per tempi
lunghissimi gli appartenenti alle stesse civiltà: queste ultime erano state giudicate
spesso ricordi e cascami di un passato sepolto dal progresso (più o meno
violentemente imposto), onnivoro divoratore ed uniformatore nel suo nuovo modello
di tutto ciò che l’aveva preceduto, ed invece colla fine del bipolarismo sono riapparse
in tutta la loro importanza per aver forgiato e per forgiare l’identità stessa di popoli e
di etnie – e dunque come elementi fondamentali nella storia del XXI secolo.
Anche nei confronti di questi ultimi studiosi – come di tutti - non si può però non
ricordare quel che si è concluso a proposito di Huntington: il mondo è ben più
complicato e complesso di quel che menti pur brillanti cercano di immaginare, esso è
troppo più disordinato e quindi – ripetiamo - è semplicemente impossibile
racchiuderlo ed esprimerlo in un’unica teoria.
Sul senso della storia
Il mondo può essere certamente esaminato da un punto di vista e di osservazione (per
esempio quello dell’imperialismo americano) ed appare allora unico, ordinato ed
ordinabile, ma i punti di vista e di osservazione sono molteplici e spesso
inconciliabili e conflittuali: non esiste - né può esistere – dunque una teoria in grado
di fonderli in un’unità e di esprimere così la condizione oggettiva del mondo.
Insomma: le teorie che pretendono di dire una parola definitiva sulla situazione
politica internazionale hanno validità se e solo se sono elaborate per guidare le azioni
di uno stato (o di una qualsiasi altra formazione), cioè se riassumono, chiariscono e
condensano una prospettiva particolare fra le tante, ma filosoficamente – in quanto
pretese di enunciare il reale stato del mondo – esse valgono quanto le idee della
metafisica secondo Kant, e cioè nulla (anche se possono esercitare una qualche
funzione orientativa dei nostri pensieri).
Visto che il mondo è il luogo in cui molteplici forze si incontrano e si scontrano
ognuna secondo i suoi motivi, la sua storia ed il suo pensiero, non è possibile uscire
da questa relatività di posizioni per cogliere una loro supposta unità ed un presunto
ordine generale, né è possibile assurgere ad una punto d’osservazione unico e
superiore e ciò per almeno due motivi.
70
Innanzitutto, un ordine superiore in cui le varie e particolari motivazioni umane
trovassero unità e coerenza fra loro implicherebbe evidentemente una mente, una
logica, uno spirito, una ragione, un dio, ecc., che le avesse volute e che le dirigesse: si
tornerebbe a quella filosofia che asserisce (come Hegel) che non sono gli uomini a
fare la loro storia e che anzi essi sono mossi e diretti come marionette inconsapevoli
da una qualche forza onnipotente che ne tira i fili - ma questa è un’evidente ed
insostenibile sciocchezza.
In secondo luogo, risulta incomprensibile come mai e in virtù di quale capacità
superiore qualche uomo sarebbe riuscito ad elevarsi al di sopra dell’umanità stessa
per cogliere la realtà profonda delle azioni, altrimenti inconsapevoli, di tutti gli altri
uomini.
Eppure non ci si può fermare a questo risultato puramente negativo: il discorso sulla
storia ha bisogno di essere approfondito per cercare di rispondere alla domanda se la
storia ha comunque un senso, se questo senso esiste e, se esiste, qual è.
Per senso della storia qui si intende che gli eventi sono connessi fra loro e che tali
connessioni (o, almeno, le principali) sono conoscibili.
I
I filosofi che per semplicità possono essere chiamati irrazionalisti (come per es.
Schopenhauer, Kierkegaard, ecc.) negano che questo senso esista, o che comunque
valga qualcosa, ed alla loro posizione si adatta benissimo la proposizione 6.341 del
‘Tractatus’ di Wittgenstein (che comunque qui stava parlando d’altro):
“… Pensiamo una superficie bianca, con sopra macchie nere irregolari. Noi diciamo
ora: Qualunque immagine ne nasca, sempre posso avvicinarmi quanto io voglia alla
descrizione dell’immagine, coprendo la superficie con un reticolato di quadrati
rispondente al fine e dicendo d’ogni quadrato che è bianco, o nero. A questo modo
avrò ridotto la descrizione della superficie in forma unitaria. Questa forma è
arbitraria, poiché avrei potuto impiegare con uguale successo una rete di maglie
triangolari o esagonali. … Alle diverse reti corrispondono diversi sistemi di
descrizione del mondo. …”.
Il significato di tutto ciò è chiaro: i fatti sono quelli che sono e non hanno alcuna
connessione fra loro; le varie filosofie (della storia) vengono calate su di essi per
permetterci di organizzarli in un disegno che li renda comprensibili, ma esse non
fanno parte della storia stessa (sono invece nostri artifici intellettuali), quindi il
disegno tracciato in base ad esse è una creazione arbitraria: ogni filosofia sarebbe
insomma in grado di ricostruire e di spiegare la storia a sua immagine e somiglianza
ed ognuna di queste ricostruzioni e spiegazioni della storia sarebbe diversa da quelle
offerte da ognuna delle altre filosofie.
La storia, insomma, non avrebbe un suo senso proprio, ma dargliene uno sarebbe
sempre possibile, seppur arbitrario.
Questa concezione della storia che la considera un caotico guazzabuglio di eventi
senza alcun ordine non è tuttavia accettabile perché cozza contro l’evidenza di tutta
71
la serie di praticamente infiniti nessi causali che li connettono invece fra loro - e che
possono oltretutto essere compresi e spiegati. Il senso della storia esiste.
II
Il vero problema comincia però adesso, proprio quando – stabilito che c’è - si deve
chiarire però di che senso si tratti.
Su questo punto le posizioni dei vari filosofi della storia sono ancora una volta
numerose e diverse, ma, dovendo semplificare, esse possono venir divise in due aree
a seconda della risposta che danno alla domanda ‘chi è l’artefice della storia?’: a tale
domanda si può infatti rispondere che:
a) la storia non è fatta dagli uomini;
b) la storia è fatta dagli uomini.
a) A partire almeno dagli Stoici (III a.C.) per finire con Vico (XVIII), Hegel (XIX) ed
il neoidealismo italiano (Croce e Gentile), molti filosofi hanno sostenuto che la storia
ha un suo ordine interno, una sua logica di sviluppo, una sua forza intima (il Logos, la
Ragione, lo Spirito, ecc. o, per alcuni cristiani, Dio) che muove gli uomini come
passeggeri su un vagone; Hegel arrivò a parlare di ‘astuzia della Ragione’ per far
comprendere come questo soggetto universale usava i grandi protagonisti della storia
(lui aveva in mente Napoleone) che, credendo di perseguire i loro obiettivi, in realtà
realizzavano fini di cui non erano nemmeno consapevoli.
Versioni meno ‘intellettuali’ di queste filosofie parlano di destino, fatalità, ecc., ma il
principio è sempre lo stesso: noi non siamo padroni (né dunque responsabili!) di quel
che accade e che ci accade.
Probabilmente le motivazioni che portano a queste filosofie sono fondamentalmente
due, ma entrambe rispondono allo stesso principio di economia psichica, cioè al
tentativo di trovare spiegazioni (al senso del corso degli eventi) col minor sforzo
intellettuale possibile.
La prima è che è confortante credere che gli eventi accadono come accadono perché
qualcuno o qualcosa li vuole così e che questo qualcuno o qualcosa è talmente grande
che possiamo solo accettarlo (e metterci l’animo in pace): ‘Perché è successo
questo?’ ‘Perché era destino, perché l’ha voluto Dio’, ecc.: tutto è chiaro e non ci si
pensi più.
La seconda motivazione dei sostenitori di questo tipo di filosofia è che essi partono
anche (e, si spera, soprattutto) da un’osservazione senz’altro giusta, e cioè che troppe
cose accadono senza che nessuno le abbia previste e volute e che continuamente si
verificano esiti imprevisti (ed imprevedibili): per esempio da almeno un millennio
possiamo parlare di ‘progresso’ senza che nessun piano umano sia stato concepito (né
sarebbe stato umanamente concepibile, né tantomeno attuabile) in questo senso.
Come non concludere allora che ci dev’essere una regia universale ben al di sopra
degli uomini e che di conseguenza questi sono solo pedine inconsapevoli (o,
comunque, ben poco consapevoli)?
72
L’osservazione di cui sopra è sicuramente fondata e merita una spiegazione, ma
quella che sostiene l’esistenza di un soggetto autore universale (comunque lo si
chiami) è a dir poco infantile (cioè mitologica) e non vale niente: alla domanda
‘perché è accaduto questo?’ rispondere ‘perché Dio ha voluto così’ o ‘perché la legge
del progresso ha richiesto questo passaggio’, ecc., significa ‘questo è accaduto così
perché doveva accadere così’ … ma questo è un semplice giro di parole!
b) Chi dunque sostiene – come avviene in queste pagine - che sono gli uomini a fare
la storia si trova anche a dover spiegare perché allora essa li sorprende così spesso e
come è possibile che sia tanto imprevedibile.
Ebbene, i piani, i progetti, le azioni di ogni uomo e di ogni gruppo si incrociano
continuamente con quelli di altri e da ognuno di questi incontri le motivazioni
degli uni e quelle degli altri escono modificate e cambiano così la direzione
dell’intero corso degli eventi.
Ecco perché la storia è imprevedibile, ecco come si risolve l’apparente paradosso
dell’ ‘eterogenesi dei fini’ di Max Weber e perché i futurologi sbagliano sempre: essi
tengono conto solo della direzione di una sola serie di fatti, non anche del suo
incrociarsi con quelli di altre serie e quindi delle conseguenti continue modifiche
dell’intero corso degli eventi.
Un esempio: un minuto prima che due futuri genitori si incontrassero per la prima
volta nessuno dei due conosceva nemmeno l’esistenza dell’altro e si trovarono
dunque nello stesso luogo nello stesso momento per cause (o serie causali) diverse ed
indipendenti l’una dall’altra, ma quell’incontro - che evidentemente non potè
assolutamente essere voluto da nessuno dei due - nondimeno cambiò le loro vite
perché da quel momento essi agirono in un modo nuovo e (ripetiamolo) prima
imprevedibile (e fece sì che un bambino venisse al mondo).
Insomma: è ovvio che furono i due futuri genitori a scegliere di sposarsi, ma non di
incontrarsi e, dunque, agirono anche in seguito ad un evento del tutto fortuito.
Ecco allora che solo ricostruendo a posteriori quel che è avvenuto lo storico può
scoprire quel mix di caso e di necessità (queste due parole sono impiegate
volutamente per ricordare ‘Il caso e la necessità’ di Jacques Monod, anche se venne
scritto a proposito dell’evoluzionismo) che rendono gli eventi comprensibili e
razionali nel loro accadere, ma, appunto, solo a posteriori, solo dopo che sono
accaduti perché, mentre accadevano (o, addirittura, prima che accadessero), il loro
incrociarsi, e dunque la nascita di altri eventi e comportamenti, non era in alcun modo
prevedibile: le previsioni sono insomma sempre un azzardo perché non tengono (né
possono tenere) conto del possibile (e probabile) incrocio con altre serie causali indipendenti appunto da quelle su cui si erano fondate le previsioni stesse.
Intendiamoci: così come Newton disse che se avesse conosciuto precisamente lo stato
di quiete e di moto di ogni particella dell’Universo avrebbe potuto prevederne la
storia (fisica) dei secoli seguenti, allo stesso modo ci sarà sempre qualcuno che potrà
dire che Dio o lo Spirito o la Ragione ecc. ha predisposto in partenza tutto questo
intrico ed incrociarsi di serie causali che modificano l’intero divenire per muovere
l’intera storia secondo i suoi disegni superiori, ma questo pensiero non dice nulla
73
(quindi non è nemmeno un pensiero) perché noi siamo uomini, solo uomini, e non
possiamo né pensare né agire al di sopra dei nostri limiti: oltretutto immaginare che
siamo nelle mani di forze onnipotenti ed imperscrutabili lascia le cose esattamente
come sono e non può modificare in alcun modo i nostri comportamenti - a meno che
una casta sacerdotale non pretenda di esercitare il potere in nome di una sua supposta
conoscenza di questo mistero, ma questa è davvero un’altra faccenda.
Anonimous: l’asimmetrica jihad difensiva
Lo studio di Anonimous sulla guerra al terrore è un bell’esempio di quanto appena
sostenuto.
Nel 2004 Anonimous si autodefinì così: ‘io sono stato un analista [statunitense] ed ho
gestito attività di analisi ed operative. Negli ultimi diciassette anni la mia carriera si è
focalizzata esclusivamente su terrorismo, insurrezioni islamiche, Islam militante e
sugli affari riguardanti l’Asia meridionale – Afghanistan e Pakistan’: il suo studio su
al-Qaeda e su Osama bin Laden è dunque quanto di meglio si possa trovare.
Anonimous prende in esame i nudi fatti e li fa parlare per quel che sono in se stessi;
ascolta tutti gli attori della vicenda, li prende tutti sul serio e sa porsi dal punto di
vista di ognuno di essi; pur essendo (ovviamente) completamente dalla parte degli
USA, egli studia anziché demonizzare il nemico perché ritiene che per combatterlo
bisogna comprenderlo e che per comprenderlo bisogna prenderlo sul serio –
rispettarlo! - ; infine, non si affida mai a teorie generali e preconfezionate ed anzi se
vi accenna lo fa per dire che sono sbagliate e frutto di ignoranza e/o di pregiudizio.
Grazie a questo abbandono delle teorie globali onnicomprensive ed a questo
completo radicamento del pensiero nella realtà (‘effettuale’ direbbe Machiavelli)
Anonimous riesce dunque ad esaminare freddamente e realisticamente l’intera
situazione: la sua è dunque una grande lezione di metodo che in queste pagine - che
parlano di filosofia piuttosto che di storia - viene particolarmente apprezzata e
valutata.
I
Innanzitutto Anonimous si chiede qual è la causa del cosiddetto terrorismo islamico di al-Qaeda e di Osama bin Laden in particolare - e la risposta la trova in quel che gli
stessi cosiddetti terroristi vanno da sempre dicendo e proclamando apertamente (ma
che in Occidente non è mai stato ascoltato): ‘bin Laden è stato preciso nel dire
all’America le ragioni perché ci sta muovendo guerra. Nessuna di queste ragioni ha a
che fare con la nostra libertà e con la nostra democrazia, ma esse hanno tutto a che
fare con le politiche e le attività americane nel mondo mussulmano. … Egli non
potrebbe avere tanto successo se i mussulmani non credessero che la loro fede, i loro
fratelli, le loro risorse e le loro terre sono sotto attacco da parte degli Stati Uniti e più
in generale dell’Occidente’.
74
L’aggressione e la minaccia occidentale si aggravarono ulteriormente al tempo della
prima guerra del Golfo all’inizio degli anni Novanta, quando le truppe americane e
quelle degli alleati occuparono tranquillamente e sciamarono liberamente in tanti stati
arabi e soprattutto in Arabia Saudita, la custode dei principali luoghi santi dell’Islam.
Secondo i cosiddetti fondamentalisti islamici i mussulmani sono aggrediti dovunque
nel mondo: ‘la politica USA sostiene l’oppressione e spesso l’aggressione dell’India
indù in Kashmir, dei cattolici filippini a Mindanao, della Russia cristiana ortodossa in
Cecenia, dei comunisti cinesi nello Xinjiang, degli apostati sauditi nella Penisola
Arabica, degli ebrei israeliani in Palestina. Per assicurarsi la cooperazione di questi
governi contro al Qaeda … gli USA hanno anche inviato truppe per aiutare i governi
ad uccidere i mujaheddin nelle Filippine, nel Caucaso, nello Yemen e in Africa
orientale’, oltre naturalmente a sfruttare le risorse dei paesi mussulmani e ad
insediarvisi con proprie basi grazie a governi compiacenti, apostati e corrotti.
Ecco allora quali sono ‘i chiari, focalizzati, limitati e largamente popolari scopi della
politica estera di bin Laden: la fine del sostegno americano a Israele e la definitiva
eliminazione di tale stato; il ritiro delle forze americane ed occidentali dalla Penisola
Arabica; il ritiro delle forze americane ed occidentali dall’Iraq, dall’Afghanistan e
dalle altre terre islamiche; la fine del sostegno americano all’oppressione dei
mussulmani operata da Russia, Cina e India; la fine della protezione americana dei
repressivi ed apostati regimi in Arabia Saudita, Kuwait, Egitto, Giordania, ecc.; la
conservazione delle risorse energetiche del mondo mussulmano e la loro vendita a
prezzi più alti’.
Anche Huntington riconosce che ‘l’Occidente non ha conquistato il mondo con la
superiorità delle sue idee, dei suoi valori o della sua religione, ma attraverso la sua
superiorità nell’uso della violenza organizzata. Gli occidentali lo dimenticano spesso,
i non-occidentali mai’, ma negli USA e in Occidente questa pur ovvia verità è troppo
scomoda e politicamente troppo scorretta per poter essere accettata, così si preferisce
non prenderla nemmeno in considerazione e precisamente questa è una delle due
cause della cecità occidentale nei confronti del fenomeno, l’altra essendo semplice
ignoranza e pigrizia mentale.
Anche Rashid Khalidi (a proposito della guerra in Iraq piuttosto che di quella in
Afghanistan) riconosce con amarezza questa completa ed oltretutto veramente
offensiva ignoranza e conseguente impreparazione dell’Occidente a proposito del
mondo arabo ed islamico, ma Anonimous su questo punto è addirittura violento e
continuamente sferzante.
Come si vede, per Anonimous le motivazioni degli insorgenti islamici sono più che
comprensibili, sicuramente fondate ed erano già state decisive nella resistenza contro
l’invasione sovietica dell’Afghanistan quando ‘bin Laden … e migliaia di
mussulmani non afghani accorsero per combattere l’Armata Rossa non perché i
sovietici erano atei e comunisti … ma piuttosto perché erano atei e comunisti che
avevano invaso e occupato una terra mussulmana, avevano ucciso
indiscriminatamente più di un milione di uomini, donne e bambini mussulmani, ne
avevano spinti oltre tre milioni in esilio e chiaramente cercavano di sradicare l’Islam
dal paese’.
75
II
Comunque, riconosciuto o no dall’Occidente, era in questo contesto di sentimenti
offesi e di minacce percepite che bin Laden operava: ‘bin Laden e i suoi sodali non
sono spinti dal ‘fallimento della società mussulmana’ di modernizzarsi e di evolversi
secondo il riuscito modello occidentale’: anche se è vero che soprattutto nei paesi
arabi ‘le disposizioni dei governi postcoloniali … hanno ulteriormente asservito i
mussulmani anziché liberarli’ e che ‘molti milioni di mussulmani … incolpano
l’Occidente di questo fallimento e bramano di ricorrere alla violenza indiscriminata
alla ricerca di vendetta … bin Laden … non è uno di questi’ perché ‘attribuisce il
successo dei [moderni] crociati al fatto che molti mussulmani … mancarono di
prendere parte alla jihad difensiva … e quindi di lavorare per riaffermare la
grandezza dell’Islam’.
Bin Laden è stato fondamentale nell’orientare il profondo risentimento del mondo
mussulmano e nel dargli una nuova ed unitaria direzione perché, dopo essere accorsi
in Afghanistan per combattere contro l’Armata Rossa ed averla scacciata, ‘molti
[mujaheddin] tornarono a casa dopo la guerra per combattere contro i loro governi
nazionali’ e fu proprio da allora che ‘bin Laden ha lavorato duro per spostare il fuoco
dell’attacco dagli stati-nazione mussulmani verso gli Stati Uniti, sostenendo che gli
stati-nazione sopravvivevano solo grazie alla protezione ed al supporto USA’.
L’invito di bin Laden a tutti i combattenti per fede (‘State attenti … a non
frammentare i vostri sforzi e a non dissipare le vostre risorse in battaglie marginali
coi lacchè e con le parti, ma concentrate i colpi alla testa dell’infedele finchè non
collasserà. Una volta che sarà collassato tutte le altre parti collasseranno, svaniranno
e saranno sconfitte’) li convinse a mirare tutti insieme al cuore del nemico: anche se i
colpi contro i regimi dei paesi mussulmani non cessarono certamente, è in questa
concentrazione contro gli USA che ‘la multinazionale e multietnica organizzazione al
Qaeda rappresenta un risultato tremendo – davvero senza precedenti nel mondo
islamico moderno – attribuibile in larga parte alla leadership di bin Laden ed alla sua
abilità nel mantenere l’odio dei membri di al Qaeda fisso sugli Stati Uniti’: ‘il genio
di bin Laden consiste … nel costruire ed articolare la consistente e convincente tesi
che è in corso un attacco all’Islam guidato e diretto dall’America’ e ‘il modo in cui
bin Laden percepisce gli intenti delle politiche e delle azioni americane risulta essere
condiviso dalla gran parte del mondo islamico’, così che ‘gran parte del miliardo e
trecento milioni di mussulmani ci odia’ e questo ‘odio bin Laden l’ha convogliato e
concentrato – ma non causato – contro gli Stati Uniti e più generalmente contro
l’Occidente’; ‘l’odio modella ed informa le reazioni dei mussulmani alle politiche
americane ed alla loro messa in atto’ e ‘la minaccia che Osama bin Laden pone
risiede nella coerenza e nella compattezza delle sue idee, nella loro precisa
articolazione e negli atti di guerra che egli intraprende per renderle effettive’.
‘Atti di guerra’ li chiama Anonimous perché ‘le azioni militari di al Qaeda e dei
suoi alleati sono atti di guerra, non terrorismo; esse fanno parte di una jihad
difensiva’.
76
Insomma: ‘bin Laden vuole cambiare drasticamente le politiche americana ed
occidentale nei confronti del mondo islamico, non necessariamente distruggere
l’America, ancora meno le sue libertà. Egli è un guerriero pratico, non un terrorista
apocalittico’ ed è sbagliato sostenere come si fa abitualmente in Occidente che ‘bin
Laden predica e pratica una forma aberrante di Islam … [e che] è semplicemente un
assassino esaltato che usa la retorica religiosa per giustificare i suoi attacchi’ perché
in realtà ‘bin Laden sta conducendo una jihad difensiva contro gli Stati Uniti’ che non
a caso chiama colonialisti (cioè eredi e continuatori del colonialismo europeo) e
crociati (cioè aggressori e conquistatori delle terre islamiche).
‘Il governo USA ritiene … che … al Qaeda ed i suoi alleati … sono terroristi,
grossomodo dello stesso tipo dei terroristi di stato che abbiamo affrontato fin dagli
anni Settanta, solo che ce ne sono di più. Questo non è l’assunto sul quale operare.
Mentre è chiaramente sbagliato identificare al Qaeda come uno stato-nazione –
soprattutto perché non ha un indirizzo stabile – è un errore più grande e più dannoso
descriverli come terroristi. … Dobbiamo … accettare il fatto … che bin Laden e al
Qaeda stanno guidando un’insurrezione islamica popolare, mondiale e sempre
più potente … e le guerre contro un’insurrezione guidata in modo competente …
durano di più, costano più vite e denaro e sono più sistematicamente brutali che
episodici confronti coi terroristi. … l’America è in guerra con una forza diretta
religiosamente’.
Le modalità di questa jihad difensiva sono gli eclatanti e sanguinosi attentati spesso
suicidi contro gli americani che hanno puntellato tutta la storia di al Qaeda: Aden
(Yemen) nel 1992, Mogadiscio (Somalia) nel 1993, primo tentativo alle Torri
Gemelle (1993), Riyadh (Arabia Saudita) nel 1995, Dharhan (Arabia Saudita) nel
1996, Nairobi (Kenia) e Dar es Salaam (Tanzania) nel 1998, ancora Aden nel 2000
fino alle Torri Gemelle di New York il famosissimo 11 settembre 2001.
Per scompaginare l’avversario e chiamare a raccolta le masse islamiche per la lotta
gli attentati clamorosi sono la tattica militare giudicata la più adatta per due motivi
principali: innanzitutto, la sproporzione delle forze è talmente immensa da rendere
impensabile qualsiasi scontro aperto con l’Occidente (per questo quella che si sta
svolgendo fra mondo mussulmano e Occidente è una ‘guerra asimmetrica’) e, in
secondo luogo, bin Laden si muove nel mondo islamico la cui fede è certamente ben
più accesa, sicuramente ben più militante (combattere l’invasore infedele è un dovere
di ogni mussulmano!) e molto più pervasiva di quella cristiana, tanto da esaltare
addirittura il martirio, cioè il sacrificio volontario della propria vita per la riuscita di
un attentato, cioè di un’azione della guerra santa.
Tuttavia questi due motivi spiegano solo le modalità con cui la guerra viene vissuta e
condotta dal mondo islamico - non la guerra stessa!
III
Di fronte a questo tentativo di riscossa del mondo islamico gli USA e l’Occidente si
sono trovati di fronte ad un brutto (per loro) dilemma: o riconoscere le ragioni
dell’avversario e cambiare la propria politica – ma ciò avrebbe significato negare se
77
stessi! – o eliminare le organizzazioni islamiche nate contro il loro imperialismo e
continuare come prima e come se niente fosse questa loro politica.
Data la sua concreta e completa impraticabilità, la prima alternativa non è mai stata
presa nella minima considerazione e ovviamente non potè che essere scelta senza
discussioni la seconda: questa ‘politica dello status quo non lascia all’America che
l’opzione della guerra di annientamento’, ma questo non può giustificare la disonestà
e/o cecità intellettuale che l’Occidente continua a manifestare a proposito del
problema: ‘nel decidere come affrontare la minaccia islamica uno dei più grandi
pericoli per gli americani consiste nel continuare a credere … che i mussulmani ci
odiano e ci attaccano per quello che siamo e che pensiamo piuttosto per quel che
facciamo’, ma questa tesi occidentale è fin troppo comoda innanzitutto perché scarica
tutte le colpe e tutte le responsabilità sull’avversario che viene considerato un
fanatico, pazzoide e sanguinario oscurantista, e in secondo luogo perché continua a
giustificare, legittimare e proclamare portatrici di progresso e di libertà le politiche
imperialiste americane e occidentali.
Soprattutto però è completamente falsa perché, come Anonimous ha già ampiamente
sostenuto, in generale ‘i mussulmani prendono il mondo come viene … nonostante
possano essere più offesi dei membri di altre confessioni da alcuni aspetti della
modernità’ ma ‘la minaccia focalizzata e letale posta alla sicurezza nazionale
americana non nasce dal fatto che i mussulmani sono offesi da quello che l’America
è, ma piuttosto dalla loro plausibile percezione che le cose che essi più amano e
considerano – Dio, Islam, i loro fratelli e le terre mussulmane – sono attaccate
dall’America’.
‘In bin Laden e nei nostri nemici islamici non c’è nulla di apocalittico o di
narcisistico. Essi non stanno cercando di distruggere il mondo in uno scontro tipo
Armageddon, né sono persone psicologicamente sconvolte inclini e deliziate
nell’assassinare innocenti’; quella di bin Laden e dei militanti islamici ‘è una guerra
contro un obiettivo specifico e per scopi specifici e limitati … il loro scopo non è
quello di spazzare via la nostra democrazia secolare, ma di dissuaderci con mezzi
militari dall’attaccare le cose che amano’.
IV
Il metodo di indagine di Anonimous è sicuramente quello da adottare ed è
apprezzabile il suo sforzo di esaminare le posizioni del nemico con assoluta apertura
mentale libera dai pregiudizi e dalle chiusure del politicamente corretto, però anche
alla sua analisi possono essere mosse obiezioni che appaiono effettivamente
insuperabili.
Innanzitutto, Anonimous meritoriamente racconta e prende sul serio tutte le accuse
che il mondo mussulmano muove all’Occidente (e soprattutto agli USA) e quanto
esso si senta minacciato dalle loro politiche neo-coloniali (dopo quelle coloniali),
tanto da individuare la causa dell’insorgenza islamica nel conseguente desiderio di
liberazione e di riscossa, tuttavia non spende una parola (una) per giudicare se queste
accuse sono fondate o no, se corrispondono o no a verità, né – soprattutto - cosa
78
l’Occidente e gli USA rispondono (se lo fanno) ad esse: in questo modo Anonimous
viola così il suo stesso metodo perché trascura una delle parti in causa (la propria!).
In secondo luogo, bin Laden, al Qaeda e i fondamentalisti sono considerati tout court
il mondo islamico, gli unici che lo rappresentano, tutti gli altri essendo corrotti e/o
traditori: non c’è dubbio che questo sia quel che pensano i mussulmani che
insorgono, ma è evidente che essi non sono i soli islamici e che quelli fra loro più
moderati o laicizzati che non scendono in guerra dovrebbero avere esattamente gli
stessi loro diritti, ma Anonimous non li nomina nemmeno mai!
In terzo luogo, visto che Anonimous non ha mai nulla da obiettare alle accuse ed alle
motivazioni di bin Laden e di al Qaeda, ipso facto le riconosce pienamente veritiere:
dalla sua analisi risulta allora inequivocabilmente che secondo questo singolare
agente dei servizi USA bin Laden ed al Qaeda sono interamente dalla parte della
ragione (e l’Occidente e gli USA da quella del torto), ma nonostante ciò Anonimous
non spende una parola una per indicare rimedi a questa situazione che non siano la
guerra a bin Laden e ad al Qaeda.
In quarto luogo, agli USA Anonimous riserva sempre e solo sferzanti rimproveri che
si traducono in costanti, aperti e ripetuti insulti ma - oltre al fatto che sembra poco
credibile che egli non trovi una sola cosa buona nella risposta del suo paese (per il
quale attivamente lavora!) all’insorgenza islamica – tutti gli errori che egli rileva
nella politica USA vertono sull’inadeguatezza della loro risposta che egli ritiene
dovrebbe essere sì di (una generica ed appena accennata) revisione della loro politica
estera, ma contemporaneamente e soprattutto più radicalmente ed efficacemente
militare! Insomma: bin Laden e al Qaeda hanno ragione a dichiarare guerra agli USA,
i quali a loro volta sbagliano completamente le strategie e le tattiche che impiegano
per schiacciarli … come dovrebbero fare!!!
In quinto luogo, Anonimous è troppo occupato a difendere bin Laden e al Qaeda (per
i quali mostra solo comprensione e apprezzamento) per considerare anche i torti e le
colpe del mondo islamico che nel suo discorso risulta essere sempre la vittima di
oppressioni subite e di ingiustizie patite, ma ciò è assolutamente falso ed
inaccettabile: dovunque nel mondo, ma attualmente soprattutto in Africa (araba e
nera) è fin troppo palese invece quanto sia difficile, per non dire impossibile,
convivere coi mussulmani, quanto intolleranti essi sono e quanta violenza sanno
impiegare nei confronti di coloro che giudicano infedeli, cioè di tutti gli altri.
In conclusione: Anonimous è assolutamente troppo parziale e, oltretutto, lo è a favore
della parte avversa a quella in cui milita e lavora; anche se giudica che la ragione è
totalmente da questa parte avversa e contro la quale milita e lavora, vorrebbe
ugualmente che venisse annientata tanto che rimprovera gli USA (che afferma essere
dalla parte del torto) di non averlo saputo fare: pensa infatti che a causa dei suoi
ritardi e delle sue indecisioni ‘l’America … ha perso l’occasione unica di far saltare
al Qaeda e i talebani all’età della pietra’ (!) e si propone così di insegnare ai suoi
connazionali proprio le giuste tattiche e strategie adatte allo scopo!
E’ vero che egli afferma che ‘la vittoria [degli USA, s’intende] risiede in un’ancora
indeterminata mescolanza di azioni militari più decise con un drammatico
79
cambiamento di politica estera; nessuno dei due basta da solo’, ma su questo
drammatico cambiamento di politica estera formula solo isolati e vaghi accenni.
V
Comunque, dopo l’11 settembre gli USA intrapresero (in ritardo) la guerra in
Afghanistan per schiacciare al Qaeda che vi si era insidiata fin dal 1996 in seguito
alla vittoria dei talebani del mullah Omar, ma qui (come in Iraq per chiudere i conti
con un altro nemico) essi non vollero combattere semplicemente una guerra
‘normale’ ma, sempre in nome della stessa cieca e ignorante presunzione, insistettero
(e insistono) invece nel voler imporre agli afghani (ed agli irakeni) il sistema di
governo e di valori occidentali, una pretesa assurda che non può che provocare
disastri, nuovi odi ed ulteriori incomprensioni: anche Huntington lo riconosce: ‘nel
mondo che emerge, un mondo fatto di conflitti etnici e scontri di civiltà, la
convinzione occidentale dell’universalità della propria cultura comporta tre problemi:
è falsa, è immorale, è pericolosa ... l’imperialismo è la conseguenza logica e
necessaria dell’universalismo’.
La storia della guerra in Afghanistan non rientra nei temi di queste pagine (che
vogliono essere di filosofia) cui interessa invece il metodo di ricerca di Anonimous,
fatto di spregiudicatezza e, soprattutto, di abbandono delle facili teorie globali in
favore di studi ogni volta particolari e fondati su una stretta aderenza ai fatti: egli
scrive nel 2004 e, data l’adozione delle sopra ricordate premesse e strategie sbagliate,
prevede che la guerra in Afghanistan finirà in un disastro perché secondo lui ‘è una
guerra che l’Alleanza non può vincere a meno che l’America … non sia disposta ad
occupare indefinitamente l’Afghanistan’; ‘l’attuale regime afghano [di Karzai] non
può sopravvivere a meno che le forze straniere guidate dagli USA non vengano
massicciamente incrementate, non siano preparate ad uccidere generosamente e non
rimangano in permanenza in Afghanistan’.
VI
Dieci anni dopo è fin troppo facile riconoscere che gli americani ed i loro alleati sono
effettivamente rimasti nell’Afghanistan spartito in zone d’influenza e che hanno
dimostrato la massima risolutezza nel voler stroncare con la forza e senza scendere a
nessun compromesso quello che chiamano terrorismo islamico eliminando i nemici
uno alla volta (come è avvenuto con lo stesso bin Laden il 2 maggio 2011).
A dispetto delle previsioni di Anonimous la missione in Afghanistan sembrerebbe
quindi compiuta e per quest’anno - tre anni dopo quello completo dall’Iraq - è
previsto il ritiro delle truppe straniere (o, almeno di un gran numero di esse) dal
paese, ma è dubbio che davvero questa sia la strada per risolvere il problema –
ammesso poi che sia risolvibile!: Anonimous (e tanti altri) sono infatti lì a ricordarci
che le cause dell’insorgenza islamica sono ancora tutte sul campo né si riducono certo
alla sola al Qaeda, anzi forse si sono addirittura accresciute o approfondite, e non è
combattendone gli effetti che esse spariscono.
80
Secondo Anonimous bisognerebbe allora che innanzitutto l’Occidente e, soprattutto,
gli Stati Uniti imparassero a riconoscere le ragioni del mondo islamico invece di
pensarlo sempre secondo le proprie categorie – giudicate le uniche vere e giuste ma, come direbbe Glucksmann, questa è innanzitutto una battaglia mentale.
Il fatto è che questa ignoranza e cecità nei confronti delle ragioni e dell’esistenza
stessa dell’altro, anzi, la sua vera e propria negazione, è ‘un modo di pensare che le
élites americane hanno acquisito fin dalla fine della seconda guerra mondiale’ e la
polemica nei suoi confronti è uno dei temi su cui Anonimous insiste con maggior
forza: secondo lui la cieca fiducia in se stessi è arrivata al punto tale che ‘mandiamo
diplomatici, ufficiali e predicatori a persuadere forzosamente i mussulmani ad
occidentalizzare il Corano, le tradizioni e i detti del Profeta’, convinti come siamo
che ‘l’America non ha bisogno di riconsiderare le sue politiche, né tantomeno
cambiarle; essa deve semplicemente spiegare meglio al mondo mussulmano che non
li capisce la rettitudine delle sue vedute e la purezza dei suoi propositi’.
Anonimous fa così proprie le parole di Joshua Mitchell secondo cui ‘la politica estera
americana in Afghanistan e in Iraq è guidata da un principio così inscritto nella
psiche americana da diventare una sindrome: caccia via i tiranni e allora cittadini e
leaders si uniranno per portare quella libertà che la presenza del tiranno impediva.
Accadde in America; sicuramente accadrà altrove. Di qui la nostra guerra di
liberazione per liberare l’Iraq del suo Giorgio III. … La nostra politica estera soffre
della sindrome del re Giorgio. La libertà non è un’aspirazione né spontanea né
universale’ ma noi non ci rendiamo conto che ‘gran parte del mondo al di fuori del
Nordamerica non è, non vuole essere e probabilmente non sarà mai come noi’.
A questa vera e propria hubris (come la chiama Anonimous) - cioè alla ‘tracotanza’
che nell’antica tragedia greca era la violazione di leggi divine che causava inevitabili
disgrazie e punizioni (la nemesi) – negli Stati Uniti dagli anni Novanta si è
accompagnata anche una nuova e conseguente concezione della guerra.
Anonimous: il disastro della guerra a bassa intensità
Dimentichi di ogni insegnamento di pensatori come Clausewitz e quindi che in
guerra, come aveva detto il generale Sheridan, ‘niente dev’essere lasciato … [al
nemico] se non occhi per piangere’, o l’ammiraglio Halsey secondo cui bisognava
‘uccidere giapponesi, uccidere giapponesi, uccidere più giapponesi’ e continuare ad
ucciderli finchè ‘il giapponese sarà parlato solo all’inferno’, gli odierni leaders
americani hanno ordinato invece ai loro generali di ‘combattere e vincere in fretta; di
non uccidere molti nemici, di non distruggere molte loro proprietà e di non uccidere
molti dei suoi civili; e soprattutto di perdere il numero minimo di soldati americani
perché la delicata opinione pubblica americana non sopporta alte perdite’.
Ora, tutto ciò è perfettamente logico se si considera la fiducia che gli americani hanno
nel valore indiscusso della loro civiltà che quindi pensano basti venga conosciuta per
essere accettata: per loro la vittoria consiste insomma nell’imporla in un primo
81
momento (quindi al minor costo possibile) perché essa agirà poi da sola convertendo
il nemico sconfitto in un ammiratore ed in un alleato.
La hubris degli USA (e l’impresentabilità all’opinione pubblica di guerre combattute
sul serio) li ha condotti così ad intraprendere guerre a bassa intensità ed a bassi costi
umani che però – nonostante le continue proclamazioni di vittoria – hanno lasciato
invece i nemici ancora sul campo ed ancora decisi a continuare lo scontro per il
momento solo rimandato: ciò è particolarmente vero nel caso della guerra contro
quello che viene chiamato fondamentalismo islamico e di quelle in Afghanistan e in
Iraq, dei cui abitanti si è preteso ed immaginato che ‘il più ardente desiderio’ fosse ‘il
trapianto dello stile di vita americano’ e che dunque bastasse abbatterne i governi per
aver vinto i loro cuori.
Ecco così che per esempio in Afghanistan e in Iraq non si sono sigillati i confini
prima di iniziare l’avanzata, che si sono occupate le città e si sono proclamati governi
amici lasciando che i nemici si disperdessero e si riorganizzassero nelle campagne,
nelle province e nei paesi confinanti.
Anonimous usa parole di fuoco per denunciare la follia di questa ‘ricetta per il
disastro’ e la vigliaccheria dei comandanti militari che non denunciano mai tale
strategia sicuramente sbagliata e dunque perdente e fallimentare: secondo lui ‘solo un
pazzo conta di ottenere la vittoria in un modo simile’, così in ‘Iraq …, Somalia, Haiti,
Serbia, Kosovo, Afghanistan, ancora in Iraq … i lasciti [delle guerre così
malcondotte] inquinano il panorama internazionale come potenti mine che attendono
solo di essere fatte esplodere’.
Forse questa baldanza degli USA deriva dal successo nella seconda guerra mondiale
quando i loro peggiori nemici (italiani, tedeschi e giapponesi) una volta sconfitti ne
divennero entusiasti sostenitori, ma, a parte il fatto che allora si combattè in modo
durissimo ed estremamente distruttivo e sanguinoso, per Anonimous nell’ultimo
quarto di secolo contro nemici così estranei all’Occidente, e quindi così irriducibili,
come i mussulmani questo modo di concepire e gestire la guerra ha comportato, e non
poteva non comportare, che ‘le guerre combattute fin dal 1991 non sono state vinte.
Nella migliore delle ipotesi esse hanno represso problemi che si riproporranno ancora
per costare all’America più sangue e più denaro’.
Gli USA devono aprire finalmente gli occhi e comprendere fino in fondo che quella
che stanno combattendo contro il terrore (così la chiamano) è una vera ed inevitabile
guerra: se essi si decideranno ad aggiustare una buona volta la loro politica nei
confronti del mondo mussulmano potranno solo renderla meno prolungata, ma
dovranno ugualmente fronteggiare ‘moderni combattenti capaci di assoluta
spietatezza. … Il progresso sarà misurato dal ritmo delle uccisioni e, sì, dalla conta
dei cadaveri … una conta veritiera che arriverà a cifre estremamente elevate. Le pile
dei cadaveri conterranno tanti o più civili che combattenti. … Uccidere in gran
numero non è sufficiente a sconfiggere i nostri nemici mussulmani … ma rimarrà
l’unica opzione dell’America finchè essa insiste nelle sue politiche fallimentari nei
confronti del mondo mussulmano’.
In conclusione, così come già aveva detto (per esempio) von Clausewitz due secoli fa
‘la guerra è l’ultima risorsa e … una volta iniziata è immorale ed inutilmente costoso
82
non distruggere il nemico e finire la guerra il più presto possibile’, ma questa
strategia contrasta troppo con la presunzione a stelle e strisce: ancora una volta, come
direbbe Glucksmann, si tratta qui innanzitutto una battaglia mentale – come sempre e
come dappertutto.
Conclusione
Desta stupore che fra gli autori qui considerati un nazista (Schmitt) rimpiangesse la
guerra moderata e un antico cinese (Sun Tzu) la volesse la meno distruttrice possibile
mentre quelli occidentali – con tutti i discorsi sulla pace che circolano - ne hanno
esaltato la furia annientatrice.
E’ poi sorprendente che, nonostante la loro diversità e quella dei tempi in cui
scrissero, gli autori qui presi in considerazione giungono però tutti alle stesse
conclusioni che quindi non possono che essere accettate e fatte proprie: eccone allora
un brevissimo elenco.
Innanzitutto, la guerra è una costante ineliminabile della storia dell’umanità e dunque
invece di cianciare di pace è utile e produttivo affrontarla con razionalità.
In secondo luogo, la guerra è il fondamento di ogni società che nasce ed esiste in
quanto provvede innanzitutto alla propria difesa e sicurezza.
In terzo luogo, lo scopo della guerra è l’annientamento del nemico, dunque essa è e
rimane sempre la stessa.
In quarto luogo, il suo corso ‘naturale’ viene continuamente alterato, rallentato,
ostacolato, modificato, ecc. oltre che dagli imprevisti soprattutto dalle concrete
condizioni politiche del momento.
In quinto luogo, ogni contendente esibisce i propri motivi che dunque sono sempre
relativi e spesso soltanto semplici mascheramenti ideologici di comodo.
In sesto luogo, la rivoluzione è una guerra civile.
In definitiva allora l’unico modo per evitare la guerra – che è e rimane orribile sembra essere o quello di renderla inutile e controproducente grazie all’adozione di
politiche pacifiche più convenienti (come si è meritoriamente fatto in Europa), o,
come sostiene Glucksmann, di costruire un equilibrio – anche del terrore! – degli
armamenti che renda impossibile il successo di un’aggressione.
Non ci si illuda però che l’uomo potrà mai diventare ‘migliore’.
Sottomarina maggio 2014
(le pagine 46-50 su Arthur Koestler sono state aggiunte il 19 marzo 2017)
83
Bibliografia
Sun Tzu:’L’art de la guerre’ – Flammarion, Saint-Armand-Montrond (Cher) 1991.
Karl von Clausewitz: ‘Della guerra’ – Oscar Mondadori, Cles (TN) 1978.
F. T. Marinetti: ‘Teoria e invenzione futurista’ – Arnoldo Mondadori Editore
(I Meridiani), Vicenza 1983.
F. Gaeta: ‘Il nazionalismo italiano’ – Editori Laterza, Bari 1981.
S. Freud: ‘Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte’ (in ‘psicoanalisi e
società’) – Newton Compton Editori, Roma 1969.
Carl Schmitt: ‘Il concetto discriminatorio di guerra’ – Editori Laterza, Bari 2008.
Hu Sheng (chief editor): ‘A Concise History of the Communist Party of China’ –
Foreign Languages Press, Beijing 1994.
A cura di Luigi Bonanate: ‘La guerra nella società contemporanea’ – Principato,
Milano 1976.
Arthur Koestler: ‘The Heel of Achilles’ – Random House, New York 1974.
Arthur Koestler: ‘Janus – A Summing Up’ – Vintage Books A Division of Random
House, New York 1979.
Martin Heidegger: ‘Umanesimo e scienza nell’era atomica’ (a cura di Angelo
Crescini) – Editrice La Scuola, Brescia 1986.
André Glucksmann: ‘Le discours de la guerre’ – Editions de l’Herne, Vanves 1967.
‘La force du vertige’ – Bernard Grasset, Paris 1984.
Rashid Khalidi: ‘La resurrezione dell’impero’ – Bollati Boringhieri, Fabriano2004.
Anonimous: ‘Imperial Hubris - Why the West Is Losing the War on Terror’ Brassey’s Inc., Washington D.C. 2004.