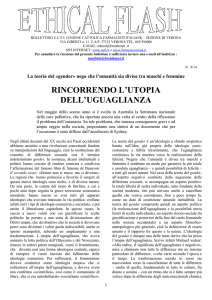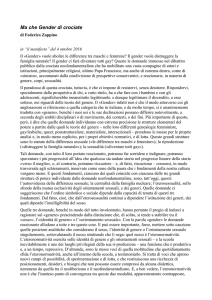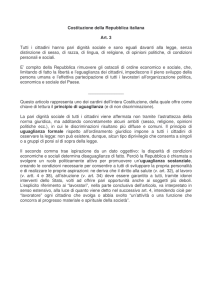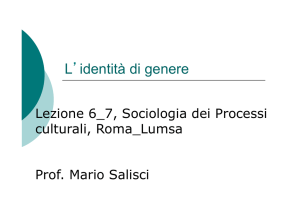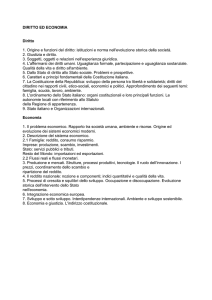Negli ultimi decenni del XX secolo nei paesi occidentali abbiamo assistito a una rivoluzione
concettuale fondata su manipolazioni del linguaggio, cioè la sostituzione del concetto di differenza
sessuale con il termine indeterminato “gender”. In sostanza, hanno cercato di rendere concreta e
condivisa l’affermazione del famoso libro di Simone de Beauvoir Il secondo sesso: “Donne non si
nasce, ma si diventa”.
Le ragioni che hano permesso e favorito il sorgere di questa nuova ideologia sono molte, e di
diversa natura. Da una parte, la caduta del muro di Berlino, a cui è pochi anni dopo seguita la grave
recessione economica mondiale, hanno messo in crisi tutti gli apparati ideologici che avevano
intessuto la vita politica: crollano infatti tutti i tipi di ideologia comunista e socialista, e poi anche il
liberalismo capitalista. In questo vuoto, la caccia a nuovi valori con cui giustificare le scelte
politiche ha portato a una sorta di “divinizzazione” dei Diritti umani, che da obiettivo che le società
si dovevano porre sono diventati i valori guida indiscutibili, anche se spesso manipolati, subendo
un ampliamento ed una trasformazione. L’utopia dell’uguaglianza, che aveva animato la lotta
politica dell’800 e del 900, rinasce in settori prima marginali, come il femminismo, che diventa così
una forma ideologica centrale, capace di riempire il vuoto lasciato dal fallimento delle ideologie
comuniste. Per rafforzarsi, il femminismo doveva costituirsi come ideologia utopica che si
richiamava all’utopia dell’uguaglianza, e doveva avere una conferma “scientifica”, così come il
comunismo di Marx, che si era autodichiarato “socialismo scientifico”.
La teoria del gender è un’ideologia a sfondo utopistico basata sull’idea, già propria delle ideologie
socio-comuniste e fallita miseramente, che l’eguaglianza costituisca la via maestra verso la
realizzazione della felicità. Negare che l’umanità è divisa tra maschi e femmine è sembrato un
modo per garantire la più totale e assoluta eguaglianza – e quindi possibilità di felicità – a tutti gli
esseri umani.
Nel caso della teoria del gender, all’aspetto negativo costituito dalla negazione della differenza
sessuale, si accompagnava un aspetto positivo: la totale libertà di scelta individuale, mito fondante
della società moderna, che può arrivare anche a cancellare quello che veniva considerato, fino a
poco tempo fa, come un dato di costrizione naturale ineludibile.
La teoria del gender comprende quindi un aspetto politico (la realizzazione dell’uguaglianza e la
possibilità senza limiti di scelta individuale), un aspetto storico-sociale (la giustificazione a
posteriori della fine del ruolo femminile nelle società occidentali), un aspetto filosoficoantropologico più generale, cioè la definizione di essere umano e il rapporto fra questo e la natura.
L’ideologia del gender è dunque una delle tante derive che ha preso l’utopia dell’uguaglianza:
(p.17) scrive Michael Walzer “alla radice, il significato dell’uguaglianza è negativo” mira eliminare
non tutte le differenze ma un insieme particolare di differenze, che varia secondo l’epoca e il luogo.
Che si stesse trasformando in modo non controllabile il rapporto fra sessualità e genere lo
aveva già capito Ivan Illich all’inizio degli anni Ottanta, e lo aveva raccontato nel suo libro Il genere
e il sesso. Per una critica storica dell’uguaglianza (1984). Secondo Illich, il gender indica “una
differenza di comportamenti, rintracciabile in tutte le culture vernacolari”, cioè distingue i luoghi, i
tempi, gli utensili, i modi di parlare, i gesti e le percezioni associati agli uomini da quelli associati
alle donne in modo proprio di un periodo e di un luogo. Il gender indica, in altre parole, una
complementarità asimmetrica fra donne e uomini. Il sesso, invece, è il frutto di un discorso
scientifico – nato nel tardo Settecento –che definisce la differenza in base a caratteristiche
biologiche, e traccia una linea di confine fra normalità e anormalità.
Illich sostiene che il processo storico è andato verso una cancellazione del genere – “il
passaggio dal dominio del genere a quello del sesso costituisce un cambiamento della condizione
umana che non ha precendenti” – e ne vede le cause nella modernizzazione: “Una società
industriale non può esistere se non impone certi presupposti unisex: il presupposto che entrambi i
sessi siano fatti per lo stesso lavoro, percepiscano la stessa realtà e abbiano, a parte qualche
trascurabile variante esteriore, gli stessi bisogni”. Illich – che naturalmente era più favorevole al
genere, cioè alla differenza complementare, che però avrebbe voluto meno diseguale – aveva
intuito il processo di trasformazione sociale in corso, ma non i suoi sviluppi ideologici. Questi
sarebbero invece andati in un’altra direzione: quella della condanna della differenza sessuale
biologica in favore di una riscoperta del gender, non più come ruolo imposto dalla società, ma
come possibilità di scelta sessuale individuale secondo la teoria queer – sviluppo libertario del
gender – e cioè secondo scelte rinnovabili anche più volte nel corso della vita.
Pur se in modo diverso, Illich aveva però senza alcun dubbio capito che la trasformazione sociale in
corso stava muovendosi verso la cancellazione di tutte le differenze – anche di quella, fondamentale
in tutte le culture, fra donne e uomini – con un ritmo che si è fatto sempre più veloce dopo la
diffusione degli anticoncezionali chimici, negli anni Sessanta. La separazione fra sessualità e
riproduzione, infatti, ha permesso alle donne di adottare un comportamento sessuale di tipo
maschile – che forse non si adatta alla natura femminile, e dunque probabilmente non contribuisce
ad aumentare la felicità delle donne, anche se questo è un altro discorso – e quindi di svolgere dei
ruoli maschili rimuovendo ogni ostacolo, e cioè abolendo anche la maternità.
La separazione fra sessualità e procreazione ha provocato una separazione fra procreazione e
matrimonio, e quindi anche fra sessualità e matrimonio: poasiamo cogliere qui le condizioni per
l’affermarsi dei “diritti” al matrimonio e al figlio avanzati dai gruppi omosessuali, e strettamente
collegati all’idea di gender, cioè alla negazione dell’identità sessuale “naturale”.
Come Gauchet ha messo in luce, queste trasformazioni hanno profonde conseguenze sul piano
sociale: se la sessualità smette di essere un problema collettivo collegato al prolungamento del gruppo
umano nel tempo, e diventa un affare privato ed espressione della propria individualità, ne discende
ovviamente una crisi dell’istituto famigliare e un cambiamento nello statuto dell’omosessualità. Mentre
una volta, infatti, era la famiglia che produceva il figlio come ovvia conseguenza dell’attività sessuale dei
coniugi, oggi sempre più spesso è il figlio desiderato che crea la famiglia. E può essere considerata famiglia
quella di chiunque desideri un figlio.
Circa cinquanta anni dopo che la de Beauvoir aveva scritto quella frase, la sua idea sembrava
finalmente trionfare. Se le identità sessuali sono solo costruzioni culturali, è possibile decostruirle, ed è
quello che si propongono di fare movimenti femministi ed omosessuali.
Chi ha dato una base scientifica a questa ideologia è stato un medico di Baltimora, che era stato
collaboratore di Kinsey, John Money. In uno studio pubblicato nel 1972, e fondato sul caso di due
gemelli, Money sembra portare la prova scientifica definitiva della sua teoria che non esiste una
identità sessuale biologicamente fondata. Secondo lui, si trattava solo di un inganno della cultura
patriarcale per tenere le donne lontane dal potere: bisognava dunque rifondare tutta la cultura, tutte
le discipline, per conquistare libertà ed emancipazione. Come scrivono nell’introduzione Peter
R.Beckman e Francine D’Amico (1994 Introduzione al volume Women., Gender and World
Politics):“etichettare gli individui come donne (o uomini) è l’esercizio del potere, dal momento che
l’etichetta crea nell’essere umano una serie di aspettative e dà l’indirizzo su cosa sono e cosa non
sono” (p.24)
Questa presunta prova scientifica dell’”eguaglianza” perfetta fra gli esseri umani viene a dare un
unico sbocco al dibattito che si è svolto all’interno del femminismo dell’Otto e Novecento, in cui si
sono alternate due posizioni, quella dell’uguaglianza e quella della differenza, creando le condizioni
per cui i diritti per le donne potessero venire richiesti per motivi opposti, o perché le donne sono
eguali agli uomini, o perché la loro differenza ha un valore. Con la “prova” scientifica di Money
finisce per prevalere la prima, cioè quella che nega la differenza femminile a favore di una
concezione neutra dell’essere umano.
La tesi di Money è stata accolta con entusiasmo dal femminismo radicale americano,
anche se è stata smentita pochi anni più tardi dal drammatico suicidio del “caso clinico” sul quale
Money aveva realizzato la sperimentazione decisiva. Nella teoria del gender, infatti, le femministe
hanno trovato una soluzione facile a una loro necessità: quella di spiegare l’origine della posizione
subordinata della donna nella società, e dunque di individuare i modi per correggerla. L’idea che i
confini fra uomini e donne non siano naturali, ma costruiti da una cultura “patriarcale”, ha
suggerito infatti lo sviluppo di una fitta attività di decostruzione delle categorie culturali,
considerata essenziale per poter pensare il mondo dal punto di vista delle donne. Di qui il successo
di Money, nonostante le smentite alle sue tesi e il fatto che la ricerca scientifica abbia confermato
come la differenza maschio/femmina sia presente già nel DNA di ogni essere umano.
A questa realtà – questa sì veramente “scientifica” - si è opposta con successo la filosofa
americana Judith Butler, l’interprete più famosa del pensiero del “gender” e del “queer”, cioè colei
che con più autorevolezza ha teorizzato che bisogna cancellare l’identità eterossessuale come
normale e normativa per aprirsi a tutte le altre possibilità. Quando la Butler afferma che il
desiderio è “queer” – cioè indeterminato e indeterminabile, ma essenzialmente mobile, instabile,
nomade – è ben consapevole di fare un’affermazione politica che vuole mettere radicalmente in
questione gli assunti normalizzatori in vigore nella società. Significa, con le sue parole, “chiamare
esplicitamente in causa la forza del desiderio a testimone politico dell’inconsistenza di ogni
pretesa di normalità” (La disfatta del genere, Meltemi). “L’esigenza di essere riconosciuti – scrive a
proposito delle unioni omosessuali – rappresenta una richiesta politica molto potente, può
condurre a nuove forme di gerarchia sociale”, in quanto può arrivare a mettere in discussione il
principio su cui si basa ogni sistema legislativo, cioè il carattere universale delle leggi: “Ciò che
davvero conta è cessare di legiferare per tutti imponendo qualcosa che è vivibile solo per alcuni e,
similmente, smettere di vietare a tutti ciò che risulta intollerabile solamente ad alcuni. Le
differenze di posizione e di desiderio stabiliscono i limiti alla possibilità di universalizzazione di
quanto riflesso etico”. In sostanza, i cambiamenti in atto dovrebbero portarci a negare che “la
differenza sessuale sia una differenza primaria” e quindi di aprire la nostra cultura a ipotesi
rivoluzionarie: un’occasione, insomma “perché nuove forme di parentela e nuovi assetti sessuali
costringano a ripensare la cultura stessa”.
Coloro che sostengono come l’introduzione della legalizzazione delle unioni omosessuali sia
innocua dovrebbero rileggersi i filosofi che hanno costruito l’ideologia con cui li giustificano, cioè
quella del gender, e riconoscere che non si tratta di un provvedimento di poco peso e di una
semplice estensione dei diritti individuali, ma un passo rivoluzionario e, per molti di noi,
estremamente pericoloso. Sul quale è necessario fermarsi a riflettere con serietà.
La chiave della rivoluzione del gender è il linguaggio, come ha ben capito il premier
spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, che solo cambiando qualche termine – “genitore” invece di
“madre” e “padre”, “parentalità” invece di “famiglia” – è riuscito a cancellare nei documenti la
famiglia tradizionale. Con un’altra operazione artificiosa si sostituiscono “sesso” con “sessualità” e
“sessuato” con “sessuale”, per confermare che non conta la realtà, ma solo l’orientamento del
desiderio. Come però ricorda lo studioso Xavier Lacroix, rimane invece indispensabile “riconoscere
l’apporto che il carnale dà al simbolico e al relazionale”: capire cioè che l’ancoraggio fisico della
paternità in un corpo maschile e della maternità in un corpo femminile costituisce un dato di fatto
irriducibile e strutturante che deve essere recepito non solo come un limite, ma come una fonte di
significato. Bisogna insomma ammettere che al di là dello spermatozoo o dell’ovulo c’è qualcuno,
mentre il concetto di omoparentalità elimina qualunque leggibilità carnale dell’origine. I diversi
sistemi di parentela che esistono al mondo hanno variamente articolato il fisico e il culturale, ma li
hanno sempre articolati, perché la sfida centrale della famiglia consiste proprio nel tenere insieme
coniugalità e parentalità.
Si tratta quindi di una vera e propria sfida antropologica al fondamento culturale non solo
della nostra società ma di tutte le società umane, come dimostra la critica avviata dai teorici del
gender (per esempio, dalla filosofa americana Judith Butler) a Lévi-Strauss e a Freud, colpevoli di
avere fondato i loro sistemi di pensiero sulla differenza sessuale fra donne e uomini. E la
demonizzazione di ogni tipo di differenza non solo si basa su una utopia di uguaglianza proposta
come via maestra verso la felicità – un’utopia che senza dubbio ha le sue origini proprio in quella
socialista che ha mostrato le sue disastrose realizzazioni nel secolo appena trascorso – ma in
questo caso si arriva a un esito estremo del pensiero decostruzionista, e cioè alla negazione
dell’esistenza della natura stessa. Secondo un interessante documento sul gender pubblicato nel
dicembre 2006 dalla Conferenza episcopale francese – La problématique du “genre” (che “I
Quaderni di Scienza & Vita” hanno tradotto in italiano nel loro secondo numero) – la realtà di
natura non sarebbe del tutto ignorata, ma piuttosto considerata come non attiva, e in ogni caso da
sottomettere. Se ogni tipo di differenza, sancita da una definizione sociale, è letto come un
sistema di potere, sulla scorta di Foucault, si può vedere in ogni superamento di paradigma un
momento evolutivo di liberazione, secondo una nuova forma di darwinismo sociale. Le forme più
diffuse e più facilmente vivibili di relazioni affettive e sessuali sono così considerate come quelle
evolute, che quindi devono imporsi, mentre l’“eterocentrismo” viene considerato un momento
della storia dello sviluppo umano ormai non più adatto e da superare.
Riappare così un’idea di rivoluzione sessuale di natura evoluzionista che già si era
affermato all’inizio del Novecento, come aveva con chiarezza affermato una delle più famose
“profetesse” di una rivoluzione sessuale di stampo femminista, la svedese Ellen Key, che ha
conosciuto una grande fortuna anche in Italia con il suo bestseller L’Amore e il matrimonio (1909).
In questo libro la Key espone la sua idea evoluzionista di morale sessuale, che prevede la fine del
matrimonio: “La vita è una evoluzione continua, e in conseguenza di ogni evoluzione muoiono
certe verità che una volta erano ritenute vitali e se ne formano delle nuove”. Bisogna quindi
“trionfare del pregiudizio nutrito dal cristianesimo” con una nuova morale, cioè “quella che si basa
sulla bontà fondamentale della natura umana e sull’uguaglianza di tutti gli uomini”, perché
sicuramente l’umanità sta per innalzarsi “alla superumanità” . Questa nuova morale è fondata
sull’idea che “la felicità dell’individuo sia la condizione essenziale per la felicità dell’umanità”.
Liberarsi dal “dogma dell’eterocentrismo” per aprirsi ad ogni tipo di identità, e quindi di
unione, sarebbe perciò – lo sentiamo ripetere di continuo – un progresso. Si procede così
irresponsabilmente per questa strada, dimenticando che non si tratta di un semplice allargamento
dei diritti individuali, ma di una trasformazione antropologica così profonda da toccare le
fondamenta dei processi cognitivi umani: i bambini, fin dai primi mesi, colgono la distinzione
sessuale – anche senza informazioni sui genitali, e non certo per la differenza del loro statuto
sociale – e questa struttura binaria diventa un fattore potente di organizzazione del loro
apprendimento e del funzionamento sociale.
I processi cognitivi di categorizzazione sono potenti: cosa può succedere agli esseri umani
se poi vengono smentiti dall’ideologia? E cosa può succedere di una società in cui le persone non
incontrano più la differenza sessuale, cioè non vivono più quell’esperienza che – scrive la Agacinski
– “mette ciascuno di fronte a una finitezza che gli impedisce di prendersi, lui solo, per
l’incarnazione dell’‘uomo’ e che lo obbliga a coesistere con l’altro”?
L’ideologia del gender è stata recepita con entusiasmo soprattutto dalle organizzazioni
internazionali, perché corrisponde alla politica di allargamento dei diritti individuali che è
considerata il fondamento della libertà democratica: il volume di Dale O’Leary Maschi o femmine?
La guerra del genere (Rubettino) – uscito quasi dieci anni fa negli Stati Uniti dove ha suscitato
grande interesse – racconta come il problema del genere sia stato al centro della battaglia politica
nelle conferenze ONU del Cairo e di Pechino, a cui la O’Leary ha partecipato personalmente. Il
testo ha il merito di raccontare una storia poco conosciuta, cioè come – per esprimersi con le
parole, citate dall’autrice, dell’Istituto di ricerca per l’avanzamento delle donne (INSTRAW) –
“adottare una prospettiva di genere significa (…) distinguere tra quello che è naturale e biologico
da quello che è costruito socialmente e culturalmente, e nel processo rinegoziare tra il naturale – e
la sua relativa inflessibilità – e il sociale – e la sua relativa modificabilità”. In sostanza, significa
negare che le diversità fra donne e uomini siano naturali, e sostenere invece che sono costruite
culturalmente, e quindi possono essere modificate a seconda del desiderio individuale. L’adozione
di una “prospettiva di genere” è stata la linea ideologica adottata con forza da alcune delle
principali agenzie dell’ONU e dalle ONG che si occupano di controllo demografico, con il sostegno
della maggior parte delle femministe dei paesi occidentali, ma con l’opposizione dei molti gruppi
nati a difesa della maternità e della famiglia.
Da qui il termine gender (che è più elegante e neutro di “sesso”) non solo è entrato nel
nostro linguaggio, ma è usato addirittura nella denominazione di un filone di ricerca accademica –
i Gender Studies – spesso però nell’inconsapevolezza del suo rivoluzionario significato ideologicoculturale.
Tanto che la nuova categoria ha avuto anche applicazioni positive sul piano scientifico,
come nella ricerca storica, dove in sostanza è servita a rendere consapevoli gli storici della
costruzione sociale delle identità sessuali e a ricordare che esse si formano in una dimensione di
relazione, aprendo così quella che era nata come storia delle donne a una attenzione anche ai
ruoli maschili. Ma la sua vera ragion d’essere, come ha ben spiegato la O’Leary, è essenzialmente
sul piano politico, soprattutto per la sua utilizzabilità ai fini della totale normalizzazione della
sessualità omosessuale. Anche le istituzioni culturali si sono aperte a questa nuova possibilità: lo
dimostrano due libri recenti, Altri femminismi (Manifestolibri), curato dalla Società Italiana delle
storiche, e Omosapiens. Studi e ricerche sugli orientamenti sessuali (Carocci). Il concetto di gender
rappresenta in questi studi il primo passo per sviluppare in modo più ampio lo sganciamento
dell’identità sessuale dalla realtà biologica, tanto che, come si sostiene, il gender ha il suo logico
sviluppo nell’approccio queer, cioè nella prospettiva dell’identità sessuale come scelta mobile e
revocabile, anche più volte nel corso della vita.
Secondo Dale O’Leary, i fautori della potente rete che sostiene il gender nel mondo delle
agenzie internazionali sono:
1.il gruppo che si occupa del controllo della popolazione
2 quello dei libertari della sessualità
3 gli attivisti dei diritti dei gay
4 i promotori multiculturali del polically correct
5 la componente estremista degli ambientalisti
6 i neo.marxisti
7 i decostruzionisti post-modernisti
Lobby potenti, che gestiscono la costruzione del pensiero polically correct nei paesi
occidentali. Eppure, come gli studi scientifici hanno dimostrato e continuano a dimostrare, parlare
di identità maschile e di identità femminile ha senso innanzitutto proprio dal punto di vista
biologico. Oltre che infondata, la teoria del gender sottintende una visione politica estremamente
pericolosa, facendo credere che la differenza sia sinonimo di discriminazione. Eppure, il principio
di uguaglianza non richiede affatto di fingere che tutti siano uguali: solo nella misura in cui
l’esistenza della differenza venga effettivamente riconosciuta e considerata, si potrà realmente dare
a tutti, allo stesso modo e in pari grado, piena dignità e uguali diritti. Nulla di nuovo, sia chiaro: è da
tempo che il diritto e la filosofia vanno ribadendo come l’autentico significato del principio di
uguaglianza risieda non nel disconoscere le caratteristiche individuali, fingendo un’omogeneità che
non esiste, ma, al contrario, stia proprio nel dare a tutti le stesse opportunità. Il laico Norberto
Bobbio affermava che gli uomini non nascono uguali: è compito dello Stato metterli in condizione
di divenirlo. Come ribadiscono, tra gli altri, la Chiesa cattolica e parte del femminismo, la vera
uguaglianza si verifica non solo quando soggetti uguali vengono trattati in modo uguale, ma anche
quando soggetti diversi vengono trattati in modo uguale. La parità tra i sessi non si ottiene certo
facendo entrare le donne in una categoria astratta di individuo (categoria che, tra l’altro, non esiste,
essendo tarata sul modello maschile), ma si raggiunge partendo dal presupposto che la società è
composta da cittadini e da cittadine.
Certo, è indubbio che fino ad oggi la differenza tra i sessi quasi sempre e quasi ovunque ha
assunto la forma di una gerarchia tra gli uomini e le donne, in cui è sempre stato preordinato il
maschio. Si tratta, però, di piani diversi: la subordinazione non sta nella natura, ma nell’illecito uso
che di essa si è fatto, e si continua a fare. È su questo illecito uso ancora presente che dobbiamo
concentrarci, come tentano di fare un saggio di Alain Tournaine (Il mondo è delle donne (il
Saggiatore 2009) e quello di Anne Stevens docente di European Studies a Birmingham, Donne,
potere, politica (il Mulino 2009). Entrambi dedicano molte osservazioni alla politica, che è forse
oggi, soprattutto nei paesi occidentali, il luogo più eclatante della disparità tra i sessi. A fronte di un
corpo elettorale pariteticamente composto da uomini e donne, infatti, i rappresentanti eletti sono in
massima parte maschi. Il tema, a cui si è tentato di dare anche spiegazioni storiche, è complesso e
spinoso. Eppure è indubbio che la democrazia richieda la contestuale presenza in politica sia degli
uni che delle altre.
Ovviamente esiste una grande varietà di posizioni su come risolvere, in concreto, il
problema della scarsa rappresentanza femminile. Noi rimaniamo convinte che dovrebbero essere gli
stessi partiti ad autodisciplinarsi affinché le liste elettorali rispondano effettivamente ad un principio
democratico, assicurando una rappresentanza tendenzialmente paritetica in società composte da
donne e uomini. Intervenendo così, (e non imponendo invece le quote per legge), i partiti sarebbero
infatti obbligati ad investire nella formazione di una classe politica competente e preparata
composta da entrambi i sessi, invece di ricorrere a candidature femminili improvvisate, a ridosso
della scadenza elettorale.
La politica, però, è solo uno degli aspetti della disparità ancora in atto. Anne Stevens
analizza anche il mondo del lavoro (segregazione verticale e orizzontale, disparità retributiva), lo
stile di vita, le aspettative sociali e l’impiego del tempo. Qui è sufficiente un solo esempio concreto:
le domande rivolte alle vittime di violenza sessuale sono ancora oggi umilianti, in modo non
paragonabile a quelle rivolte alle vittime in altri processi penali.
Tra i nodi affrontati da Alain Touraine, invece, ne segnaliamo due. Il primo è quello, urgente
e grave, della spaventosa violenza di cui le donne sono vittime (come la cronaca nera ci attesta
pressoché quotidianamente), un vero allarme sociale rispetto al quale dovremmo interrogarci molto
seriamente a diversi livelli. L’altro, è relativo al fatto che la maggior parte delle giovani donne di
oggi rifiuta di definirsi femminista, esprimendo fastidio o addirittura inquietudine rispetto al
termine. Touraine spiega questa presa di distanza con il fatto che per le donne di oggi il
femminismo “è completamente integrato al mondo politico”. Questa vicinanza lo avrebbe
definitivamente sminuito, trattandosi di una generazione che nutre una completa sfiducia nella
capacità della politica di migliorare le cose. Una politica, inoltre, che viene percepita come
intrinsecamente debole essendo fondata sulla (falsa) uguaglianza, quando le giovani donne di oggi
sanno che maschi e femmine uguali non sono. Touraine, però, rifiuta di definire il movimento delle
donne come rivoluzionario (definendolo, in opposizione, democratico). A nostro avviso, però, la
qualifica di rivoluzionario non è tanto una questione di metodo, quanto piuttosto di risultato.
Certe che il femminismo tout court non esista (si pensi, su tutte, alla contrapposizione tra
femminismo dell’uguaglianza e femminismo della differenza), e consapevoli che anche il
femminismo ha avuto i suoi limiti ed ha compiuto i suoi errori, non possiamo però negare che il
cambiamento profondo della vita delle donne nel corso della seconda metà del Novecento, abbia
rivoluzionato radicalmente, nel bene e (forse) un po’ anche nel male, la società nel suo complesso.
Oltre alle stesse donne.
Una critica radicale dell’ideologia del gender intesa come teoria dell’uguaglianza si è sviluppata
all’interno del femminismo: da una parte, nel femminismo americano ha cominciato ha individuare una
diversa etica, maschile e femminile. La prima è stata la filosofa Carol Gilligan Con voce di donna.Etica e
formazione della personalità (1987): “fin dall’infanzia, a causa del rapporto figlia-madre (rapporto che
permane senza conflittualità) e figlio-madre (rapporto che si spezza perché il figlio cerca l’indipendenza
dalla madre), le personalità etiche del bambino e della bambina si differenziano in maniera essenziale e
definitiva”. Ma da molte intellettuali femministe l’esistenza di una differenza femminile viene
negata anche quando questa differenza è proposta in senso positivo, come moralità superiore
fondata sull’etica della cura, in contrapposizione alla differenza maschile della giustizia e dei diritti,
come ha sostenuto la filosofa. Questa tesi, infatti, è stata sottoposta a una critica serrata da
un’altra filosofa, Joan Tronto, che considera la predisposizione alla cura solo come una costruzione
culturale. Traspare da questa disputa l’ansia di alcune femministe che, nel tentativo di porre fine
alla condizione marginale delle donne nella società, preferiscono rinnegare la differenza femminile
in cambio di una “neutralità” che sembra loro più rassicurante. Dimenticando – come scrive
Sylvane Agacinscki – che “ciò che fonda la parità è l’universale dualità del genere umano”, cioè
proprio il porre “la differenza sessuale come differenza universale”.
Questa linea critica è stata approfondita da Eva Feder Kittay (La cura dell’amore,Vita e Pensiero,
2010). L’autrice parte da una delle domande chiave del femminismo: come mai le donne, anche
quando hanno ottenuto uguali diritti, non ottengono una uguaglianza di fatto nella società?
Perché l’uguaglianza si è dimostrata così irraggiungibile per le donne? Kittay risponde dicendo che
l’uguaglianza è possibile solo per le donne che non hanno responsabilità di cura, e forse non è il
tipo di uguaglianza che le donne desiderano: p.XXI “l’indipendenza che spesso le donne cercano
non è quella forma di indipendenza isolata che la filosofia liberale proclama, ma una forma che
richiede il presupposto della responsabilità sociale per aiutare e supportare le relazioni di
dipendenza”.
Kittay infatti scrive che le sembra che si possa delineare una critica dell’ideale di uguaglianza che
chiama “critica della dipendenza”. Tale critica della dipendenza è una critica femminista
dell’uguaglianza e sostiene che la concezione della società vista come associazione di eguali
maschera o occulta ingiuste dipendenze, legate all’infanzia, alla vecchiaia, alla malattia e alla
disabilità p.XXXII E’ necessario quindi cercare di chiarire un’idea di uguaglianza tanto radicale da
abbracciare la dipendenza, perché nessuna cultura estesa oltre una generazione può considerarsi al
sicuro dalle esigenze della dipendenza (p.3) e perché le identità di gruppo costituiscono una sgradita
intrusione di differenza nell’ideale di uguaglianza.
Anche se è evidente la natura di genere del lavoro di dipendenza, sappiamo che non è obbligatorio
che siano donne ad eseguirlo, anche se comunque considerato un lavoro di livello inferiore, quindi
spesso affidato ai lavoratori immigrati.
La Kittay afferma quindi che l’uguaglianza sarà sempre formale, o addirittura vacua, finché la
prospettiva della differenza non sarà riconosciuta e incorporata nel tessuto della teoria e della
pratica politica (p.5), anche se è ben consapevole della difficoltà di questo, perché l’incontro con la
dipendenza è raramente ben accolto tra coloro che si nutrono di libertà ideologica, di
autosufficienza e di uguaglianza (p.11).
Con la creazione delle utopie di uguaglianza e di autonomia individuale, abbiamo costruito delle
finzioni che ci danneggiano, perché fondate su un ideale che presuppone indipendenza, ben lontano
dalla realtà.
Le critiche femministe all’uguaglianza sono significative, perché denunciano che molti hanno
supposto che concedere maggiori possibilità alle donne significava necessariamente pretendere tutto
ciò che gli uomini si erano accaparrati (p.19). Le donne invece non vogliono più considerare il
genere maschile come modello di riferimento.
Ormai è un fatto acquisito che le donne prendono decisioni morali in modo diverso, e quindi
vogliono trattamento specifico.
Le donne sanno ormai, sostiene Kittay, che la neutralità di genere non farà che perpetuare quelle
differenze che sono già in gioco. Se, d’altra parte, mettiamo in evidenza la differenza, corriamo il
rischio di ridurre le donne a mere vittime (p.26)
Molto interessante è la critica all’ideologia del gender avanzata dalla filosofa femminista francese
Sylviane Agacinski, secondo cui “la promiscuità del genere umano non rappresenta solo un dato
dell’antropologia fisica: essa rappresenta anche una dualità culturale strutturante nonché un valore,
in quanto essa è generatrice di singolarità e di eterogeneità” (la politica dei sessi, p.136). Secondo la
Agacinski “si nasce femmina o maschio, si diventa donna o uomo. Lungi dal dipendere soltanto da
un programma aanatomico, essa riguarda scelte psichiche consce o inconsce, e chiama in causa
modelli sociali. Il fatto che non ci sia conseguenza obbligata tra l’identità biologica e l’identità
psicologica, tra il sesso anatomico e il genere sessuale sociale, non cancella affatto il principio della
differenza. Nemmeno l’inversione deliberata dei modelli tradizionali di comportamenti maschili o
femminili sovverte il principio della dualità dei modelli nelle loro forme culturali”(p.15-16)
Sul piano filosofico, Agacinski osa criticare apertamente il dogma di Simone de Beauvoir: “è ora di
rompere i ponti con la logica del Secondo sesso che ha concepito l’emancipazione delle donne solo
a partire da una negazione dell’identità sessuale. Ho capito che la libertà esaltata dalla filosofa si
pagava a prezzo di un assurdo rinnegamento della natura, della maternità e del corpo femminile
come se la donna avesse sofferto di un handicap naturale legato al suo corpo e alla sua funzione
biologica. Il corpo femminile è costantemente descritto come un fardello di carne che imprigiona la
donna e che fa di lei un oggetto, strumento del desiderio e dell’attività maschili. La fecondità
femminile naturale non può a priori e in generale essere qualificata come svantaggio in rapporto a
degli individui maschili” (p.59-62)
Molto chiara è anche la sua critica all’utopia dell’eguaglianza che si nasconde dietro la teoria del
gender:“due cose sono o identiche o differenti, anche se un oggetto può essere identico a un altro da
un certo punto di vista, e differente da un altro punto di vista, o sotto un altro aspetto. Quanto
all’uguaglianza, essa si oppone alla disuguaglianza, e non alla differenza” (p.178)
Tanto che si può affermare che “a partire dal suo “ancoraggio” biologico, la differenza maschiofemmina costituisce un modello che struttura universalmente le società, quantunque i valori e i
contenuti attribuiti a questa differenza siano culturalmente variabili”(p.20)
E’ nota la posizione della Chiesa rispetto a questo tema, ben chiarita dalla Lettera ai Vescovi sulla
collaborazione fra donne e uomini dell’allora cardinale Ratzinger. E’ interessante però ritrovare
elementi di questa polemica contro il gender anche in molte femministe laiche, che contribuiscono
alla creazione di una opinione pubblica critica nei confronti dell’introduzione di questo termine nei
testi pubblici e delle leggi che ne derivano.
Ci sono inoltre delle contraddizioni interne alla società contemporanea che rendono difficile una
vera applicazione della teoria del gender, contro cui si scontrano anche gli organismi internazionali.
Come segnala Giulia Galeotti (Gender Genere, Viverein, 2010), infatti, i nodi irrisolti sono almeno
tre:
1) oggi si assiste ad un incremento di femminilità e mascolinità nelle donne e negli uomini
occidentali, anche nel vestire ecc. prevalgono di meno i soggetti indistinti.
2) la scarsa presenza femminile in parlamento. La volontà di dividere il potere fra uomini e donne
può essere legittima solo se si ammette che il sesso non è un tratto sociale ma un tratto differenziato
universale.
3) questione dell’aborto, in cui le legislazioni stabiliscono che solo la donna decide. Ma allora le
donne esistono!