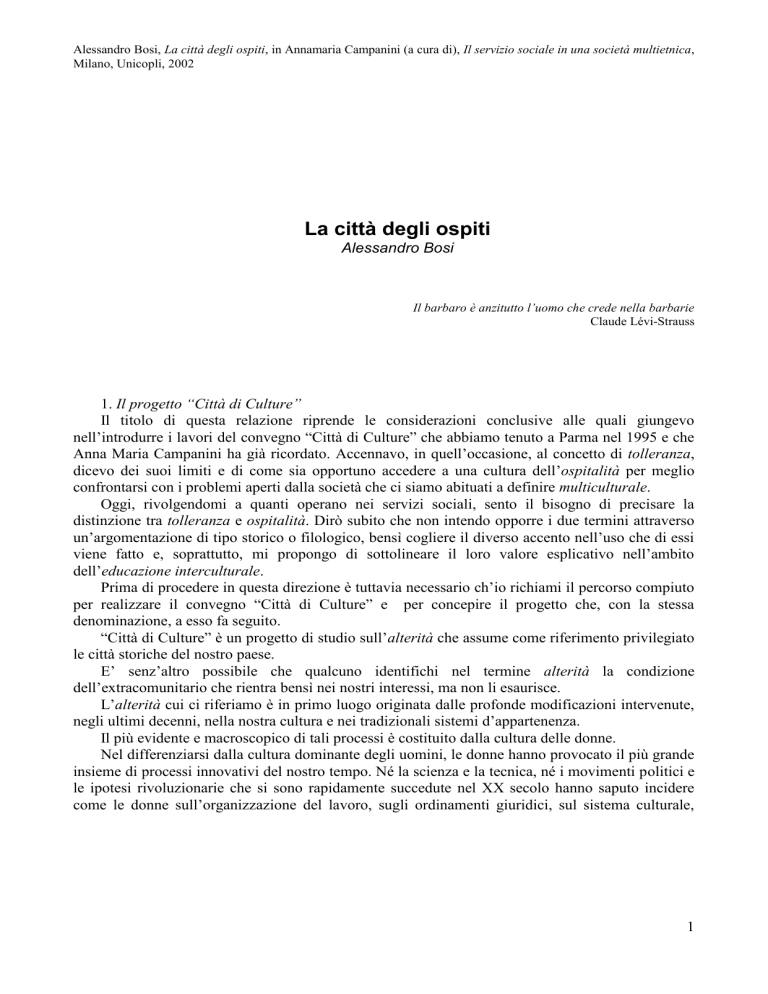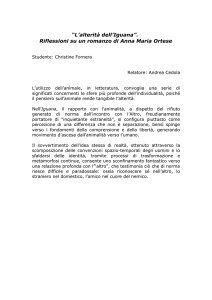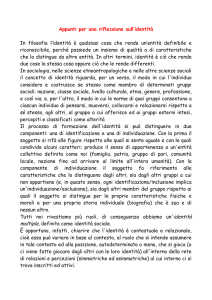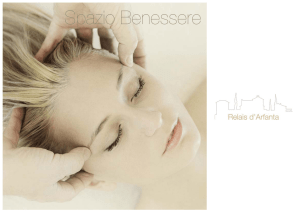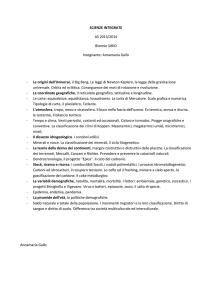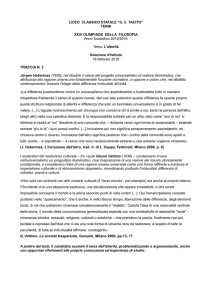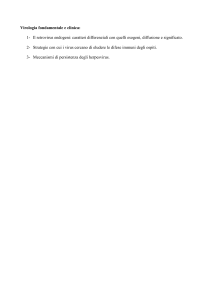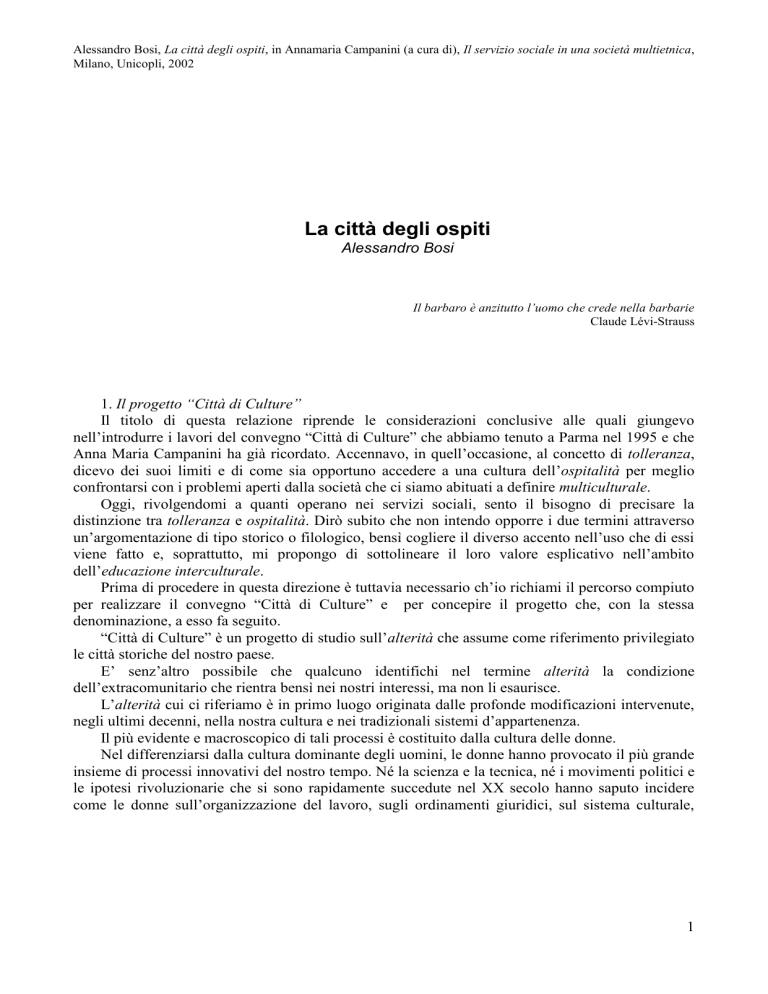
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
La città degli ospiti
Alessandro Bosi
Il barbaro è anzitutto l’uomo che crede nella barbarie
Claude Lévi-Strauss
1. Il progetto “Città di Culture”
Il titolo di questa relazione riprende le considerazioni conclusive alle quali giungevo
nell’introdurre i lavori del convegno “Città di Culture” che abbiamo tenuto a Parma nel 1995 e che
Anna Maria Campanini ha già ricordato. Accennavo, in quell’occasione, al concetto di tolleranza,
dicevo dei suoi limiti e di come sia opportuno accedere a una cultura dell’ospitalità per meglio
confrontarsi con i problemi aperti dalla società che ci siamo abituati a definire multiculturale.
Oggi, rivolgendomi a quanti operano nei servizi sociali, sento il bisogno di precisare la
distinzione tra tolleranza e ospitalità. Dirò subito che non intendo opporre i due termini attraverso
un’argomentazione di tipo storico o filologico, bensì cogliere il diverso accento nell’uso che di essi
viene fatto e, soprattutto, mi propongo di sottolineare il loro valore esplicativo nell’ambito
dell’educazione interculturale.
Prima di procedere in questa direzione è tuttavia necessario ch’io richiami il percorso compiuto
per realizzare il convegno “Città di Culture” e per concepire il progetto che, con la stessa
denominazione, a esso fa seguito.
“Città di Culture” è un progetto di studio sull’alterità che assume come riferimento privilegiato
le città storiche del nostro paese.
E’ senz’altro possibile che qualcuno identifichi nel termine alterità la condizione
dell’extracomunitario che rientra bensì nei nostri interessi, ma non li esaurisce.
L’alterità cui ci riferiamo è in primo luogo originata dalle profonde modificazioni intervenute,
negli ultimi decenni, nella nostra cultura e nei tradizionali sistemi d’appartenenza.
Il più evidente e macroscopico di tali processi è costituito dalla cultura delle donne.
Nel differenziarsi dalla cultura dominante degli uomini, le donne hanno provocato il più grande
insieme di processi innovativi del nostro tempo. Né la scienza e la tecnica, né i movimenti politici e
le ipotesi rivoluzionarie che si sono rapidamente succedute nel XX secolo hanno saputo incidere
come le donne sull’organizzazione del lavoro, sugli ordinamenti giuridici, sul sistema culturale,
1
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
sulla vita delle genti. La cultura delle donne ha provocato una modificazione paragonabile soltanto
all’abolizione della schiavitù, ma con effetti anche più radicali ove si consideri la cosa con riguardo
al problema dell’alterità. Mentre lo schiavo è un’alterità sociale che riguarda il modo di concepire
la relazione tra le classi, la donna è, rispetto al soggetto che ha svolto un ruolo egemone nella storia,
l’alterità antropologica che attraversa ogni individuo (essendo ognuno di noi sia uomo sia donna) e
la sua più intima relazione sociale (quella istituita nella famiglia). Per questo, la cultura delle donne
ha posto ogni individuo, tanto gli uomini quanto le donne, difronte a una nuova consapevolezza di
che cosa si debba intendere per alterità: non tanto la condizione dell’altro per come viene
interpretata dal soggetto, ma la condizione del soggetto e dell’altro per come si percepiscono nella
relazione.
Un secondo processo di interna differenziazione che riguarda i paesi occidentali è costituito dal
repentino passaggio da una cultura prevalentemente intergenerazionale a una sempre più
accentuatamente intragenerazionale.
Si è ripetutamente sottolineato come, a partire dagli anni Cinquanta, ogni generazione di
giovani non si identifichi col sistema di valori dei padri. In questi termini si è spiegata la frattura
generazionale come un evento ricorrente a partire dalla metà del secolo. Personalmente giudico
sbrigativa questa ipotesi che interpreta i fatti soltanto attraverso la lente del conflitto e della
contestazione generazionale e carica quindi obiettivamente le giovani generazioni d’ogni
responsabilità. Credo invece che le cose siano andate diversamente già a partire dalla metà del XIX
secolo quando la generazione dei padri ha consegnato ai figli, attraverso l’istituzione della scuola
pubblica, uno strumento (l’alfabeto) che non conoscevano e non potevano dunque controllare. Nella
storia precedente, il passaggio generazionale era avvenuto sempre con la consegna ai figli di quegli
strumenti che i padri avevano usato per un’intera vita e questo aveva garantito la persistenza dei
rapporti e la comune identificazione negli stessi sistemi valoriali nonostante i conflitti individuali
fossero spesso aspri. Il XX secolo è il primo che procede oltre la tragedia d’Edipo perché la linea di
continuità generazionale non è più interrotta dai figli che uccidono il padre (come si continua a
credere), ma dai padri stessi nel momento in cui consegnano ai figli uno scettro che non rappresenta
più il loro regno. E di continuo, nel XX secolo, i padri hanno lasciato ai figli linguaggi e attrezzi
diversi da quelli che avevano usato e con i quali si erano misurati. Per questo, hanno visto crescere,
con i figli, un’alterità dalla fisionomia per loro difficilmente decifrabile.
E’ senz’altro probabile che la società differenziata favorisca il nascere di numerose alterità, di
soggettività, cioè, che si costituiscono come altre nei confronti di riferimenti che avevano avuto in
periodi precedenti un ruolo centrale quando non esaustivo: l’uomo e i padri negli esempi qui
richiamati.
2
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
Nell’economia di questa esposizione, non posso trascurare un terzo processo di interna
differenziazione culturale, rilevante soprattutto nel nostro Paese, e che più dei precedenti ha
specifica attinenza con i temi dell’intercultura: mi riferisco all’affermarsi in Italia di una
multireligiosità precedente e indipendente dalla presenza di popolazioni straniere.
Storicamente, la nostra vita sociale è stata caratterizzata da tre culture (cattolica, laica e
socialista) che Benedetto Croce ha riunito in una sola identità nazionale sottolineando come noi tutti
non possiamo non dirci Cristiani.
Alla metà degli anni Settanta questa condizione entra in un processo di progressiva crisi.
Nella nostra storia recente, dovremo considerare il 1974 come una data periodizzante. In
quell’anno, mentre viene consumandosi per proprio conto la cultura partecipativa degli anni
Sessanta, la crisi energetica conseguente alla guerra del Kippur dischiude scenari politici e culturali
affatto nuovi. D’un tratto è a tutti chiaro che la civiltà occidentale dipende, assai più di quanto non
fossimo stati disposti a credere, dai paesi arabi. La loro decisione di chiudere i rubinetti della
benzina, come ci eravamo abituati a dire, ha l’effetto traumatico d’insinuare il dubbio che il
controllo politico del mondo non dipenda soltanto dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica. Si
erodeva così l’idea stessa che la storia potesse essere letta riferendosi all’opposizione tra borghesia e
proletariato, fra capitalismo e socialismo. Molti giovani, che di quell’opposizione avevano fatto una
ragione di vita, cominciarono a guardare altrove e scoprirono concezioni e sistemi valoriali propri di
altre parti del mondo. E’ soprattutto fecondo l’incontro col mondo orientale e ha come effetto il
fiorire d’una cultura multireligiosa che, per un Paese come il nostro, non avremmo messo nel conto
solo pochi anni prima.
Un quarto di secolo dopo quel 1974 ci troviamo difronte alla seconda, talvolta alla terza
generazione di mussulmani o buddisti italiani. Nel frattempo, gli adepti di altre fedi non cristiane si
sono sempre più autorevolmente proposti nella nostra vita sociale dando vita a vere e proprie culture
autonome all’interno delle città nelle quali si sono insediati.
Tutto questo è estraneo ai processi immigratori che sono, a loro volta, evidentemente portatori
di diverse culture religiose.
In Italia, il fenomeno della multireligiosità riguarda ancor oggi, nonostante la presenza degli
immigrati, una popolazione limitata, ma non è soltanto al numero degli individui che dobbiamo
guardare, bensì al prestigio e alla storia delle singole culture religiose, alla loro persistenza e
radicamento nella popolazione autoctona di cui concorre a modificare, in processi di lunga lena, i
comportamenti sociali fino a cambiare gradualmente la morfologia stessa delle città attraverso una
domanda di spazi e ambienti che non può restare insoddisfatta oltre un certo segno.
Queste acquisizioni hanno consentito al progetto “Città di Culture” di guadagnare il
convincimento che la società multiculturale del nostro tempo ha origini endogene prima che
3
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
esogene: essa genera un’alterità che, rispetto al sistema culturale autoctono, definisco, con una
schematizzazione che tornerà utile più oltre, prossima in quanto essa stessa autoctona. Solo in un
secondo momento, la società multiculturale è anche l’esito di un processo esogeno che genera,
rispetto al sistema culturale autoctono, un’alterità distante in quanto alloctona.
Nel relazionarsi all’alterità distante, il sistema culturale autoctono ha adottato, e non potrebbe
che essere così, gli atteggiamenti più diversi in uno spettro di posizioni che va dal rifiuto
all’accoglienza. Il progetto “Città di Culture”, ritiene che le politiche dell’accoglienza, alle quali
aderisce, debbano rapidamente passare da una fase, come è quella attuale, caratterizzata da forti
enunciazioni di principio, alla definizione di ambiti operativi sempre più circoscritti nei quali
produrre un sapere desunto da condizioni osservabili e da riscontri con i quali ognuno possa
confrontarsi.
Per questo, il progetto ha assunto la città storica italiana come un riferimento culturale e un
laboratorio nel quale individuare concrete dinamiche relazionali alle quali fare riferimento.
Heidegger ci ha insegnato che ogni epoca deve sapersi assumere la responsabilità di pensare un
problema e da parte mia sono convinto che pensare la città dovrebbe costituire l’impegno del
presente.
La città è stata sempre, nella storia, il luogo in cui si rivelano in modo più acuto e drammatico
le contraddizioni del presente. Nel suo essere crogiolo di culture, la città realizza in ogni epoca quei
sincretismi che la storia consente e impone. Alla prova della multiculturalità, la città storica italiana
vanta sue particolari peculiarità e, così a me sembra, lancia una sfida alla metropoli che abbiamo
frettolosamente identificato come la culla del cosmopolitismo. Ma di questo abbiamo parlato
ampiamente nel convegno “Città di Culture”.
2. Tolleranza e ospitalità
L’approccio al tema dell’alterità che ho qui riassunto ci proietta oltre la cultura della tolleranza
con la quale, nondimeno, credo sia opportuno confrontarsi e che a mio giudizio rappresenta, per la
nostra coscienza civile, un punto di non ritorno.
Il concetto di tolleranza al quale facciamo abitualmente riferimento è un frutto tra i più raffinati
della modernità nascente che viene elaborato a partire dagli Essais di Montaigne del 1580 fino al
Trattato sulla tolleranza di Voltaire del 1763 attraverso gli scritti di Bayle, Spinoza, Locke e
Beccaria.
4
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
La modernità è stata giustamente celebrata come l’epoca nella quale si afferma una nuova
dimensione fisica e spirituale dell’esistenza.
All’attonita coscienza dell’uomo uscito dalla concezione curtense dell’universo medioevale,
disegnato secondo le linee concentriche della cosmologia tolemaica, Copernico aveva dischiuso
spazi immensi che attendevano d’essere ricompresi in una nuova visione d’insieme. I bisogni
dell’intraprendente borghesia impongono all’uomo di misurare lo spazio per costruire strade, ponti,
città che consentano di creare e raggiungere sempre nuovi mercati. In breve, quella terra che aveva
attraversato da nomade seguendo i cicli delle stagioni o affidandosi all’istinto di sopravvivenza e
che più tardi aveva riconosciuto come la Madre Terra in cui cercare il sito dove radicarsi, si
trasforma in un intreccio di vie di comunicazione che non risparmiano i mari. Lo spazio è bensì
infinito e non si può più dire che sia raccolto intorno a lui, ma ora l’uomo scopre di poterlo
percorrere e non disdegna di abitare in ogni dove. Non vi sono mitiche Colonne d’Ercole oltre le
quali sia impossibile procedere e i mondi più lontani sono popolati da uomini di diverse culture, non
da mostri, giganti né sirene ammaliatrici. Infine i diversi mondi, quando sia in grado di raggiungerli
e includerli nella rete di strade che prepara la comunicazione fra tutti i popoli, altro non sono che il
suo stesso mondo.
D’altro canto, la nascente scienza sperimentale gli insegna, attraverso l’osservazione e la
sperimentazione, una disposizione nei confronti dell’oggetto da conoscere che modificherà anche il
suo modo di percepire sé stesso. E’ il periodo che abbraccia il tempo necessario alla filosofia
occidentale per elaborare, dal cogito cartesiano (1637) all’io penso kantiano (1781), l’imponente
architettura di un Soggetto capace d’ergersi difronte al Mondo. Dalle prime prove degli ilozoisti, la
filosofia occidentale non si era più misurata con la fisicità della Natura e ora la sua esuberante
irruzione nella modernità mette a nudo quale ritardo si sia venuto accumulando. La Chiesa cerca di
dissuadere Galileo dai suoi propositi ricordandogli che all’uomo era bastato percepirsi come il figlio
di Dio per affermare la propria regalità sul creato mentre ora un Mondo infinito e infinitamente
variabile sfuggirebbe inesorabilmente al suo controllo. Ma il cammino è ormai tracciato e l’uomo
dovrà riconquistare l’antico primato proprio attraverso il confronto titanico col Mondo. D’altra
parte, il Mondo, l’oggetto meccanico che sta davanti ai suoi occhi, è, al contempo, parte di sé stesso,
è cosa estesa e non pensante da coniugare in qualche modo con quella cosa pensante e non estesa
che esprime la sua natura eletta, secondo quanto apprendeva da Cartesio. La Natura non è dunque
soltanto nel Mondo, ma nel Soggetto stesso, nella sua parte pesante, il corpo, mentre la mente
reclama la propria autonomia e superiorità.
Divorato da una vera e propria ossessione identitaria, il Soggetto Moderno, crede di riconoscere
nello Stato e nella Religione le forme istituzionali che possano garantirgli la ricomposizione del
proprio sé diviso fra mente e corpo.
5
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
Lo Stato Moderno, dotato d’un sovrano, d’un popolo e d’un territorio così ben definiti da poter
essere spesso percepiti come naturali contro ogni evidenza storica, alimentano il sentimento
dell’identità nazionale. Lo Stato ha un proprio corpo di leggi, una moneta, una burocrazia, un
esercito e sa comunicare con gli altri stati attraverso la propria diplomazia; infine può apparire come
l’abito col quale il Soggetto, trova un’appartenenza adeguata all’esigenza di cogliere l’infinitamente
grande, molteplice e mutevole, a partire dalla sua dimensione infinitamente piccola e altrimenti
priva di collocazione. Lo Stato Moderno è un prodotto degli uomini e della loro intenzione, come
recita la concezione contrattualista, di sottrarsi a una condizione naturale in cui prevalgono gli istinti
disaggreganti. Ma lo Stato Moderno continua equivocamente a essere, nell’idea di volontà generale
espressa da Rousseau, anche lo Stato organico che gli antichi avevano concepito come sovrastante
la determinazione degli individui. Così, nella sintesi idealistica di Hegel come nelle sanguinarie
pagine della Rivoluzione Francese, lo Stato si prepara e essere l’entità in cui si afferma un’idea di
cittadinanza che ha l’inequivocabile sapore illuminista d’una nascente religione laica. In esso, il
Soggetto ritrova l’antica ragione del proprio essere animale politico che è come dire adatto a vivere
nella polis e dunque con gli altri uomini. Così lo Stato Moderno indica al Soggetto quali sono gli
uomini con i quali costruire quel sentimento dell’identità nazionale che rafforza l’individuo nel suo
percepirsi in un’unità sostanziale con i molti che condividono la sua stessa cittadinanza.
D’altro canto è alla Religione che il Soggetto dovrà rivolgersi per accedere a quell’universalità
che continua a percepire come il proprio irrinunciabile orizzonte ultimo. Ma il Soggetto che ha
eletto con Cartesio il dubbio a metodo per affrontare i propri problemi esistenziali, che con
Montaigne avverte la propria anima in uno stato di continuo tirocinio, è cauto quando non scettico
ove si tratti di guadagnare verità universali. Del resto, nei diversi abiti dello Stato Moderno, la
Religione deve misurarsi con la visione atea delle cose che la ragione illuministica suggerisce fin
dalle sue prime prove (Pierre Bayle Trattato della tolleranza universale, 1686). Da questo
confronto, derivano almeno tre conseguenze di grande rilievo:
- la religione non può pretendere di esprimere verità assolute (Bayle)
- la Chiesa altro non è che un ente privato (Bayle)
- la funzione pubblica è detenuta dallo stato laico (Locke).
La storia era stata buona maestra di questi orientamenti: dalla Riforma alla Controriforma, dalla
pace di Augusta del 1555 (che sancisce, col diritto d’ogni re a professare la propria religione, il
dovere dei sudditi a riconoscersi nella medesima scelta) a quella di Westfalia del 1648 (che aveva
esteso la libertà dei sovrani a ogni individuo), Stato e Religione erano venuti definendo la loro
reciproca autonomia nel rispetto del Soggetto.
6
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
Per quanto schematica, del resto avevo anticipato che non intendo approfondire la cosa con
rigore filologico, questa lettura della modernità evidenzia come la tolleranza sia impensabile al di
fuori di una cultura del Soggetto Moderno.
Attraverso l’elaborazione della tolleranza, l’Altro è a sua volta identificato nella distanza che lo
divide dal Soggetto. Come dire che la tolleranza richiede:
- la distinzione radicale (e moderna) tra soggetto che tollera e oggetto tollerato
- la definizione, direi territoriale, dei due campi in cui soggetto e oggetto si situano
- il verso, inequivocabilmente dal soggetto all’oggetto, dell’azione che li riguarda.
Siamo dunque compiutamente all’interno dello schema inclusione-esclusione che lo spirito di
tolleranza non ci aiuta a superare, ma a interpretare nel rispetto dei diritti d’ogni alterità. Cosa non
di poco conto, occorre ammettere, in un’epoca come la nostra ancora caratterizzata da espressioni
forti e preoccupanti d’intolleranza. Ma non basta: proprio lo spirito di tolleranza ci ha resi avvertiti
del fatto che neppure essa stessa può pretendere d’affermarsi come una nozione assoluta. Chi non
ammetterebbe infatti che certe azioni e certi principi devono essere giudicati intollerabili? Pensare
di tollerare tutto ciò che accade comporterebbe una visione rassegnata e priva d’ogni valenza morale
nei confronti degli accadimenti.
Per queste ragioni la tolleranza rappresenta un guadagno irrinunciabile.
Nondimeno, la sua reputazione è venuta declinando nel XX secolo al punto da essere ormai
utilizzata quasi esclusivamente a contrariis, per affermare il rifiuto dell’intolleranza. Si direbbe che
l’idea di tolleranza conserva i suoi significati tradizionali quando ci si riferisca all’ordine
macrosociale o all’ambito politico: come sinonimo di democrazia e liberalità costituisce un valore
ove si affermino istanze autoritarie. Ma è nell’ambito delle relazioni interpresonali che la sua
pregnanza si affievolisce o addirittura si converte in disvalore: chi sarebbe contento d’essere
tollerato, chi userebbe l’espressione ti tollero con intenzioni benevoli? Uno studio sul tipo sociale
dell’individuo tollerato, condotto secondo le modalità con le quali Schutz ci consegnò gli
impareggiabili ritratti dello straniero, del reduce, del cittadino ben informato, ci aiuterebbe
probabilmente a capire le ragioni della distanza tra concetto e uso del termine nelle relazioni
interpersonali.
Nell’interpretazione della società multiculturale è prevalso in passato, e ancor oggi è talvolta
presente, un approccio che definirei di tipo integrazionista ancora ispirato alla cultura del soggetto e
della tolleranza.
E’ quanto accade ogni volta che si identifica la società multiculturale con i problemi posti
dall’immigrazione (dimenticando le cause endogene della differenziazione culturale) o quando si
afferma che l’Italia, avrebbe conosciuto solo negli ultimi decenni l’immigrazione (dimenticando
come sia stata per secoli la meta privilegiata di quanti hanno avuto aspirazioni egemoniche nel
7
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
Mediterraneo e come di ciò siano vitale espressione la varietà delle nostre città, dei dialetti e del
cibo, aspetti significativi della cultura materiale).
Questo modo d’indirizzarsi alla lettura della società multiculturale, muove dal fraintendimento
che essa costituisca un’emergenza alla quale far fronte con politiche di contenimento e controllo
dell’ordine pubblico. La soluzione dei problemi è allora affidata al Ministero degli Interni mentre
nelle città gli Assessorati ai Servizi Sociali allestiscono appositi uffici per stranieri deputati al primo
intervento a favore degli immigrati e alla soddisfazione dei loro bisogni elementari: casa, lavoro e
salute. L’esito più alto cui accede questo tipo d’impostazione consiste nel concepire politiche
d’assimilazione o integrazione dello straniero. Si chiarisce così come l’Altro può essere tollerato in
quanto si progetta la sua riduzione all’integro, all’unità rappresentata dal Soggetto egemone. La
visione integrazionista pretende di applicare all’alterità che più sopra ho definito distante gli stessi
criteri di socializzazione che abitualmente si utilizzano quando si deve intervenire su forme di
marginalità e devianza che riguardano la popolazione autoctona e quindi l’alterità prossima.
L’immigrato è insomma assimilato a un deviante cresciuto nella propria cultura e che ci si adopera
per riconsegnarlo alle tradizioni originarie.
Non dobbiamo credere che questo esito sia rivelatore di una sottostante concezione razzista, che
pure non ha mancato di farsi sentire su questi temi in Europa e talvolta anche in Italia. In realtà, il
razzismo, nel considerare ogni forma di meticciato un impoverimento delle razze che concorrono a
determinarlo, non mette conto di promuovere politiche integrazioniste, ma opera unicamente nel
senso dell’esclusione. Semmai, l’integrazionismo prende le mosse da un utilizzo improprio delle
espressioni società multirazziale o multietnica con le quali si afferma il concetto che su uno stesso
territorio convivono razze diverse. Ora non vi è dubbio che vi siano sulla terra uomini diversi per il
colore della pelle, degli occhi e dei capelli, per la struttura del corpo o la frequenza dei gruppi
sanguigni. Il fatto che queste diversità siano raggruppabili in tre grandi famiglie (caucasica,
mongolica, negroide) chiamate razze, oppure che ogni diversità sia contenuta nel più grande insieme
definito umanità, come ci ha insegnato Einstein, non è di per sé rilevante anche se ognuno può
comprendere come i due approcci siano opposti e presuppongano inconfrontabili sistemi di valore.
Ma in ogni caso, la singola razza, volendo dar credito a questo concetto, ha dato vita a numerose
culture che nei secoli e nei millenni, non certo in questo volger d’anni, sono venute incontrandosi,
contaminandosi, arricchendosi in un intreccio e in una complessificazione irriducibile alle famiglie
originarie. Certo persistono, come ci insegnò Lévi Strauss, problemi di non scarsa entità legati alle
ragioni per cui in certe parti del mondo il progresso ha camminato più in fretta, ma a parte le
difficoltà nel valutare il processo d’incivilimento dei popoli, resta il fatto che ogni tentativo di
riconquistare la mitica purezza razziale perduta è stato smentito, e quanto dolorosamente sappiamo,
dalla storia. Contro ogni disegno volto a ricondurre la varietà all’unità, s’è dunque imposto nei fatti
8
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
il processo contrario che testimonia come nel mondo siano le diverse culture, certamente assai più
numerose delle razze, a muoversi, incontrarsi e comunicare. Negli ultimi anni, da quando s’è venuta
disegnando una nuova geografia umana del globo, ogni individuo che nasca in un luogo qualsiasi
della terra ha più probabilità di morire in un altro che non in quello d’origine. In questa situazione
storica, il bianco, il nero e il giallo che s’incontrano, dialogano e confliggono sullo stesso territorio
sono persone che hanno le stesse probabilità di appartenere o a culture diverse o alla medesima
cultura. Per questo è improprio parlare di società multirazziale; personalmente non sono interessato
a un dibattito, tutto ideologico, sull’opposizione razzismo e antirazzismo che finirebbe
inevitabilmente per restare subalterna ai risultati di un qualche laboratorio che ci consegnasse una
nuova e definitiva scoperta scientifica in proposito.
L’idea di società multiculturale rappresenta insomma un guadagno teorico e non un
cambiamento di superficie perché costituisce un paradigma attraverso cui interpretare le relazioni
tra gli individui nei contesti sociali laddove l’espressione società multirazziale ne descrive la
condizione, che si pretende naturale, a partire da un presupposto per ciò stesso ideologico.
Per quanto detto, un approccio integrazionista è inapplicabile alla società multiculturale in
quanto pretende di ridurre all’uno il molteplice trattandolo come una deviazione dell’uno.
In Italia, a partire dagli anni Novanta, piuttosto nella Scuola che nei Servizi Sociali, si è venuto
affermando un approccio interazionista che tende a superare l’impostazione assistenzialistica del
periodo precedente avendo guadagnato una nuova cultura della diversità.
Negli anni che precedettero la riforma del 1963 e l’istituzione della scuola media unificata, in
pieno boom economico, i flussi migratori dal meridione al settentrione del Paese crearono in alcune
regioni situazioni non troppo diverse da quelle attuali. I figli di contadini pugliesi, pastori sardi o
pescatori siciliani trasferitisi nelle grandi fabbriche del nord non conoscevano affatto l’italiano della
Scuola. Del resto, anche i figli degli operai e dei contadini settentrionali, abituati all’uso del dialetto,
s’imbattevano in problemi analoghi.
Ebbene, in quel periodo, la strategia adottata fu di tipo integrazionista: si operò così da
ricondurre le diverse culture della nuova utenza a quell’unica che si voleva imporre come modello
generale anche a prezzo di esclusioni numericamente assai rilevanti.
Questo schema è stato ripetuto in altre circostanze.
Anche le donne hanno rappresentato per la Scuola una nuova utenza solo a partire dagli anni
Settanta. Nei decenni precedenti, esse erano scarsamente presenti come discepole e soltanto in un
numero limitato di ordini scolastici mentre assai di rado accedevano ai gradi superiori
dell’istruzione. La cultura che le donne apprendono a Scuola e attraverso i libri di testo, come è
stato denunciato in modo esauriente, è quella degli uomini che prima le escludono dal sistema
dell’istruzione e, successivamente, non potendo persistere in questa pretesa per ragioni che
9
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
attengono essenzialmente alla necessità economica di introdurle, seppure in modo subalterno, nei
meccanismi produttivi della società industriale, tendono a integrarle nel loro modello.
E ancora, una nuova utenza è stata costituita dagli handicappati di cui si è perseguita
l’integrazione attraverso pratiche di omologazione ai cosiddetti normodotati.
Quando, attraverso rivendicazioni, lotte politiche e processi sociali assai complessi, la nuova
utenza si è imposta come un soggetto di diritto e ha saputo rendere pubblica l’identità che prima era
dissimulata e negletta, la Scuola è passata dall’approccio integrazionista a quello interazionista.
Esemplare in questo senso il caso dell’handicappato. In pochi anni, questa espressione è
apparsa inadeguata e offensiva: in realtà essa identifica il tutto con la parte, la persona col suo
deficit, e prospetta la sua condizione come immodificabile. Per questo, l’espressione portatore
d’handicap è sembrata meglio corrispondente alla situazione. Ma ben presto, anche per le prove
spesso straordinarie offerte da questi soggetti quando siano messi nelle condizioni di esprimere
compiutamente le loro potenzialità, si è fatto ricorso alla locuzione portatore d’altre abilità il cui
significato è senz’altro eloquente.
Anche in questo caso, come nel passaggio da multirazziale a multiculturale, non siamo difronte
a un’operazione di superficie se non per chi si rifiuti di capire come le parole costituiscano un modo
d’interpretare le cose.
Da quelle passate esperienze, la Scuola ha acquisito che:
- ogni nuova utenza rappresenta un mondo di significati e valori;
- il confronto con una nuova utenza consente di mettere in discussione la norma vigente e i
modelli culturali di riferimento.
Sono queste le basi di un approccio interazionista che certamente non fiorisce nella cultura del
Soggetto, ma in quella della Relazione. Quest’ultima non vanta una storia altrettanto importante dal
momento che viene faticosamente affermandosi solo nel nostro tempo.
In materia di multiculturalità la Scuola italiana ha fatto tesoro di queste passate esperienze e in
tempi relativamente brevi ha guadagnato, già dall’inizio degli anni Novanta, principi e orientamenti
tipici dell’approccio interazionista.
Ci si muove con ogni evidenza in questa direzione quando si distingue multiculturalità e
interculturalità.
Il primo termine sta a indicare il dato di fatto di una società in cui convivono molte e diverse
culture mentre il secondo rappresenta l’orizzonte cui indirizzarsi, la società dove le diverse culture
sono in un significativo rapporto di comunicazione tra di loro. Con riferimento alla società
interculturale, si parla di educazione interculturale, espressione che sottolinea l’esigenza di
accedere a relazioni di tipo formativo non etnocentrate. Va detto che questa aspirazione non è certo
nuova, ma la società multiculturale le ha dato un particolare impulso. Dal superamento di visioni
10
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
comunque autocentrate deriva la tendenza a concepire la relazione formativa in termini di agire
educativo. Con ciò s’intende porre l’accento sul coinvolgimento di docente e discente nel costruire
insieme, seppure con ruoli e funzioni diverse, un percorso che risulti educativo per entrambi. Anche
in questo caso non si può certo dire che ci troviamo difronte a novità in senso assoluto: la pedagogia
ha da sempre sostenuto un indirizzo di questo tipo. Ma certamente la società multiculturale ha la
prerogativa di accentuare, rispetto al passato, il dato di esperienza e storie di vita alquanto
diversificate tra i soggetti della relazione educativa. Inoltre, i percorsi educativi e di crescita sono
fissati dalla Scuola in modi assai meno rigidi di quanto non accadesse in un recente passato e
corrispondono tendenzialmente alle esigenze locali e individuali. L’espressione agire educativo, che
in questo senso penserei mutuata dall’agire comunicativo di Habermas, richiede una comune
intenzionalità di docenti e discenti nella costruzione di percorsi comuni che non esistono prima e al
di fuori di quella stessa intenzionalità, che non appaiono in programmi ministeriali e indirizzi
stabiliti per un’intera generazione e comunque per altri che non siano i soggetti coinvolti nella
relazione. In questo senso l’agire educativo è un evento irripetibile che vive e si esaurisce con la
relazione che lo ha prodotto.
L’educazione interculturale non è dunque intesa dalla Scuola come la risposta a una
contingente situazione storica, ma rappresenta un valore permanente che non dipende dalla
presenza, tra i discenti, di questa o quella cultura.
A misura che viene affermandosi al di fuori della Scuola, l’approccio interazionista favorisce
un orientamento del diritto sempre più rispettoso dell’alterità: su questo, altri relatori si sono
ampiamente soffermati, altri torneranno sul tema nella prosecuzione dei nostri lavori e pertanto non
mi dilungherò. Intendo invece richiamare l’attenzione sul fatto che grazie a questa intelligenza della
situazione, le problematiche della società multiculturale, che come abbiamo visto erano
appannaggio del Ministero degli Interni, sono state assunte con sempre maggior interesse dal
Ministero della Pubblica Istruzione mentre a livello locale sono fioriti centri interculturali per
iniziativa degli assessorati alla cultura.
La società multiculturale, affrontata come emergenza e rischio in un recente passato, è ormai
riconosciuta anche come occasione di scambio fra culture diverse.
Sia chiaro che il mio non è un bilancio politico della situazione; mi propongo piuttosto di
prospettare due diversi atteggiamenti interpretativi e gli orizzonti concettuali ai quali mettono capo,
non certo di affermare una visone edulcorata del presente.
Da ultimo, l’approccio interazionista prevede, in luogo della tolleranza, l’ospitalità.
Nella nostra, come in altre lingue, il termine ospite indica sia colui che esercita l’azione di
ospitare sia chi la riceve. La cosa è possibile solo grazie alla deterritorializzazione e simultaneità
dello scambio.
11
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
La sollecitazione con la quale l’ospitante mette a disposizione la propria casa, Fai come fossi a
casa tua si sente spesso dire, è forse di dubbio gusto dal momento che insinua l’abitudine a chissà
quali comportamenti dell’altro, ma certamente mira, nelle intenzioni di chi la pronuncia, a creargli
una condizione di agio attraverso la sospensione della propria sovranità sullo spazio.
Nell’esercizio dell’ospitalità, gli ospiti si comportano come se nessuno fosse il padrone di casa
tranne che per gli aspetti inerenti la cura e il lavoro. Di norma, chi esercita l’ospitalità si assume
precise responsabilità pratiche, esonera l’altro da qualsiasi lavoro e, se non vi è una particolare
consuetudine nella frequentazione, respinge le sue offerte d’aiuto. D’altra parte, chi riceve
ospitalità, non s’ingerisce oltre un certo segno nell’operosità di chi lo ospita per non esautorarlo dal
suo ruolo. Nelle situazioni in cui l’ospitalità è vissuta con autentico piacere, chi ospita non avverte il
peso di queste incombenze dal momento che le interpreta sia come un’opportunità di esprimere
all’altro i sentimenti che ha nei suoi confronti, sia di godere della sua presenza liberata da ogni
onere e quindi, verosimilmente, più disposta a fornire il meglio di sé. Il padrone di casa esercita
dunque la sua sovranità sullo spazio solo per questi aspetti pratici e, per così dire, alberghieri. Al di
fuori di essi, la deterritorializzazione consiste nel rinunciare a qualsiasi pretesa di egemonizzare la
relazione. L’ospitato viene abitualmente messo nelle condizioni di esprimere sé stesso mentre chi
ospita, secondo la più antica tradizione consacrata dalle opere di Omero e Virgilio, si dispone al suo
ascolto. Semmai, in presenza di più ospitati, chi ospita svolge una funzione di regia cercando di
mitigare gli eccessi di eventuali ospiti così esuberanti da impedire agli altri di esprimersi a loro volta
come vorrebbero. La deterritorializzazione è evidentemente una simulazione alla quale gli ospiti si
attengono conoscendo, di norma, i limiti oltre i quali non è opportuno procedere. Quando chi ospita
reclamasse il ripristino del proprio ruolo di padrone di casa, vorrebbe dire che, per eccesso di
suscettibilità da parte sua o per imprudenza di qualche ospitato, quell’equilibrio è stato infranto. Lo
stesso discorso, a termini rovesciati, vale nel caso l’ospitato, sdegnato per qualche offesa ricevuta,
prenda cappello. In questi casi, il rito sociale dell’ospitalità s’interrompe: esso si esercita, nel suo
aspetto più proprio, finché la condizione di reciprocità fra chi dà e chi riceve ospitalità è vissuta
come deterritorializzazione.
L’ambivalenza del termine ospite non rimanda certo a due distinte situazioni nelle quali un
individuo, dopo essere stato ospitato, ospita a sua volta. Nell’ospitalità, lo scambio relazionale
avviene in modo simultaneo, non differito. L’ospite che ospita e quello che è ospitato, liberati dal
vincolo di marcare ciascuno il proprio territorio, celebrano il rito dell’ospitalità, più volte nella
stessa situazione, scambiandosi le parti. Se è l’ospitante che organizza l’ospitalità attraverso le cure
pratiche, come abbiamo visto, se a lui spetta il ruolo d’introdurre l’ospitato all’ospitalità vera e
propria disponendosi al suo ascolto, all’ospitato compete di non protrarre indefinitamente questa
12
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
situazione, ma d’introdurne la reversibilità così da mettere l’ospitante nelle condizioni di esprimere
a sua volta sé stesso.
Questo non significa naturalmente che nella storia della relazione fra due o più individui sia
fissato in modo irreversibile il ruolo di chi ospita e di chi è ospitato. Anzi, è senz’altro considerata
una buona norma di comportamento il restituire un’ospitalità ricevuta. E tuttavia, quando ciò accada
con eccessivo formalismo, quando lo stesso ospite non invita l’altro se non dopo essere stato a sua
volta invitato e soprattutto, se entrambi gli ospiti avvertono l’invito come incombenza e non come
piacere, allora siamo difronte a relazioni, che qui definisco convenzionali dove l’incontro è motivato
in modo più o meno esplicito, da interessi non per la relazione in quanto tale, come avviene
nell’ospitalità, ma per il ruolo sociale dei singoli. Nella relazione convenzionale non avviene affatto
la deterritorializzazione in quanto l’altro non è ascoltato per ciò che è, ma per le cose utili che può
dire a chi lo ascolta.
3. Socialità e pregiudizio
Non è il caso in questa sede di approfondire ulteriormente la riflessione sulla relazione
d’ospitalità: le considerazioni che abbiamo guadagnato dovrebbero essere sufficienti per tornare al
nostro tema. In che senso, ci si potrebbe chiedere, la relazione d’ospitalità può aiutarci a capire la
società multiculturale?
Le città nelle quali viviamo sono, assai più di quanto non accadesse nella società preindustriale,
massicciamente territorializzate. Ogni spazio dichiara esplicitamente un’appartenenza e con essa il
criterio della sua fruibilità per cui ciascun individuo sa quali luoghi gli sono interdetti e quali è
abilitato a frequentare, in quali circostanze, con quale ruolo. Lo spazio deterritorializzato, quello
pubblico, un tempo frequentato da un’intensa vita sociale, è oggi interpretato come luogo di transito
per muoversi da un contenitore all’altro. Questi contenitori non devono essere pensati
necessariamente come edifici: anche un segmento di strada, di piazza e perfino di giardino, di
bosco, di spiaggia possono essere territorializzati se in essi possiamo sostare soltanto nella qualità
di utenti. La strada, dove i soggetti produttivi sono in costante movimento e dove sostano,
abusivamente in quanto strada e marciapiede sono luoghi di transito, solo quanti vivono
d’elemosina, d’espedienti o di piccole truffe, è il luogo deterritorializzato delle nostre città dove
quotidianamente esercitiamo forme di spontanea ospitalità.
Nelle nostre case o, comunque, negli ambienti territorializzati esercitiamo il rituale
dell’ospitalità come una forma intenzionale di socializzazione. E infatti, come abbiamo visto, la
13
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
deterritorializzazione corrisponde a una simulazione intenzionale che alcuni individui decidono di
praticare entro limiti definiti.
La strada è invece un luogo autenticamente deterritorializzato dove un tempo si vivevano
intensi rapporti di socializzazione mentre oggi, nella dimensione del traffico e del transito, i rapporti
sono piuttosto di sociabilità come avrebbero detto Georg Simmel, Leopold von Wiese e altri.
La sociabilità o socialità delle relazioni di strada è caratterizzata da rapporti inintenzionali e
istantanei mediati da precise regole sociali, quelle che riguardano essenzialmente il traffico e
comunque il movimento, da comportamenti collettivi consolidati nella cultura del posto e da un
linguaggio interpersonale eminentemente indessicale. Gli individui che entrano in fugaci relazioni
comunicano fra di loro essenzialmente col linguaggio del loro corpo, con una scarna gestualità o
con espressioni verbali che indicano le loro intenzioni al di là dei significati letterali espressi dalle
parole e locuzioni pronunciate.
L’ospitalità delle nostre città, per quanto ridotta allo spazio del traffico e del movimento,
suggerisce come esistano porzioni di mondo che non sono proprietà di nessun individuo e sulle
quali nessuno può esercitare la propria regalità. Sulla strada, l’ambiguità costitutiva dell’ospite, si
rivela al di là della simulazione in quanto ogni individuo è ugualmente ospitato e condivide con gli
altri, seppure istantaneamente, una comune appartenenza.
Ma chi sono gli individui che si muovono sulla strada?
Possiamo distinguerli in due categorie: quella dei produttori e quella dei barboni, vu’cumpra,
artisti di strada, zingari: la congerie insomma d’individui che possiamo definire la corte dei miracoli
della città. Costoro vivono sulla e della strada e traggono le loro risorse, come abbiamo già visto,
dall’altrui carità, da espedienti e piccole truffe.
Identifichiamo ora i produttori e la corte dei miracoli in due categorie radicalmente
giustapposte e che intendo usare ironicamente: il Noi e il Loro.
I produttori corrispondono alla categoria del Noi che abitualmente concepiamo come la
centralità della relazione; la corte dei miracoli corrisponde alla categoria del Loro che è come dire il
luogo periferico della relazione. La categoria del Noi ha effettivamente un ruolo centrale nel sistema
produttivo e, conseguentemente, nella città-istituzione dove la categoria del Loro ha invece un ruolo
manifestamente subalterno e periferico. Ma nella città-strada i rapporti si rovesciano. La categoria
del Noi tende a vivere la strada per attraversarla, quella del Loro per radicarsi in essa fino a
eleggerla come luogo della propria appartenenza e visibilità sociale. Come dire che sulla strada, nel
luogo dell’ospitalità, la categoria del Noi è periferica e quella del Loro centrale. Rispetto al sistemacittà, l’identità delle due categorie è mutevole e irriducibile a criteri assoluti: il Noi e il Loro, che
rappresentano emblematicamente la polarità irriducibile, sarei a dire la fondazione teorica della
stranieritudine, rivelano qui, a una lettura per l’appunto ironica, la loro inconsistenza.
14
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
Ma non basta. Anche analizzandole con riguardo alla loro relazione, le categorie del Noi e del
Loro si rivelano meno rigide e oppositive di quanto si potrebbe credere.
Assunte singolarmente, nell’insieme delle figure sociali che ciascuna rappresenta, esse stanno
evidentemente in un rapporto di reciproca alterità. Ma se le scomponiamo nei loro componenti, le
cose cambiano.
Con riferimento alla tradizionale cultura d’appartenenza e a quella della città, la popolazione
del Noi comprende individui autoctoni e alloctoni. Lo straniero che lavora è infatti un produttore (e
come tale appartiene alla cultura del Noi) di cultura alloctona. Considerazioni analoghe valgono per
la categoria del Loro che contiene a sua volta individui autoctoni e alloctoni. Il barbone e il vu‘
cumprà vivono ugualmente sulla e della strada, ma il primo ha un’originaria cultura autoctona, il
secondo alloctona.
Nella dimensione della strada abbiamo dunque relazioni fra diversi tipi di alterità, con riguardo
alle categorie qui richiamate.
Un produttore autoctono e un barbone autoctono, per esempio, stanno in una relazione
d’alterità, appartenendo alle opposte categorie del Noi e del Loro; ma, condividendo le medesime
tradizioni, appartengono, rispetto a queste, alla medesima identità culturale: definiremo pertanto la
loro relazione con l’espressione alterità prossima.
Per le stesse ragioni, un produttore autoctono e un vu’cumprà alloctono non avendo fra di loro
nessuno dei due elementi d’identificazione considerati, sono in una relazione che definiremo
d’alterità distante.
Su queste basi possiamo stabilire i quattro tipi di relazione compresi nella tavola seguente.
NOI
LORO
autoctoni
autoctoni
alloctoni
alloctoni
autoctoni
alloctoni
autoctoni
alloctoni
ALTERITA’
PROSSIMA
X
ALTERITA’ DISTANTE
X
X
X
Nella vita quotidiana, hanno evidentemente relazioni anche individui autoctoni e alloctoni
appartenenti alla medesima famiglia del Noi o del Loro ma di questi non ci interessa considerare la
relazione dal momento che mi sono proposto di analizzare la relazione tra individui che
rappresentano l’opposizione Noi – Loro. Da questo punto di vista, un produttore autoctono e uno
alloctono sono identificati nella famiglia del Noi e non stanno dunque fra di loro in un rapporto
d’opposizione. Lo stesso diremo per due individui della corte dei miracoli di cui uno sia autoctono e
15
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
l’altro alloctono: in questa riflessione essi sono identificati nella famiglia del Loro e non stanno
quindi in un rapporto d’opposizione.
Fra quelle individuate, la relazione tra produttori autoctoni e corte dei miracoli alloctona
rappresenta il luogo in cui più acuto è il pregiudizio sociale.
La relazione a essa simmetrica, quella fra produttori alloctoni e corte dei miracoli autoctona è
probabilmente caratterizzata da pregiudizi non meno radicati, ma che ha una minore possibilità di
permeare il senso comune e quindi d’espandersi sia per la posizione numericamente minoritaria dei
produttori alloctoni e il loro scarso peso, almeno in Italia, nei luoghi del consenso sociale, sia per
l’irrilevanza che la corte dei miracoli, autoctona o alloctona che sia, ha nella formazione
dell’opinione pubblica.
La relazione tra produttori autoctoni e corte dei miracoli alloctona assume, nell’immaginario
collettivo, i caratteri della polarità assoluta, quella che riassume in sé ogni forma di
contrapposizione fino a cancellare nel senso comune ogni altro tipo d’opposizione. Attraverso di
essa l’alloctono è indebitamente identificato col vu’cumprà e l’autoctono col produttore.
Il pregiudizio sociale, che riprendendo l’etimologia, viene considerato come un giudizio
affrettato, formulato prima di avere una conoscenza appropriata della situazione, rivela, proprio in
questa relazione, la sua più vera natura. Esso non è un giudizio errato quanto al tempo della sua
formulazione, ma piuttosto deriva dalla percezione, del tutto arbitraria, che la propria collocazione
sia centrale nella relazione. Il pregiudizio è insomma il frutto di una cultura autocentrata che non sa
porsi in una relazione d’ospitalità con l’alterità, che non sa, per quanto detto, deterritorializzarsi
nemmeno quando, come nel caso della strada, non vi è una proprietà da vantare né una regalità da
esercitare.
Ho prospettato recentemente, nell’ambito del seminario Scuola ed interculture: aspetti
psicopedagogici e didattici, organizzato dall’Assessorato ai Servizi Educativi del Comune di
Parma, un’indagine su sette aree di pregiudizio che la popolazione autoctona dei produttori potrebbe
avere nei confronti di quella alloctona della corte dei miracoli. Senza escludere che possano
esisterne altre, le sette aree individuate sono le seguenti:
Prima area d’incompatibilità: il tempo di vita quotidiana.
Il tempo di vita dei produttori autoctoni, è occupato da una sorta di ossessione per il lavoro e
per l’efficienza produttiva. Essi si comportano come se avessero sempre più cose da fare del tempo
di cui dispongono.
I vu’cumprà dichiarano esplicitamente un diverso modo di vivere. Nella città industriale
trascorrono la giornata appoggiati a un muro con l’aria di chi guarda il mondo che passa davanti ai
loro occhi senza poterci fare nulla. Per gli autoctoni del Noi, che vivono come se fossero persuasi di
16
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
sapere indirizzare il mondo secondo i disegni più appropriati, questo atteggiamento è giudicato una
forma di rassegnata apatia, un’indolente resa agli eventi.
Seconda area d’incompatibilità: lo spazio di vita quotidiana.
Lo spazio pubblico della città, superata l’adolescenza, è usato essenzialmente dai produttori
autoctoni per attraversarlo. Quando non siano turisti, si muovono freneticamente nelle loro città che
vivono come lo spazio esistente fra luoghi pubblici e privati verso i quali dirigersi in tutta fretta.
La presenza dei vu’ cumprà nello spazio della città, il radicarsi nello spazio pubblico così da
diventarne paesaggio, costituisce una sorta di sguardo ironico sul sistema di vita dei produttori
autoctoni.
Terza area d’incompatibilità: il privatizzarsi dell’esperienza di vita
La città industriale ha aperto, al suo nascere, un processo di progressiva diserzione dello spazio
pubblico. Il carattere tendenzialmente autosufficiente delle abitazioni, come degli altri contenitori
privati o pubblici, ha svuotato la città dei suoi originari valori. Essa non è il luogo degli affetti, che è
la casa, non è il luogo dell’educazione, che è la scuola, né quello della socializzazione, che ognuno
cerca nei posti più diversi, e neppure dei riti, della preghiera, tantomeno dell’espressività.
I vu’ cumprà non ricreano lo spazio pubblico, ma, con la loro presenza, dicono che le strade e
le piazze della città possono essere vissute mentre i produttori del Noi si ostinano nell’affermare il
contrario.
Quarta area d’incompatibilità: la scolarizzazione della vita
La cultura occidentale tende a scolarizzare tutta l’esperienza vissuta. Oltre agli otto-dieci anni
di scolarizzazione obbligatoria, molti individui ne vivono altrettanti sui banchi di scuola. Ma non
basta: è diffusa la tendenza a scolarizzare gran parte delle esperienze di vita. Tutto, o quasi, quanto
c’è da imparare, passa attraverso una qualche forma di scolarizzazione; alla scuola si attribuisce,
con una certa disinvoltura, qualsiasi emergenza sociale e si pretende che sia essa stessa a farsene
carico.
Per i la popolazione alloctona che vive sulla e della strada, le cose stanno diversamente. Se si
chiede loro come hanno imparato la lingua del posto e tutto ciò che sanno della civiltà in cui vivono
come di quella in cui sono cresciuti, invariabilmente risponderanno che la loro scuola è la strada, è
la piazza.
17
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
Quinta area d’incompatibilità: la civiltà orale
La civiltà della scrittura, che i paesi industrializzati hanno conosciuto a livello di massa
soltanto alla fine del secolo scorso, ha in poco tempo cancellato la tradizione orale dalla memoria
collettiva. Quest’opera di rimozione evidenzia il suo carattere ideologico quando si generalizza
indebitamente la propria esperienza. Oggi un miliardo di individui non sono alfabetizzati e in tutti i
paesi industrializzati l’analfabetismo di ritorno riguarda porzioni consistenti di popolazione.
Nonostante queste contraddizioni, la rimozione della civiltà orale, la tendenza a considerarla come
un residuo del passato da bonificare, impedisce di coglierne i valori e la significatività.
Le culture dei paesi poveri dicono, anche nelle strade delle nostre città, di un diverso rapporto
con la civiltà orale e della possibilità di custodirne i significati anche nel nostro tempo.
Sesta area d’incompatibilità: le promesse della scienza
Per molti anni, i produttori del Noi hanno dimostrato di credere in un’idea di progresso che
prometteva di risolvere le grandi contraddizioni del pianeta. L’anno 2000 è stato indicato come la
scadenza simbolica per una svolta decisiva nella storia dell’umanità che avrebbe cancellato la fame
e la miseria mentre si sarebbero trovati gli opportuni rimedi alle più gravi malattie. Oggi è
convincimento diffuso che l’utopia del 2000 non si realizzerà. La stessa cultura che ha prodotto
l’idea di progresso sta annientando le primarie risorse della vita mentre il divario tra paesi ricchi e
poveri cresce di giorno in giorno. Nonostante le capacità di calcolo e previsione del futuro si siano
affinate, nessuno è in grado di fare previsioni attendibili sul futuro mentre le ipotesi più rosee si
confondono con le teorie catastrofiste.
A fronte di questa situazione, la sola presenza dei vu’ cumprà ha il significato inquietante di
una promessa non mantenuta. Loro sono qui anzitutto perché nelle loro terre non è fiorito il
benessere promesso e anzi, spesso, proprio quelle terre sono state inquinate e devastate dal sistema
produttivo che doveva risanarle.
Settima area d’incompatibilità: la sessualità
Ho riservato per ultima l’incompatibilità che considero più importante, quella rimuovendo la
quale, le altre vengono, se non risolte, quantomeno interpretate in una nuova prospettiva: intendo
l’incompatibilità sessuale.
Vivono nelle città ricche molti vu’ cumprà senza compagna e senza lavoro. Due grandi
principi d’ordine sono così trasgrediti: il legame sessuale e il legame sociale che, attraverso il
lavoro, si riflette sui tempi di vita e sulle relazioni interpersonali.
Non bastasse, ovunque in Europa, i neri che abitano le città occidentali e intercettano i
produttori autoctoni nei loro movimenti quotidiani per vendere i loro prodotti sono fieri, belli e
18
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
dignitosi. Essi hanno la carica vitale che è propria dello straniero, di chi è andato in un mondo
nuovo intenzionato a giocarsi un’opportunità concreta.
Da questo punto di vista, volendo adottare il linguaggio che l’antropologia utilizza per
descrivere le lotte fra le società primitive, potremo dire che, nella gara per la conquista delle donne
che ha sempre caratterizzato lo sviluppo delle civiltà, i neri sono maschi oltremodo competitivi. La
durezza di queste parole non suoni a offesa delle donne che nessuno più può considerare come
prede: sono piuttosto una esplicita critica nei confronti degli uomini e dei loro modelli sociali.
In rapporto alla nostra popolazione, è intuitivo che il modo di vivere la città dei vu’ cumprà
secondo logiche piuttosto improntate alla relazione che all’efficienza produttiva, sia più vicino alla
sensibilità femminile che a quella maschile.
Nel considerare le relazioni interculturali, i rapporti sessuali non sono abitualmente tenuti nel
dovuto conto. I demografi continuano a fare previsioni senza considerare il peso e l’incidenza della
popolazione che viene dal sud del mondo. Inoltre, la nostra cultura della sessualità, divenuta in tutta
fretta liberale da un pugno d’anni e costruita su una cultura della corporeità inventata nelle palestre
e dal sapore tipico del prodotto succedaneo, dovrà fare i conti con i loro più severi costumi sessuali
fondati su un linguaggio del corpo esercitato in una tradizione millenaria.
Ognuna di queste sette aree d’incompatibilità è, nella mia ipotesi, un possibile luogo di
pregiudizio sociale che meriterebbe d’essere approfondito nell’ambito dell’educazione
interculturale. Per muoversi in questa direzione occorre assumere come elementi guida per la
ricerca due aspetti che ho ampiamente illustrato in questa esposizione e che riassumo così:
- la strada, come luogo deterritorializzato dell’ospitalità pubblica non appartiene a nessuno
e non legittima nessuna visione di tipo autocentrato
- l’opposizione Noi – Loro non è assoluta, ma rientra in un sistema di relazioni in cui la
cultura alloctona può appartenere alla famiglia del Noi e quella autoctona alla famiglia del
Loro.
Muovendo da questi assunti, la condizione del Loro, nelle sette aree indicate, può essere
relativizzata in un duplice senso:
- gli individui che compongono la famiglia del Loro non rappresentano l’intera cultura
alloctona del territorio che invece comprende anche individui ascritti alla famiglia del Noi
- è probabile che in alcune delle sette aree indicate si possa rilevare che la condizione
attuale del Loro coincida con quella del Noi in un’epoca passata, ma relativamente
recente.
Sono, queste, soltanto ipotesi che intendo approfondire in una futura ricerca da svolgere nell’ambito
dell’educazione interculturale; per ora mi consentono di concludere dicendo la città degli ospiti non
è un’astrazione, né un auspicio: essa è quella parte di città in cui gli individui della società
19
Alessandro Bosi, La città degli ospiti, in Annamaria Campanini (a cura di), Il servizio sociale in una società multietnica,
Milano, Unicopli, 2002
multiculturale si ospitano reciprocamente nell’ambito delle relazioni quotidiane. Per quanto
elementare, per quanto istantanea e inintenzionale possa essere, questa ospitalità ha un suo
particolare rilievo nello strutturare i modi con i quali ciascuno si rapporta all’alterità.
20