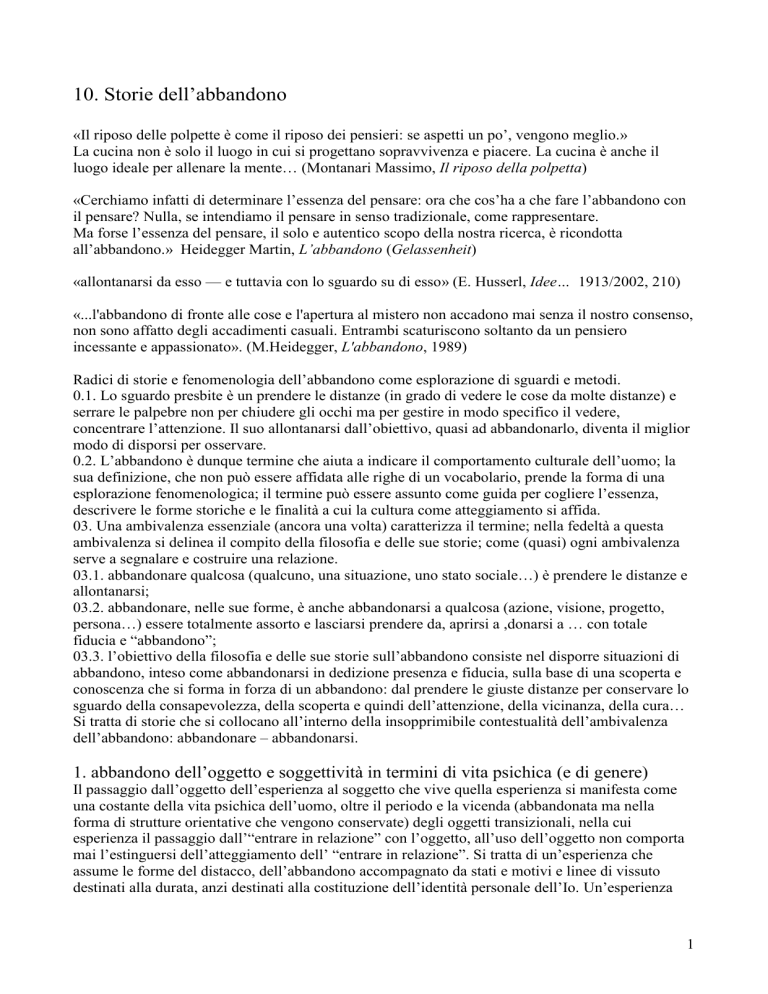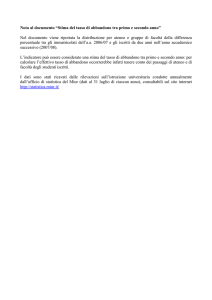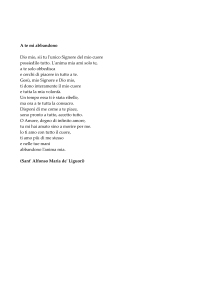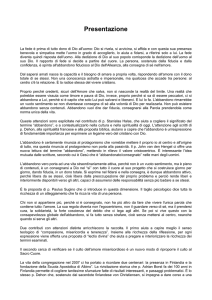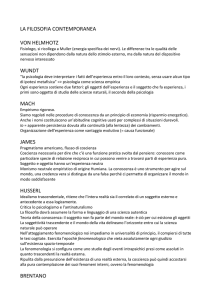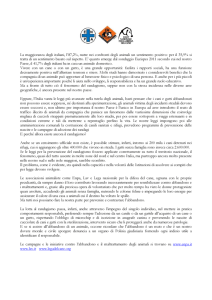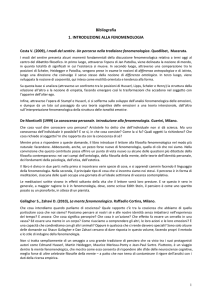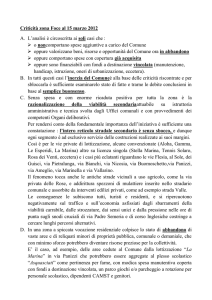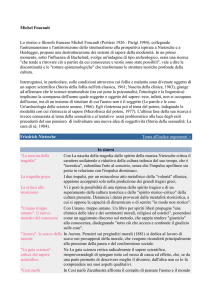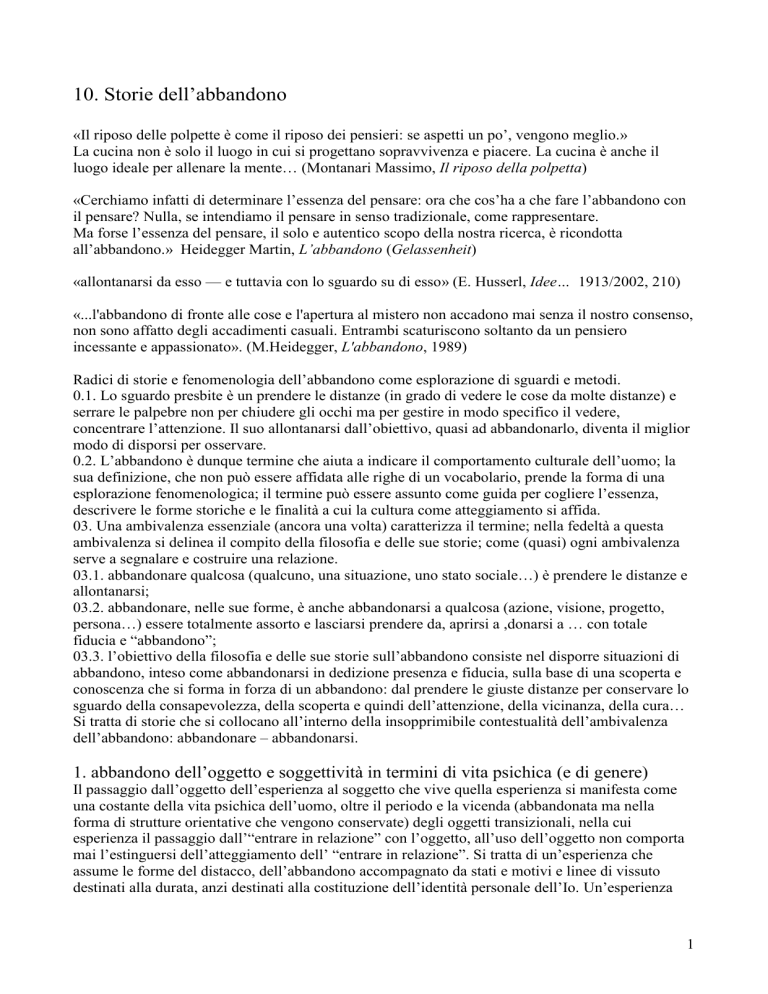
10. Storie dell’abbandono
«Il riposo delle polpette è come il riposo dei pensieri: se aspetti un po’, vengono meglio.»
La cucina non è solo il luogo in cui si progettano sopravvivenza e piacere. La cucina è anche il
luogo ideale per allenare la mente… (Montanari Massimo, Il riposo della polpetta)
«Cerchiamo infatti di determinare l’essenza del pensare: ora che cos’ha a che fare l’abbandono con
il pensare? Nulla, se intendiamo il pensare in senso tradizionale, come rappresentare.
Ma forse l’essenza del pensare, il solo e autentico scopo della nostra ricerca, è ricondotta
all’abbandono.» Heidegger Martin, L’abbandono (Gelassenheit)
«allontanarsi da esso — e tuttavia con lo sguardo su di esso» (E. Husserl, Idee… 1913/2002, 210)
«...l'abbandono di fronte alle cose e l'apertura al mistero non accadono mai senza il nostro consenso,
non sono affatto degli accadimenti casuali. Entrambi scaturiscono soltanto da un pensiero
incessante e appassionato». (M.Heidegger, L'abbandono, 1989)
Radici di storie e fenomenologia dell’abbandono come esplorazione di sguardi e metodi.
0.1. Lo sguardo presbite è un prendere le distanze (in grado di vedere le cose da molte distanze) e
serrare le palpebre non per chiudere gli occhi ma per gestire in modo specifico il vedere,
concentrare l’attenzione. Il suo allontanarsi dall’obiettivo, quasi ad abbandonarlo, diventa il miglior
modo di disporsi per osservare.
0.2. L’abbandono è dunque termine che aiuta a indicare il comportamento culturale dell’uomo; la
sua definizione, che non può essere affidata alle righe di un vocabolario, prende la forma di una
esplorazione fenomenologica; il termine può essere assunto come guida per cogliere l’essenza,
descrivere le forme storiche e le finalità a cui la cultura come atteggiamento si affida.
03. Una ambivalenza essenziale (ancora una volta) caratterizza il termine; nella fedeltà a questa
ambivalenza si delinea il compito della filosofia e delle sue storie; come (quasi) ogni ambivalenza
serve a segnalare e costruire una relazione.
03.1. abbandonare qualcosa (qualcuno, una situazione, uno stato sociale…) è prendere le distanze e
allontanarsi;
03.2. abbandonare, nelle sue forme, è anche abbandonarsi a qualcosa (azione, visione, progetto,
persona…) essere totalmente assorto e lasciarsi prendere da, aprirsi a ,donarsi a … con totale
fiducia e “abbandono”;
03.3. l’obiettivo della filosofia e delle sue storie sull’abbandono consiste nel disporre situazioni di
abbandono, inteso come abbandonarsi in dedizione presenza e fiducia, sulla base di una scoperta e
conoscenza che si forma in forza di un abbandono: dal prendere le giuste distanze per conservare lo
sguardo della consapevolezza, della scoperta e quindi dell’attenzione, della vicinanza, della cura…
Si tratta di storie che si collocano all’interno della insopprimibile contestualità dell’ambivalenza
dell’abbandono: abbandonare – abbandonarsi.
1. abbandono dell’oggetto e soggettività in termini di vita psichica (e di genere)
Il passaggio dall’oggetto dell’esperienza al soggetto che vive quella esperienza si manifesta come
una costante della vita psichica dell’uomo, oltre il periodo e la vicenda (abbandonata ma nella
forma di strutture orientative che vengono conservate) degli oggetti transizionali, nella cui
esperienza il passaggio dall’“entrare in relazione” con l’oggetto, all’uso dell’oggetto non comporta
mai l’estinguersi dell’atteggiamento dell’ “entrare in relazione”. Si tratta di un’esperienza che
assume le forme del distacco, dell’abbandono accompagnato da stati e motivi e linee di vissuto
destinati alla durata, anzi destinati alla costituzione dell’identità personale dell’Io. Un’esperienza
1
dinamica che innesca studi di rilievo e di analisi sia dal punto di vista psicologico (psicanalitico)
che dal punto di vista filosofico (gnoseologico).
Che fine hanno fatto i nostri oggetti transizionali? Che tipo di rapporto abbiamo maturato con la
realtà a partire da essi? Questa è l’area dell’abbandono e della sua dinamica.
1.1. l’abbandono dell’oggetto, formazione dell’indentità (identificazione). La vita dell’oggetto
nell’io: «regno delle tracce mestiche delle cose» (Freud, Butler in Butler Judith 1997 La vita
psichica del potere. Teorie della soggettivazione e dell’assoggettamento, Meltemi, Roma 2005 p.
162).
«Riflettendo sulle sue speculazioni in Lutto e melanconia, Freud scrive ne L’lo e l’Es che nel saggio
precedente aveva supposto che «un oggetto perduto tornasse a ergersi nell’Io, che cioè un
investimento oggettuale venisse sostituito da un’identificazione. Allora però non conoscevamo
ancora tutto il significato di questo processo e non sapevamo quanto frequente e tipico esso sia. In
seguito abbiamo compreso che una tale sostituzione concorre in misura notevole alla configurazione
dell’Io, contribuendo in modo essenziale a produrre ciò che viene chiamato il suo “carattere” (p.
491)». […] Egli conclude poi questa riflessione affermando che «questa identificazione è l’unica
condizione che consente all’Es di rinunciare ai propri oggetti (...) autorizza a pensare che il carattere
dell’Io sia un sedimento degli investimenti oggettuali abbandonati, tenente in sé la storia di tali
scelte d’oggetto (ib. p.492).» Ciò che Freud definisce il “carattere dell’Io” sembra essere la
sedimentazione degli oggetti amati e perduti, i cimeli archeologici di un lutto insoluto.
Ciò che forse stride maggiormente in questa riflessione è il capovolgimento della posizione su cosa
significhi rielaborare il dolore, rispetto a quella sostenuta in Lutto e melanconia. Nel saggio
precedente, Freud ritiene infatti che il dolore possa essere rielaborato attraverso un de-investimento,
una rottura dell’attaccamento, con la successiva formazione di nuove forme di attaccamento. Ne
L’Io e l’Es introduce la nozione che l’identificazione melanconica sia un prerequisito per poter
lasciar andare l’oggetto. Sulla base di una tale dichiarazione, cambia il significato di “lasciar andare
un oggetto”, ché non esiste una rottura decisiva dell’attaccamento. Avviene, piuttosto,
l’incorporamento dell’attaccamento come identificazione, laddove l’identificazione diventa una
forma magica e psichica di preservare l’oggetto. Nella misura in cui l’identificazione coincide con
la conservazione psichica dell’oggetto e tali identificazioni portano alla formazione dell’io,
l’oggetto perduto continua a ossessionare e abitare l’io come una delle sue identificazioni
costitutive. L’oggetto perduto, in questo senso, viene reso coestensivo con l’io stesso. In realtà, si
potrebbe concludere che l’identificazione melanconica permette la perdita dell’oggetto in un mondo
esterno precisamente in quanto fornisce un modo per conservare l’oggetto come parte dell’io, e
quindi per prevenirne la perdita definitiva. Qui vediamo che lasciar andare l’oggetto significa,
paradossalmente, non tanto un abbandono pieno dell’oggetto, quanto un trasferimento dello stato
dell’oggetto da esterno a interno.» (Butler 1997 p.127, 128-129) Identificazione e malinconia
diventano il nostro modo di gestire l’abbandono.
1.2. la situazione specifica della melanconia: identificazione melanconica e assoggettamento.
1.2.1. la situazione precedente descriveva l’identificazione attraverso l’abbandono; descrive infatti
come «un investimento oggettuale venisse sostituito da un’identificazione … una tale sostituzione
concorre in misura notevole alla configurazione dell’Io, contribuendo in modo essenziale a produrre
ciò che viene chiamato il suo “carattere”» (Butler 1997 p.127); situazione che «autorizza a pensare
che il carattere dell’Io sia un sedimento degli investimenti oggettuali abbandonati … Sulla base di
una tale dichiarazione, cambia il significato di “lasciar andare un oggetto”, ché non esiste una
rottura decisiva dell’attaccamento. Avviene, piuttosto, l’incorporamento dell’attaccamento come
identificazione, laddove l’identificazione diventa una forma magica e psichica di preservare
l’oggetto.» (Butler 1997 p.128)
1.2.2. l’identificazione melanconica è definita invece da una relazione specifica che si rapporta al
processo di “assoggettamento”: del diventare soggetto in un rapporto di sottomissione
(apprendimento formativo, educativo) alle molte autorità sociali consolidate;
2
1.2.2.1. la tesi: «la melanconia nel senso di Freud è il risultato di una perdita non compianta …
processo incompiuto del lutto» (Butler 1997, p.138,127). Essa è determinata dall’abbandono di un
oggetto (di una situazione, di un modo di essere) che non poteva essere posseduto, di cui non si
poteva dichiarare all’esterno, pubblicamente, socialmente e a se stessi, il possesso per le forti
proibizioni che lo impedivano e che lo auto-impedivano (si tratta di proibizioni esterne ed interne al
soggetto; sociali e individuali, come nel caso dell’incesto, della omosessualità… in generale la
formazione del genere, come produzione culturale sociale, è un lunga storia di proibizioni e
indirizzi preordinati). La mancata possibilità del possesso si traduce nell’impossibilità di dichiararne
la perdita. Si tratta dunque di una perdita impossibile o perdita negata, non pianta non pensabile non
narrabile; un lutto incompiuto, cioè non compiuto. La melanconia, in modo specifico, è dunque la
conservazione di una perdita negata, difficile da recuperare in tracce mestiche del vissuto (del
vissuto come non-vissuto, come negato).
1.2.2.2. il processo: abbandono per interiorizzazione, ma interiorizzazione melanconica (cioè di una
perdita non vissuta come tale, non elaborata, non riconosciuta) «Abbandonare l’oggetto diventa
possibile soltanto a condizione di un’interiorizzazione melanconica, oppure — cosa che sarebbe
ancor più importante per i nostri obiettivi — di un incorporamento melanconico.
Se nella melanconia viene rifiutata una perdita, non per questo essa viene abolita.
L’interiorizzazione mantiene la perdita all’interno della psiche; più precisamente, l’interiorizzazione
della perdita è parte del meccanismo del suo rifiuto. Se l’oggetto non può più esistere nel mondo
esterno, allora esisterà internamente, e tale interiorizzazione sarà un modo per rinnegare la perdita,
per tenerla a bada, per posticipare il riconoscimento e la sofferenza che ne deriva.» (Butler 1997
p.129)
1.2.2.3. l’esito: «Ne Il disagio della civiltà, Freud rende chiaro che la coscienza richiede il continuo
sacrificio o la rinuncia dell’istinto per produrre la particolare soddisfazione che essa stessa richiede;
la coscienza non trova mai appagamento nella rinuncia, ma ne è paradossalmente rafforzata (“la
rinuncia accresce l’intolleranza”, Freud 1929, pp. 610-619). La rinuncia non abolisce l’istinto;
schiera l’istinto per i suoi obiettivi, in modo tale che la proibizione, e l’esperienza vissuta della
proibizione come rinuncia ripetuta, sia nutrita proprio dall’istinto cui rinuncia.» (Butler 1997,
p.136) [può fornire un esempio il caso: il legame che intercorre tra l’istinto omosessuale (perdita
negata come tale) e la ossessiva, impaurita pulsione omofobica]; «… lo stesso Freud ne L’lo e l’Es
riconosce che la melanconia, il processo incompiuto del lutto, è centrale alla formazione delle
identificazioni che costituiscono l’io… Com’è dunque che nella melanconia il super-io può
diventare una sorta di concentrato delle pulsioni di morte?» (Butler 1997 p.127) [ancora come
esempio: la pulsione autodistruttiva, individuale e della civiltà, espressione di un legame libidico
con la vita e la civiltà non riconosciuto nell’abbandono.]
1.2.3. l’identificazione melanconica (l’interiorizzazione di una perdita non compianta) diventa il
contesto per le definizione del genere, della sua natura e del problemi che lo caratterizzano a livello
individuale e sociale, quando il genere viene appunto inteso come una gestione sociale della
sessualità secondo canoni ufficiali o socialmente controllati e legittimati dal consenso condiviso.
«Vorrei in primo luogo spiegare il senso in cui un’identificazione melanconica è centrale nel
processo attraverso il quale l’io assume un carattere di genere. In secondo luogo, vorrei esplorare
come questa analisi della formazione melanconica del genere metta in luce la difficoltà di vivere
entro una cultura che fatica a piangere la perdita dell’attaccamento sessuale.» (Butler 1997 p.127)
«Se l’assunzione della femminilità e l’assunzione della mascolinità procedono attraverso la
realizzazione di un’eterosessualità sempre debole, possiamo però comprendere la forza di questa
realizzazione che si esprime imponendo l’abbandono degli attaccamenti omosessuali, o forse in
modo più incisivo, prevenendo la possibilità di un attaccamento omosessuale, una forclusione.»
(Butler 1997 p.129) Una perdita di ciò che non si è mai posseduto in quanto precluso (forclusione),
non una negazione di una scelta consapevole esplicitamente vissuta (scelta, esclusione e rimozione).
1.2.3.1. Nota al termine “forclusione”: forclusione come proibizione preventiva che impedisce di
conseguenza di gestire il lutto per la perdita di ciò che non poteva essere perduto in quanto ne era
3
precluso il possesso o la possibile esperienza; quindi una perdita non tematizzabile, che non può
essere pianta; in quanto era “passione da non vivere” allora è “perdita da non piangere”; è la perdita
della perdita e la conseguente melanconia dell’essere o, in senso più ristretto, del genere; con la
conseguente debolezza di ogni forma di genere e di sessualità e di vivere sociale o relazione sociale,
generata e accompagnata dalla forclusione. «Dico “forclusa” per suggerire che questa sia una
perdita preventiva, un portare il lutto per possibilità non vissute. Se questo amore è fuori
discussione dall’inizio, allora non può accadere, e se accade, certamente non è accaduto. Se accade,
accade soltanto sotto il segno ufficiale della sua proibizione e del suo disconoscimento.» (Butler
1997 p.133) (Come nel caso, sopra in esempio, di atteggiamenti di omofobia ostentati con
immediata violenza e determinazione che svelano una omosessualità inconsapevole repressa ma
mai affrontata, perché non vissuta come repressione e perdita, che perciò non può essere tematizzata
né “compianta”, ma così interiorizzata, non le impedisce affatto di essere attiva, anzi segue la logica
dei comportamenti primari propri delle pulsioni dell’es.)
«Vorrei commentare che da un punto di vista fenomenologico vi sono molti modi di fare esperienza
della sessualità e del genere che non si riducano a questa equivalenza, che non presuppongono che
il genere sia stabilizzato attraverso l’insediamento di una eterosessualità sicura, ma per il momento
preferisco evocare questa costruzione rigida e iperbolica della relazione tra genere e sessualità, allo
scopo di risalire alla formazione di ciò che definiamo il carattere sessuato dell’io attraverso la
questione della perdita che non è stata, né può essere, compianta.» (Butler 1997 p.130)
1.2.3.2. Nota più generale: ipotesi di fondazione fenomenologica dell’abbandono, della
“forclusione”, della melanconia; ciò che è abbandonato (con una certa consapevolezza, come nella
rimozione, o senza consapevolezza a causa di una negazione preventiva, come nella forclusione e
nella conseguente melanconia dell’essere e del genere) viene conservato nella forma di ciò che è
abbandonato. Il tema si affaccia nella indagine di Husserl in occasione delle riflessioni su
«affermazione e negazione con i loro correlati noematici». Ogni negazione, che a livello di logica
diventa un caso di negazione / affermazione, nel vissuto della coscienza, entra a far parte di una
storia di rifiuto e di assenso, di abbandono e riconoscimento. La negazione è negazione di un porre;
non toglie la posizione negata ma la conserva come negata; la propone nella forma della
cancellazione e quindi le attribuisce una nuova modalità di essere (anche il non-essere è un modo
dell’essere e un dei suoi modi originari; Platone, Aristotele); la negazione «nel negatum ha il suo
prodotto positivo, un non-essere che è esso stesso essere» (Husserl 1913/2002 p. 269). In questa
conservazione del negato, nella consapevolezza che ciò che viene abbandonato è conservato nella
forma di ciò che è abbandonato, si collocano la mestizia e la melanconia della mente, la dinamica
del ritorno del dimenticato, l’urgenza con cui ciò che è oggetto di abbandono chiede la parola e
vuole uno spazio nella nostra narrazione. « Noi possiamo vivere nella coscienza negatrice, in altre
parole, «compiere» la negazione: in tal caso lo sguardo dell’io è diretto verso ciò che subisce la
cancellazione. Ma possiamo anche dirigere lo sguardo, in quanto sguardo afferrante, al cancellato
come tale, a ciò che porta il marchio della cancellatura: e in questo caso il cancellato si presenta
come un nuovo «obiectum», e si presenta nel semplice modo dossico originario di «esistente». Il
nuovo atteggiamento produce il nuovo obiectum d’essere; anche quando si «effettua» il rifiuto il
rifiutato è dato alla coscienza col carattere della cancellatura; ma soltanto nel nuovo atteggiamento
questo carattere diventa una determinazione che può essere attribuita come predicato al nucleo
noematico del senso. E lo stesso vale naturalmente per l’affermazione.» Husserl Edmund 1913 Idee
per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino 2002, p.266.
La negazione nell’abbandono come vissuto dotato e posto in una configurazione specifica. Ciò che
è presente come negato, non è semplicemente negato ma è presentificato come negato, nella forma
di un abbandono interiore.
[Un tentativo di sintesi – conclusione in passaggi rapidi
1. Un sistema sociale che assume tra i propri compiti quello della formazione di identità personali
accettate, condivise e apprezzate è definito dalle proprie proibizioni, da limiti ed esclusioni. (Valori,
principi, leggi come strumenti di selezione e delimitazione del campo del normale, civile…)
4
2. Il campo delle proibizioni preventive, delle preclusioni accompagnate da vergogna e stigma, è un
campo operativo nei processi di “assoggettamento”, termine con cui si indica (Foucault, Butler) sia
il cammino di formazione del soggetto sia le forme di sottomissione.
3. L’efficacia regolativa del processo di assoggettamento (nell’ambivalenza del termine) consiste
nel suo configurarsi come campo di definizione, limitazione, esclusione e conseguente perdita
predeterminata, ovvia e quindi inconsapevole o non tematizzata né rielaborata per il soggetto che si
fa soggetto (e si definisce socialmente nel genere) assoggettandosi. Limite che determina esclusione
e perdita, ma, per la sua preordinata ovvietà, si presenta come una perdita non vissuta come perdita.
4. Il campo delle formazioni/negazioni mette dunque in atto una esclusione e una sottrazione
preventive non tematizzate e non tematizzabili: una “forclusione”; una perdita che non può essere
compianta né rielaborata; interiorizzata come perdita, ma non avvertita come tale; il suo stato di
vissuto è indicato con il termine “malinconia”. Qui la malinconia trova la sua specifica definizione:
diventa un tratto del processo di identificazione dell’Io e un tratto del genere (considerato qui nella
versione del socialmente costruito).
5. Si tratta di una perdita che non può essere avvertita come tale, non è vissuta come abbandono,
non è compianta, ma ad un tempo non viene tolta o rimossa ma interiorizzata come perdita non
compianta; essa conserva però e perciò, anzi potenzia, l’efficacia di ciò che preventivamente
preclude.
6. Conserva una efficacia pulsionale e istintiva, ma nella forma della negazione e della preclusione;
nell’incapacità di risalire tematicamente alle proprie ragioni. Essa genera allora intolleranza e
violenza nei confronti di identità e atteggiamenti che si manifestino nella forma di ciò che è
precluso e di ciò che (in quanto forcluso) è melanconicamente interiorizzato come perso;
un’intolleranza emotiva istintiva e sorda . In altri termini, il “forcluso” (ciò che è forcluso) esplode
in intolleranza e “pulsione di morte” (verso di sé, l’altro, il contesto) tanto più violente quanto più
inconsapevoli delle proprie radici interiori o interiorizzate, per le quali non è mai avvenuta
l’accettazione dell’abbandono.]
[In sintesi della sintesi:
1. Un sistema sociale è definito dalle proprie proibizioni, limiti ed esclusioni.
2. Il campo delle proibizioni preventive (preclusioni) è operativo nei processi di “assoggettamento”:
formazione del soggetto, sottomissione.
3. L’efficacia del processo di assoggettamento consiste nel suo configurarsi come ovvio. Perché
ovvio il limite è perdita non vissuta come perdita.
4. Una esclusione preventiva non tematizzata: una “forclusione”;
una perdita interiorizzata ma non avvertita come tale: la “malinconia”
5. Perdita non avvertita come tale, non vissuta come abbandono, conserva però e perciò, anzi
potenzia, l’efficacia di ciò che preventivamente preclude.
6. Conserva una efficacia pulsionale e istintiva, ma nella forma della preclusione, nell’incapacità di
risalire a ragioni. Genera allora intolleranza e violenza nei confronti di identità e atteggiamenti che
si manifestino nella forma di ciò che è precluso e di ciò che è melanconicamente interiorizzato
come perso; un’intolleranza emotiva istintiva e sorda .]
2. abbandoni filosofici: abbandono dell’oggetto e soggettività costituente (la proposta
filosofica del ritorno al soggetto.
2.1. l’oggetto per un soggetto: le origini in Platone e da Kant a Schopenhauer a … Husserl
Una definizione generale e generica di idealismo, ispirata a Platone, indica l’atteggiamento di
allontanarsi dall’esperienza visiva sensibile, abbandonarla per rifugiarsi nei concetti, nelle idee, allo
scopo di vedere meglio la realtà, definendola a partire dai concetti; si tratta di una “seconda vista”
come la chiamava già Democrito, quella della mente, capace di definire e denominare la visione
organizzandola nella forma di oggetti. L’idealismo moderno, all’inizio dell’età contemporanea,
procede nella stessa direzione: le radici della costruzione dell’oggetto, all’interno del processo
conoscitivo e come suo risultato “oggettivo”, si trovano (a priori direbbe Kant) nella costituzione
5
formale del soggetto, della mente e delle sue capacità e modalità conoscitive. Non si dà quindi
oggetto senza un soggetto né soggetto conoscente senza un oggetto conosciuto: la relazione è
inscindibile, anche se l’analisi gnoseologica che la filosofia mette in campo, distinguendo per
momenti e forme, sembra legittimare una separazione (metafisica e in astratto) tra oggetto e
soggetto. Seguendo le distinzioni analitiche proposte dalla indagine filosofica si può sostenere che il
risultato conoscitivo oggettivo che si ottiene a livello analitico filosofico è possibile in forza di un
doppio abbandono: delle forme del soggetto di fronte alla materialità empirica dell’oggetto (le
forme non appartengono all’oggetto come sua essenza e sua delimitazione, ma sono modi del
soggetto), dei dati empirici di fronte alla lettura formale estetica e concettuale del soggetto la realtà
fenomenica è in sé indeterminata). Nell’esperienza estetica dell’arte e nella percezione della
bellezza questo duplice abbandono raggiunge il vertice massimo e, ad un tempo, la massima
armonia e il massimo piacere. Possono guidare al tema le tesi esposte da Kant nella Critica della
Ragion pura e la riflessione di Schopenhauer che, nell’opera Il mondo come volontà e come
rappresentazione, riprende l’impostazione di Kant sul problema del rapporto soggetto oggetto e la
porta ad evidenza nella descrizione dell’esperienza estetica del bello.
2.1.1. Nell’Io penso, del soggetto, l’unificazione dell’esperienza nell’oggetto. Kant.
«Il principio dell’unità sintetica dell’appercezione è il principio supremo di ogni uso dell’intelletto.
Secondo l’Estetica trascendentale, il principio supremo della possibilità di ogni intuizione in
rapporto alla sensibilità era: ogni molteplice di essa sottostà alle condizioni formali dello spazio e
del tempo. Il principio supremo della possibilità stessa in rapporto all’intelletto è: che ogni
molteplice dell’intuizione sottostà alle condizioni della unità sintetica originaria dell’appercezione.
Tutte le molteplici rappresentazioni e intuizione sono soggette al primo, in quanto esse ci sono date;
al secondo, in quanto debbono poter essere unificate in una coscienza; perché senza di ciò niente
può esser pensato e conosciuto, perché le rappresentazioni date non avrebbero comune l’atto
appercettivo Io penso, e non sarebbero perciò mai unificate in una autocoscienza.
L’intelletto è, per parlare in generale, la facoltà delle conoscenze. Queste consistono nel rapporto
determinato di date rappresentazioni con un oggetto. Ma l’oggetto è ciò, nel cui concetto il
molteplice di una data intuizione è unificato. Se non che ogni unificazione delle rappresentazioni
richiede l’unità della coscienza nella sintesi di esse. Dunque, l’unità della coscienza è ciò che solo
costituisce il rapporto delle rappresentazioni con un oggetto, e quindi la loro validità oggettiva,
ossia ciò che le fa conoscere, e su cui perciò riposa la possibilità dell’intelletto.» Kant Immanuel
1781 Critica della ragion pura, Laterza, Bari 1971 p.135-136
2.1.2. «Ogni oggetto sempre e perennemente presuppone un soggetto» Schopenhauer.
Riferire le capacità conoscitive della mente umana alle sole rappresentazioni significa per
Schopenhauer fare ritorno a Kant (dopo e contro Hegel), riprendere l’idea della conoscenza
come processo in cui la mente organizza il dato dell’esperienza in oggetti, servendosi delle proprie
forme a priori; ciò equivale a riaffermare che la mente umana estende la sua conoscenza al solo
mondo dei fenomeni e delle rappresentazioni, mentre le resta precluso l’incontro con la realtà in sé.
L’oggetto che noi conosciamo è l’oggetto per un soggetto; si tratta, per definizione, dell’oggetto
della rappresentazione e della conoscenza. «Tutto ciò che appartiene o può appartenere al mondo [al
mondo che è dato alla nostra conoscenza e di cui parliamo], deve inevitabilmente avere come
condizione esclusiva il soggetto ed esistere soltanto per il soggetto […] …noi non sappiamo punto
distinguere un tale oggetto dalla rappresentazione, anzi troviamo che questa e quello sono tutt’uno,
poiché ogni oggetto sempre e perennemente presuppone un soggetto, e rimane quindi
rappresentazione; così pure abbiamo conosciuto il fatto d’essere oggetto, come appartenente alla più
generale i forma della rappresentazione …» (Schopenhauer Arthur 1819 Il mondo come volontà e
rappresentazione, Laterza, Bari 1986 p.147s). Nella conoscenza dunque soggetto e oggetto non
sono pensabili come entità indipendenti. Solo l’abbandono della loro concezione metafisica, che li
definisce come realtà in sé, permette l’esperienza del conoscere.
2.1.3. Di più. L’esperienza estetica della bellezza, secondo Schopenhauer, si realizza grazie ad un
duplice abbandono: l’abbandonarsi congiunto del soggetto e dell’oggetto nell’idea (idee non
6
concetti; non astrazioni dell’intelletto ma “originarie e immutabili forme e proprietà… forze
universali» che costituiscono le essenze universali della realtà). L’arte realizza «il passaggio dalla
conoscenza comune di singoli oggetti alla conoscenza dell’idea». Essa comporta l’abbandono della
ragione strumento di gestione delle rappresentazioni e l’abbandono delle nozioni di oggetto e
soggetto. È la storia di un duplice, parallelo e sincrono abbandono a determinare l’incanto,
l’incontro e l’unione nell’esperienza estetica dell’arte, della bellezza e dell’essenza ideale della
natura.
«Quando sollevati dalla potenza dello spirito, abbandoniamo il modo comune di considerare le cose
cessiamo di ricercare secondo le forme del principio di ragione e le loro reciproche relazioni, il cui
termine ultimo è sempre il rapporto con la nostra volontà; e perciò non consideriamo più il dove, il
quanto, la causa, e la finalità delle cose ma solo ciò che esse sono; e non lasciamo che il pensare
astratto, i concetti della ragione s’impadroniscano della coscienza, ma, invece, diamo tutta la forza
del nostro spirito all’intuizione, sprofondiamo in questa e lasciamo che 1’intera coscienza venga
riempita dalla tranquilla contemplazione dell’oggetto naturale che ci sta davanti — sia esso
paesaggio, albero, roccia, edificio, o altro —, e, con un’espressiva locuzione tedesca, ci perdiamo
(verliert) in questo oggetto, cioè dimentichiamo la nostra individualità, la nostra volontà e restiamo
soltanto come puro soggetto come chiaro specchio dell’oggetto, come se solo l’oggetto esistesse,
senza nessuno là davanti a percepirlo; e quindi non si può più separare il contemplante dalla
contemplazione, poiché sono diventati una cosa sola, dato che 1’intera coscienza è riempita e presa
da un’unica immagine intuitiva; quando finalmente 1’oggetto si e sciolto da ogni relazione con la
volontà allora ciò viene conosciuto non e più la singola cosa in quanto tale, ma l’idea, la forma
eterna, la diretta oggettivazione della volontà. Pertanto chi è assorto nella contemplazione non è più
un individuo dato che proprio l’individualità si è in essa perduta. Egli è invece puro soggetto della
conoscenza, fuori della volontà, del dolore, del tempo. […] Mentre la scienza, seguendo
l’incessante ed instabile flusso di cause ed effetti, quando raggiunge un risultato, viene sempre
risospinta più lontano e non può mai trovare un termine ultimo, né un appagamento pieno, come
quando non si raggiunge mai, pur correndo, il punto in cui le nubi toccano l’orizzonte. L’arte, al
contrario, è sempre alla sua meta. Essa, infatti, strappa l’oggetto della sua contemplazione fuori dal
corrente flusso del mondo e lo tiene isolato davanti a sé: questo singolo oggetto che in quel flusso
era una particella infinitesima diviene per essa un rappresentante del tutto un equivalente della
molteplicità infinita nello spazio e nel tempo. Essa si ferma a questo singolo oggetto: essa ferma la
ruota del tempo. Le relazioni svaniscono: suo oggetto è solamente l’essenziale, l’idea.»
Schopenhauer Arthur 1819 Il mondo come volontà e come rappresentazione, III § 34, 36 (da
Arthur Schopenhauer, Il pensiero filosofico e morale, Le Monnier, Firenze 1981 p. 71, 72)
2.2. l’urgenza di un’epoché nei confronti del mondo (contro la caduta nell’obiettivismo)
Un filone permanente della storia della filosofia si configura come una lunga storia dell’abbandono,
di un abbandono non solo come tema della filosofia, ma come suo indispensabile fondamento e
fondazione. Alcune tappe essenziali: compare nella sospensione del giudizio (epoché) propria di
Socrate e degli scettici, si trasforma in filosofia pratica nella tradizione religiosa e soprattutto nel
misticismo, diventa con Descartes metodo (dubbio metodico) per raggiungere i principi saldi di
ogni filosofare, è momento della logica dialettica di Hegel nella forma dell’Aufhebung (togliereconservare), si presenta, nella filosofia di Husserl, come sospensione (epoché) dell’oggetto e della
soggettività metafisica, scelta indispensabile per avviare un cammino di riemersione della
coscienza, condurne l’analisi in termini di fenomenologia trascendentale, indicare le strade per la
costruzione del mondo secondo senso. Spunti più analitici.
2.2.1. l’invito scettico all’epoché. Lo scetticismo è un esercizio di “epoché”, di sospensione del
giudizio definitivo nei diversi campi in cui l’uomo è chiamato a conoscere, decidere, partecipare,
prendere posizione, desiderare, sperare … Un esercizio di ascesi filosofica attuato allo scopo di
introdurre alla felicità, togliendo la fonte di ansia e turbamento, e con l’effetto di rilanciare e tenere
sempre aperta la ricerca (la sképsis). Fondato su di una doppia convinzione: la realtà è complessa (si
7
tiene presente «la disuguaglianza che c’è tra i dati del senso e quelli della ragione […] attenendoci
pertanto ai fenomeni, viviamo senza dogmi»), la verità assoluta è impossibile, inutile, nociva.
Abbandonare il dogmatismo per abbandonarsi alla realtà e alla sua osservazione.
2.2.2. la funzione metodica del dubbio (dell’epoché) in Descartes. Un abbandono radicale e
impietoso delle convinzioni diffuse e condivise allo scopo di trovare un solido (vero e certo)
fondamento su cui edificare.
«Il mio disegno è stato sempre di riformare soltanto i miei pensieri e di edificare in un fondo tutto
mio: nulla di più. E se della mia opera, che mi piace assai, vi faccio qui vedere il modello, non
intendo con questo consigliare a nessuno d’imitarlo. Altri, che Dio ha meglio favoriti delle sue
grazie, avranno forse disegni anche più alti; ma temo forte che questo non sia già troppo audace per
molti. Anche solo la risoluzione di disfarsi di tutte le opinioni precedentemente accolte non è un
esempio che ciascuno debba seguire. E il mondo è quasi tutto composto di due specie di ingegni, ai
quali esso non conviene affatto: anzitutto, di coloro che, credendosi più capaci di quel che sono, non
possono astenersi dal precipitare i loro giudizi, né avere abbastanza pazienza per condurre con
ordine i loro pensieri: donde viene che, se si prendessero una volta la libertà di dubitare dei principi
ricevuti e di allontanarsi dalla via comune, non saprebbero poi tenere il sentiero necessario per
andare diritto, e resterebbero sviati per tutta la vita. E ci son coloro che, avendo ingegno o modestia
sufficiente a giudicarsi meno capaci, a distinguere il vero dal falso, di altri dai quali posson essere
istruiti, debbono contentarsi di seguire le opinioni di questi, piuttosto che cercarne delle migliori da
sé.
Quanto a me, sarei stato senza dubbio nel numero di questi ultimi se non avessi avuto che un solo
maestro o non avessi mai saputo le differenze che vi sono state in ogni tempo fra le opinioni dei più
dotti. Invece, sin dagli anni di collegio, appresi che non si può immaginare nulla di tanto strano e
poco credibile che non sia stato detto da qualche filosofo. Poi, viaggiando, potei costatare che non
tutti quelli che sentono in modo contrario da noi sono per questo barbari o selvaggi: che, anzi, molti
di essi usano la ragione quanto e più di noi. Il che mi fece comprendere come un medesimo uomo,
con la stessa intelligenza, educato sin dall’infanzia tra francesi o tedeschi, vien su diversamente da
quel che sarebbe se fosse vissuto sempre tra cinesi o cannibali. Persino nella moda dei nostri abiti
quel che ci è piaciuto dieci anni fa, e che forse ci tornerà a piacere da qui ad altri dieci anni, ci
sembra ora stravagante e ridicolo. Non una conoscenza certa, dunque, è per lo più quel che ci fa
persuasi, ma l’abitudine e l’esempio. Ma per la scoperta di verità un po’ difficili la maggioranza dei
consensi vale poco o nulla, perché è più facile che le scopra un uomo solo che non tutto un popolo.
Per queste ragioni, dunque, io non sapevo scegliere nessuno le cui opinioni mi sembrassero
preferibili a quelle degli altri, e mi trovai, si può dire, costretto a cercare di guidarmi da me stesso.
Allora, come un uomo che cammina nell’oscurità e solo, presi la risoluzione di avanzare tanto
lentamente e con tanta circospezione in ogni cosa, per cui, pur progredendo di poco, evitassi tuttavia
di cadere. Anzi, non cominciai neppure a ripudiare d’un tratto le opinioni che per l’addietro si
fossero potute insinuare nella mia mente senza esservi introdotte dalla ragione, ma presi tempo per
tracciare prima il disegno dell’opera che intraprendevo, e per cercare ponderatamente il
vero metodo da seguire nella conoscenza delle cose di cui la mia intelligenza era capace.
Descartes René 1637 Discorso sul metodo, in Opere filosofiche, Laterza, Bari 1967 p. 139s
2.2.3. dallo stato di crisi della filosofia, attraverso l’epoché, la scoperta della radice del senso del
mondo e la fenomenologia come descrizione trascendentale della coscienza: Edmund Husserl.
2.2.3.1. lo stato del disagio di crisi: In un articolo apparso nel 1911 sulla rivista «Lògos» con il
titolo La filosofia come scienza rigorosa Husserl individua nell’affermazione della mentalità
positivistica la principale responsabile della crisi dei saperi e dei valori: rescindendo ogni nesso tra
metafisica e scienza ed elevando i puri fatti a unico oggetto di conoscenza, il positivismo ha inteso
allontanare dall’orizzonte della ragione filosofica le domande di senso, ha posto in ombra il
soggetto che conosce, ordina, rielabora quei fatti: ha così condotto a un ingenuo obiettivismo, al
culto dei fatti positivi, consolidando quel semplicistico «atteggiamento naturale» per cui il mondo
non è che una realtà data, oggettiva, indipendente dai modi in cui la coscienza la percepisce e la
8
comprende. Ispirandosi al modello di scientificità imposto dalla matematica e dalla fisica moderne,
il positivismo ha così ridotto la conoscenza a misurazione o descrizione di rapporti quantitativi,
considerati come dati oggettivi, indipendenti dal soggetto. Dei fatti è possibile una conoscenza,
osserva invece Husserl, solo in quanto vi è una coscienza, un soggetto che li osserva e organizza. La
crisi della filosofia pensata come una semplice scienza dei fatti, destinata a creare solo “uomini di
fatto”, viene superata nella prospettiva fenomenologica di Husserl mediante il recupero della
relazione intenzionale che sussiste tra coscienza e mondo, tra soggetto e oggetto.
2.2.3.2. Nelle Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica del 1913,
Husserl presenta la prima mossa del piano che potrà condurre la filosofia a recuperare l’originaria
natura di scienza rigorosa. Tale mossa consiste nell’epoché fenomenologica; un abbandono che
determina un cominciamento e una fondazione.
«L’«epoché» fenomenologica. Al tentativo cartesiano di un dubbio universale potremmo ora
sostituire l’universale «epoché» nel nostro nuovo e ben determinato senso. Ma a ragion veduta noi
limitiamo l’universalità di questa epoché. Poiché, se le concediamo tutta l’ampiezza che può avere,
non rimarrebbe più alcun campo per giudizi non modificati e tanto meno per una scienza: infatti
ogni tesi e ogni giudizio potrebbero venire modificati in piena libertà e ogni oggettualità suscettibile
di essere giudicata potrebbe venire messa tra parentesi. Ma noi miriamo alla scoperta di un nuovo
territorio scientifico, e vogliamo conquistarlo proprio col metodo della messa tra parentesi, limitato
però in un certo modo.
Questa limitazione può essere indicata in una parola. Noi mettiamo fuori gioco la tesi generale
inerente all’essenza dell’atteggiamento naturale, mettiamo tra parentesi quanto essa abbraccia sotto
l’aspetto ontico [nella copia A: il regno dell’in sé e di qualunque cosa in sé]: dunque l’intero mondo
naturale, che è costantemente «qui per noi», «alla mano», e che continuerà a permanere come
«realtà» per la coscienza, anche se noi decidiamo di metterlo tra parentesi.
Facendo questo, come è in mia piena libertà di farlo, io non nego questo «mondo», quasi fossi un
sofista, non metto in dubbio la sua esistenza, quasi fossi uno scettico; ma esercito l’epoché
«fenomenologica » [che mi vieta assolutamente ogni giudizio sull’esistenza spazio-temporale].
[Nella copia E la frase tra parentesi quadre è cancellata. Al suo posto viene aggiunto quanto segue:
cioè: io non assumo il mondo che mi è costantemente già dato in quanto essente, come faccio,
direttamente, nella vita pratico-naturale ma anche nelle scienze positive, come un mondo
preliminarmente esserne e, in definitiva, non lo assumo come il terreno universale d’essere per una
conoscenza che procede attraverso l’esperienza e il pensiero. Io non attuo più alcuna esperienza del
reale in un senso ingenuo e diretto. […] … il vecchio corso dell’esperienza continua come prima,
salvo il fatto che questa esperienza, modificata attraverso questo nuovo atteggiamento, non mi
fornisce più il “terreno” sul quale io fino a questo momento stavo.]
Io metto quindi fuori circuito tutte le scienze che si riferiscono al mondo naturale e, per quanto mi
sembrino solide, per quanto le ammiri, per quanto poco io pensi a obiettare alcunché, non faccio
assolutamente nessun uso di ciò che esse considerano come valido. Non mi approprio di nemmeno
una delle loro proposizioni, anche se sono perfettamente evidenti, non ne assumo nessuna e da
nessuna di esse ricavo alcun fondamento — beninteso, fin tanto che esse vengono concepite, come
avviene appunto in queste scienze, quali verità concernenti le realtà di questo mondo. Le posso
assumere soltanto dopo aver loro applicato le parentesi, ossia soltanto nella modificazione di
coscienza della messa fuori circuito del giudizio, dunque non come quelle proposizioni che sono
nella scienza, dove reclamano una validità che del resto io riconosco e utilizzo.» Edmund Husserl
1913 Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Libro I, sez. II, § 32,
Einaudi, Torino 2002 pp. 71-72.
In ripresa di tema: « D’altra parte, l’intero mondo spazio-temporale, al quale l’uomo e l’io umano
appartengono come singole realtà subordinate, è secondo il suo senso un essere meramente
intenzionale, quindi tale da avere il senso, meramente secondario e relativo, di un essere per una
coscienza. [È un essere che la coscienza pone nelle sue esperienze (in nota come sostituzione nella
copia D: è un essere che la coscienza esperisce nel modo della presenza in persona, dell’essere stato
9
in persona, dell’ad-veniente in persona e che è dato alla coscienza come qualcosa di identico,
attraverso una molteplicità di atti di coscienza e in modo tale che questo averne coscienza riconduce
alla molteplicità (caratteristica) di una possibile esperienza originariamente offerente, e (segue il
testo)], che può per principio essere intuito e determinato soltanto come ciò che permane identico
nella molteplicità delle manifestazioni motivate, ma che, all’infuori di questa identità, è un nulla.»
(Husserl 1913/2002 p.122-123)
L’abbandono, la sospensione di validità nei confronti di ogni oggettivazione del mondo, delle
visioni del mondo e in esse dello stesso soggetto, della coscienza (come accadeva in Descartes ove
l’“io penso” viene trasformato in sostanza, res cogitans), delle categorie considerate come essenze
metafisiche, ha come risultato il ritorno al soggetto, alla coscienza originaria e al suo atteggiamento
costituente: la intenzionalità. L’epoché attua una “riduzione fenomenologica” del soggetto a
coscienza pura e del mondo alle sue essenze eidetiche, avvia così il cammino di una indagine
filosofica fenomenologica di tipo trascendentale: Ǥ 49. La coscienza assoluta come residuo
dell’annientamento del mondo.»
2.2.3.3. L’atteggiamento fenomenologico e la coscienza pura come campo della fenomenologia. «In
altre parole: invece di compiere in modo ingenuo gli atti costitutivi della natura con le loro tesi
trascendenti, e di lasciarci determinare, attraverso le motivazioni in essi immanenti, a effettuare
sempre nuove tesi trascendenti, mettiamo «fuori gioco» tutte queste tesi, non vi prendiamo più parte
e dirigiamo invece il nostro sguardo in modo da poter afferrare e studiare teoreticamente la
coscienza pura nel suo proprio essere assoluto. Questa è ciò che ci rimane come quel «residuo
fenomenologico» che abbiamo cercato; e rimane, sebbene abbiamo «messo fuori circuito» il mondo
intero, con tutte le cose, gli esseri viventi e gli uomini, compresi noi stessi. Propriamente non
abbiamo perduto nulla, anzi abbiamo guadagnato la totalità dell’essere assoluto che, rettamente
inteso, racchiude in sé tutte le trascendenze mondane e le «costituisce» in sé.» (Husserl 1913/2002
p. 124)
In appendice IX, dell’autunno 1929, Husserl riprende: «Così si risponde alla domanda che è stata
precedentemente posta: sopra che cosa rimanga ancora se l’epoché fenomenologica sospende la
validità dell’universo — come inizialmente si è detto: la totalità di tutto ciò che è in generale.
Rimane, o piuttosto si dischiude per la prima volta attraverso l’epoché, la regione assoluta
dell’essere, la regione della soggettività assoluta o «trascendentale»; […] Risulterà tuttavia come la
regione della soggettività assoluta o trascendentale «porti in sé», in un modo del tutto peculiare,
attraverso la reale o possibile «costituzione intenzionale», l’universo reale, oppure tutti i possibili
mondi reali, tutti i mondi in un senso lato. Solo attraverso questa evidenza verrà in luce il peculiare
significato della descritta epoché fenomenologica, la cui consapevole attuazione si rivelerà come
quell’operazione metodica, assolutamente necessaria, che è capace di dischiuderci, con la regione
assoluta dell’autonoma soggettività, quel terreno dell’essere e di esperienza a cui è riferita, con la
fenomenologia, ogni filosofia radicale, quel terreno che le conferisce il senso di una scienza
assoluta.» (Husserl 1913/2002 p. 394-395)
Husserl sospende il giudizio sull’atteggiamento naturalistico di stampo positivistico e perviene a
una soggettività pura e trascendentale che non è disgiunta dagli oggetti che intenziona, ma anzi si
realizza proprio nell’attività intenzionale con cui si relaziona al mondo in funzione
conoscitivamente costituente. Una relazione non solo gnoseologica, ma anche volitiva, affettiva,
emotiva. Husserl, in una prospettiva ampia, vede nell’io un fluire di esperienze percettive, emotive,
affettive, volitive. La coscienza si presenta così come una corrente di esperienze vissute
(Erlebnisse) che si esplicano nei molteplici modi del percepire, del ricordare, del desiderare, del
volere ecc. Compito della filosofia fenomenologica è dunque la descrizione delle forme essenziali
dei vissuti, dei modi in cui le cose si danno alla coscienza che le conosce, comprende, ricorda. In
quanto indaga questi modi la filosofia è fenomenologia, descrive cioè le diverse realtà (naturale,
morale, religiosa, estetica ecc.) nel modo in cui esse si danno al soggetto; concentra il suo interesse
sulla relazione tra le due polarità «coscienza» e «mondo»; mette in luce la natura «intenzionale»
dell’io, descrivendo la struttura e le direzioni degli atti con cui la coscienza si riferisce alla realtà.
10
L’indagine fenomenologica e trascendentale sposta perciò l’attenzione dai semplici fatti ai modi
essenziali in cui le cose si danno alla coscienza: a queste modalità (e non a realtà metafisiche)
Husserl dà il nome di essenze (éidos); esse costituiscono i modi a priori della relazione tra
coscienza e mondo. La fenomenologia è dunque scienza di essenze e non di dati di fatto. Poiché i
fenomeni (e le essenze) da indagare sono di natura assai varia (fisica, sociale, religiosa, etica,
estetica ecc.), il progetto di rifondazione fenomenologica dei saperi si articolerà in «ontologie
regionali»: lo studioso di ciascuna regione individuerà così i modi tipici in cui i fenomeni naturali,
religiosi, etici, estetici ecc. appaiono alla coscienza, contribuendo a una rifondazione
fenomenologica dell’enciclopedia dei saperi.
[ in sintesi preliminare: abbandoni filosofici e ritorno al soggetto
grazie all’epochè [abbandono 1] lo sviluppo analitico [abbandono 2, abbandonarsi] della
fenomenologia
l’analisi (il lavoro della filosofia): fenomenologia trascendentale
momenti
1. nell’atto conoscitivo, che ha origine empirica, la coscienza coglie il particolare (questo rosso,
questa nota) e può farlo perché contemporaneamente ne intuisce l’essenza universale (il rosso, il
suono); cogliendo un fatto “qui e ora” la coscienza afferra anche l’essenza (l’eidos, l’essenza
eidetica).
2. la conoscenza mette capo ad un atto eidetico: un vedere immediato della coscienza come un
vedere essenziale; si caratterizza per la capacità di cogliere qualcosa alla luce dell’idea, delle
essenze eidetiche.
3. le essenze metafisiche della tradizione vengono afferrate alla loro origine negli atti della
coscienza come essenze eidetiche: atti intuitivi (originari e primi, dati alla coscienza in se stessa)
con cui la coscienza intenziona il mondo (atti con cui “oggettiva” il mondo, i modi oggettivi di
essere della coscienza).
4. gli atti della coscienza (essenze o intuizioni eidetiche) costituiscono l’oggetto della
fenomenologia trascendentale della coscienza, analisi che si presenta così come scienza di essenze
(e non di meri fatti).]
2.3. il residuo fenomenologico: la coscienza intenzionale e la sua analisi fenomenologica
trascendentale
L’abbandono di oggetti consegnati alla loro natura di fatto, senza alcun riferimento alle forme della
mente e della conoscenza da cui ricavano la loro definizione formale; l’abbandono del soggetto e
dell’oggetto considerati come realtà in sé che, presentandosi come dati assoluti e tra di loro estranei,
pretendono di ridurre la conoscenza ad atti passivi di ricezione (e suscitano problemi ancora irrisolti
di concordanza mente-realtà), rilanciano la filosofia come studio delle possibilità del soggetto e
conseguentemente delle pluralità di senso del mondo. Di contro all’impostazione di tipo metafisico,
soggetto e oggetto, nella loro intrinseca relazione diventano intenzionalità della coscienza e natura
noematica dell’oggetto. Conservando quindi l’epoché nei confronti dell’atteggiamento naturale, che
identifica immediatamente il percepito e pensato con il reale, la fenomenologia è in grado di porre
in evidenza l’oggetto intenzionale. Allo scopo è necessario inoltre abbandonare, come problema
filosofico, la questione della corrispondenza tra pensiero (noema) e realtà (considerata in sé); tale
questione infatti è anch’essa un atto intenzionale della coscienza; non può configurarsi come
quesito che possa disporre, per essere risolto come dovrebbe, di un “terzo occhio” posto tra soggetto
e oggetto (entrambi reali) con il compito di decretare la corrispondenza tra i due. Se così fosse si
verificherebbe quell’andare all’infinito che è evidenziato già da Platone e da Aristotele nella
situazione del “terzo uomo”. Dunque: «Analogamente alla percezione, ogni vissuto intenzionale ha
— e appunto questo costituisce l’elemento fondamentale della intenzionalità — il suo «obiectum
intenzionale», ossia il suo senso oggettuale. In altre parole: avere senso, o «avere qualcosa in
mente» [etwas im Sinne haben], è il carattere fondamentale di ogni coscienza, che di conseguenza
non è soltanto un vissuto in generale, ma un vissuto che ha un senso, un vissuto «noetico».
11
2.3.1. la coscienza intenzionale. La coscienza è intenzionalità: «Il titolo del problema, che abbraccia
l’intera fenomenologia, è l’intenzionalità. Esso esprime in effetti la proprietà fondamentale della
coscienza; tutti i problemi fenomenologici, compresi quelli iletici [non solo formali, ma anche
materiali, sensibili], trovano posto in esso» (Husserl 1913/2002 p.361). I vissuti di coscienza hanno
la proprietà di riferirsi agli oggetti corrispondenti; viceversa gli oggetti hanno un significato
afferrabile e condivisibile all’interno di questo riferimento ai vissuti della coscienza. Può sembrare
una banalità, ma questa impostazione taglia corto con cattive tradizioni scettiche, con annosi
problemi della relazione (se vi sia e come avvenga) tra mente e realtà (soggetto e oggetto, anima e
corpo ecc.) e sulle loro inutili impostazioni dualistiche di tipo metafisico.
«L’intenzionalità come principale tema fenomenologico. Passiamo ora a una peculiarità dei vissuti
che può essere indicata addirittura come il tema generale della fenomenologia «oggettivamente»
orientata, cioè all’intenzionalità. Essa rappresenta una peculiarità essenziale della sfera dei vissuti in
generale, in quanto tutti i vissuti partecipano in qualche modo all’intenzionalità, sebbene non si
possa di ogni vissuto dire che abbia un’intenzionalità nel medesimo senso in cui diciamo di ogni
vissuto che entri come obiectum nel raggio di una possibile riflessione, anche se si tratta di un
astratto momento di vissuto, che è temporale. L’intenzionalità è ciò che caratterizza la coscienza in
senso pregnante e consente nello stesso tempo di indicare l’intera corrente dei vissuti come corrente
di coscienza e come unita di un’unica coscienza. […] Noi intendemmo per intenzionalità la
proprietà dei vissuti di essere «coscienza di qualche cosa». In questa mirabile proprietà, a cui
devono essere ricondotti tutti gli enigmi della teoria della ragione e della metafisica, ci imbattemmo
dapprima analizzando il cogito esplicito: un percepire è percepire di qualcosa, poniamo di una cosa
spaziale; un giudicare è giudicare di uno stato di cose; un valutare è valutare di uno stato di valore;
un desiderare è desiderare di uno stato di desiderio, ecc. L’agire va all’azione, il fare all’impresa,
l’amare all’amato, il godere al goduto, ecc. In ogni attuale cogito, uno «sguardo» che si irradia
dall’io puro si dirige verso l’«oggetto» di quello che di volta in volta è il correlato di coscienza, alla
cosa spaziale, allo stato di cose, ecc., e realizza i differenti modi in cui la coscienza può essere
coscienza di questo oggetto.» (Husserl 1913/2002 p. 209-210)
2.3.2. natura noematica prima dell’oggetto. Nell’atto conoscitivo, che ha origine empirica, la
coscienza coglie il particolare (questo rosso, questa nota) e può farlo perché contemporaneamente
ne intuisce l’essenza universale (il rosso, il suono); cogliendo un fatto “qui e ora” la coscienza
afferra anche l’essenza (l’eidos, l’essenza eidetica), in virtù della quale riconosce in quel rosso o in
quella nota un colore oppure un suono. La conoscenza mette capo ad un atto eidetico: un vedere
immediato della coscienza come un vedere essenziale; si caratterizza per la capacità di cogliere
qualcosa alla luce dell’idea, delle essenze eidetiche. Le essenze metafisiche della tradizione
vengono afferrate alla loro origine negli atti della coscienza come essenze eidetiche: atti intuitivi
(originari e primi, dati alla coscienza in se stessa) con cui la coscienza intenziona il mondo (atti con
cui “oggettiva” il mondo, i modi oggettivi di essere della coscienza) e che costituiscono l’oggetto
della fenomenologia trascendentale della coscienza, analisi che si presenta così come scienza di
essenze (e non di meri fatti).
Momenti distinti, in successione e completamento, per una sequenza analitica allo scopo di svolgere
una indagine fenomenologica:
2.3.2.1. il vissuto (Erlebnis) intenzionale e una conoscenza eidetica. «In generale, appartiene
all’essenza di ogni cogito attuale di essere coscienza di qualche cosa. […] Tutti i vissuti che
presentano questa proprietà essenziale si dicono anche «vissuti intenzionali» (atti nel senso
amplissimo delle Ricerche logiche); in quanto sono coscienza di qualcosa, si dicono
«intenzionalmente riferiti» a questo qualcosa. Va tenuto ben presente che qui non è in questione
una relazione tra un accadimento psichico — detto vissuto — e un altro esistente reale della
natura — detto oggetto —, o di un intreccio psicologico che avrebbe luogo nella realtà oggettiva
tra l’uno e l’altro. Ciò che è invece in questione sono dei vissuti considerati dal punto di vista della
loro pura essenza, ossia di essenze pure e di ciò che in esse è «a priori» incluso in maniera
incondizionatamente necessaria.» (Husserl 1913/2002 p. 84-85) «“Essenza” indicò anzitutto ciò
12
che si trova nell’essere proprio di un individuo come suo quid. Ma ogni simile quid può essere
“trasposto in idea”. Una intuizione empirica o di qualcosa di individuale può essere trasformata in
un vedere eidetico (ideazione), e questa stessa possibilità non deve essere intesa come empirica, ma
come una possibilità essenziale. […] L’essenza [eidos] è un oggetto di una nuova specie: Come ciò
che è dato nell’intuizione di qualcosa di individuale o intuizione empirica è un oggetto individuale,
così ciò che è dato nell’intuizione eidetico è un’essenza pura.» (Husserl 1913/2002 p. 16,17).
2.3.2.2. componenti noetiche del vissuto (la noesi, gli sguardi, le attenzioni…). «… poiché il vissuto
intenzionale è coscienza di qualcosa, e lo è conformemente alla sua essenza, per esempio come
ricordo, come giudizio o come volontà, ecc., possiamo indagare che cosa debba essere
eideticamente enunciato dal lato di questo «di qualcosa». Ogni vissuto intenzionale, grazie ai suoi
momenti noetici, è appunto noetico.» (Husserl 1913/2002 p. 224)
2.3.2.3. il noema, lo statuto noematico. «Alla molteplicità di dati che compongono lo statuto
effettivo, noetico, corrisponde sempre una molteplicità di dati che possono essere esibiti nel quadro
dell’intuizione veramente pura, in uno «statuto noematico» correlativo, o più brevemente, nel
«noema», termine che da qui innanzi useremo costantemente.
La percezione, per esempio, ha il suo noema, più radicalmente il suo senso percettivo, ed è il
percepito come tale. Allo stesso modo ogni ricordo ha il suo ricordato come tale appunto come il
suo ricordato, precisamente come è «inteso», «come è dato alla coscienza» nel ricordo, e il
giudicare ha il suo giudicato come tale, il godere ha il suo goduto come tale, ecc. Il correlato
noematico, che è detto qui (in un significato molto ampliato) «senso», è sempre da assumere
esattamente quale si trova «immanentemente» nel vissuto della percezione, del giudizio, del
godimento, ecc., ossia quale ci viene offerto dallo stesso vissuto, se noi lo interroghiamo nella sua
purezza.» (Husserl 1913/2002 p.225)
2.3.2.3.1. Un esempio e un confronto tra atteggiamento naturale (presunto) e atteggiamento
fenomenologica; esempio condotto con metodo fenomenologico, nell’ambito dell’intuizione pura.
«Supponiamo di guardare con soddisfazione un melo fiorito in un giardino, il fresco verde
dell’erbetta del prato, ecc.» (Husserl 1913/2002 p. 225)
2.2.2.3.1.1. atteggiamento naturale. «Nell’atteggiamento naturale, il melo è per noi qualcosa di
esistente nella realtà spaziale trascendente, e la percezione, come la soddisfazione, è uno stato
psichico che appartiene a noi, uomini reali. Tra l’una e l’altra realtà, tra l’uomo reale, e quindi la
percezione reale, e il melo reale sussistono dei rapporti reali. In certi casi si dice, in tale situazione,
che la percezione è una «mera allucinazione», che il percepito, questo melo davanti a noi, non esiste
nella «vera» realtà della natura. Il rapporto reale, che era prima inteso come realmente sussistente,
ora è interrotto. È rimasta soltanto la percezione, non c’è più nulla di reale a cui essa si riferisca.»
(Husserl 1913/2002 p. 225-226)
2.3.2.3.1.2. «Passiamo ora all’atteggiamento fenomenologico. Il mondo trascendente riceve le sue
«parentesi», noi esercitiamo l’epoché nei riguardi del suo essere reale. Domandiamoci ora che cosa
si possa eideticamente reperire nel complesso dei vissuti noetici della percezione e della valutazione
di piacere. Insieme con l’intero mondo fisico e psichico, è messo fuori circuito il reale [wirkliche]
sussistere del rapporto naturale [realen] tra la percezione e il percepito; eppure è rimasto
manifestamente un rapporto tra la percezione e il percepito (come tra il godere e il goduto), un
rapporto che giunge a datità eidetica nella «pura immanenza», ossia sulla sola base del vissuto
percettivo e di godimento fenomenologicamente ridotto, così come si inserisce nella corrente
trascendentale dei vissuti. Appunto questa situazione puramente fenomenologica ci deve ora
occupare.» (Husserl 1913/2002 p. 226) Cioè, la questione fenomenologica: questione eidetica
(relativa al noema). «Nel quadro del nostro atteggiamento fenomenologico possiamo e dobbiamo
invece porre la questione eidetica: che cosa è il «percepito come tale», quali momenti essenziali
implica in sè in quanto noema percettivo? Noi troviamo la risposta dirigendo il nostro sguardo puro
verso ciò che è dato nella sua essenza, e possiamo descrivere fedelmente, in perfetta evidenza, «ciò
che si manifesta» come tale. In altri termini: noi possiamo «descrivere la percezione sotto l’aspetto
noematico». (Husserl 1913/2002 p. 227)
13
2.3.2.3.2. La trasformazione evidenziata dall’analisi fenomenologica e l’ingresso all’essenza
eidetico dei vissuti intenzionali colti nel loro aspetto noematico: dunque la differenza tra enunciati
di realtà e enunciati nomatici è la scoperta e l’analisi del vissuto come tale.
«Enunciati noematici ed enunciati di realtà. Il noema nella sfera psicologica.
È chiaro che tutti questi enunciati descrittivi, per quanto possano suonare identici agli enunciati di
realtà, hanno subito una radicale modificazione di senso; allo stesso modo, ciò che è stato descritto,
sebbene si dia come «esattamente la stessa cosa» è tuttavia radicalmente diverso, in virtù per così
dire di un cambiamento di segno che l’inverte. «Nella» percezione ridotta (nel vissuto
fenomenologicamente puro) noi troviamo, come qualcosa che appartiene ineliminabilmente alla sua
essenza, il percepito come tale, che richiede di essere espresso come «cosa materiale», « pianta»,
«albero», «fiorito», ecc. Le virgolette hanno un significato manifesto: esse esprimono quel
mutamento di segno e la corrispondente radicale modificazione di significato. L’albero simpliciter,
la cosa della natura, è qualcosa di completamente diverso da questo albero-percepito come tale, che
come senso percettivo appartiene inscindibilmente alla percezione.» (Husserl 1913/2002 p. 227)
«In entrambi i casi, sia nell’atteggiamento psicologico che in quello fenomenologico, bisogna tenere
ben presente che il «percepito» come senso non contiene in sé altro (e quindi non gli può venire
attribuito niente altro in base a «conoscenze indirette ») che quanto «veramente si manifesta» in ciò
che nel dato caso si manifesta percettivamente, e lo contiene esattamente nella modalità di datità
nella quale ciò è appunto dato alla coscienza nella percezione. Su questo senso, come è immanente
alla percezione, può sempre dirigersi una particolare riflessione, e il giudizio fenomenologico deve
adattasi, attraverso un’espressione fedele, soltanto a ciò che in tale riflessione viene afferrato. […]
Decisivi sono soprattutto la descrizione assolutamente fedele di quanto può essere effettivamente
trovato nel quadro della purezza fenomenologica e il tener lontano tutte le interpretazioni che
trascendono il dato.» (Husserl 1913/2002 p. 228, 229).
2.3.2.3.3. l’intreccio (continuo) noesi e noema nei vissuti di coscienza; intreccio esemplificato con
riferimento alla percezione visiva, e non solo: «… il pieno noema consiste in un complesso di
momenti noematici, nel quale il momento specifico del senso forma soltanto una sorta di necessario
strato nucleare su cui sono essenzialmente fondati gli altri momenti, che possiamo indicare appunto
per questo, ma in in senso più ampio del termine, come momenti del senso.» (Husserl 1913/2002
p.229) «Il medesimo colore noematico, che nell’unità continua di una coscienza percettiva che si
modifica continuamente è dato alla coscienza come identico e in sé invariato, si adombra in una
molteplicità continua di sensazioni cromatiche. Noi vediamo un albero che non cambia colore (il
suo colore, quello dell’albero) mentre la posizione degli occhi e la relativa orientazione variano in
molti modi e lo sguardo non cessa di muoversi sul tronco e sui rami, e mentre noi intanto ci
avviciniamo e facciamo così fluire in diverse maniere il vissuto percettivo. Se ora riflettiamo sulle
sensazioni, sugli adombramenti, li afferriamo come datità evidenti e, se variamo l’atteggiamento e
la direzione dell’attenzione, possiamo con perfetta evidenza mettere in relazione gli adombramenti
stessi e i corrispondenti momenti oggettuali, riconoscerli come corrispondenti e vedere quindi
senz’altro che per esempio gli adombramenti cromatici relativi al colore che è stato fissato come il
colore della cosa si rapportano a questa come una “molteplicità” continua si rapporta a un’“unità”».
(Husserl 1913/2002 p. 248)
«È facile persuadersi che distinzioni analoghe valgono per le sfere del sentimento e della volontà,
ossia per vissuti di piacevolezza o spiacevolezza, del valutare in ogni senso, di desiderio, di
decisione, di azione: tutti questi sono vissuti che contengono parecchie, e spesso molte
stratificazioni intenzionali, noetiche e corrispondentemente anche noematiche.» (Husserl 1913/2002
p. 242)
2.3.3. Un tentativo di sintesi finale: l’atteggiamento naturale, collocato in epoché, crea le condizioni
per una fenomenologia del vissuto di coscienza, coscienza definita come l’insieme dei vissuti
intenzionali quindi caratterizzata dalla intenzionalità. Noema e noesi sono i momenti della
riflessione analitica fenomenologica dei vissuti e quindi della coscienza intenzionale. Noema:
l’intenzionalità come oggetto proprio del vissuto (vissuto o obiectum intenzionale), il contenuto
14
noematico, l’essenza, l’eidos, il senso, il senso immanente di una esperienza data alla coscienza (il
percepito, il desiderato, come ricordo, come giudizio, come volontà ecc. osservati
fenomenologicamente con la specificazione: il percepito come tale, l’osservato come tale ). Noesi:
l’atto intenzionale come atto, gli atteggiamenti, gli sguardi possibili molteplici (percepire,
desiderare, osservare ecc.), l’aspetto noetico con i tratti della molteplicità e della mutevolezza ma
correlata all’uno del noema; la molteplicità dei suoi possibili adombramenti. Nel gioco noema –
noesi, nella situazione della distanza e della scoperta, dell’abbandono e del riconoscimento si
definisce e prende forma la vita della coscienza come fonte dei sensi del mondo. È un processo
continuo ad un tempo unitario e imprevedibile, destinato a definire, nell’abbandono e nella ripresa,
la nostra libera identità collocata nel campo del possibile.
3. abbandono dimensione e struttura del percepire, del tempo interiore e della
memoria.
Storie dell’abbandono raccontano tragicamente il brutale e definitivo distacco da persone o cose cui
ciascuno legava il riconoscimento di sé e dell’altro, in esso è quindi sempre in gioco un abbandono
di se stessi. E l’abbandono accade sempre in due sedi: nell’oggetto (fatto, luogo, persona conosciuta
e amata…) che si allontana e intraprende, nella realtà e nella percezione e memoria del soggetto, un
cammino di diversa definizione di sé, ha una sua storia alla quale non siamo più presenti (in realtà
non siamo mai presenti del tutto); nel soggetto che vive l’abbandono come evento che incide sulla
sua soggettività, sottoposta a torsioni di riorientamento a volte radicali e drammatiche, anche
quando, per resistere all’abbandono, si vuole affidare a un mondo di ricordi. («… Voleva rispondere
che dall’esilio non si torna, che qualunque tentativo è un inganno, l’assurda illusione di abitare nel
paese dei ricordi. È tutto bello nel paese dei ricordi, non ci sono imprevisti né terremoti e persino la
pioggia è piacevole nel paese dei ricordi. Il paese di Peter Pan è il paese dei ricordi.» Luis
Sepùlveda 2009 L’ombra di quel che eravamo, Guanda, Parma p. 35)
La relazione tra i due (oggetto soggetto), interessati dall’abbandono, è il tempo interiore della
coscienza.
L’abbandono come movimento e struttura del percepire è ricostruito attraverso un percorso
iconografico. Emerge la logica di un continuo abbandonare che è riprendere. L’abbandono
consegna ciò che viene lasciato a nuove relazioni e a nuovi campi di significazione (di
semantizzazione). Prendono corpo così le infinite variazioni sul tema nei più svariati campi
espressivi: filosofia, scienza, arte (letteratura, pittura, musica…).
3.1. L’abbandono e il tempo interiore.
L’abbandono cade dunque, ancora una volta, nella relazione tra i due, oggetto e soggetto, che
paradossalmente, nel distacco sono posti di fronte ad una nuova esperienza di relazione tra loro,
tutta giocata, visto l’abbandono, nel tempo interiore del soggetto.
L’abbandono fissa l’oggetto (la persona, il fatto, l’evento, il luogo, la circostanza… ) da cui ci si
allontana nella sua staticità temporale, ma contemporaneamente lo colloca in una nuova situazione
evolutiva; è conservato in quanto posto in un contesto diverso da quello in cui era, ma in esso
continua ad evolvere secondo una dinamica che non riguarda più l’oggetto (il fatto, la circostanza, il
luogo…) in sé , ma l’oggetto nel soggetto; con l’abbandono, quell’evento viene ripreso nella trama
del ricordare e subisce un processo ambivalente di staticità (fissazione) e di movimento (evoluzione,
ripresa e sviluppo) nel tempo interiore.
3.1.1. L’oggetto (il fatto, il luogo…), nella memoria, resta immutato nella sua istantanea lontananza,
non toccato dal tempo; infatti, l’esperienza (anche solo ipotetica) di un ritorno a quei fatti e luoghi
segna solo la loro lontananza anzi l’estraneità di fronte ad un’esistenza che è andata avanti senza di
noi. L’abbandono condanna alla distanza, senza possibilità che essa possa venire colmata; deludenti
sono i tentativi di annullamento dell’abbandono e dell’esilio; in questi tentativi si pone in evidenza
il vuoto delle relazioni intercorso, il nulla da recuperare, l’emergere progressivo del distacco
inconsapevole in cui è maturato e ha preso sempre più forma l’abbandono.
15
3.1.2. L’oggetto, l’evento tuttavia evolve in quanto presente al nostro vivere e sentire; è sì collocato
in un passato ormai abbandonato ma si tratta di un passato che costituisce l’esperienza presente del
nostro ricordare e, in quel ricordare, del nostro percepire, ragionare, desiderare, provare emozioni. Il
passato, come il futuro, nel tempo interiore (non nel tempo fisico cronologico), è pur sempre una
dimensione del presente. («Se il passato e il futuro non appartenessero al presente con la memoria e
l’intenzione, per l’umanità non ci sarebbe nessuna strada, nessun luogo dove andare» Ursula Le
Guin, The Dispossessed; esergo in Lorber Judith 1994 L’invenzione dei sessi, il Saggiatore, Milano.
E ciò sia in piacevolezza che in tragedia del ricordare «Dimenticare era stata un’esigenza
immediata, bisognava cambiare marciapiede per evitare incontri, bisognava fare subito dietrofront e
tornare sui propri passi. E tutto quello che era carico di futuro si era ritrovato di colpo avvelenato di
passato.» Luis Sepùlveda 2009 L’ombra di quel che eravamo, Guanda, Parma p. 58)
3.1.3. La riflessione filosofica (e no) si sposta dalle storie dell’abbandono, struggenti e avvolgenti,
drammatiche e laceranti, alla logica e alle implicazioni plurime dell’abbandono, alla sua intrinseca
caratteristica ambivalenza, quella di contenere un allontanamento e una ricollocazione, un oblio e
una scoperta, una condanna e una redenzione. Del resto è proprio della stessa filosofia (e non solo)
definirsi come una storia di abbandoni che ha il proprio contrappunto in una scoperta, ritrovamento,
riconoscimento, rinnovamento e, comunque, cammino (una storia della filosofia come insieme di
storie). Nella filosofia può prendere forma una fenomenologia trascendentale dell’abbandono.
3.1.4. una fenomenologia in musica dell’abbandono: abbandonare una nota (lasciarla andare) e
consegnarla ai legami di una melodia.
«Quando risuona una nuova nota, quella precedente non è che sia dileguata senza lasciare traccia,
altrimenti non saremmo neppure in grado di rilevare i rapporti delle note che si susseguono,
avremmo cioè una nota per ogni attimo, eventualmente una pausa vuota nell’intervallo di battuta tra
due note, ma mai e poi mai avremmo la rappresentazione di una melodia. D’altra parte non è che ci
si possa accontentare del persistere delle rappresentazioni delle note nella coscienza. Se queste
rimanessero immodificate, invece di una melodia avremmo un accordo di note simultanee o,
piuttosto, un’accozzaglia disarmonica di note, così come la otterremmo se rintoccassero
simultaneamente tutte le note che fossero già risuonate. La rappresentazione di una melodia può
avvenire solo attraverso quella caratteristica modificazione per cui ogni sensazione di nota, dopo
che è dileguato lo stimolo corrispondente, risvegli una rappresentazione simile e provvista di una
determinazione di tempo, che a sua volta si modifica progressivamente nel tempo mantenendo i
singoli suoni nella loro posizione determinata e nella loro determinata misura di tempo.»
Husserl Edmund 1928 La coscienza interiore del tempo, ed. Filema, Napoli 2002
Il tempo della musica come esperienza percepita, il movimento della sua specifica razionalità, è
segnato dalla dialettica continua di percezione, dileguarsi e abbandono che determina e si
accompagna ad un suo modificarsi e prendere posizione e senso dentro percorsi in definizione
continua e aperta. La sequenza abbandono e “ripresa” (non “ricordo”) propria del tempo musica è la
trama precategoriale del pensiero a partire dal momento iniziale dello sguardo e della sua “sintesi
passiva”, immediata, fino al momento considerato finale del metodo - trama di sistema.
3.1.5. abbandono e fenomenologia della coscienza interna del tempo. Il motivo dell’abbandono, per
la logica del suo movimento, svolge un ruolo indispensabile nell’analisi della coscienza interiore del
tempo svolta da Edmund Husserl (nelle lezioni su La fenomenologia della coscienza interna del
tempo pubblicate da Heidegger nel 1928). Questo ambito fornisce il contesto fenomenologico per
afferrare la dimensione dell’abbandono come misura del tempo interiore. L’abbandono si colloca
così all’interno della coscienza e permette alla trama dei vissuti psichici di essere colta nella sua
dinamica specifica di successione e ripresa, mantenimento e mutamento.
3.1.5.1. il contesto generale in Husserl. Il tema si colloca nello scenario adeguato se si ricorda
l’insistenza con cui Husserl vuole distinguere le proprie indagini fenomenologiche, in quanto
avviano una nuova direzione della filosofia trascendentale, sia dallo psicologismo di origine
empirica, sia, all’opposto, dal trascendentalismo puramente formale di origine kantiana. La
fenomenologia è descrittiva, ma non del fenomeno o della cosa nel suo apparire (è inutile e sciocco
16
dimostrare che il mondo esiste e appare a noi, presupporremmo ciò che viene dimostrato), né di
rigide e immodificabili forme a priori con cui la mente determina il dato d’esperienza, ma dei modi
con cui il mondo si dispone in aree di senso sulla base degli atti intenzionali della coscienza; la
fenomenologia è dunque scienza e indagine della soggettività costituente.
3.1.5.2. il contesto generale (sommario) storico – filosofico. Anche la riflessione sul tempo, quale a
riprese si è svolta nella storia del pensiero filosofico, si ripresenta nel metodo proprio della
fenomenologia. Platone e Aristotele, è noto, allo scopo di aver ragione concettuale del tempo lo
legano al movimento: è il moto dei corpi celesti a determinare il tempo del mondo, “immagine
mobile dell’eternità” (così nel Timeo platonico); più in generale, Aristotele presenta il tempo come
numerazione del movimento: il tempo dunque rimanda ed è definito da quel movimento di cui è
misura. Il tempo non è dunque una realtà a sé, rimanda ad un movimento e varia la sua natura e
dinamica sulla base del movimento a cui decide di fare riferimento. Tenendo fermo questo rimando
del tempo al movimento, Husserl presenta il tempo interiore riferendolo ad un movimento interiore:
al movimento della coscienza come insieme dei vissuti psichici. E’ necessario perciò afferrare il
moto della coscienza, la dinamica dei vissuti psichici, per descrivere, cioè fenomenologicamente
portare ad evidenza, il tempo della coscienza o la coscienza interiore del tempo. E l’abbandono è
l’elemento costitutivo di questa dinamica.
3.1.5.3. la relazione con l’analisi fenomenologica della percezione. La descrizione della dinamica
del tempo interiore rimanda in modo più specifico all’analisi fenomenologica della percezione e
della costituzione del mondo secondo oggetti che sembra porsi a naturale conclusione dello stesso
processo percettivo (naturalezza di conclusione che porta Husserl a parlare, in questo contesto, di
“sintesi passiva”). Infatti, le indagini fenomenologiche sulla percezione, e sull’esperienza passiva,
fanno luce sugli atti grazie ai quali si costituisce per noi l’oggetto nella sua determinatezza e nella
sua modalità di senso; è dunque una riflessione sulle condizioni generali di possibilità di
un’esperienza di oggetti.
Per cogliere il movimento specifico del fatto percettivo l’analisi richiede preliminarmente la
disponibilità a sospendere percezioni del mondo consolidate linguisticamente e teoreticamente in
forma di concetti, allo scopo di poter lavorare su un terreno nuovo; occorre mettere da parte ogni
considerazione di natura logica per analizzare e descrivere le strutture dell’esperienza nella sua
forma più semplice, in quella forma che non chiama ancora in causa la soggettività come centro da
cui partono attenzioni di natura conoscitiva e volitiva che intrecciano le nostre percezioni e i nostri
ricordi interpretandoli e orientandoli secondo punti prospettici definiti e fornendoci visioni
concettuali e logiche del mondo. Dal rispetto di questo processo di sospensione derivano,
sommariamente, tre convinzioni preliminarmente fondamentali.
3.1.5.3.1. Prima: la fenomenologia del percepire fa notare come l’oggetto non venga mai dato a noi
percettivamente nella sua unità e totalità; ciò che (anche per abitudine percettiva) chiamiamo
oggetto è invece un sistema continuo di percezioni, risultato di un processo di sintesi di
conservazione e di orientamento. Le percezioni, dal canto loro, non sono eventi istantanei, ma
hanno la natura di un decorso che si dipana nel tempo e che, nella sua forma normale, si dà come
un’unità concordante in cui ogni fase si sussegue concatenandosi alle altre: attesa, verosimiglianza,
conferma, smentita. Su queste componenti dei fatti percettivi si basano sia i procedimenti tesi a
intervenire sulla percezione per suscitare su di essa l’attenzione del soggetto, sottrarla all’abitudine
e all’ovvietà quotidiana, sia i procedimenti intenzionati a modificare le esperienze percettive
relativamente a dati quotidiani finora considerati ovvi, a dissolverle demolendo abitudini anche
secolari di percezione (strategie su cui fanno leva sia la scienza, nei momenti di un radicale
mutamento di lettura concettuale dell’esperienza [la scoperta scientifica], sia l’arte e la pubblicità: la
loro efficacia è affidata infatti alla possibilità di interrompere il rapporto abitudinario attesa conferma nei confronti dell’esperienza e gestirlo in nuove direzioni).
3.1.5.3.2. Seconda: l’esperienza percettiva non riguarda dunque “cose”, “oggetti” (questi sono
termini che indicano la realtà a livello di astrazione da qualsiasi situazione e si rivelano puri nomi di
concetti) ma “stati di cose”: percepisco “oggetti” all’interno di una visione complessiva di
17
esperienza e del relativo atto intenzionante secondo attenzione, interesse, cura ecc.; solo
quest’ultimo contesto di visione dà senso vissuto agli “oggetti” percepiti, che in sé (astratti dai
vissuti della coscienza) sono privi di senso. Una stessa espressione (ad esempio: “il foglio è
bianco”) assume significati diversi in forza dei diversi vissuti di attesa / sorpresa / progetto /
interesse (“stato di cose”) in cui si colloca (ad esempio: diverso significato ha l’espressione “il
foglio è bianco” nel contesto di una riflessione sulla luce e sul colore o all’atto di apertura di un
presunto lascito testamentario).
3.1.5.3.3. Terza: è facile constatare che qualsiasi oggetto, fisicamente da noi collocato in uno
spazio, non viene mai percepito, dalla immediata intuizione sensibile, in tutti i suoi lati e aspetti
concreti (non vediamo il retro del tavolo che ci sta di fronte); tuttavia noi riteniamo sempre di
vedere “la cosa” e non soltanto un suo lato o aspetto; la nostra percezione è percezione di oggetti,
cose. L’analisi fenomenologia non dà per scontato ma problematizza questo passaggio dalla datità
parziale (o prospettica) alla percezione della cosa intera: quest’ultima non è mai identica alla prima;
si attua in forza di un processo, di una operazione e di un tempo della coscienza. La datità percettiva
immediata (quella che viene considerata apparizione e visione diretta dell’oggetto) è portata a
completezza di oggetto (cosa – apparizione indiretta) da una sintesi passiva a livello di percezione e
da un atto intenzionante della coscienza descrivibile nella forma dell’oggettivazione. Il processo
percettivo sensibile è cioè un processo di riempimento orientato teleologicamente, in contesti
finalistici sempre diversi, all’idea della pienezza massima fino all’unità di un oggetto.
In conclusione, l’apparizione non è mai isolata, né costituisce un fatto unico; è un continuum che si
inserisce in un deflusso ininterrotto di percezione costitutiva attraverso la forma temporale della
corrente di coscienza. La “cosa”, l’oggetto, in quanto fatto percettivo, può trovare ora una sua
definizione fenomenologia: è il correlato oggettuale, sintetico-unitario, dell’esperienza percettiva
(in altri termini: è l’unità oggettuale che si costituisce progressivamente nella molteplicità del
continuum di apparizioni); o viceversa: l’esperienza percettiva, in definizione fenomenologia, non è
scoperta progressiva di una realtà oggettuale indipendente dalla coscienza e in sé rigidamente
determinata, ma è progressiva costituzione di sintesi unitarie; (ancora in altri termini, la cosa a cui
viene attribuita una identità e una oggettiva determinazione, è tale solo in rapporto a una
molteplicità soggettiva di apparizioni unitariamente composta nella percezione e nei concetti).
L’oggetto quindi non è più il filo conduttore. Non ha centralità, come se fosse un in sé, né nella
definizione di strutture disciplinari teoretiche (ambiti scientifici), né nella descrizione del processo
percettivo, né come telos nella esplorazione delle funzioni di sintesi a priori delle forme
trascendentali della mente (Kant); la fenomenologia (soprattutto la fenomenologia genetica) segue
la storia dell’oggettivazione e con ciò la storia dell’oggetto stesso (e del mondo) in quanto oggetto
(campo) di una conoscenza possibile. L’esplorazione fenomenologica prende in considerazione il
movimento della coscienza e, sospeso con l’oggetto anche un tempo oggettivo, indaga “la
coscienza interiore del tempo”: “quella coscienza in cui si costituiscono gli oggetti temporali con le
loro determinatezze temporali”.
3.1.5.4. Chiarito il contesto di lavoro e il progetto d’analisi, allo scopo di cogliere ora il movimento
del tempo interiore e il ruolo giocato in esso dall’abbandono, è necessario riprendere la dinamica
del processo percettivo in forma applicata come nell’esempio della nota musicale. La percezione
provoca una sensazione che resta con un suo tempo nella coscienza in forza della rappresentazione.
3.1.5.4.1. Tornando all’analisi, presentata da Husserl, dell’esperienza e del percorso di una nota
nell’ascolto musicale: perché esso sia possibile dobbiamo escludere sia il dileguarsi della nota senza
che lasci traccia al cessare dello stimolo (non si coglierebbe la melodia), sia la presenza di tutte le
note contemporaneamente (il loro persistere immodificate produrrebbe un’accozzaglia disarmonica
di suoni), bisogna invece afferrare la modificazione progressiva della sensazione, secondo una
propria specifica modalità di essere nel tempo, dopo che è dileguato lo stimolo corrispondente. Lo
scomparire della nota, il suo abbandonare la condizione di stimolo presente, è contemporaneamente
un suo consegnarsi ad una ripresentificazione memorativa ma continuamente modificante che la
inserisce in una (altrimenti impossibile) armonia. «La successione viene a rappresentazione solo a
18
condizione che la sensazione precedente non persista inalterata nella coscienza, ma si modifichi in
modo appropriato e precisamente si modifichi costantemente di momento in momento. Nel
passaggio alla fantasia essa riceve il carattere temporale che è in continua alterazione, così il
contenuto appare di momento in momento vieppiù sospinto indietro. Questa modificazione non è
però più una cosa che riguardi la sensazione, non viene provocata dallo stimolo». Solo quando la
sensazione è consegnata alla rappresentazione riceve il suo carattere temporale in quanto si
inserisce in processi di modifica nei quali la sensazione stessa prende forma e senso in
continuazione (finchè c’è un tempo interiore); questo movimento è la coscienza interiore del tempo.
3.1.6. La dinamica del tempo interiore è chiarificabile con il termine abbandono: lo stimolo
materialmente produce la sensazione, ma questa prende senso solo quando dileguandosi dalla forma
presente si colloca all’interno degli “allacciamenti” (di variabilità assolutamente imprevedibile a
partire dallo stimolo) che si attuano nella rappresentazione e che costituiscono appunto il tempo
interiore della coscienza. La temporalità interiore, segnata dal consegnarsi (dileguarsi, abbandono)
dello stimolo a nuove e continue connessioni, si costituisce nella situazione temporale
comunemente indicata con il termine “passato”. Ed è la radice del raccontare / raccontarsi.
3.1.7. La fenomenologia del tempo interiore, nell’analisi delle connessioni e modifiche che lo
costituiscono, deve dunque ulteriormente portare ad evidenza il tema del passato: «l’associazione
deve essere anche creativa e aggiungere un nuovo momento detto “passato”. Questo momento,
scala, si altera continuamente…». Lo stimolo che dilegua coincide con la dimensione del passato; si
impone allora l’analisi fenomenologica della funzione costituente, quanto al senso, di questo
continuo (vario e progressivo) collocare nel passato, da intendere di nuovo come forma inesorabile
di abbandono. Il passato non è certamente presente, sarebbe una contraddizione, ma non è
nemmeno esterno al rappresentare presente, ne è anzi una modalità: è un nuovo contenuto presente
con il carattere di “passato” (la nota che si è dileguata resta proprio come dileguata, elemento
presente di una melodia, non più di quella sola nota, attualmente percepita); il passato si configura
come una modalità del continuum della rappresentazione; anzi, la messa nel passato, l’abbandono, è
condizione di tale decorso e del suo addensarsi e costituirsi secondo nuovi significati e secondo la
dinamica della ritenzione come ripresentificazione («impressione originaria e il suo continuum di
modificazioni … la nota di per sé è la stessa, ma, «nel modo di come» appare, è sempre altra …
consaputa in una continuità di modi: consaputa come adesso … consaputa adesso come «poco
prima» … consaputa come durata decorsa, mentre il restante tratto della durata non è ancora
consaputo»). Viceversa, l’impressione percettiva (la presentazione, presenza, attualità, percezione),
sorretta dalla coscienza interiore del tempo, è sempre riproduzione (presentificazione, copresentazione, riproduzione…) richiamo e coinvolgimento determinante di una esperienza passata;
in tal senso la serialità e il ripetersi non annulla l’unicum di un’esperienza (o di un’opera d’arte: la
sua essenza di apparizione rende l’arte un unicum in ogni apparizione / presentificazione fruente).
3.1.8. Premesse, presupposti e analisi permettono, in forma di conclusione, di fare il punto sulla
nuova dimensione dell’abbandono. La descrizione fenomenologica del tempo interiore della
coscienza si delinea come un decorso continuo in cui ogni momento inteso come un adesso, dotato
di una sua individualità e di un suo punto sorgivo, è segnato dallo sprofondamento progressivo nel
passato e qui, nel suo scomparire dalla presenza, entra in una nuova contestualità con un altro
presente, cade in una ritenzione che è perciò ripresentificazione memorativa (presentificazione di
secondo grado, presentarsi e accadere nella memoria) e si consegna così a quell’avventura di
risignificazione continua che costituisce il terreno materiale primo in cui la coscienza esplica e
realizza la propria essenziale funzione di soggettività costituente il mondo secondo aree di senso;
guarda il mondo con sguardi di senso e orientati, ipotizzando letture e tesi e, nel caso della scienza
costruendolo in sistemi teorici, in rami scientifici secondo “ontologie regionali”.
3.2. la condanna del mancato abbandono, della assenza di oblio, della memoria totale.
L’oblio, l’abbandono e la ripresa per ricollocazione, è condizione per ricordare. Occorre
sottolineare il ruolo della dimenticanza per consentire la costruzione di percorsi di senso e di una
19
memoria vivibile. Tragico (e infernale, insopportabile) è il non poter dimenticare; altrettanto come è
tragico (è il nulla del soggetto individuale o collettivo) il non poter o non volere ricordare il passato
nell’agire presente.
Un racconto: la tragica condanna a non poter dimenticare: Funes, o della memoria.
«Cadendo, perdette i sensi; quando li riacquistò, il presente era quasi intollerabile tanto era ricco e
nitido, e così pure i ricordi più antichi e banali. Poco dopo s’accorse della paralisi; la cosa appena
l’interessò; ragionò (sentì) che l’immobilità era un prezzo minimo; ora la sua percezione e la sua
memoria erano infallibili.
Noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. Funes: tutti i tralci, i grappoli e gli acini
d’una pergola. Sapeva le forme delle nubi australi dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva
confrontarle, nel ricordo, con la copertina marmorizzata d’un libro che aveva visto una sola volta, o
con le spume che sollevò un remo, nel Rio Negro, la vigilia della battaglia di Quebracho. Questi
ricordi non erano semplici: ogni immagine visiva era legata a sensazioni muscolari, termiche, ecc.
Poteva ricostruire tutti i sogni dei suoi sonni, tutte le immagini dei suoi dormiveglia. Due o tre volte
aveva ricostruito una giornata intera; non aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione aveva chiesto
un’intera giornata. Mi disse: — Ho più ricordi io da solo, di quanti non ne avranno avuti tutti gli
uomini insieme, da che mondo è mondo —. Anche disse: —I miei sogni sono come la vostra veglia
—. E anche: — La mia memoria, signore, è come un deposito di rifiuti —. […] … il vertiginoso
mondo di Funes. Questi, non dimentichiamolo, era quasi incapace di idee generali, platoniche. Non
solo gli era difficile di comprendere come il simbolo generico «cane» potesse designare un così
vasto assortimento di individui diversi per dimensioni e per forma; ma anche l’infastidiva il fatto
che il cane delle tre e quattordici (visto di profilo) avesse lo stesso nome del cane delle tre e un
quarto (visto di fronte). Il suo proprio volto nello specchio, le sue proprie mani, lo sorprendevano
ogni volta. […] Sospetto, tuttavia, che non fosse molto capace di pensare. Nel mondo sovraccarico
di Funes non c’erano che dettagli, quasi immediati.»
Borges Jorge Luis 1935-1944 Finzioni. Einaudi, Torino 1985 p.102-103, 104-105.
4. abbandono, definizione ontologica dell’esistenza (dell’e-sistere) Martin Heidegger
4.1. abbandono: termine per indicare lo stato della cultura e i criteri adottati per delinearlo.
4.1.1. i criteri suggeriti per condividere il significato del termine abbandono come atteggiamento di
cultura e situazione di esistenza (individuale e collettiva): due stili di pensiero.
«Ci sono due modi di pensare, entrambi necessari e giustificati, anche se in maniere diverse: il
pensiero calcolante e il pensiero meditante». Così Heidegger si dispone all’analisi della società
contemporanea nella breve opera dal titolo “L’abbandono” in cui presenta filosoficamente la
situazione dell’“abbandono” e descrive l’età contemporanea. Il pensiero calcolante è il progettare
mettendo in conto e misurando situazioni e risultati, programmare per “sbrigare gli affari di tutti i
giorni … affrontare le cose pratiche”; un semplice attenersi ai fatti, rappresentarli, seguirli
assecondandoli. La forza crescente del pensiero calcolante mette ancor più in risalto l’abbandono in
cui attualmente è lasciato il pensiero meditante; quel pensiero che, privo di fini, diventa
speculazione pura e meditazione. Nel pensiero calcolante si manifesta in realtà la povertà di
pensiero (Wir sind …gedanken-arm), che si profila come assenza di pensiero (Wir sind …
gedanken-loss): «L’assenza di pensiero è un ospite inquietante che si insinua dappertutto nel mondo
d’oggi. Infatti al giorno d’oggi, se si vuole conoscere qualcosa, si prende sempre la via più rapida e
più economica… la rivoluzione della tecnica che ci sta travolgendo nell’era atomica potrebbe
riuscire ad avvincere, a stregare, a incantare, ad accecare l’uomo, così che un giorno il pensiero
calcolante sarebbe l’unico ad avere ancora valore, ad essere effettivamente esercitato». Heidegger
Martin, L’abbandono (la Gelassenheit), il melangolo, Genova 1989
4.1.2. raccogliersi nell’abbandono: il pensiero meditante. Al pensiero meditante, di cui Heidegger
lamenta l’attuale assenza dovuta al prevalere di una ragione del calcolare, sembra possa venire
attribuita l’accusa di astrattezza, di distanza dalla concretezza: si tratta di un pensiero che «fluttua
senza saperlo al di sopra della realtà, perde il contatto col terreno su cui si fonda», lontano dalla
20
realtà, “fuori dal mondo”. Obiezioni che Heidegger richiama per specificare come il meditare non
sia un allontanarsi ma un modo per raccogliersi «su ciò che ci tocca più da vicino, che riguarda
ciascuno di noi nella sua individualità, qui e ora… un confronto adeguato con ciò che sta realmente
emergendo nella nostra epoca». Ed è un raccogliersi che richiede l’abbandono. L’abbandono non è
allora un chiamarsi fuori da ciò che accade e dalla assunzione di responsabilità, né una filosofia del
pianto, nostalgica di un fittizio mondo perduto, ma è l’arte di star vicino domandando, dando la
parola non alle cose prodotte dall’uomo, che feticisticamente lo dominano, ma lasciando che il
pensiero emerga nella sua autentica essenza: l’essenza del pensare è il domandare, e ne è anche
l’autentica pietà. Per questo è necessario “l’abbandono di fronte alle cose” per tornare alla
domanda. «Cerchiamo infatti di determinare l’essenza del pensare: ora che cos’ha a che fare
l’abbandono con il pensare? Nulla, se intendiamo il pensare in senso tradizionale, come
rappresentare. Ma forse l’essenza del pensare, il solo e autentico scopo della nostra ricerca, è
ricondotta all’abbandono».
4.2. le direzioni dell’abbandono nella vicenda dell’esistere, nella definizione dell’esistenza.
4.2.1. la tentazione e il fascino di un abbandono “Assoluto” nella cultura per professione.
Nelle analisi critiche dei sistemi politici totalitari del primo Novecento ricorre una domanda irrisolta
(ricorre perché irrisolta) sul perché uomini di cultura, intellettuali di mestiere, dediti al “pensiero
meditante”, deputati a guidare gli uomini nella comprensione e lettura del presente, furono incapaci
di cogliere la logica dei sistemi totalitari, il crollo in essi e la distruzione programmata dell’umanità
fin dai suoi fondamenti elementari e “naturali”. Non la avvertirono, non la compresero, non si
sdegnarono, non vi si opposero; tra questi “maestri di pensiero” e del “pensiero meditante”
compare, per ironia tragica quasi assoluta, proprio lo stesso Heidegger. Heidegger, che forniva,
culturalmente, gli strumenti filosofici per salvare l’esistenza del singolo dai sistemi assoluti e da una
visione metafisica asservita al pensiero dominante della tecnica, aderisce e appoggia il nazismo.
Emerge l’idea di intellettuali presenti nell’età contemporanea ma operanti e pensanti in quasi totale
abbandono della realtà; in loro l’abbandono diventa assenza, cecità, pavidità, servigio. L’analisi di
una simile collocazione dei “maestri di pensiero” non può essere consegnata ad un semplice
ragionamento o rimprovero morale come assenza di coraggio, opportunismo…; il problema va
affidato ad una analisi che cerca le radici logiche, filosofiche, strutturali di quelle scelte (molte delle
quali umanamente comprensibili); solo in tal modo la parola passa ad un impegno culturale che
riscopre e salva l’esistenza dell’uomo nel proprio compito di umanità. Ecco un’ipotesi. Nella loro
opera sembra prender forma un atteggiamento culturale che si attribuisce il dovere e l’arte
dell’abbandono dalle contingenze storiche in nome di un punto assoluto che il pensiero
(l’intellettuale) ritiene di poter raggiungere e a partire dal quale la realtà viene costruita, ricostruita,
finalmente secondo senso, logica, rigore e armonia (la vecchia impostazione di Hegel).
L’intellettuale ritiene dunque che al pensiero si addica l’abbandono dalle inezie del quotidiano,
dalle quali non deve lasciarsi impaniare, e considera proprio compito, dovere e missione, quando
entra nel mondo, il pensare in termini assoluti. Questo vezzo del distacco e dello sguardo altero e
lontano lo porta a non ritenersi responsabile di fronte ad un tribunale dei fatti, ma solo di fronte al
tribunale della giustizia assoluta (“fiat justitia et pereat mundus”), componente imprescindibile di
una società perfetta, tranello utopistico contesto del loro ragionare. In questo vezzo si annida una
incoercibile “inclinazione verso il tirannico” che si dispone a terreno di nutrimento dei sistemi
totalitari. L’astrazione si sovrappone all’umano; l’intransigenza e la fedeltà alla proprie idee
sorpassa la percezione della realtà in atto; in un modo sempre più cocciuto proprio quando si
aspetterebbe dall’acume dell’intellettuale una capacità di comprendere, di agire di conseguenza
ribellandosi alla intollerabile “banalità del bene” da loro ordinatamente composta in utopia al punto
da diventare una tragica e devastante “banalità del male”.
Per ironia della sorte, in quell’aristocratico distacco (quasi “Realrepugnanz”) trova sublime e alta
realizzazione il disegno che la cultura dominante prepara per le masse: l’estraneazione, la
distruzione dell’uomo nelle forme dell’autodistruzione. Negazione dell’uomo attuata dall’uomo
21
stesso nel momento in cui opera per la propria realizzazione sociale e personale, costruita dall’opera
da lui stesso messa in atto come forma di realizzazione di sé. Destino prefigurato e denunciato dalla
tradizione hegelo-marxista (estraniazione dell’uomo dal prodotto, dal lavoro, da se stesso, dagli
altri; nella messa in valore della merce il lavoratore annulla il proprio valore), dalle analisi di Weber
sulla società contemporanea, dallo studio dell’industria culturale quale viene articolato dalla Scuola
di Francoforte. Stacco dalla realtà che si traduce in due atteggiamenti solo apparentemente
antitetici: lo sguardo aristocratico della distanza si abbina alla laboriosità quotidiana dell’uomo di
cultura (cultura per mestiere e professione a sé) che procede indisturbata per non notare orrori e
macerie; in un “affaccendamento irriflesso” alla base generale di una esistenza umana
autoconsegnata alla proprie monotone abitudini (come da tesi della studiosa polacca Jolanta BrachCzaina) . Si tratta di analisi che vengono formulate negli studi sulla logica del totalitarismo del
‘900; richiamate e condotte a trattazione sistematica in particolare nelle opere di Hannah Arendt
(riassunte sinteticamente in Hannah Arendt, Ritorno in Germania, ed. Donzelli, Roma 1996).
4.2.2. una prima “torsione” ontologica: di contro all’abbandono come un “chiamarsi fuori” in nome
dell’Assoluto, si pongono (e si oppongono) le tappe per una scoperta del proprio essere-nel-mondo
come situazione e temporalità ontologicamente costituente (scoperta e abbandono al proprio sé, che
è “esser-ci”, Dasein).
Nelle opere di Heidegger (almeno nelle opere), l’abbandono non si definisce come un vezzo
aristocratico dell’intellettuale che si ritiene pensatore di professione e che, nel rifugio del sistema
razionale, costruito e difeso da una armonia logica, disdegna il confronto con la realtà, se ne trae
fuori, non ne comprende il corso e finisce per assecondarne i più turpi e disumani sviluppi politici.
L’abbandono deve diventare la scoperta e il coraggio dell’“essere-nel-mondo”; della temporalità
come luogo unico dell’essere. È questa una prima radicale svolta, una torsione, un primo
abbandono. È il tema che si definisce a partire dall’opera più nota (e incompiuta) di Heidegger,
Essere e tempo (1927), e sorregge tutta la sua filosofia; un tema che è insieme analisi della
contemporaneità, dell’esistenza descritta fenomenologicamente nei suoi aspetti strutturali e
temporali, proposta di radicale conversione culturale. Si può evidenziare sommariamente la
riflessione scandendola in tappe essenziali, presentate come momenti di snodo, di svolta e di
“torsione” nel cammino dell’esistenza.
4.2.2.1. dalla metafisica all’ontologia
La metafisica (tradizionale) studia l’essere come cosa, come ente, come oggetto, e si presenta come
corrispettivo teorico del pensiero calcolante e della cultura tecnica. È una direzione che va colta,
analizzata per essere abbandonata, perché l’indagine filosofica (in nuova e prima direzione) deve
porre al centro della propria attenzione non l’essere come oggetto o cosa, ma quell’ente da cui parte
la domanda sull’essere: l’uomo, non ridotto a oggetto, a cosa tra cose, ma considerato nel suo
domandare. L’indagine metafisica deve dunque lasciare il posto all’indagine ontologica che si
dipana come analitica fenomenologica dell’esistere.
4.2.2.2. ontologia come analitica dell’esserci la cui essenza è aver-da-essere (una prassi filosofica
analitica ed ermeneutica dell’esistenza): abbandonarci come ente, assumerci come “esser-ci”.
L’uomo è quell’ente il cui domandare presuppone un suo abbandono (come abbandonarsi, aprirsi,
essere presso…) alla propria dimensione mondana, al proprio costitutivo e imprescindibile essernel-mondo (la dimensione della “gettatezza”); è un Esser-ci. Gettato in un mondo che è un già
costituito, nella finitezza delle relazioni sociali già intrecciate, l’uomo come esserci, scopre la sua
essenza in quanto “aver-da-essere” («L’essenza di questo Esserci consiste nel suo aver-da-essere»);
l’uomo, proprio nel suo esser gettato, trova la condizione di progetto; la sua essenza si svolge in una
temporalità costituente. « L’Ente che ci siamo proposti di esaminare è il medesimo che noi stessi
siamo. L’essere di questo ente è sempre mio. Nell’essere che è proprio di esso, questo ente si
rapporta sempre al proprio essere. Come ente di questo essere, esso è rimesso al suo aver-da-essere.
L’essere è ciò di cui ne va sempre per questo ente.» (Heidegger Martin 1927 Essere e tempo,
Longanesi, Milano 1976 p. 64)
22
Nell’opera di Heidegger, Essere e Tempo, l’abbandono indica due diverse direzioni: la prima,
abbandonarsi al proprio essere-nel-mondo; la seconda, nell’esserci abbandonare l’esistenza che
consegna la propria dimensione mondana alla ripetizione impersonale di ciò che è condiviso ed
esistere invece come progetto. L’essere gettati in un mondo già definito può configurarsi come
situazione di vincolo a cui ci si debba passivamente adeguare e diventare ripetitori; quello stesso
esser gettati si configura invece come incontro con una temporalità concreta; temporalità che
costituisce l’ambito in cui matura l’essenza dell’uomo come “aver-da-essere”, si delinea l’essenza
dell’uomo in termini di abbandono attivo e affidamento al proprio “essere-per-una-possibilità”.
«L’“essenza” di questo ente [l’uomo come esserci] consiste nel suo aver-da-essere. L’essenza
(essentia) di questo ente, per quanto in generale si può parlare di essa, dev’essere intesa a partire dal
suo essere (existentia).» (Heidegger 1927, p. 64) Si tratta di due opposti movimenti che rendono il
termine abbandono ambiguo o per lo meno ambivalente e ne mettono a rischio la funzione
denotativa. E’ una ambivalenza che, nel suo svolgersi, apre ad una nuova situazione ontologica e di
conseguente analisi fenomenologia; ad una seconda direzione, una seconda torsione, indicata dallo
stesso Heidegger con il termine: svolta (Khere).
4.2.3. una seconda torsione ontologica: ontologia come accadere dell’essere. Abbandono è esistenza: stare fuori nella radura (nell’accadere) dell’essere.
4.2.3.1. Una consapevolezza filosofica riguardante l’agire e l’essere, come preliminare contesto.
«Noi non pensiamo ancora in modo abbastanza decisivo l’essenza dell’agire. Non si conosce l’agire
se non come il produrre un effetto la cui realtà è valutata in base alla sua utilità. L’essenza
dell’agire, invece, è il portare a compimento ( Vollbringen). Portare a compimento significa:
dispiegare qualcosa nella pienezza della sua essenza, condurre-fuori a questa pienezza, producere.
Dunque può essere portato a compimento in senso proprio solo ciò che già è. Ma ciò che prima di
tutto «è», è l’essere. Il pensiero porta a compimento il riferimento (Bezug) dell’essere all’essenza
dell’uomo. Non che esso produca o provochi questo riferimento. Il pensiero lo offre all’essere
soltanto come ciò che gli è stato consegnato dall’essere. Questa offerta consiste nel fatto che nel
pensiero l’essere viene al linguaggio. Il linguaggio è la casa dell’essere. Nella sua dimora abita
l’uomo. I pensatori e i poeti sono i custodi di questa dimora.» Heidegger Martin 1949 Lettera
sull’«umanismo», in Segnavia, Adelphi edizioni, Milano 1987 p.267
Il “fallimento” di Essere e tempo (se di fallimento si può parlare; il termine viene utilizzato solo per
l’esigenza di sottolineare un mutamento di percorso in atto nel pensiero di Heidegger, e in
considerazione della scelta di lasciare quell’opera nella forma del non compiuto) si inscrive nella
ingenua pretesa di pervenire all’essere muovendo dall’esserci; il senso dell’essere non può venire
colto da un ente finito, particolare; non è possibile determinare il senso dell’essere interrogando un
ente, sia pure privilegiato come l’esserci: l’essere di cui si vuole trovare il senso non è quello di un
ente particolare; tra l’essere e gli enti esiste un’incolmabile differenza ontologica.
Imprimendo una svolta (Kehre) al proprio itinerario di ricerca, Heidegger sceglie da questo
momento un diverso modo di rapportarsi all’essere: abbandona l’impianto tipico della metafisica
occidentale che da Platone in poi ha concepito l’essere come una generica presenza oggettiva,
comune sostrato, e ha finito con il privilegiare la ricerca sugli enti; imposta l’indagine sull’essere
affidandosi, abbandonandosi interamente ad esso. L’uomo non è soggetto attivo del conoscere; è,
piuttosto, l’essere che si svela a chi sappia disporsi al suo ascolto, a chi sappia abbandonarsi
all’essere, restando pronto a comprenderne la parola, il logos; se l’uomo è soggetto attivo lo può
essere nella dimensione dell’apertura, dell’ascolto e dell’abbandono (abbandonarsi al pensiero
meditante-completante).
Ritorna la distinzione / opposizione tra pensiero calcolante e pensiero meditante; se quello si affida
al produrre umano e al suo crescere procedendo a tentoni incalzato dalla riuscita dell’utile e
secondo i tempi brevi della misurabilità del successo e del profitto, questo, il pensiero meditante,
sorge e si costituisce all’interno della consapevolezza e dell’apertura ad un già dato in cui l’uomo si
colloca (come esser-nel-mondo) ed è chiamato ad esserci. In doppia direzione (doppia come
successione e non come bivio o antitesi). La modalità essenziale che definisce l’uomo nella sua
23
gettatezza e come esserci è, s’è già visto, l’aver-da-essere. L’ontologia come fenomenologia
analitica dell’esserci, in Essere e Tempo, presentazione dei modi della gettatezza e del suo aver da
essere, si rivolgeva all’uomo, all’ente da cui parte la domanda sull’essere. Ora, nella svolta, lo
sguardo ha subito una torsione radicale, parte dall’essere nel quale l’uomo sta e riprende l’esame di
questo stare nella “radura” dell’essere non a partire dai modi dell’umano esserci ma a partire
dall’essere la cui natura consiste nell’apparire, nello svelarsi; svelarsi e apparire che traducono ed
esprimono il senso del termine verità. In questo contesto è necessario riprendere la funzione
filosofica del portare a chiarezza cosa sia esistere, cosa sia esistenza.
(in sintesi semplificata: non possiamo trattare, impostare il problema dell’essere [del mondo, del
tempo…] come se fosse un oggetto, un ente al quale siamo esterni e per il quale possiamo avere uno
vista totale, ne siamo parte e coinvolti. Occorre allora scoprire il nostro esserci, nella gettatezza e
nel progetto, e disporci al dipanarsi, svelarsi, disporsi secondo verità dell’essere [del mondo, del
tempo…]; porci in ascolto e pensare domandando.)
4.2.3.2. La svolta nell’e-sistenza, la torsione ontologica strutturale dell’e-sistere: «stare fuori in (inaus-stehen)». «La svolta (Khere) dell’oblio dell’essere nella verità dell’essere».
L’essere appare, si dà, si manifesta (τò òν φαίνεται); si manifesta nella parola (τò òν λέγεται);
questa è la sua natura, la sua essenza, il suo destino. In questo contesto l’esistenza si trova a dover
essere ridefinita. Abbandonato l’oblio dell’essere, generato dal pensiero calcolante e da quella
cultura tecnico-metafisica che riduce l’essere a cosa, l’esistenza consiste nello stare in questo
apparire e disvelarsi che è l’essere, sede e contesto di verità (α̉λήθεια = α-λήθεια = dis-velamento,
togliersi dell’oblio). «In ordine al contenuto e-sistenza significa stare-fuori-nella (hin-aus-stehen)
verità dell’essere».
4.2.3.2.1. L’abbandono manifesta di nuovo la propria ambivalenza. Indica il movimento di
trascendenza (abbandono, trascendimento)che l’esserci compie per sua natura e definizione («con
l’analisi dell’essere-nel-mondo abbiamo mostrato che alla costituzione ontologica dell’esserci
appartiene la trascendenza. L’esserci stesso è il trascendente. Esso si oltrepassa, cioè va oltre se
stesso nella trascendenza.»); ma indica anche, e ora in forma prioritaria, il movimento
dell’abbandonarsi, dell’aprirsi, dello stare dell’uomo nell’essere che è apparire, verità, disvelamento
(l’essere stesso, nel suo disvelarsi, nella sua verità, uscita dalla dimenticanza, può, forse, venir
definito secondo la logica indicata dal termine abbandono). Abbandono è dunque sia la via che il
contesto in cui il movimento accade. In questa ambivalenza, grazie ad essa, accade l’incontro e la
realizzazione (il manifestarsi dell’essere, l’accadere dell’uomo nell’esistere). Non si è più, infatti,
all’interno di una ambivalenza linguistica, ma ad un movimento ontologico doppio, speculare e
asimmetrico, luogo di incontro non prevedibile, ad un tempo offerto e negato.
4.2.2.3.2.2. Nell’affrontare e presentare questa svolta, la riflessione di Heidegger si affida a
espressioni ora ossimoriche, ora circolari che obbligano il pensiero a tornare sui propri passi. Nella
radura dell’essere “la quiete è fonte e dispiegarsi di ogni movimento”, “pensare è giungere nella
vicinanza di ciò che è lontano”, “l’abbandono allora non sarebbe soltanto la via, ma anche lo stesso
muoversi su questa via”, “nel punto così inteso requie la raccolta insorgenza”. Si tratta di ossimori
che mettono in difficoltà il pensiero, lo mettono a disagio, perché lo alimentano ponendolo di fronte
agli estremi di un percorso; estremi che indicano il percorso nella sua totalità e non solo in una delle
sue tappe; di nuovo: si tratta del pensiero meditante, non del pensiero calcolante. Poiché
nell’esistenza come trascendersi nello stare, secondo un abbandono che coinvolge l’essere e l’uomo,
è coinvolta la totalità sia come contesto (quiete) che come traguardo del divenire (movimento),
allora la parola che coglie la logica di una totalità coinvolta nel proprio divenire è, secondo lo stile
di Eraclito, l’ossimoro e la circolarità autoriprendentesi. L’abbandono apre dunque ad una nuova
logica; e questa nuova logica, a sua volta, indica e avvia una nuova (la terza “svolta” o “torsione”)
dimensione di ricerca e di riflessione, quella consegnata all’attesa della parola, nell’ascolto e
custodia del linguaggio.
24
4.3. e-sistenza abbandonarsi all’ascolto dell’essere nella filosofia della poesia (la svolta della e
nella e-sistenza)
Riprendendo il passo già citato: «Il linguaggio è la casa dell’essere. Nella sua dimora abita l’uomo.
I pensatori e i poeti sono i custodi di questa dimora. Il loro vegliare è portare a compimento la
manifestazione dell’essere; essi, infatti, mediante il loro dire, la conducono al linguaggio e nel
linguaggio la custodiscono.». L’essere accade, si dà, si manifesta nella parola (così Heidegger
interpreta il “τò òν λέγεται” della Metafisica di Aristotele); perciò la parola è la casa, la radura, la
dimora dell’essere. La parola non va usata come strumento che denota cose, etichetta oggetti
divenuti merce, ma va custodita come il contesto del disvelarsi dell’essere e quindi contesto di
verità. L’impegno della filosofia è quello, ora, di custodire la casa dell’essere, il linguaggio,
conservando la parola nel suo accadere sorgivo, originario e pregnante. Si impone qui una nuova e
lunga (“appena iniziata”) storia di affiancamento: quella tra filosofia e poesia. La prima è
ermeneutica, la seconda è accadere della parola; la prima dunque ascolta e commenta la seconda
abbandonandosi alla verità nella poesia.
4.3.1. Nella poesia infatti è la parola che ha la parola, essa rappresenta la situazione in cui “solo la
parola può «avere la parola»”, poichè «nomina qualcosa di iniziale, ed ogni inizio è inesauribile ed
unico nel contempo». Le riflessioni di Heidegger vertono ricorrentemente ora, dopo “la svolta”, sul
testo poetico, luogo privilegiato in cui l’essere si dà alla parola, accade nella parola in modo
originario, ortivo, sorgivo. Hölderlin e l’essenza della poesia (1937); L’Inno Andenken di
Hölderlin (1944); La parola nella poesia. Georg Trakl, Il canto dell’esule; L’origine dell’opera
d’arte (1950). Occorre presentare la natura del testo poetico per comprendere come nella sua
essenza possa essere definito come “casa dell’essere”, sede della sua manifestazione.
A presentare la natura del testo poetico, come accadere dell’essere nel dire, ricompare una nuova
serie di ossimori (e la conseguente funzione totale ed unitaria, ermeneutica dell’ossimoro): la
solennità è nella semplicità, il rigore è nell’indeterminatezza, il concetto è immagine, l’agire non
mira ad effetti, lo stare è apparire, la festa è nell’attesa e, finalmente, «il parlato della poesia
costituisce il dettato di origine stanziandolo come il fermamente disdetto alla parola». Aspetti del
testo poetico che vengono evidenziati da Heidegger nel testo riservato alle composizioni di
Hölderlin (Heidegger Martin, L’inno Andenken di Hölderlin, Mursia, Milano 1997). Si tratta di
ossimori che sembrano derivare, in prima istanza, da una prassi di constatazione e commento del
testo poetico, in realtà conducono a cogliere la specificità della poesia e a comprendere perché in
essa la parola può appunto definirsi la casa dell’essere, o la radura dell’essere. .
4.3.1.1. La tesi. L’affermazione che la parola è la casa dell’essere e che il poeta e il filosofo ne sono
i custodi, quindi l’attenzione di Heidegger per la poesia come sede e luogo dell’essere, diventa
analisi dei tratti formali (ed essenziali) che fanno sì che il testo poetico si presenti come la “sede
dell’essere”: la poesia è in grado di conservare la parola nel suo “punto ortivo”, la conserva come
“dettato di origine”. La poesia conserva e fa accadere la parola nel suo punto ortivo poiché la
conserva nel suo stato di inizio come nascita e sorgente; e, conservandola nel suo punto di nascita,
la parola è, senza fine, fonte di senso. Si dà al dire nel testo poetico conservando la funzione ortiva,
generativa del dettato d’origine. «I singoli dettati, infatti, rilucono e sono udibili solo a partire dal
punto ortivo del dettato d’origine […] ogni dettato parla muovendo dall’intero dell’uno e inesausto
dettato d’origine, e ogni volta dice unicamente tale uno e inesausto» (Heidegger Martin La parola
nella poesia. Georg Trakl, Il canto dell’esule, Marinotti, Milano 2003. p.283, 285)
Due assunti preliminari: 1. «Ma la parola può essere solo a partire da se stessa e può essere solo
parola; quindi solo la parola può "avere la parola”.» 2. «La ricchezza di ogni parola genuina,
ricchezza che non è mai una dispersa molteplicità di significati, bensì l'unità semplice
dell'essenziale, ha il suo fondamento nel fatto che tale parola nomina qualcosa di iniziale, ed ogni
inizio è inesauribile ed unico nel contempo.» (Heidegger, L’inno Andenken p.19)
Su questi assunti, della parola “tautegorica”, della parola sorgiva decolla l’esperienza interpretativa
che è vicenda ermeneutica ontologica, non semplice interpretazione di un testo, ma incontro
originario (e originante) con l’essere.
25
4.3.1.1.1. interpretare è allora puntualizzare, indicare al fine di pervenire al punto, al punto ortivo:
cioè venire al punto indicandolo cogliendolo come fonte e sorgente dei singoli dettati presenti nello
sviluppo del testo poetico; puntualizzare è venire al punto “ortivo” che «accoglie in sé … custodisce
ciò che ha ottenuto e raccolto, riempie di luce e pervade di splendore ciò che ha raccolto:
unicamente in tal modo lo ri-lascia nel e al suo pieno stanziarsi […] Ogni grande poeta…detta
unicamente muovendo da un unico dettato d’origine» (Heidegger Martin La parola nella poesia.
Georg Trakl, Il canto dell’esule, Marinotti, Milano 2003. p.283)
Questo modo di intendere il “puntualizzare” muta radicalmente la funzione e la sede
dell’interpretare e dell’introdurre. Nella letteratura l’analisi, in molti modi e con molte scuole, tenta
di avvicinarsi con propri commenti e introduzioni al testo poetico. Introduzioni che sono
ammissibili in forza del loro scomparire. Se introducono al testo poetico, devono poi togliersi,
scomparire, non cedere alla tentazione di sostituirsi ad esso di fatto annullandolo proprio mentre si
presentano come una introduzione. «Basta averle dato ascolto per una volta, perché facilmente da
quel momento in poi le "introduzioni" estese diventino per noi un impedimento.» (Heidegger,
L’inno Andenken p.7)
4.3.1.1.2. è proprio del testo poetico “disdirsi alla parola”: nella poesia la parola supera il suo dire.
«La parola del poeta e quel che in tale parola è poetato superano poetando il poeta e il suo dire.
Quando attribuiamo "alla poesia" questo carattere, ci limitiamo sempre alla poesia essenziale. Essa
soltanto compone poeticamente cose iniziali, essa soltanto svincola cose originarie in vista del loro
proprio avvento.» (Heidegger, L’inno Andenken p.11-12)
Nello sviluppo del testo poetico la parola si dispone nel linguaggio e si disdice come parola sorgiva,
si allontana nel linguaggio dal proprio punto ortivo, ma il suo disdirsi è poetico poichè conserva il
proprio riferirsi al dettato di origine che permea il dire. La poesia è definita da questa ossimorica
capacità: il dettato d’origine (la parola ortiva), nel disdirsi, resta in sé fermo. «…resta in sé fermo
nel suo disdirsi alla parola … ciò che è in tal modo raccogliente pervade tutto stanziandovisi
intimamente […] Il punto raccoglie presso di sé allogando fin nel supremo e nell’estremo. Ciò che è
in tal modo raccogliente pervade tutto stanziandosi intimamente. […] Nel punto così inteso requie
la raccolta insorgenza, l’ortus di ogni cosa. […] Il punto ortivo, l’elemento raccogliente, ottiene per
sé e raccoglie in sé; quindi custodisce ciò che ha ottenuto e accolto. Lungi dall’operare alla maniera
di una capsula che tutto rinchiuda ermeticamente in sé, il punto ortivo riempie di luce e pervade di
splendore ciò che ha raccolto: unicamente in tal modo lo ri-lascia nel e al suo pieno stanziarsi. […]
Tuttavia l’indole plurisenziente del dire poetico non si disintegra in un’indeterminata e stonata
moltitudine di sensi (polisemia). Il plurisenziente tono del dettato d’origine di Trakl proviene da una
raccolta, ossia da un intesa unisona, che, considerata per se stessa, resta sempre ineffabile. L’indole
plurisenziente di questo dire poetante — la sua dovizia di cenni, note e figure — non è
l’imprecisione di chi si lasci andare alla “libera spontaneità”, bensì il rigore di chi, lasciando, si
lasci esigere dall’accuratezza del “retto, giusto osservare”, compaginandosi con esso.» (Heidegger
La parola nella poesia. Georg Trakl p.283, 359)
4.3.2. L’analisi dell’essenza della poesia si configura di nuovo come una fenomenologia
dell’abbandono, e ancora una volta di un abbandono ambivalente. La parola sorgiva disdice se
stessa nel proprio darsi alla parola, a lei compete il movimento proprio dell’abbandono
dell’allontanarsi, distanziarsi; ma si tratta di un abbandono che permette di mantenere ferma e stare
presso quella parola in cui la parola ortiva si disdice; un abbandono che è un abbandonarsi.
4.3.2.1. La funzione e la definizione della poesia nel suo movimento permette di cogliere il
movimento dell’esistenza, come se fosse custodita nel testo poetico, nella sua essenza.
Colui che ascolta è in nuova forma di esistenza che Heidegger chiama in modo specifico
evidenziando il trattino con cui divide la parola: e-sistenza, «stare fuori nel» (“egli sta fuori
nell’apertura dell’essere”) e, anche qui, si tratta di una situazione di abbandono: colui che ascolta e
sta fuori nell’essere che si dà nella parola poetante si abbandona ad esso per essere accolto. «il
componimento, inteso come parola che noi non abbiamo davanti, ma che a partire da sé deve
26
accoglierci nello spazio della sua verità … frequentazioni della parola non sono mai possibili; sarà
invece la parola a trovarci o a trascurarci». (Heidegger, L’inno Andenken p.36)
Qui l’abbandono, e l’e-sistenza, assume la forma dell’ascolto; situazione definibile appunto come la
nostra capacità di stare fuori (di noi) nell’accadere della parola; sempre della parola in senso
poetico, come parola ortiva, accadere dell’essere (e non chiacchiera del pensiero calcolante).
4.3.2.2.. Prende senso e rilevanza allora il tema dell’esilio come definizione dell’essenza del testo
poetico e dell’essenza dell’e-sistenza. L’abbandono si addice all’e-sistere poiché è: “stanziarsi
nell’esilio”, “esilio come punto ortivo del dettato d’origine”; “l’anima è un’indole estranea sulla
terra”. Il canto dell’esule di Trakl diventa il punto di incontro tra poesia e filosofia nel comune
compito di “custodi della casa dell’essere”, ma ciò comporta il “rimanere migranti”, il “trattenersi
come peregrinanti”, lo “stanziarsi come un’indole estranea sulla terra”, lo “stanziarsi nell’esilio”,
“l’esule è in cammino su un sentiero”, “l’anima è un’indole estranea sulla terra” . «L’esilio è il
punto ortivo del dettato d’origine, poiché il salubre tono – la tonica cadenza – dei risonanti e
rilucenti passi dello straniero infiamma l’oscuro migrare di coloro che lo seguono, nel senso che
trasfigura questo migrare nel canto intento all’ascolto» (Heidegger La parola nella poesia. Georg
Trakl p.349)
4.3.3. Alla filosofia il compito di rendere possibile l’ascolto, l’attesa, lo stare nell’esilio. Da qui
riparte la “svolta” nella definizione dell’esistenza come posizione estatica dell’uomo nella
manifestazione dell’essere che si dà nella parola (nella parola poetica). Perciò l’avvio di un comune
cammino (ermeneutico) di filosofia e poesia.
4.3.3.1. Poesia e filosofia hanno in comune il compito della “parola ortiva”. «L’intimo colloquio del
pensare con il poetare durerà a lungo. Esso è appena iniziato.» Con il doppio e collegato compito: 1.
“puntualizzare”: ricondurre ogni dettato al dettato d’origine; 2. collocare nell’ascolto.
«… e-sistenza significa stare-fuori-nella (hin-aus-stehen) verità dell’essere». Si tratta di un compito
etico alla cui riuscita la civiltà contemporanea lega la propria salvezza. Ci viene richiesto il coraggio
dell’abbandono, di una abbandono che ascolta, osserva cogliendo e dice ascoltando. «Ma se una
volta siamo riusciti a darle ascolto, è stato solo dopo un lungo cammino. Percorrere questo
cammino significa lasciarsi alle spalle molte di quelle cose che ci sono abituali e che probabilmente
sono per noi una luce, significa rinunciare alle mete che possono essere raggiunte rapidamente e alle
speranze che non contano nulla. […] Ascoltare, infatti, non è soltanto percepire la parola. Ascoltare
è in primo luogo concentrare l'attenzione… siamo tra quelli che aspettano.» (Heidegger, L’inno
Andenken p.7,17)
4.4. Un abbandono che si adagia nella radura dell’ombra per ascoltare.
(nella forma di una conclusione o chiusura circolare)
4.4.1. All’inizio vi era l’invito platonico: «… Bel luogo per fermarci! Questo platano è molto
frondoso e alto; l'agnocasto è alto e la sua ombra bellissima; e, nel pieno della fioritura com'è, rende
il luogo profumatissimo. […] Allora ascolta.» Platone, Fedro 230 b-e
4.4.2. In quel fresco partecipare si profila l’ombra lunga dell’abbandono. «E chi accoglie
l’abbandono — abbandono a imponderabili forze estranee, a forze universali — ottiene un
distendersi estatico del mondo, un allungarsi dell’ombra di questo mondo in cosmo. Qualcosa che si
avvicina a una pratica mistica passiva che contempla perfino l’abbandono della scrittura ossia
dell’intenzionalità della scrittura. L’abbandono, la Ruhe che è anche l’essere abbandonati
(verlassen), è un fenomeno crudelmente più alto della vocazione, della chiamata all’opera. Scrivere
[e vivere] per abbandono.» Rubina Giorgia, Felice. Il padre della scrittura di Kafka, in Baratta
Stefano, Ermini Flavio (a cura di) 2004 I nomi propri dell’ombra, Moretti & Vitali, Bergamo p.53.
27