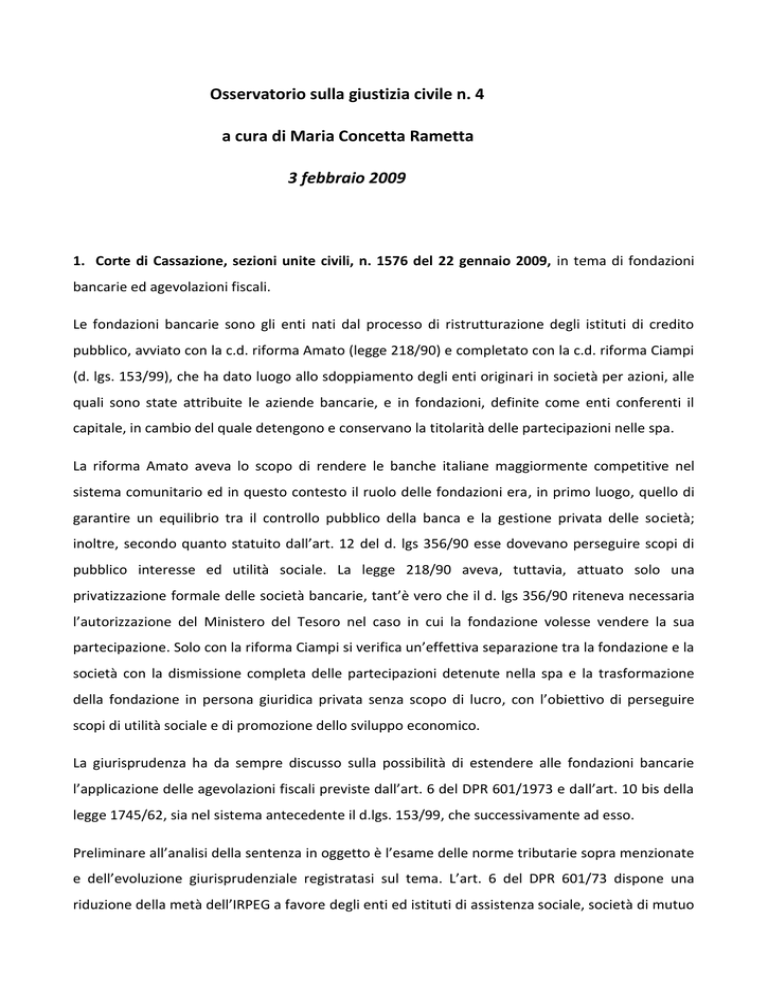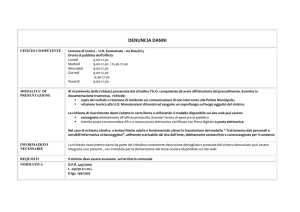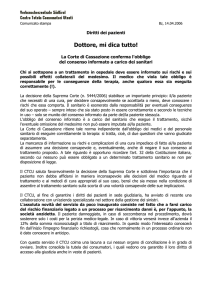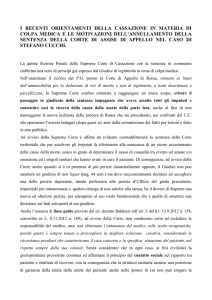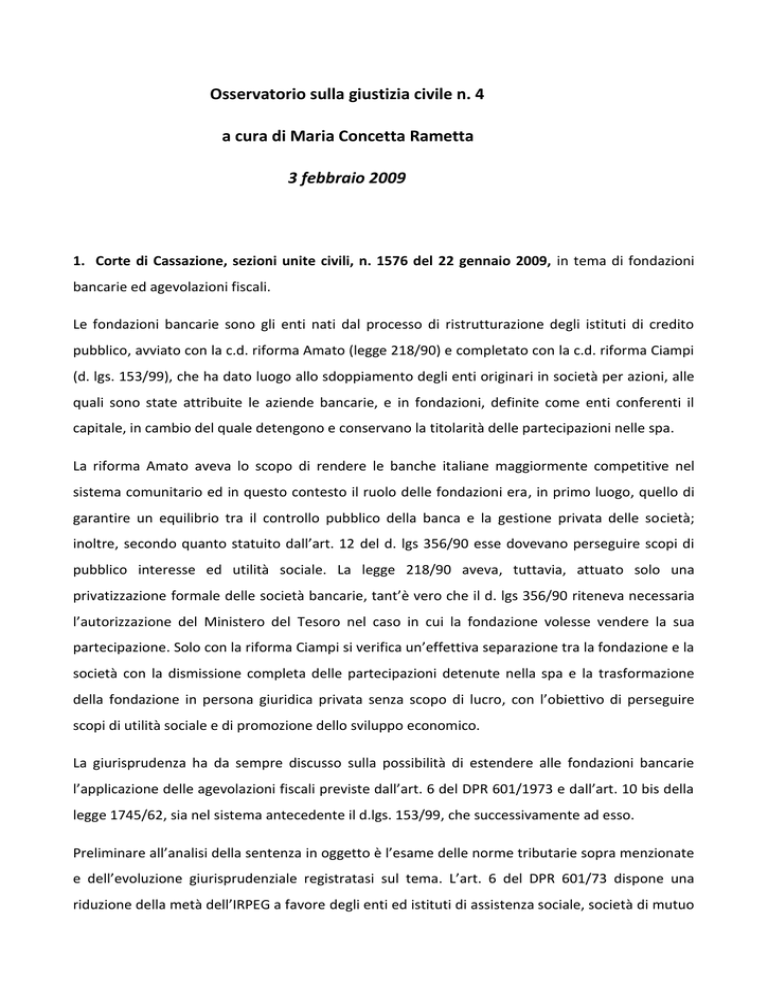
Osservatorio sulla giustizia civile n. 4
a cura di Maria Concetta Rametta
3 febbraio 2009
1. Corte di Cassazione, sezioni unite civili, n. 1576 del 22 gennaio 2009, in tema di fondazioni
bancarie ed agevolazioni fiscali.
Le fondazioni bancarie sono gli enti nati dal processo di ristrutturazione degli istituti di credito
pubblico, avviato con la c.d. riforma Amato (legge 218/90) e completato con la c.d. riforma Ciampi
(d. lgs. 153/99), che ha dato luogo allo sdoppiamento degli enti originari in società per azioni, alle
quali sono state attribuite le aziende bancarie, e in fondazioni, definite come enti conferenti il
capitale, in cambio del quale detengono e conservano la titolarità delle partecipazioni nelle spa.
La riforma Amato aveva lo scopo di rendere le banche italiane maggiormente competitive nel
sistema comunitario ed in questo contesto il ruolo delle fondazioni era, in primo luogo, quello di
garantire un equilibrio tra il controllo pubblico della banca e la gestione privata delle società;
inoltre, secondo quanto statuito dall’art. 12 del d. lgs 356/90 esse dovevano perseguire scopi di
pubblico interesse ed utilità sociale. La legge 218/90 aveva, tuttavia, attuato solo una
privatizzazione formale delle società bancarie, tant’è vero che il d. lgs 356/90 riteneva necessaria
l’autorizzazione del Ministero del Tesoro nel caso in cui la fondazione volesse vendere la sua
partecipazione. Solo con la riforma Ciampi si verifica un’effettiva separazione tra la fondazione e la
società con la dismissione completa delle partecipazioni detenute nella spa e la trasformazione
della fondazione in persona giuridica privata senza scopo di lucro, con l’obiettivo di perseguire
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
La giurisprudenza ha da sempre discusso sulla possibilità di estendere alle fondazioni bancarie
l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 6 del DPR 601/1973 e dall’art. 10 bis della
legge 1745/62, sia nel sistema antecedente il d.lgs. 153/99, che successivamente ad esso.
Preliminare all’analisi della sentenza in oggetto è l’esame delle norme tributarie sopra menzionate
e dell’evoluzione giurisprudenziale registratasi sul tema. L’art. 6 del DPR 601/73 dispone una
riduzione della metà dell’IRPEG a favore degli enti ed istituti di assistenza sociale, società di mutuo
soccorso, enti di beneficenza e assistenza, accademie, fondazioni ed associazioni storiche,
letterarie, scientifiche aventi scopi esclusivamente culturali nonché degli enti il cui fine è
equiparata per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. L’art. 10 bis della legge 1745/62 esonera
dalla ritenuta i dividendi spettanti a persone giuridiche pubbliche o a fondazioni che hanno
esclusivamente scopi di beneficenza, educazione ed assistenza.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente estendeva le agevolazioni fiscali alle fondazioni
bancarie sulla base della natura strumentale dell’attività di amministrazione della partecipazione
societaria, necessaria al fine di raccogliere le rendite per realizzare gli scopi statutari di utilità
sociale, e sulla base di quanto disposto dall’art. 12 del d. lgs 153/99. Tale norma, contenuta nella
riforma Ciampi, riteneva applicabile l’art. 6 del dpr 601/73 alle fondazioni che, avendo adeguato i
propri statuti a quanto disposto nel d. lgs. 153/99, perseguivano scopi di utilità sociale in modo
prevalente e non avevano più natura di enti commerciali. La giurisprudenza sostenendo che essa
avesse natura interpretativa e non innovativa, ritenne che fosse applicabile in modo retroattivo
alle fondazioni già esistenti ed ai pregressi anni d’imposta. A fronte di tale impostazione si
registrava un orientamento negativo, fondato sul fatto che le utilità sociali venivano perseguite
dalle fondazioni non in modo esclusivo, come richiesto dalla norma, e sulla natura commerciale
dell’attività di amministrazione delle partecipazioni nella società bancaria.
A causa del contrasto la questione venne rimessa alle sezioni unite che si pronunciarono con la
sentenza 27619/06, dopo aver effettuato un rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia europea con
il quale si chiedeva se le fondazioni bancarie costituissero soggetti ai quali poter applicare le
norme sulla concorrenza e sugli aiuti di stato, dato che, in caso di soluzione affermativa,
l’applicazione delle agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie sarebbe risultata in contrasto con il
trattato europeo.
La Corte di Giustizia, considerando che per impresa deve intendersi qualsiasi ente che eserciti
un’attività economica a prescindere dal suo status economico e dalle modalità di finanziamento e
che per “attività economica” deve intendersi qualsiasi attività che consista nell’offrire beni e
servizi o direttamente sul mercato o tramite il controllo di un altro operatore che fornisce al
mercato tali beni, conclude ritenendo che non svolge attività economica la fondazione che
possiede partecipazioni che attribuiscano solo i diritti connessi alla qualità di azionista; al
contrario, deve essere considerata impresa (sottoposta pertanto alla disciplina sugli aiuti di stato)
la fondazione che, attraverso le azioni possedute, partecipi alla gestione dell’azienda bancaria.
Spetta poi al giudice nazionale verificare in concreto alla luce dei principi affermati se tali enti
possano essere qualificati come imprese e se l’agevolazione fiscale di cui si discute possa essere
considerata come un aiuto di stato.
Le sezioni unite con la decisione del 2006 stabiliscono che, al fine di godere dell’esenzione
tributaria, il soggetto richiedente deve dimostrare l’esclusivo perseguimento di fini di utilità sociale
ed il fatto che l’attività di amministrazione delle partecipazioni azionarie nelle spa titolari
dell’azienda bancaria abbia natura strumentale rispetto al conseguimento delle proprie risorse
economiche. In tale ottica non rilevano le trasformazioni subite da tali enti con le leggi 218 e 356
del 1990, dato che esse prevedevano comunque un collegamento genetico tra le fondazioni e le
società, ma può rilevare la stipulazione di patti parasociali dai quali si desuma che la fondazione ha
natura di impresa avendo il potere di controllare e gestire l’attività bancaria. In questo caso l’art.
10 bis della legge del 1962 dovrà essere disapplicato i quanto l’agevolazione fiscale in esso prevista
costituisce un aiuto di stato.
La successiva giurisprudenza si è attestata nel senso indicato dalle sezioni unite del 2006: in
particolare, si è precisato che la dimostrazione del perseguimento degli scopi di utilità sociale è
posta a carico del soggetto che richiede l’agevolazione e che non si tratta di una prova impossibile,
potendo essere data attraverso la produzione dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio
dei revisori; che la descritta verifica postula un’indagine sull’esercizio in concreto dell’attività
d’impresa e presuppone che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole del
processo tributario, cioè mediante la proposizione della questione nel ricorso introduttivo; che il
carattere di impresa commerciale è escluso dalla previsione statutaria o legale dell’esclusività del
fine di utilità sociale e dall’accertamento dell’impossibilità di influenzare la gestione della società.
La giurisprudenza ha, inoltre, escluso sostanzialmente la necessità del rinvio al giudice di merito
per l’esame della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalle norme agevolative ritenendo
che se il tema della prova del perseguimento di tali finalità non è stato prospettato con il ricorso
introduttivo non può più essere introdotto, rendendo inutile il rinvio. Da ciò è sorta la necessità
della pronuncia in oggetto con la quale le sezioni unite confermano l’indirizzo sostenuto nel 2006.
Già dalla rubrica normativa e, dunque, dall’interpretazione letterale che l’art. 12 delle preleggi
pone come primo criterio interpretativo, si evince che la riforma Amato non aveva lo scopo di
riformare il mondo degli enti non profit, ma quello di ristrutturare il sistema creditizio. Essa ha
creato nel nostro ordinamento un ente nuovo di difficile classificazione ma che sicuramente non
ha nulla a che vedere con gli enti di beneficenza di cui parlano gli art. 6 del dpr del 73 e 10 bis della
legge del 1962; pertanto, sussiste una presunzione legale secondo la quale le fondazioni svolgono
attività bancaria, che può essere superata solo con la dimostrazione della realizzazione di scopi
sociali considerati prevalenti su quelli bancari. Nella riforma Amato il fine principale del legislatore
era quello di assicurare alle fondazioni il controllo della gestione, considerando del tutto secondari
i fini di utilità sociale. Il divieto della gestione diretta dell’azienda bancaria costituiva un limite
strutturale ed un’ovvia conseguenza della riforma che voleva una scissione tra l’ente conferente e
l’ente gestore; tuttavia, ciò non escludeva che in realtà il potere di direzione fosse nelle mani degli
enti conferenti, tant’è vero che anche la Corte di Giusitizia ha affermato che la fondazione serviva
ad assicurare la continuità operativa tra essa e la banca. La Corte di Cassazione ricorda ancora
come per la giurisprudenza prevalente la detenzione di partecipazioni, che si traduce in un vero e
proprio controllo, costituisce lo svolgimento di un’attività di impresa rapportabile al modello della
holding.
Alla stregua di tali considerazioni è evidente che le fondazioni bancarie descritte dalla riforma
Amato non possono essere assolutamente assimilate agli enti di cui parlano le norme tributarie
che prevedono le agevolazioni fiscali, né alle persone giuridiche che perseguono esclusivamente
fini sociali, né agli enti elencati dall’art. 6 che sono caratterizzati da una delineata specializzazione
e che non hanno scopo di lucro. Da ciò si deve escludere qualsiasi applicazione analogica o
estensiva della norma: la prima è esclusa dall’eccezionalità della previsione, la seconda è scartata
dalla stessa norma che non ammette la sua applicabilità al di là dei casi previsti dal legislatore.
L’inapplicabilità dell’art. 10 bis discende, invece, dal fatto che tale disposizione trova spazio solo se
lo scopo sociale è perseguito in via esclusiva.
La Suprema Corte, infine, esclude la fondatezza dell’argomento, utilizzato dalla giurisprudenza
favorevole in assoluto all’estensione delle agevolazioni fiscali, relativo alla natura interpretativa e,
pertanto, retroattiva dell’art. 12 del d. Lgs 153/99. La riforma Ciampi ha trasformato le fondazioni
bancarie in enti con personalità giuridica di diritto privato ed ha stabilito che esse devono
dismettere le partecipazioni nelle società bancarie e possono esercitare imprese solo se
strumentali ai fini statutari. L’art. 12 estende le agevolazioni fiscali solo agli enti che si adeguano a
quanto previsto dalla normativa e che perseguano prevalentemente fini sociali ed opera solo dal
momento della entrata in vigore della riforma e non retroattivamente
2. Corte di Cassazione, sezioni unite civili, n. 553 del 14 gennaio 2009, in tema di caparra
confirmatoria.
Con questa importantissima sentenza la Suprema Corte ha finalmente risolto una questione che
ha alimentato il dibattito giurisprudenziale in questi ultimi anni in ordine al coordinamento dei
rimedi descritti dall’art. 1385 c.c., in relazione alla caparra confirmatoria. Essa costituisce una
somma di denaro o una quantità di cose fungibili che viene data al momento della conclusione del
contratto da una delle parti e la cui funzione, a seconda della tesi cui si aderisce, può essere
probatoria, sanzionatoria dell’inadempimento, o determinativa in modo forfettario del
risarcimento del danno. L’art. 1385 stabilisce che, in caso di adempimento, la caparra va restituita
oppure imputata alla prestazione dovuta ed, al contrario, in caso di inadempimento se è la parte
che ha dato la caparra a non aver ottemperato all’impegno, l’altra potrà tenerla e recedere, se
invece è inadempiente colui che l’ha ricevuta deve restituire il doppio della somma, salvo che
l’altro voglia chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, insieme al risarcimento. Si ritiene
pacificamente che i due rimedi previsti dalla norma per l’ipotesi dell’inadempimento del contratto,
sono alternativi e non cumulabili e che le regole risarcitorie sono differenti a seconda del rimedio
esperito dalla parte adempiente, nel senso che qualora decida di recedere e tenere la caparra (o
chiedere il doppio) essa stessa costituirà il risarcimento del danno; se invece, chiede la risoluzione
o l’esecuzione la norma prevede che il risarcimento è regolato dalle norme generali e, pertanto, il
danno dovrà essere provato.
La questione alla base del contrasto giurisprudenziale e proposta all’attenzione delle sezioni unite
dall’ordinanza di rimessione riguarda, in particolare, la possibilità, per la parte che ha chiesto in
primo grado la risoluzione ed il risarcimento del danno, di chiedere in secondo grado, avendo
ottenuto solo la prima, il recesso e la ritenzione della caparra. Le sezioni unite, tuttavia, dopo aver
esaminato le posizioni giurisprudenziali esistenti su tale problematica e su altre ad essa connesse,
rilevano che, in realtà, le questioni da esaminare sono più articolate e riguardano: 1) i rapporti tra
l’azione risolutoria e risarcitoria e quelli tra il recesso e la ritenzione della caparra; 2) il rapporto tra
il recesso e l’azione di risoluzione (distinguendo i casi in cui questa abbia natura costitutiva o
dichiarativa); 3) i rapporti tra la risoluzione di diritto, la rinuncia all’effetto risolutorio ed il recesso;
4) i rapporti tra l’azione di risarcimento e l’istanza di ritenzione della caparra; 6) la possibilità di
ritenere la caparra, in assenza di azione risarcitoria, a prescindere dal rimedio caducatorio
prescelto.
Con riferimento alla prima questione, una prima impostazione ritiene che la parte che ha chiesto
di recedere ben può modificare la sua istanza domandando la risoluzione ed il risarcimento del
danno, poichè non si tratterebbe di una domanda nuova, e pertanto preclusa ai sensi dell’art. 345
cpc, ma di una perdurante facoltà, oltretutto di minore portata rispetto alla istanza di risoluzione,
di cui la parte continua ad essere titolare. In tale ottica, infatti, una domanda è considerata nuova
se tende ad alterare, ampliandoli, i termini della controversia o a modificare la domanda originaria
ed il suo fatto costitutivo, in modo da non poterla più assorbire; pertanto, poiché sia la domanda
di recesso che quella di risoluzione tendono allo scioglimento dal contratto e discendono
entrambe dall’inadempimento, si afferma che la domanda di recesso, essendo più limitata rispetto
a quella di risoluzione, non altera i presupposti della domanda originaria e non costituisce una
istanza nuova. Secondo la tesi contraria alla fungibilità dei due rimedi le domande di recesso da un
lato e di risoluzione e risarcimento dall’altro sono diverse poiché hanno una causa petendi
differente; per tale motivo, la domanda di risoluzione proposta in appello in sostituzione
dell’istanza di recesso è una domanda del tutto nuova, preclusa ai sensi dell’art. 345 cpc.
La Suprema Corte passa, quindi, in rassegna le decisioni relative alle ipotesi in cui si verifica una
risoluzione di diritto, rispetto alla quale la sentenza ha natura dichiarativa. Alcune sentenze, pur
sostenendo l’impraticabilità del recesso una volta avutasi la risoluzione ex lege, a seguito dello
spirare del termine contenuto nella diffida ad adempiere, affermano, solo però con riferimento
all’istanza risarcitoria, che l’esercizio dei diritti di cui al secondo comma dell’art. 1385, costituisce
un istanza di risarcimento dei danni più limitata rispetto a quella esercitata secondo le regole
generali. Una pronuncia del 1997, esaminando un’ipotesi in cui vi era stata sì la diffida ad
adempiere (presupposto della risoluzione di diritto), ma in cui la parte aveva poi rinunciato ad essa
con comportamenti concludenti, ha ritenuto possibile esercitare in queste ipotesi il recesso.
Avverso tale posizione si è schierata unanimemente la dottrina, secondo la quale non è possibile
rinunciare all’effetto risolutorio derivante dalla risoluzione di diritto: così come, ai sensi dell’art.
1453, la parte che chiede la risoluzione non può poi chiedere l’adempimento, allo stesso modo
non si può inviare una diffida ad adempiere e, dopo lo spirare del termine, decidere di recedere da
un contratto che ormai è stato risolto. Infine, altre pronunce, muovendo dalla funzione risarcitoria
della caparra, hanno ritenuto ammissibile la domanda di recesso successiva ad una risoluzione di
diritto già verificatasi, nel caso in cui però non era stato chiesto il risarcimento .
Con riferimento ai rapporti tra la caparra ed il risarcimento dei danni, la giurisprudenza si divide
tra chi ritiene che non si può domandare la caparra a titolo di risarcimento se si chiede la
risoluzione, dovendosi provare il danno secondo le regole generali, e chi invece afferma che,
anche nel caso di istanza di risoluzione, la caparra può avere la funzione di risarcire il minimum.
Le sezioni unite, al fine di dare una soluzione della questioni indicate, ritengono necessario
ricostruire la nascita e la ratio della caparra confirmatoria, inquadrandola nell’ottica del principio
del giusto processo, il quale deve essere evitabile, celere e deve realizzare l’equo
contemperamento degli interessi delle parti secondo il canone della buona fede. La suprema
corte, dopo aver evidenziato che il termine “caparra” viene usato nella norma sia per indicare il
negozio accessorio al contratto con cui si stabilisce la dazione di essa (“a titolo di caparra), sia il
suo oggetto (restituzione della caparra), con riferimento alla funzione dell’istituto sottolinea il
fatto che le posizioni dottrinali e giurisprudenziali contrastanti sono dovute alla ecletticità della
caparra, la quale, esclusa soltanto la funzione probatoria, è volta sia a garantire l’esecuzione del
contratto, sia a svolgere una funzione di autotutela, evitando il ricorso al giudice, sia una funzione
di liquidazione forfettaria, convenzionale e preventiva del danno. La descritta variabilità della
finalità distingue, inoltre, la caparra confirmatoria da altre figure similari come la caparra
penitenziale, che costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, e dalla clausola penale, a
differenza della quale la parte adempiente può decidere di chiedere il risarcimento del danno
integrale secondo le regole generali, pur in assenza di uno specifico patto in tal senso.
Nell’analizzare la questione principale tra quelle elencate sopra, ovverossia il rapporto tra la
risoluzione ed il recesso, la cassazione evidenzia che il problema ha origini antiche. Infatti, già
sotto la vigenza del codice civile del 1865, poiché era prevista a tutela della parte adempiente
soltanto la possibilità di recedere o chiedere l’esecuzione del contratto, si discuteva sulla
possibilità di domandare la risoluzione ed il risarcimento integrale del danno. Soltanto con il codice
del 1942 il legislatore attribuisce tale facoltà, specificando nella relazione al re che la caparra serve
a deflazionare il contenzioso, assicurando la rapidità nella composizione delle liti nel caso in cui la
parte adempiente decida di recedere e ritenere la caparra, o a garantire il risarcimento dei danni
qualora si scelga di adire le vie giudiziali chiedendo l’esecuzione o la risoluzione.
Nell’immediatezza dell’emanazione del codice la dottrina, pur ritenendo pacificamente che i due
rimedi fossero alternativi, si era divisa tra chi sosteneva che, nel caso in cui si fosse chiesta la
risoluzione e non si fosse dimostrato il danno, nessun risarcimento poteva essere dato, e chi
invece, temperava la rigidità dell’alternatività affermando che, in mancanza di prova del danno
poteva essere attribuita in ogni caso la somma oggetto della caparra, che costituiva, pertanto, il
minimum risarcibile.
Negli anni sessanta comincia ad emergere l’idea secondo la quale, poiché il legislatore definisce in
termini di recesso una serie di atti unilaterali diversificati tra loro sia per la causa che per gli effetti,
il recesso non è una categoria giuridica autonoma, ma costituisce una diversa modalità di
risoluzione del contratto e, più in particolare, di una ipotesi di risoluzione di diritto. Il recesso
viene, dunque, definito come una forma di risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha una
funzione di semplificazione probatoria e che presuppone un inadempimento avente gli stessi
caratteri dell’inadempimento che comporta la risoluzione giudiziale, di natura costitutiva. In quel
periodo l’orientamento dominante riteneva, pertanto, possibile chiedere il recesso anche nel caso
in cui fosse stata già richiesta la risoluzione, ciò fino al momento delle precisazione delle
conclusioni.
Solo recentemente l’impostazione consolidata viene scossa da decisioni minoritarie che, pur
condividendo il principio per il quale il recesso costituisce un’istanza di contenuto minore rispetto
alla risoluzione ed ha la stessa causa petendi, tuttavia è una domanda nuova e, quindi, preclusa,
essendo differente sia il petitum immediato che quello mediato. Il primo è diverso perché
trattandosi di una risoluzione stragiudiziale, la sentenza che la accerta ha natura dichiarativa, a
differenza di quella costitutiva relativa alla risoluzione giudiziale; il petitum mediato è diverso
perché la parte inadempiente con la sentenza costitutiva di risoluzione sopporta anche delle
modificazioni nella sua sfera giuridica, mentre nel caso del recesso prende solo atto
dell’accertamento giudiziale della verifica dei suoi presupposti.
Inoltre, con riferimento alla possibilità di considerare la caparra come un minimum di risarcimento
sempre attribuibile, anche autori recenti hanno condiviso tale idea e, muovendo dalla funzione
risarcitoria della caparra, hanno sostenuto che il legislatore ha previsto la possibilità di chiedere il
risarcimento integrale al fine di tutelare maggiormente il contraente adempiente che potrà quindi
ottenere, oltre alla caparra, anche il risarcimento integrale del danno, se riesce a provarlo. In
quest’ottica, pertanto, l’alternativa non è tra la risoluzione ed il recesso, ma tra i due rimedi
risarcitori, autonomi rispetto agli strumenti dell’adempimento e della risoluzione.
Andando ad esaminare le conclusioni della corte, si può iniziare col dire che le sezioni unite
condividono la ricostruzione del recesso, previsto dall’art. 1385, come una forma di risoluzione
stragiudiziale, avente come presupposto lo stesso tipo di inadempimento (colpevole e grave) che
rende possibile chiedere la risoluzione giudiziale. L’inadempimento deve essere, quindi,
imputabile, innanzitutto, perchè avendo, tra l’altro, la caparra funzione risarcitoria, in mancanza
della colpa del debitore, il danno non può essere risarcito; in secondo luogo, perché se mancasse
l’imputabilità, il contratto verrebbe risolto per impossibilità sopravvenuta, e ciò avrebbe l’effetto
di caducare non solo il contratto principale, ma anche il negozio accessorio istitutivo della caparra.
L’inadempimento, inoltre, deve essere grave perché altrimenti si darebbe alla parte la possibilità di
recedere dal vincolo per un suo capriccio e ciò, porterebbe, anziché a rafforzare il vincolo
contrattuale, ad indebolirlo.
Se, dunque, il recesso è una modalità alternativa di risoluzione, la questione principale da risolvere
diventa l’individuazione del rapporto tra l’azione risarcitoria e quella di ritenzione della caparra:
infatti, se la parte anziché recedere decide di chiedere la risoluzione è spinto soltanto dal volere
ottenere un risarcimento maggiore rispetto alla caparra, dato che in entrambi i casi il contratto
verrà sciolto; ciò significa che il soggetto non sceglie tra l’azione di risoluzione ed il recesso, ma tra
tenere la somma oggetto della caparra e chiedere il risarcimento integrale del danno. Le due
azioni, però, secondo le sezioni unite sono morfologicamente incompatibili. Infatti, l’art. 1385,
terzo comma, non prevede la possibilità di chiedere il maggiore danno, ma il risarcimento
integrale del danno, secondo le regole generali richiamate dalla stessa norma e che non possono
essere disapplicate. Il danno va, pertanto, provato ed il risarcimento è differente dalla caparra, la
cui ritenzione viene, infatti, domandata perché la parte, anziché rischiare di non ottenere nulla in
giudizio, qualora non riesca a dimostrare il danno subito, decide di accontentarsi di una somma
forfettaria, ma di rapida acquisizione. Pertanto, opinando in senso contrario e consentendo alla
parte di modificare le sue pretese, si darebbe la possibilità di eludere le norme in tema di onere
probatorio, di realizzare abusi nelle strategie processuali e si favorirebbero liti temerarie, in
contrasto con l’art. 111 Cost., con spreco di risorse economiche, necessarie al giudice per
realizzare tutti gli accertamenti del caso. Tale tesi risulta, altresì, confermata dal confronto con la
disciplina relativa alla clausola penale, nella quale si stabilisce che il risarcimento del danno
ulteriore può essere richiesto solo se sussiste un patto in tal senso.
Alla luce di quanto affermato si deve, inoltre, escludere la possibilità che la caparra possa
costituire un minimum risarcibile, da attribuire anche qualora si chieda la risoluzione, non avendo
senso chiedere, insieme alla risoluzione, come risarcimento ,soltanto la caparra, quando è
possibile recedere più velocemente dal contratto, trattenendo direttamente la caparra.
Infine, le sezioni unite escludono la possibilità che il contraente possa rinunciare all’effetto
risolutorio discendente da una risoluzione ex lege, verificandosi esso in modo automatico allo
spirare del termine indicato nella diffida, ai sensi di quanto disposto nell’art. 1454; opinando in
senso contrario, la disponibilità dell’effetto opererebbe sine die, mancando una norma limitativa,
in contrasto con gli altri meccanismi di risoluzione automatica e con l’affidamento nel frattempo
creatosi in capo al debitore.
In conclusione, le sezioni unite affermano i seguenti principi: 1) è inammissibile modificare la
domanda di risoluzione in istanza di recesso, perché verrebbe vanificata la funzione della caparra
di determinare in modo forfettario il risarcimento del danno ed evitare l’instaurarsi di un giudizio;
2) è inammissibile esercitare il recesso dopo aver inviato la diffida ad adempiere, perché il
contratto è già caducato, essendosi verificata una risoluzione di diritto, e la domanda avrebbe il
solo scopo di ampliare l’istanza risarcitoria, il che come detto prima costituisce una pretesa
impossibile; 3) è inammissibile la rinuncia all’effetto risolutorio; 4) l’istanza di recesso è
incompatibile con quella di risarcimento; 5)la domanda di ritenzione della caparra può essere
presentata a prescindere dal nomen iuris utilizzato nell’introdurre la domanda caducatoria: se
definita come risoluzione, il giudice dovrà, interpretando e qualificando la domanda, convertirla in
domanda di recesso.
3. Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 30055 e 30057 del 23 dicembre 2008, in tema di
dividend washing ed abuso del diritto.
Con queste due sentenze gemelle la Suprema Corte ha risolto il contrasto relativo alla possibilità o
meno di applicare, con riferimento alla disciplina precedente all'entrata in vigore dell'art. 14,
comma 6-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (introdotto dall’art. 7 bis del d.l.372/92), le
agevolazioni fiscali nelle operazioni di "dividend washing" (sentenza n. 30055) e "dividend
stripping” (sentenza n. 30057).
Il dividend stripping consiste nella costituzione, a favore di una società residente nel territorio
dello Stato, di un diritto di usufrutto su azioni o quote di una società italiana possedute da un
soggetto non residente, al fine di consentire, da un lato, al cedente la trasformazione del reddito
di partecipazione in reddito di negoziazione, al quale non si applica la ritenuta sui dividendi, e
dall’altro, alla cessionaria di percepire i dividendi per i quali sono previsti vari benefici fiscali.
Il dividend washing consiste, invece, nella stipula di un contratto di vendita, con il quale un fondo
comune d’investimento oppure una SICAV cede ad una società di capitali una parte delle sue
azioni, contestualmente ad un contratto di acquisto delle stesse azioni da parte del primo
venditore, successivamente all’acquisizione dei dividendi da parte della società. Lo scopo
dell’operazione consiste sia nell’usufruire del trattamento fiscale agevolato sui dividendi, riservato
alle società di capitali, sia nel consentire all’acquirente di diminuire le componenti attive del
reddito d’impresa, considerando la minusvalenza risultante dalla differenza del prezzo
dell’originaria vendita e di quello della seconda cessione.
La questione oggetto del contrasto giurisprudenziale rileva, come detto, soltanto per il periodo
antecedente all’entrata in vigore del d.l. 372/92, che ha escluso espressamente la possibilità di
godere di un credito d’imposta in relazione a tali operazioni.
Secondo un primo orientamento, poiché mancava una disposizione normativa che lo vietasse, il
trattamento fiscale più favorevole era applicabile sia per il dividend washing che per il dividend
stripping; secondo, invece, l’impostazione più recente accolta dalla decisione della Cassazione n.
20398/05 in ordine al dividend washing, le agevolazioni fiscali non vanno riconosciute in ragione
della nullità dei due contratti, derivante dalla mancanza della causa negoziale.
La citata pronuncia aderisce al primo orientamento solo nel punto in cui sostiene di non poter
considerare quanto statuito nell’art. 37 del dpr 600/73 come una clausola generale antielusiva,
poichè esso fa riferimento a fattispecie civilistiche, quali la simulazione e l’interposizione fittizia,
che non sempre ricorrono, proprio come nel caso del dividend washing; tuttavia, anche nel caso in
cui si volesse ritenere che l’art. 37 sia una norma generale, il principio, affermato nel passato,
secondo il quale prima dell’introduzione di tale disposizione, non esisteva una clausola generale
antielusiva, deve essere rivisto alla luce della giurisprudenza comunitaria. Questa infatti, ha
sostenuto, anche se in settori diversi da quello fiscale, che le norme comunitarie non possono
essere utilizzate in modo abusivo. Nonostante, quindi, la mancanza di una regola specifica del
settore fiscale che reprima l’abuso del diritto, quanto detto dalla giurisprudenza comunitaria in
altri settori evidenzia in ogni caso l’esistenza di un principio tendenziale che deve spingere
l’interprete a cercare degli strumenti nell’ordinamento nazionale al fine di reprimere tali
fenomeni. Abbandonata la strada volta a fondare un eventuale orientamento negativo sulla
mancanza di una norma di divieto, la corte di cassazione con le sentenze in oggetto sostiene la
soluzione negativa ritenendo che i contratti sono inefficaci nei confronti del fisco per mancanza di
causa. Infatti, sulla base del fatto che, trattandosi di un collegamento negoziale, la causa va
cercata nell’intera operazione, e non con riferimento ai singoli negozi, la suprema corte evidenzia
che il fine che sorregge l’operazione di dividend washing non è uno scopo economico, ma è il fine
di conseguire un risparmio d’imposta, e ciò costituisce un mero motivo, non idoneo pertanto a
fondare la causa negoziale.
Ricordando come sia stato più volte affermata, in relazione ad altri settori, l’esistenza di un divieto
generale di abuso del diritto (si veda da ultimo la sentenza, resa a sezioni unite, n. 23726/07), le
sezioni unite sostengono l’inapplicabilità delle agevolazioni fiscali alle operazioni in esame
ritenendo esistente un principio generale antielusivo e reputando che la fonte di esso, per i tributi
non armonizzati, non risiede nella giurisprudenza comunitaria, ma nei principi costituzionali posti
in tema di tributi dall’art. 53, e cioè nei principi della capacità contributiva e della progressività
nell’imposizione. Deriva da tale disposizione che il contribuente non può utilizzare in modo
distorto a suo favore le norme che prevedono benefici fiscali, anche se così agendo non violi
specificatamente una disposizione legislativa, salvo che vi siano delle ragioni economicamente
apprezzabili che giustifichino gli atti, ragioni che però non possono consistere nel mero risparmio
fiscale. La sopravvenienza di norme che sanciscono espressamente il principio antielusivo non
possono essere richiamate per contrastare la tesi descritta in quanto esse non fanno che
confermare l’esistenza della regola generale. Pertanto, l’introduzione dell’art. 14, comma 6-bis, del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che riduce la convenienza fiscale delle operazioni di dividend
washing e di dividend stripping, conferma l’illiceità delle operazioni poste in essere anche
precedentemente alla sua entrata in vigore, in quanto volte ad eludere le norme tributarie.
Ancora, contro tale principio non si può richiamare neanche la riserva di legge stabilita dall’art. 23
Cost., poiché riconoscere l’esistenza del generale divieto di abuso del diritto nel settore fiscale non
significa imporre al contribuente altri obblighi tributari che non derivino dalla legge, ma escludere
l’efficacia degli atti posti in essere al solo fine di eludere la normativa fiscale.
Infine, la Cassazione, muovendo dal principio secondo il quale sono rilevabili d’ufficio le eccezioni
poste a vantaggio della PA in una materia non disponibile, qual è quella tributaria, afferma che
l’inopponibilità dell’operazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria può essere rilevata
d’ufficio dal giudice. In relazione a tale punto, la suprema corte esamina, altresì, i caratteri del
giudizio tributario sottolineando che i poteri d’indagine del giudice in tale processo sono limitati
dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione finanziaria, la quale secondo i principi generali, va
provata dall’attore. Tuttavia, le sezioni unite precisano che se ciò che si chiede in giudizio è il
disconoscimento di una minusvalenza, il tema relativo all’esistenza e alla validità dei negozi dai
quali essa ha tratto origine, è acquisito al processo per effetto dell’allegazione del contribuente,
che a sua volta deve provare l’esistenza dei presupposti e l’applicazione del beneficio fiscale di cui
richiede l’applicazione. Pertanto, se l’oggetto della domanda è costituita dalla pretesa della PA e la
questione della validità ed opponibilità dei contratti entra nel giudizio come contenuto
dell’eccezione del contribuente, il giudice può d’ufficio rilevare le cause di invalidità ed
inopponibilità del contratto, salvo che ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal
giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o, nel giudizio di legittimità, dalla
necessità di svolgere indagini di fatto.
5. Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 29832 del 19 dicembre 2008, in tema di danno da
demansionamento.
Nell’ambito del rapporto lavorativo l’esecuzione della prestazione da parte del lavoratore
costituisce non solo un obbligo, ma anche un diritto autonomamente tutelabile. Lo svolgimento
dell’attività lavorativa costituisce, infatti, uno degli strumenti attraverso i quali ciascun soggetto
esplica la propria personalità ed accresce la propria professionalità. Si tratta, quindi, di un diritto
soggettivo cui corrisponde l’obbligo del datore non solo di adibire il lavoratore alle mansioni per le
quali è stato assunto, ma anche di non lasciarlo in totale inattività. A fondamento di ciò, l’art. 2103
c.c. stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è
stato assunto, a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della
retribuzione. Qualora al lavoratore vengano assegnate mansioni superiori, egli non solo avrà
diritto alla retribuzione corrispondente, ma l’assegnazione diventerà definitiva, salvo il caso in cui
egli abbia sostituito un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, se si protrae
per più di tre mesi; occorre tuttavia, considerare che per raggiungere tale soglia l’adibizione non
necessariamente deve essere fatta per un periodo continuativo, ma i tre mesi possono essere
anche raggiunti sommando singoli periodi più brevi e distanziati tra loro, poiché tali modalità
esprimono un implicito intento elusivo della norma da parte del datore. Nel caso in cui il divieto
posto dalla norma citata venga violato, il lavoratore potrà chiedere sia la condanna del datore
all’assegnazione alle mansioni per le quali il soggetto era stato assunto, sia il risarcimento del
danno, che viene definito “danno da demansionamento”.
Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi sul tema. In primo
luogo, afferma che, essendo l’art. 2103 una norma imperativa, la sua violazione comporta la nullità
del provvedimento datoriale e la condanna all’adempimento in forma specifica, costituito dal
ripristino dello status quo ante. Il lavoratore può chiedere, pertanto, al giudice di essere
riassegnato alle proprie mansioni e anche se, in linea di massima, non può rifiutarsi di adempiere
al provvedimento datoriale, potrà sempre invocare l’art. 1460 c.c.; tuttavia, il giudice deve
valutare, alla luce di una comparazione dei comportamenti delle parti con riferimento non solo
alle obbligazioni principali, ma anche a quelle collaterali, se il rifiuto di adempiere come legittima
reazione al comportamento del datore sia logico, ragionevole, trovi giustificazione nella gravità
dell’inadempimento del datore e non contrasti con i doveri di lealtà e correttezza. Al contrario,
non è possibile invocare la norma citata nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione
non incidente sulle esigenze vitali dal lavoratore.
In secondo luogo, la Corte affronta il tema della risarcibilità del danno morale alla luce dei principi
statuiti dalle sezioni unite con la recente decisione n. 26972/08, che ha risolto in senso negativo il
contrasto in ordine all’autonomia della categoria del danno esistenziale. Com’è noto, le sentenze
della Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 2003 hanno ricondotto il risarcimento del danno al
sistema bipolare disegnato dal codice, proponendo una lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 2059, a seguito della quale l’inciso contenuto nella norma, secondo il quale il danno non
patrimoniale va risarcito “nei casi determinati dalla legge”, va inteso in senso ampio facendo
riferimento non solo all’art. 185 del codice penale, ma altresì all’art. 2 della costituzione,
configurandosi, pertanto, un danno non patrimoniale risarcibile anche nelle ipotesi in cui venga
leso un diritto inviolabile della persona. All’interno della categoria del danno non patrimoniale così
inteso, il riferimento operato negli anni alle varie figure di danno biologico, esistenziale, estetico
etc., ha valore puramente descrittivo, poichè tali figure non costituiscono autonome categorie di
danno, delle quali il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione del quantum del
risarcimento, dovendo egli al contrario fare attenzione nel valutare tali elementi per evitare
duplicazioni risarcitorie. Con riferimento al risarcimento del danno morale che, nella visione
tradizionale dell’art. 2059, era limitato ai soli casi in cui il fatto costituisse reato, la suprema corte
sostiene, alla luce della nuova interpretazione della norma, che esso va esteso ai casi in cui il
danno derivi dalla lesione di un interesse della persona costituzionalmente garantito.
Infine, la suprema corte affronta il tema, già esaminato dalle sezioni unite con la pronuncia n.
6572/06, dell’individuazione dell’onere della prova incombente sul lavoratore nel caso in cui
richieda il risarcimento del danno da demansionamento ed afferma, riprendendo quanto già
statuto in quella sede, che nelle ipotesi di dequalificazione del lavoratore il danno non
patrimoniale non deriva automaticamente dall’inadempimento del datore per cui va allegato da
chi lo richiede; in particolare, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato
all’esistenza di una lesione all’integrità psicofisica accertata medicalmente, il danno esistenziale,
che al contrario di quanto ritenuto dalle sezioni unite del 2006, come detto sopra, non costituisce
un’autonoma categoria, ma è soltanto un elemento da considerare nella quantificazione del danno
non patrimoniale, va allegato e provato, anche per presunzioni.
Per quanto concerne i caratteri della responsabilità datoriale per la violazione dell’art. 2103, la
suprema corte ricorda che si tratta di una responsabilità contrattuale, derivando
dall’inadempimento di un’obbligazione ed essa va esclusa nei casi, la cui ricorrenza va provata dal
datore, in cui manchi l’intento di svilire il lavoratore, o vi sia una ragione giustificativa connessa
all’esercizio dei poteri imprenditoriali, tutelati dall’art. 41 Cost., o dei poteri disciplinari la cui prova
spetta in tal caso al datore.
5. Corte di Cassazione, prima sezione civile, n. 402 de 12 gennaio 2009, in tema di ragionevole
durata del processo.
Il diritto ad una ragionevole durata del processo è stato introdotto dalla Convenzione Europea per
la salvaguardia dei diritti del’uomo e delle libertà fondamentali e successivamente è stato
riconosciuto, nel nostro ordinamento, dall’art. 111 della Costituzione (come modificato dalla legge
2/99) e dalla legge Pinto (n. 89 del 2001). In questa sentenza la suprema Corte esamina il
problema della quantificazione del risarcimento del danno derivante dalla irragionevole durata del
processo. Al riguardo, occorre ricordare che una delle quattro sentenze a sezioni unite emanate
dalla Corte di Cassazione nel 2005 aveva sancito, al fine di determinare il quantum risarcitorio, la
necessità di attenersi ai parametri indicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo .
La decisione in oggetto, innanzitutto, contestando quanto rilevato dal ricorrente, nega la
possibilità di predeterminare in modo rigido quale debba essere la durata ragionevole del
processo, dovendosi a tal fine, ai sensi dell’art. 2 della legge Pinto, valutare una serie di elementi,
quali il comportamento delle parti, del giudice e di tutte le autorità che intervengono nel processo
e la complessità della fattispecie; tuttavia, ricorda che alcune pronunce della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo hanno segnalato, come parametri con valenza puramente indicativa, i termini di
tre anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il processo d’appello, e di un anno per il
giudizio in cassazione. Il ricorrente, in particolare, proponeva, tra i motivi di ricorso, il fatto che la
sentenza impugnata, disattendendo quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, non
attribuiva il risarcimento per ogni anno di durata del processo, ma per ogni anno eccedente la
durata ragionevole. La Suprema Corte, da un lato, afferma che i parametri di durata ragionevole
indicati dalla Corte Europea devono essere tendenzialmente rispettati (salvo che il giudice possa
discostarsi dai criteri indicati dall’art. 2 della legge Pinto in modo ragionevole e motivato),
dall’altro sostiene, invece, che il risarcimento non va dato per ogni anno di durata del processo,
dato che tale principio, seppur sancito dalla corte europea dei diritti dell’uomo, non è vincolante
per il giudice italiano, il quale deve al contrario attenersi a quanto stabilito dall’art. 2, terzo
comma, della legge Pinto, che fa riferimento solo agli anni eccedenti la durata ragionevole.
La Corte, quindi, ribadisce i principi più volte espressi in altre pronunce in ordine ala
quantificazione del risarcimento, ricordando che il danno non è in re ipsa, ma costituisce,
comunque, una conseguenza normale della violazione dell’art. 6 della convenzione europea, salvo
che vi siano circostanze dalle quali il soggetto abbia tratto vantaggio e che possono portare ad
escludere l’esistenza di un danno. In secondo luogo, riprendendo quanto detto dalle sezioni unite
prima ricordate, ribadisce che devono essere seguiti i criteri di quantificazione indicati dalla corte
europea poiché, essendo essa l’organo deputato ad interpretare le norme della convenzione, le
sue sentenze sono vincolanti per il giudice italiano. Con riferimento a tale questione, dato che la
corte europea indica come misura minima di indennizzo 1000 euro, la corte di cassazione afferma
che qualora il giudice voglia attribuire un risarcimento minore, non può farlo sulla base della
modestia della pretesa azionata, ma deve considerare le condizioni economiche del soggetto
richiedente e l’impatto che sulla sua sfera, anche patrimoniale, il processo, ha avuto a causa della
sua durata ingiusta. Infine, la suprema corte chiarisce un’affermazione della corte europea in
merito alla possibilità, nelle cause di particolare importanza, quali sono a titolo esemplificativo le
cause di lavoro e quelle previdenziali, di attribuire al danneggiato una somma aggiuntiva rispetto
al risarcimento del danno quantificato alla luce di parametri indicati. Infatti, la corte europea non
ha detto che in questo tipo di controversie la somma aggiuntiva va data automaticamente:
pertanto, anche se la fattispecie concreta costituiva una causa di lavoro, deve essere il giudice a
valutare , alla luce di tutte le circostanze concrete, se dare o meno tale somma ulteriore.
6. Corte di Cassazione, prima sezione civile, n. 28753 del 3 dicembre 2008, in tema di contratto
con se stesso e responsabilità del notaio.
L’acquirente di due immobili conviene in giudizio il notaio rogante gli atti poiché, avendo, dopo
l’acquisto, scoperto che i beni erano stati soggetti a pignoramento, aveva dovuto pagare una
consistente cifra al fine di liberare gli immobili dalle garanzie su di essi stipulate. Il convenuto
contesta le richieste dell’attore deducendo che, in relazione al primo atto di acquisto, l’acquirente
aveva stipulato il contratto sia in qualità di acquirente sia come rappresentante del venditore ed
aveva egli stesso rilasciato delle dichiarazioni mendaci sulla libertà dell’immobile; rispetto al
secondo contratto, il notaio rileva che, successivamente ad esso, era stato esonerato dall’obbligo
di effettuare le visure catastali. A seguito del rigetto delle pretese attoree da parte del tribunale, la
corte d’appello sostiene che quanto dichiarato dall’acquirente, in veste di rappresentante sulla
libertà degli immobili, ricade sotto la responsabilità della parte rappresentata, senza che
l’acquirente sia per questo impossibilitato ad agire contro il venditore e contro il notaio, il quale
nel primo atto, non era stato esonerato da alcun obbligo. Con riferimento, invece, al secondo atto
la corte d’appello ritiene priva di valore la dichiarazione di esonero del notaio, poiché successiva al
contratto di vendita. Il notaio propone, pertanto, ricorso per cassazione sostenendo che, poiché
l’acquirente era anche venditore, era venuta meno la tutela derivante dall’obbligo, posto in capo
al notaio, di acquisire le visure catastali, prevista dalla legge al fine di garantire l’acquirente
dall’esistenza dei vincoli sul bene, tutte le volte in cui, però, tale soggetto sia diverso dal venditore.
La cassazione ritiene errata la pretesa del notaio che nega in assoluto la propria responsabilità nei
casi di contratto con se stesso, nei quali il negozio è pur sempre stipulato tra due parti e le
dichiarazioni fatte dal soggetto, in qualità di rappresentate, non gli impediscono di agire in qualità
di acquirente contro il venditore e contro il notaio.
7. Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 29032 del 12 dicembre 2008, in tema di azione
revocatoria e litisconsorzio necessario.
La suprema corte con questa pronuncia ribadisce i principi consolidati relativi alla necessità del
debitore, alienante di un immobile, di partecipare al processo tendente alla revocatoria dell’atto di
disposizione da lui compiuto, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario; infatti, poiché a
causa dell’accoglimento della domanda di revocatoria il terzo acquirente viene sottoposto ad
azione esecutiva, egli diventa creditore del debitore, ai sensi dell’art. 2902, secondo comma. Si
tratta di un litisconsorzio che, ovviamente, permane in tutti i gradi del giudizio ed, inoltre, non ha
rilevanza il fatto che una parte sia rimasta contumace. Il difetto d’integrità del contraddittorio può
essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sul punto si sia formato un giudicato
interno.
8. Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 29146 del 12 dicembre 2008, in tema di doppio
grado di giurisdizione.
A seguito della riforma con la quale il legislatore ha escluso la possibilità di proporre, avverso le
sentenze del giudice di pace, il regolamento di competenza, la sentenza in oggetto ha stabilito che
la parte che voglia contestare la pronuncia di tale organo giurisdizionale sotto il profilo della
competenza potrà, ai sensi degli artt. 339 e 360 cpc, proporre appello, nei casi in cui il valore della
causa non superi i due milioni di lire, e ricorso per cassazione, se il valore è inferiore. La ricorrente,
nel caso di specie, contesta la violazione del doppio grado di giurisdizione, poiché la causa non
rientrava nella competenza per valore del giudice di pace ed il tribunale, in sede di appello, invece
di rinviare al giudice di primo grado competente, si era pronunciato nel merito. La suprema corte
rigetta il motivo, ritenendo che il doppio grado di giurisdizione non ha copertura costituzionale e
che i casi in cui il giudice d’appello può rimettere la causa al giudice di primo grado sono
tassativamente indicati dall’art. 354 cpc. E tra questi non rientra l’erronea negazione della propria
competenze da parte del giudice di primo grado. Pertanto, in questa ipotesi il giudice d’appello
deve direttamente decidere nel merito.
L’ultimo motivo di ricorso riguardava la violazione e la falsa applicazione del d. lgs. 50/92. Nella
fattispecie concreta all’esame della suprema corte si dibatteva, infatti, dell’efficacia di un diritto di
recesso esercitato dall’acquirente di un bene che, essendo stato personalizzato a seguito delle
indicazioni fornite dall’acquirente stesso, era divenuto un bene infungibile e non più
commercializzabile. Di conseguenza, il venditore riteneva applicabile il decreto 185/99 che,
relativamente ai capi confezionati su misura, esclude la possibilità di esercitare il diritto di
recesso. Ma la Cassazione rigetta anche tale motivo, muovendo dal fatto che il diritto di recesso
era stato pattuito dalle parti mediante l’inserimento nel contratto di una clausola, con la quale
esse rinviavano, per le modalità attraverso le quali esercitare tale facoltà, al d. lgs. 50/92.
9. Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 27475 del 19 novembre 2008, in tema di impresa
familiare.
A fronte di una separazione personale, uno dei due coniugi che partecipava, in costanza di
matrimonio, alla gestione dell’impresa familiare, avendo l’altro venduto l’azienda a sua insaputa,
chiede al tribunale la declaratoria del proprio diritto di prelazione, ai sensi del quinto comma
dell’art. 230 bis c.c., ed il riscatto ai sensi dell’art. 732, richiamato dalla prima norma. Il tribunale e
la corte d’appello accolgono tali richieste. La parte soccombente propone, quindi, ricorso per
cassazione per violazione e falsa applicazione delle due norme, avendo la corte d’appello ritenuto
applicabile il riscatto anche nel caso dell’impresa familiare, quando invece l’art. 230 bis ritiene
applicabile l’art. 732 solo se compatibile, riguardando il retratto successorio. La suprema Corte
rigetta il ricorso e chiarisce un problema interpretativo insorto da tempo in ordine alla corretta
lettura dell’inciso “se compatibile”, contenuto nell’art. 230 bis in relazione all’applicabilità dell’art
732. Se secondo una prima impostazione, infatti, all’ipotesi della cessione dell’impresa familiare si
può applicare solo il diritto di prelazione, la cui violazione dà luogo al risarcimento dei danni, al
contrario, seconda un’altra tesi, si può applicare anche l’art. 732, adattandolo alle specificità
dell’impresa familiare.
La suprema corte muove, in primo luogo, dal dato letterale: l’art 230 bis rinvia all’altra norma non
per l’esercizio del diritto di prelazione, ma in relazione a tale facoltà in generale, con riferimento,
quindi, non solo alla fase in cui essa viene azionata, ma anche alla successiva fase del riscatto
presso terzi: da tale precisazione deriva che il limite della compatibilità riguarda sia il diritto di
prelazione che il riscatto. Andando, poi, a considerare la ratio della norma, la sentenza rileva che
essa si ispira a finalità di protezione di coloro che hanno prestato il loro lavoro all’interno
dell’impresa familiare, con particolare riferimento, dato il momento storico di riferimento, al
lavoro femminile: valori, questi, di rilievo costituzionale la cui tutela deve, pertanto, portare ad
un’applicazione più ampia della norma ed a considerare applicabile all’impresa familiare, pur
sempre nei limiti della compatibilità, anche l’istituto del riscatto.
La suprema corte supera, infine, le obiezioni sollevate in relazione a tale interpretazione. Si
eccepisce, infatti, che tale lettura contrasta con la certezza nella circolazione dei beni, poichè il
terzo acquirente dell’azienda, non esistendo forme pubblicitarie al riguardo, non può sapere che
essa costituiva un’impresa familiare e rimane, quindi, soggetto alla coattiva retrocessione. Inoltre,
non sarebbe possibile utilizzare l’art. 732 per l’istituto, perchè la norma ritiene esercitabile il
diritto di riscatto “finchè dura la comunione ereditaria”, termine inapplicabile all’ipotesi della
cessione dell’impresa familiare. Contro la prima critica la cassazione, alla luce di un’interpretazione
sistematica, ricorda che vi sono altri casi in cui il legislatore ha ritenuto prevalenti sulla sicurezza
nella circolazione dei beni, la tutela del lavoro e della famiglia. Si pensi alla prelazione riconosciuta,
ex art. 8 della legge 590/65, nel caso di alienazione, a favore del coltivatore diretto di un fondo
rustico in concessione sulla base delle coltivazione esercitata da due anni, senza che sia prevista
alcuna forma di pubblicità. Avverso la seconda obiezione, invece, ribatte che il termine finale per
l’esercizio del riscatto nel caso di cessione dell’impresa familiare è costituito dal momento in cui
cessano i diritti di partecipazione su di essa, coincidente con il momento di liquidazione della
quota.
10. Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 973 del 16 gennaio 2009, in tema di contratti
agrari e diritto di riscatto.
Una coltivatrice diretta di un fondo altrui e proprietaria di un fondo confinante, a seguito della
vendita da parte dei proprietari del campo in cui svolge la sua attività chiede il riscatto del fondo
venduto senza rispettare il suo diritto di prelazione, derivante dal suo essere sia coltivatrice diretta
di esso che proprietaria del fondo vicino. Il tribunale accoglie la domanda e condanna il venditore
a restituire i soldi agli acquirenti. In sede di ricorso per cassazione la parte attrice contesta la
sentenza di secondo grado che aveva ritenuto possibile per i venditori proporre appello, ritenendo
che solo gli acquirenti potevano essere considerati legittimati a resistere. La suprema corte rigetta
il ricorso, affermando che pur non essendo i venditori litisconsorti necessari nel giudizio di retratto
agrario, nel caso di specie sono parti del processo, da un lato, perché chiamati in causa dall’attrice
che ha chiesto l’accertamento del suo diritto di prelazione, e
dall’altro, perché, essendo
destinatari di un provvedimento giudiziale a loro sfavorevole, hanno interesse a proporre appello.
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, seppur l’azione di riscatto agraria può essere
esperita nei confronti del solo riscattato, tendendo ad una pronuncia di mero accertamento, nulla
vieta che si possa citare in giudizio anche il venditore al fine di far accertare con effetto di
giudicato il diritto di prelazione. Di conseguenza il venditore rimasto soccombente, a fronte della
sentenza di accertamento del diritto di riscatto, potrà sicuramente impugnarla, presupponendo
essa l’accertamento del diritto di prelazione.
La suprema corte accoglie, invece, un altro motivo di ricorso, col quale si contestava la mancata
considerazione, da parte della corte d’appello, della simulazione del prezzo e la conseguente
condanna della coltivatrice a pagare il prezzo effettivamente sborsato dagli acquirenti, sulla base
di un principio consolidato secondo il quale, nei casi di riscatto agrario, il prezzo che il retraente
deve pagare è quello indicato nel contratto di vendita.