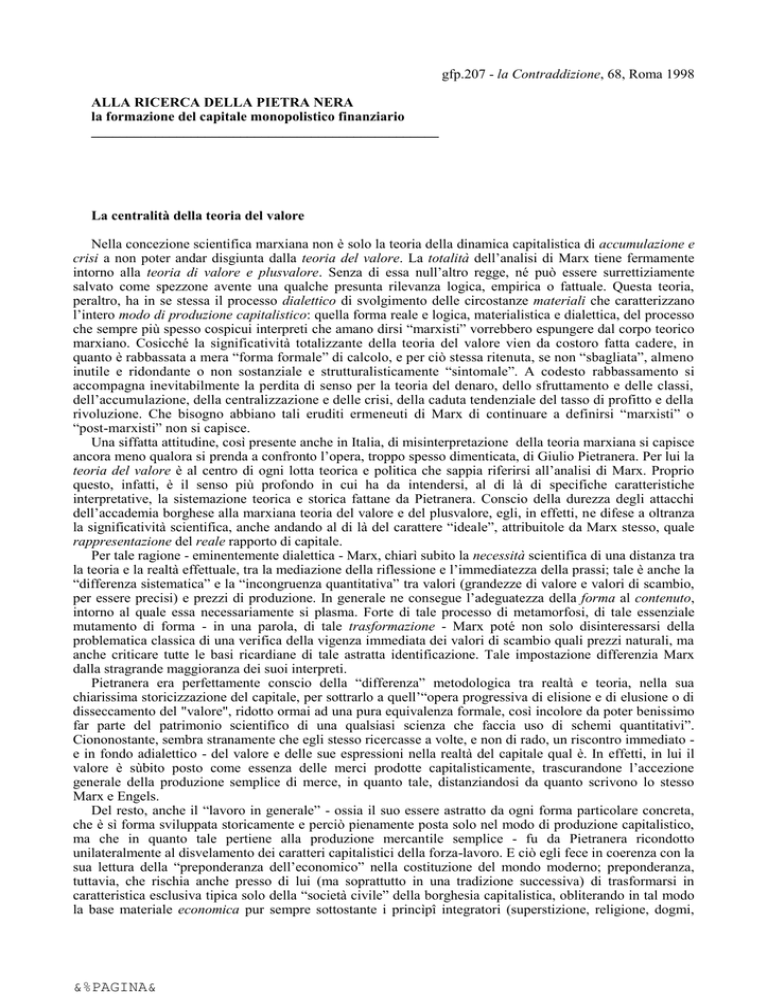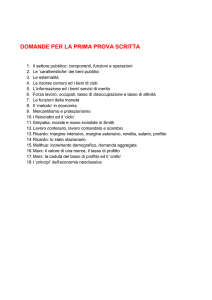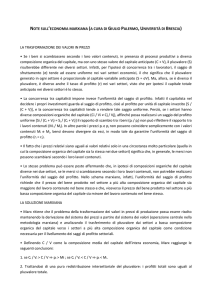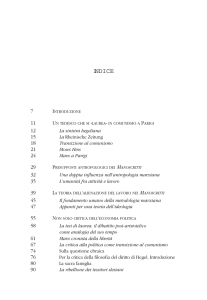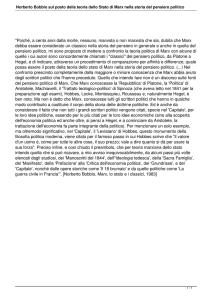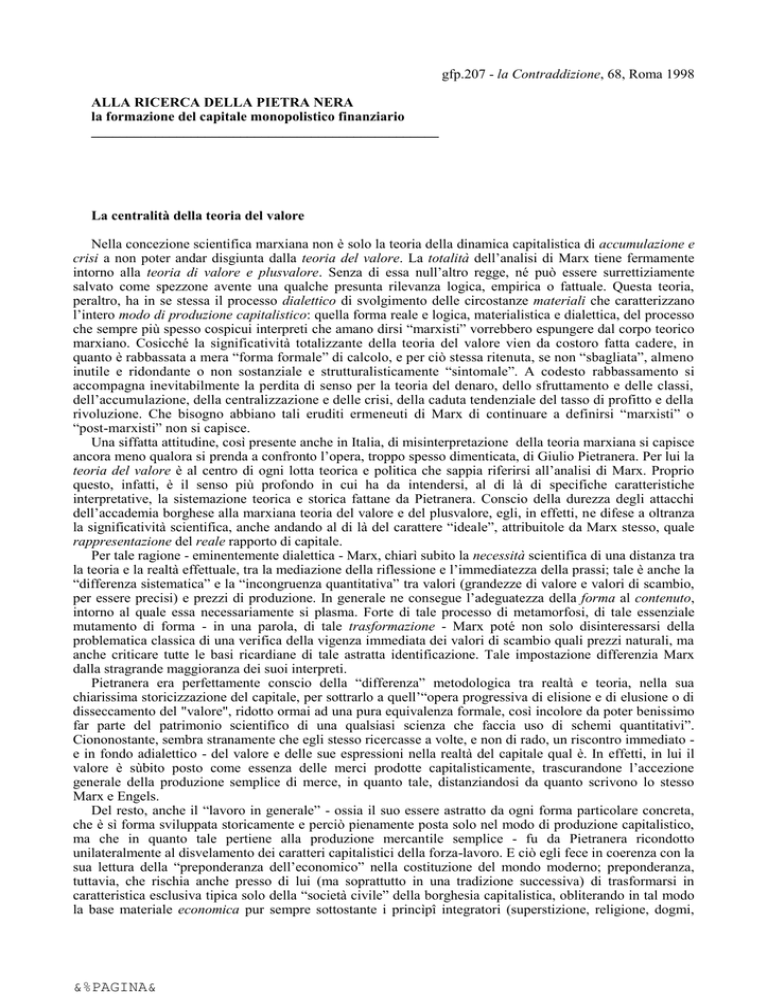
gfp.207 - la Contraddizione, 68, Roma 1998
ALLA RICERCA DELLA PIETRA NERA
la formazione del capitale monopolistico finanziario
_________________________________________________
La centralità della teoria del valore
Nella concezione scientifica marxiana non è solo la teoria della dinamica capitalistica di accumulazione e
crisi a non poter andar disgiunta dalla teoria del valore. La totalità dell’analisi di Marx tiene fermamente
intorno alla teoria di valore e plusvalore. Senza di essa null’altro regge, né può essere surrettiziamente
salvato come spezzone avente una qualche presunta rilevanza logica, empirica o fattuale. Questa teoria,
peraltro, ha in se stessa il processo dialettico di svolgimento delle circostanze materiali che caratterizzano
l’intero modo di produzione capitalistico: quella forma reale e logica, materialistica e dialettica, del processo
che sempre più spesso cospicui interpreti che amano dirsi “marxisti” vorrebbero espungere dal corpo teorico
marxiano. Cosicché la significatività totalizzante della teoria del valore vien da costoro fatta cadere, in
quanto è rabbassata a mera “forma formale” di calcolo, e per ciò stessa ritenuta, se non “sbagliata”, almeno
inutile e ridondante o non sostanziale e strutturalisticamente “sintomale”. A codesto rabbassamento si
accompagna inevitabilmente la perdita di senso per la teoria del denaro, dello sfruttamento e delle classi,
dell’accumulazione, della centralizzazione e delle crisi, della caduta tendenziale del tasso di profitto e della
rivoluzione. Che bisogno abbiano tali eruditi ermeneuti di Marx di continuare a definirsi “marxisti” o
“post-marxisti” non si capisce.
Una siffatta attitudine, così presente anche in Italia, di misinterpretazione della teoria marxiana si capisce
ancora meno qualora si prenda a confronto l’opera, troppo spesso dimenticata, di Giulio Pietranera. Per lui la
teoria del valore è al centro di ogni lotta teorica e politica che sappia riferirsi all’analisi di Marx. Proprio
questo, infatti, è il senso più profondo in cui ha da intendersi, al di là di specifiche caratteristiche
interpretative, la sistemazione teorica e storica fattane da Pietranera. Conscio della durezza degli attacchi
dell’accademia borghese alla marxiana teoria del valore e del plusvalore, egli, in effetti, ne difese a oltranza
la significatività scientifica, anche andando al di là del carattere “ideale”, attribuitole da Marx stesso, quale
rappresentazione del reale rapporto di capitale.
Per tale ragione - eminentemente dialettica - Marx, chiarì subito la necessità scientifica di una distanza tra
la teoria e la realtà effettuale, tra la mediazione della riflessione e l’immediatezza della prassi; tale è anche la
“differenza sistematica” e la “incongruenza quantitativa” tra valori (grandezze di valore e valori di scambio,
per essere precisi) e prezzi di produzione. In generale ne consegue l’adeguatezza della forma al contenuto,
intorno al quale essa necessariamente si plasma. Forte di tale processo di metamorfosi, di tale essenziale
mutamento di forma - in una parola, di tale trasformazione - Marx poté non solo disinteressarsi della
problematica classica di una verifica della vigenza immediata dei valori di scambio quali prezzi naturali, ma
anche criticare tutte le basi ricardiane di tale astratta identificazione. Tale impostazione differenzia Marx
dalla stragrande maggioranza dei suoi interpreti.
Pietranera era perfettamente conscio della “differenza” metodologica tra realtà e teoria, nella sua
chiarissima storicizzazione del capitale, per sottrarlo a quell’“opera progressiva di elisione e di elusione o di
disseccamento del "valore", ridotto ormai ad una pura equivalenza formale, così incolore da poter benissimo
far parte del patrimonio scientifico di una qualsiasi scienza che faccia uso di schemi quantitativi”.
Ciononostante, sembra stranamente che egli stesso ricercasse a volte, e non di rado, un riscontro immediato e in fondo adialettico - del valore e delle sue espressioni nella realtà del capitale qual è. In effetti, in lui il
valore è sùbito posto come essenza delle merci prodotte capitalisticamente, trascurandone l’accezione
generale della produzione semplice di merce, in quanto tale, distanziandosi da quanto scrivono lo stesso
Marx e Engels.
Del resto, anche il “lavoro in generale” - ossia il suo essere astratto da ogni forma particolare concreta,
che è sì forma sviluppata storicamente e perciò pienamente posta solo nel modo di produzione capitalistico,
ma che in quanto tale pertiene alla produzione mercantile semplice - fu da Pietranera ricondotto
unilateralmente al disvelamento dei caratteri capitalistici della forza-lavoro. E ciò egli fece in coerenza con la
sua lettura della “preponderanza dell’economico” nella costituzione del mondo moderno; preponderanza,
tuttavia, che rischia anche presso di lui (ma soprattutto in una tradizione successiva) di trasformarsi in
caratteristica esclusiva tipica solo della “società civile” della borghesia capitalistica, obliterando in tal modo
la base materiale economica pur sempre sottostante i princìpî integratori (superstizione, religione, dogmi,
&%PAGINA&
politica, autoritarismo, ecc.) dei modi di produzione precapitalistici. Per tutto ciò è ovvio che ne discenda sia per gli aspetti corretti della determinazione storica dell’astrazione, ma sia anche per l’insufficiente
considerazione dei suoi sviluppi dialettici - quel sovraccarico di determinazioni immediate che egli
(malamente capìto poi, senza sua colpa, dai suoi rari ma improvvidi seguaci) richiese alla categoria
dell’economico, di “valore” e di lavoro umano in astratto.
In effetti Pietranera, per corroborare la “realtà” del valore ricorse all’“astuzia” del profitto zero (o
tendente a tale limite) nel corso delle crisi; e ciò perché, in tali circostanze, non solo la ripartizione del
plusvalore, ma il plusvalore stesso e la diversa composizione organica del capitale neppure più si pongono.
Ma è curioso che Pietranera non accetti come ciò non serva all’analisi marxiana, al concetto di valore che, in
quanto categoria reale storicamente determinata, non abbisogna di trovare comunque un riscontro empirico e
fattuale. Insomma, in Marx è la determinatezza storica stessa che conduce alla categoria teoricamente
corretta, al concetto adeguato alla forma storica. Ma se Pietranera, nella contingenza della temperie culturale
italiana, non seppe svincolarsi del tutto da simili pastoie, tuttavia non perse mai l’orientamento scientifico
necessario, a differenza di tanti “marxisti” italiani, e non solo. Sicché la sua indicazione di ricerca, vòlta a
rendere coerenti le astrazioni “troppo elevate” delle leggi di tendenza con la realtà erratica delle fasi cicliche
di accumulazione e crisi del capitale, risulta quanto mai fruttuosa, se svincolata dall’immediata indicazione
di vigenza dei valori nella stasi dello sviluppo quantitativo e dei prezzi di produzione nel rivoluzionamento
dello sviluppo qualitativo. Epperò Pietranera, al contrario del revisionismo socialdemocratico, procedendo in
una coerente collocazione della teoria marxiana del valore, ha saputo riconnettervi coerentemente pure la
teoria della moneta, e indicarne i necessari sviluppi fino a farne la chiave esplicativa anche del
raggiungimento delle forme superiori del capitale: il carattere monopolistico finanziario dell’imperialismo.
Le nuove fasi e determinazioni storiche del capitale
Fu attraverso la magistrale Introduzione del 1960-61 al Capitale finanziario di Rudolf Hilferding che Pietranera compì tale operazione interpretativa, cogliendo, con grande precisione, pregi e limiti dell’esposizione
hilferdingiana. Tali limiti sono stati da lui sùbito ravvisati proprio nella pretesa critica alla teoria del valore
marxiana. Quella critica, sotto l’influenza marginalistica, imperversava all’epoca presso la seconda
internazionale per opera di Eduard Bernstein e dello stesso Hilferding. Si trattava di una supponente critica,
imperniata appunto su un soggettivismo metodologico condito con un convenzionalismo etico, incapace
come tale ad afferrare l’oggettività scientifica della critica marxiana. Fu proprio il fascino indiscreto del
presunto superamento della marxiana teoria del valore a spingere Hilferding, come tanti altri “postmoderni”
dopo di lui, verso la deriva di una teoria della circolazione monetaria affatto estranea a una concezione del
denaro-merce. Precisamente codesta carenza teorica è ciò che ha condotto Hilferding a sostenere ante
litteram la tesi del cosiddetto “finanziamento iniziale”, da parte del sistema monetario e creditizio, quale
fonte e pretesa causa dell’accumulazione di capitale, anziché conseguenza ed effetto di quest’ultimo
processo. Di qui, come si vedrà, discende la fondamentale e sostanziale incomprensione hilferdingiana
denunciata da Pietranera: ossia, la mancata connessione causale e gerarchica tra la forma monopolistica del
capitale, quale fondamento dell’intero processo nella sua fase superiore, e la conseguentemente necessaria
sua forma finanziaria.
Non è neppure un caso, allora, che vi sia stata proprio da parte borghese l’assunzione della monca
definizione hilferdingiana di “capitale finanziario”, assolutamente limitata ai suoi aspetti monetari e creditizi,
bancari o al più borsistici (come ancor oggi è dato leggere sulle pagine, appunto dette “finanziarie”, della
stampa quotidiana). Laddove - seguendo invece la lezione di Lenin, Bukharin, Grossmann, e altri marxisti
rigorosi - Pietranera ha correttamente compreso nella categoria di capitale finanziario la simbiosi, la fusione,
tra capitale monetario e capitale industriale operante. Nella giusta lettura fornita da Pietranera, Marx riappare
ancora una volta molto più attuale di Hilferding. Il pretesto, còlto da Pietranera in occasione della famosa
introduzione del 1960-61 per analizzare le “nuove fasi” del capitale, gli è servito per individuare alcuni temi
giusti connessi alla determinazione imperialistica del capitale: credito, società per azioni, cartelli, utile di
fondazione, fino alle conseguenze politiche.
L’esatta considerazione del contesto di fine secolo XIX, con la prolungata prima crisi di portata mondiale
del capitalismo classico inglese sfociata nella centralizzazione monopolistica e nell’avvio della fase
superiore dell’imperialismo, permise a John A. Hobson, da buon liberale inglese, di avvedersene prima e
con maggior pregnanza dei “marxisti” della socialdemocrazia tedesca. Mancava a lui, non meno che ai
socialdemocratici revisionisti, la forza teorica di ammettere consapevolmente il carattere immanentemente
contraddittorio del modo di produzione capitalistico. Fu da lì che derivarono tutti i differenti escamotages
per tentare vanamente di sanare gli “errori” di un sistema per ogni altro verso ritenuto “sano e buono”:
panacee utopiche e sentenziose (per non dire dei bassi trucchi) che, da Proudhon a Dühring, sono proseguite
fino a Webb e Keynes, e ancora oltre. Non fu certo per un gioco di dispute accademiche che nel campo delle
la Contraddizione no. 68
&%pag
teorie economiche si ebbe, allora, dopo il 1870, la reazione e l’elusione marginalistica. Da tale fascinazione
rimasero incantati i “marxisti” della seconda internazionale e tutta la genìa dei socialisti borghesi, più o meno
liberal-laburisti. Tutti costoro si dimostrarono fin da allora sùbito incapaci di comprendere i nuovi caratteri
del capitale.
Nell’incapacità di discernere tra le forme di esistenza e il perdurante fondamento del modo di produzione
capitalistico si inscrive anche tutta l’insufficienza metodologica di Hilferding stesso. Oggi, al termine del
XX secolo, si è nella fase finale - “finale” quale che ne sia la fine - di una crisi mondiale altrettanto
prolungata e profonda di quella di un secolo fa, da essere definita “epocale”. Si tratta infatti di un’epoca di
trasformazione della fase imperialistica del capitale. È la fase transnazionale, con l’unificazione planetaria
del mercato mondiale potenziale, con il declino dell’egemonia assoluta degli Usa (come allora lo fu per la
Gran Bretagna), in concomitanza con la seconda (e ultima, in un certo senso) grande rivoluzione industriale,
quella dell’automazione del controllo. La comprensione di un tal passaggio di fase non può che prendere le
mosse dalla centralità della produzione, così come si può leggere nella riflessione di Pietranera sulla lezione
marxiana. Non è inutile, perciò, rammentare come Marx indicasse nella tendenza alla concentrazione
monopolistica, nella socializzazione del processo lavorativo e nella creazione del mercato mondiale, “le tre
caratteristiche fondamentali della produzione capitalistica”; indicando altresì nella “formazione necessaria
del credito” (economizzazione dei costi della circolazione monetaria, carta moneta, ecc.) e nella “formazione
delle società per azioni” (fondazione di società, emissione di azioni, sistema di frodi e di imbrogli, ecc.),
oltreché nelle fabbriche cooperative, “gli elementi di disfacimento del vecchio sistema di produzione [e] la
forma di transizione verso un nuovo sistema di produzione” [Marx, Il Capitale, III.27].
Tutte questi elementi Marx li ascrive alla funzione del credito, in quanto fondato e sviluppato sui caratteri
del processo di produzione stesso, sì che esso a sua volta appaaia poi come la “leva principale” per affrettare
le contraddizioni del capitale e le sue eruzioni violente. Pietranera dunque, a differenza di Hilferding e di
tanti altri frettolosi economisti illuminati, ha compreso appieno i caratteri del sistema monetario e creditizio
del sistema capitalistico, soprattutto nella sua forma monopolistica, tanto, per così dire, nella loro filogenesi,
quanto nella loro ontogenesi. E dunque, ancora una volta, ritorna attuale la sua critica verso quei sedicenti
“intellettuali marxisti”, incapaci di comprendere i nuovi caratteri del capitale, dei quali Pietranera poteva a
ragione additare criticamente lo sfoggio della loro erudizione senza contatto con la realtà.
Pietranera cominciò la propria riflessione sulle nuove determinazioni teoriche e storiche del capitale
risalendo alle radici del processo di concentrazione e centralizzazione. Marx definì le società per azioni la
prima contraddizione - una “negazione negativa” - del capitale entro il modo di produzione capitalistico
stesso. È da lì che occorreva ripartire per comprendere appieno la nuova fase del capitale finanziario. Ben al
di qua dei triti e recentemente rimasticati luoghi comuni, è lì che occorre rintracciare l’origine della scissione
tra proprietà e direzione, epperò proprio nel senso marxiano della comprensione di interesse profitto e
guadagno d’imprenditore come parti del plusvalore (peraltro insieme alla rendita, alle imposte, ecc.).
Lungi dal rappresentare la decadenza pratica e teorica dei rapporti di proprietà capitalistici, la
separazione tra proprietà monetaria e gestione produttiva è precisamente il processo che ne accompagna la
centralizzazione. Essa ne definisce le moderne “tecniche di controllo”, ben illustrate da Hilferding stesso, le
quali, non negando affatto la proprietà, anzi la definiscono meglio nelle sue nuove forme. Già
nell’immediato ultimo dopoguerra, come si può leggere in un esempio riportato nell’introduzione di
Pietranera, la General Motors controllava autorimesse, posti di rifornimento e distributori di benzina gestiti
da cosiddetti “piccoli uomini d’affari indipendenti”. Ecco: questo della presunta “indipendenza” del piccolo
capitale e del lavoro formalmente autonomo, in generale, è un punto di grande attualità, totalmente frainteso
ancor oggi.
In effetti, è proprio nella forma della società per azioni che si afferma il “controllo virtuale” di minoranza.
Dunque, neppure quella prima forma di controllo elimina la “proprietà”, come alcuni ancor oggi, sulla scia
della sociologia strutturalistica parsonsiana, vorrebbero far credere; magari ipotizzando un’improbabile “tecnocrazia” del “capitale lavorativo”, concettualizzazione che, seppur assente esplicitamente in Hilferding, vi è
pericolosamente adombrata, come fece notare Pietranera. Non solo non l’elimina, dunque, bensì la rafforza
proprio nella sua forma monopolistica. Già all’inizio del secolo XX cominciava perciò a stabilirsi il
cosiddetto “controllo a catena”. Tale forma di controllo, messo in atto dalle “società a catena”, è concepito
come definitorio della gerarchia del dominio: capitale monopolistico finanziario - grande capitale - piccolo
capitale - azionisti. Scrive Pietranera che, “con il sistema delle "società a catena", il capitalista viene, per così
dire, fagocitato da un’impresa all’altra e pertanto "forzato" sia nella sua destinazione che nella concreta
utilizzazione del suo capitale”. La cosiddetta holding finanziaria detiene il controllo totale delle operazioni
condizionando, in diverso grado secondo il livello di integrazione verticale del sistema di produzione e
circolazione del plusvalore, tutto il capitale da essa “tenuto”. Finanche il “grande” capitale operante che fa
capo alla holding rimane in posizione subalterna e delegata rispetto a essa, e tutt’al più può partecipare alla
definizione di decisioni parziali e settoriali, via via sempre meno strategiche. È ovvio, allora, come la media
&%PAGINA&
e piccola impresa, e a maggior ragione il lavoro semi-artigianale cosiddetto autonomo, in quanto integrati
nella catena siano totalmente deprivati della loro supposta indipendenza decisionale strategica.
Dalla “catena” di allora è facile desumere quelle condizioni storicamente determinate del capitale che
ne consentono la generalizzazione di oggi, nelle cosiddette “filiere” produttive. Tali “filiere” configurano
la struttura di produzione e circolazione del plusvalore, entrambe controllate dal grande capitale
monopolistico finanziario transnazionale. Con questa forma universale il capitale si è pressoché
compiutamente adeguato al suo concetto, sul mercato mondiale unificato. La centralizzazione decisionale
presso il grande capitale monopolistico finanziario, dunque, si rappresenta in una direzione “autocratica”,
come ben sottolineava Pietranera. Essa, esprimendosi nelle società a catena, si avvale della banca mista di
modello tedesco, oggi detta “banca universale”. Si noti come una tale tipologia della banca moderna venga
sempre alla ribalta nelle fasi in cui si auspica (o si vorrebbe prospettare) una fuoriuscita dalla crisi. Il motivo
è chiaro: quando la sovraproduzione di capitale soffoca le prospettive di produzione e accumulazione del
plusvalore, non c’è motivo di estendere le ricche funzioni bancarie al di là della fase speculativa (ossia,
come la chiamava Grossmann, l’“esportazione di capitale all’interno”). Ma allorché l’impellenza dei finanziamenti per l’investimento si fa sentire, le funzioni di credito mobiliare e, più in generale,
l’integrazione finanziaria dell’attività monetaria con quella produttiva tornano in primo piano. Chi oggi
ripete frasi fatte sulla “finanziarizzazione” dell’economia (magari in connessione con l’altro luogo comune
della così detta e non meglio definita “mondializzazione”) probabilmente non sa neppure di che cosa stia
parlando. La forma finanziaria del capitale, infatti, come si è rammentato, nasce con la tendenza alla
centralizzazione monopolistica e caratterizza l’imperialismo.
La contraddittorietà della circolazione monetaria
Dal necessario svilupparsi della teoria marxiana del valore nella teoria del denaro discende, per contrasto,
la critica del primato della circolazione monetaria, della quale, insieme alla funzione del credito, Hilferding
non vide la contraddittorietà. E una tale incomprensione tanto più appare stupefacente quanto più si osservi
che, ciononostante, ricca e accurata risulta la descrizione storica e formale degli squilibri della circolazione
stessa. Ma è proprio qui che Pietranera seppe ben individuare l’origine di quell’errore, nella connessione
mancante tra il capitale finanziario e il suo necessario presupposto: il capitale monopolistico. Senza il
primato di valore e produzione, nella loro forma capitalistica, tale errore non potrebbe essere neppure
ravvisabile.
La prevalenza della forma finanziaria del capitale, dunque con un ruolo affatto nuovo della banca integrata all’industria, non è complicata da capire, ma richiede una grande precisione nel definire il contesto
generale, la totalità, in cui opera il capitale imperialistico. Altrimenti si rischia di restare fermi alla
concezione della banca, non solo nella sua tipologia dell’epoca del capitalismo concorrenziale, ma addirittura
a quella della forma mercantile semplice: l’anticipar moneta o cambiali per agevolare la circolazione delle
merci. È da lì, dalla mera crematistica confinante con l’usura, strettamente apparentata con la rendita
fondiaria signorile, che provengono tutte le dabbenaggini sulla presunta separazione e contrapposizione tra
profitto e rendita (o interesse), tra produttori “buoni” e speculatori “cattivi”, così cara ai ricardiani come ai
proudhoniani, ai fabiani come ai keynesiani. Ben altrimenti vanno le cose nell’epoca del capitale, e ancor più
nelle sue successive fasi imperialistiche. L’attività bancaria specificamente capitalistica trasforma
l’interesse, così come la proprietà fondiaria capitalistica sopprime e conserva la rendita fondiaria nella forma
monetaria del plusvalore: insomma, anche queste forme sono ricondotte alle parti in cui, insieme al profitto
industriale, commerciale, ecc, si scompone il plusvalore. Il richiamo marxista di Pietranera alla centralità
della produzione di valore e plusvalore è ancora una volta essenziale per comprendere l’intero processo.
La banca moderna del capitale, quale che sia la sua forma organizzativa, pura o mista, secondo la fase del
ciclo di accumulazione e crisi, ha come còmpito di far circolare il plusvalore nella forma di denaro, per
ritrasformarlo in neo-capitale. Dunque, ha il còmpito di favorire le condizioni per la trasformazione del
denaro in capitale, rastrellando tutta la ricchezza esistente in forma monetaria dispersa nel mercato
(mondiale), per concentrarla. È da qui, come andava scrivendo Pietranera, che discende quella tipologia di
gestione del capitale monetario che si incentra intorno a varie forme di “risparmio coatto”. Anzi, coerentemente con la teoria marxiana del valore, osservava che più che di risparmio sarebbe meglio parlare di “non
consumo”. In effetti, tutta l’economia borghese, culminando con quella keynesiana, nasconde dietro codesta
falsa categoria del “risparmio” il denaro come reddito non consumato, ignorando così il denaro come
capitale. “Denaro come denaro e denaro come capitale si distinguono in un primo momento soltanto
attraverso la loro differente forma di circolazione [...] Quel che importa è in primo luogo di caratterizzare le
distinzioni di forma fra i cicli D-M-D [comprare per vendere] e M-D-M [vendere per comprare]: così si avrà
anche la distinzione di contenuto che sta in agguato dietro quelle distinzioni di forma" [Marx, Il capitale,
I.IV,1]. Il “formalismo” superficiale dell’economia (e della scienza) borghese, per la quale la forma è
la Contraddizione no. 68
&%pag
indifferente al contenuto, cade facilmente in quell’agguato. Viceversa, lo studio del capitale finanziario
mostra chiaramente come attraverso il credito, l’inflazione intenzionale (di cui l’inflazione programmata è
l’ultima apparizione) e il fisco, il cosiddetto risparmio - ossia, la parte ulteriormente espropriata di plusvalore
trasformato in reddito, quando non sia direttamente profitto accantonato per autofinanziamento - sia
forzosamente ricondotto al capitale.
Il capitale finanziario, la mitica “finanziarizzazione” dell’economia, è precisamente la forma che integra
banca, borsa, stato e qual altra istituzione serva, nell’”industria” in senso lato, come fonte del proprio
autofinanziamento in quanto classe mondiale. Si spiega così anche perché quel piccolo o anche mediogrande capitale, che non sia integrato verticalmente nella “catena” o “filiera” produttiva transnazionale, e che
pertanto debba ricorrere al tradizionale finanziamento esterno da parte delle banche (non per caso controllate
dalle holdings transnazionali) sia tagliato fuori da tale “finanziarizzazione” e resti assolutamente subalterno e
dipendente. Le holdings finanziarie, i fondi di investimento gestiti dai cosiddetti “investitori
istituzionalizzati”, e quant’altro (si pensi alle grandi manovre internazionali, promosse dal Fmi, intorno alla
costituzione dei cosiddetti “fondi pensione”), diventano pertanto i protagonisti. Tale sistema finanziario
opera in simbiosi con le banche commerciali, soprattutto nella forma “mista”, per la collocazione delle azioni
industriali o, quando l’accumulazione ristagna, per la creazione e circolazione del capitale fittizio (i
cosiddetti “derivati” che recentemente tanto fanno parlare di sé).
Cartelli, trusts, holdings, ecc., sono pertanto le forme giuridiche istituzionali della proprietà capitalistica
adeguate alla fase, non forme separate, bensì espressione proprio del monopolio industriale di base che le
sostiene (ha fatto bene Pietranera a ricordare esplicitamente, a tale proposito, il contributo di Henryk
Grossmann, un altro marxista dimenticato). Non si tratta, dunque, del dominio della banca sull’industria,
nella forma che fu ipotizzata da Hilferding, ma, come si è detto, della forma nuova del capitale imperialistico
nato dalla fusione delle forme di funzione del capitale industriale in generale, di cui già parlava Marx: il
capitale monetario, il capitale produttivo e il capitale merce - empiricamente nelle sue forme di esistenza di
banca, industria e commercio. Non per caso Pietranera ha osservato come con la crisi del 1929 - crisi dalle
molte forme apparenti di “panico” monetario - fu l’industria a dare la scalata alle banche, passando sempre
più decisamente alla prerogativa monopolistica dell’autofinanziamento. E, da lì, si passò prima all’apporto
dello stato nella circolazione del capitale-denaro, e poi al già accennato sviluppo degli “investitori
istituzionali”, attività “pubbliche” e private nelle quali la banca e la borsa sono sempre più organicamente
integrate. Dunque, la riflessione critica di Pietranera ha indicato come non sia il ruolo della banca, che
interviene nel credito mobiliare industriale, l’elemento in cui vada ricercata l’origine del processo moderno
di accumulazione e crisi, bensì il nesso tra concentrazione e centralizzazione, che già Marx individuò come
elemento portante della trasformazione della concorrenza in monopolio. Engels e Marx hanno insegnato che
non si tratta di un capitalismo monopolistico che cancelli la concorrenza tra capitali, il loro procedere
anarchico nel mercato mondiale, e le loro crisi, ma di una determinazione storicamente sviluppata che ne
definisce le forme di lotta nell’epoca dell’imperialismo. “Lotta tra fratelli nemici”, la chiamava Marx, non
solo e non tanto perciò tra banca e industria, ma tra banche e banche, industrie e industrie, a seconda della
“cordata” nella catena o filiera di appartenenza: senza esclusione di colpi.
Le crisi e la storicità del rapporto di capitale
Ora, la forma monopolistica del capitale (tanto più nella sua articolazione finanziaria) allontana e
contrasta la formazione di un tasso generale del profitto. Ciò può esser vero, come ebbe attentamente a
riflettervi Pietranera, nel senso della non riscontrabilità dell’esistenza empirica di un solo tasso uniforme di
profitto, concorrenzialmente effettuale. Questa è, invero, l’ultima controtendenza indicata da Marx per
frenarne la caduta, attraverso la sottrazione dalla massa del plusvalore soltanto di un interesse minimo per i
semplici “tagliacedole” non operanti. “Una parte del capitale viene calcolata e impiegata unicamente come
capitale produttivo di interessi: non però nel senso che ogni capitalista il quale presti del capitale si
accontenta degli interessi, mentre il capitalista industriale intasca il guadagno di imprenditore. Questo non ha
nulla a che vedere col livello del saggio generale del profitto, poiché per esso il profitto corrisponde
all’interesse + profitto di qualsiasi natura + rendita fondiaria, indipendentemente dalla ripartizione fra queste
diverse categorie; ma nel senso che questi capitali [...] rendono semplicemente degli interessi più o meno
considerevoli, i cosiddetti dividendi. Questi capitali non entrano nel livellamento del saggio generale del
profitto [...]. Da un punto di vista teorico si potrebbe tenerne conto e si otterrebbe allora un saggio di profitto
minore di quello che esiste in apparenza “ [Marx, Il Capitale, III.14,vi].
Tuttavia, se si riferisce la “generalità” di quel tasso al livello che esso raggiunge per l’intera classe
proprietaria (considerando perciò anche proprio quelle detrazioni, che affluiscono a mero titolo di proprietà,
per la rendita fondiaria assoluta e per l’interesse, in misura ridotta, degli azionisti), la forma monopolistica
dell’epoca presente può bensì attenuare, per i soli capitalisti operanti nell’industria, ma non annullare la
&%PAGINA&
tendenza storica stessa alla caduta del tasso generale di profitto. Sullo sfondo di essa, Pietranera ha inquadrato la ricorrenza delle crisi cicliche. Ed è proprio il loro carattere inerente alla struttura stessa del modo
di produzione capitalistico che, cumulando la ciclicità della caduta del tasso di profitto, ne delinea la sua
tendenza storica.
Non è perciò un caso che Hilferding, quale esponente del socialismo borghese, preconizzasse il possibile
assestamento anticiclico delle crisi mediante l’intervento statale. Prima di lui, in assenza di un’ipotesi del
ruolo economico dello stato, di fronte alla realtà ineluttabile delle crisi, regnava l’horror del ristagno. Dopo
di lui, con lord Keynes e il dr. Schacht in testa, di fronte all’incontestabilità evidentissima di crisi dilanianti,
la presunzione della panacea prescritta sulla base della spesa dello stato borghese ha fatto epoca. E, in nome
di una siffatta “regolazione”, si è voluto facilmente confondere, e far confondere, lo stato del capitale con un
supponente “stato sociale”, e ogni intervento “pubblico”, che il capitale finanziario delegava al suo stato,
come un pezzo di “socialismo”. Così, da Hilferding, nacque il miraggio del “socialismo finanziario”.
Il riformismo revisionista della seconda internazionale - nonostante le critiche di Grossmann, Lenin, e
altri marxisti - seguì a lungo la via del “superimperialismo” o “ultraimperialismo”, che dir si voglia,
indicandola come tappa necessaria per il passaggio al socialismo: appunto, sulla base della centralizzazione
finanziaria in una banca mondiale. Oggi sappiamo bene che razza di bestia sia la sola Banca mondiale
realmente esistente, l’unica concettualmente e praticamente possibile in una società in cui domini il modo di
produzione capitalistico. Ma si rifletta anche quanto poco distino i vagheggiamenti “socialfinanziari” di
Hilferding dal preteso “socialismo” proudhoniano o da tutte le altre “invenzioni” monetarie della serie da
Fourier a Gesell, vate di Keynes. Se simili vaghe panacee restassero effimeramente inscritte nella loro
scioccheria, neppure meriterebbe ricordarle. Senonché ancor oggi è dato sentire teorici sedicenti “comunisti”,
ai quali Pietranera evidentemente nulla ha insegnato: costoro, in nome di una presunta definitiva saturazione
e cessata concorrenzialità del mercato capitalistico, ne sognano una qualche variamente differenziata
fuoriuscita in un sistema o sub-sistema “non mercantile”, insieme con l’”eutanasia del rentier” a interesse
zero, in un improbabile e onirico sottomondo di valori d’uso sottratti allo scambio e al dominio del denaro,
retrocedendo fino all’ipotesi, agognata da maestro Proudhon, di un cosmico “regime mutualistico” (altro non
è, se non questo, il recente mito del cosiddetto “terzo settore”, tra capitale e stato).
Con ciò i riformisti posteri di Hilferding e consorti, nostri moderni post-keynesiani-di-sinistra, trovano la
loro giusta collocazione, quali tardi epigoni del proudhonismo della più bell’acqua. Ma è lo stato, per quanto
borghese esso sia, che in prospettiva rimane il demiurgo della trasformazione sociale nel cuore dei riformisti
per i quali, come ha scritto Pietranera nell’introduzione a Hilferding, sarebbe “possibile una società
capitalistica "controllata" che mantenesse la prosperità mediante l’intervento statale rivolto a dar vita ad un
ordinamento socialista”. Del resto è à la Lassalle che risorge “la panacea del profeta. [...] In luogo della
esistente lotta di classi, subentra una formula da giornalista: “la questione sociale” [...] l’"organizzazione
socialista di tutto il lavoro sorge dall’aiuto dello stato". [...] Credere che si possa costruire una società nuova
per mezzo di sovvenzioni dello stato come si costruisce una nuova ferrovia, è degna presunzione di Lassalle”
[Marx, Critica del programma di Gotha, III].
Pietranera sfugge a tutte codeste cialtronate, fermo nella concezione del rapporto di capitale fondato sul
valore. Certo, come accennato in precedenza, un’insufficienza di sviluppo dialettico della teoria in rapporto
alla storia, da un lato, insieme a una preoccupante vanificazione dell’apporto della logica formale (e della
matematica necessaria alla bisogna), dall’altro, sono forse i limiti più gravi della costruzione pietraneriana
(probabilmente in larga parte attribuibili all’ascendenza dellavolpiana). Simili limiti, del resto, sono
riscontrabili nella stragrande maggioranza dell’esegesi marxista, non solo ma soprattutto italiana (senza
tuttavia che occorra decadere fino allo storicismo crociano, così gravemente incidente sulla deriva del
marxismo italico, al quale anche Pietranera si riferì ma riuscì a sottrarsi).
Ma poco importa qui discutere e criticare alcune incongruenze e le diverse incertezze teoriche del nostro
autore. Chi procede nelle ricerca scientifica della verità, che non è la ricerca della pietra nera filosofale, è
destinato anche a sbagliare – “sto faticando: preparo il mio prossimo errore”, dice il brechtiano signor
Keuner delle Storie da calendario, definendo ciò “la pena dei migliori”. Pietranera riuscì a percepire, infatti,
anche incorrendo in quelle incertezze interpretative cui si è fatto cenno, il significato profondo della
dinamica della storia nella costruzione dell’analisi di Marx. E tale percezione è stata proprio quella che è
mancata a tanti suoi “amici” critici, quelli che poi lo hanno scandalosamente ignorato. In Pietranera,
viceversa, le contraddizioni della realtà capitalistica sono pesantemente e significativamente presenti: si
pensi al giustissimo tentativo di connettere valore, prezzi, crisi, ecc., avendo sempre chiaro il nesso generale
tra le categorie, anche le più astratte, nell’”epoca dell’imperialismo”, come motivo conduttore del presente
storico. Purtuttavia, si è detto come codesta imprescindibile immanenza della storia non sia riuscita, in
Pietranera, a porre il compiuto sviluppo dialettico di quelle categorie teoriche.
Senonché, per apprezzarne la superiorità metodologica, serve osservare come, nella maggior parte dei
critici scolastici, quelle e altre contraddizioni neppure appaiano, talché la dialettica delle cose e dei concetti
non ci sia affatto, e l’intero sistema marxiano rimanga morto. Recuperare il corretto sviluppo intrinseco delle
la Contraddizione no. 68
&%pag
categorie teoriche - a partire dalla loro determinazione storica, senza ridurle però a una piatta verifica di
circostanze particolari se non addirittura eccezionali (come è invece, a es., per l’incongrua visitazione di
Pietranera dei “casi” idealtipici di capitalismo) - rappresenta il più valido insegnamento e la giusta
indicazione che Pietranera ci ha consegnato per conservare, fuori da dogmi, la piena validità e vitalità del
marxismo. Qui insomma interessa solo riprenderne gli insegnamenti ingiustamente dimenticati, magari
insieme a quelli di altri marxisti - per restare in Italia - come Pietro Grifone e Raniero Panzieri.
* Una presentazione più vasta dell’opera di Pietranera è contenuta nel volume Il capitalismo
monopolistico finanziario: determinazioni teoriche e storiche (scritti scelti 1947-61), La Città del Sole,
Napoli 1998, che raccoglie alcuni dei suoi più importanti saggi (La teoria del valore-lavoro nell’economia
capitalistica; La teoria del valore-lavoro e alcune sue interpretazioni ricardiane e marxiste; Il secondo libro
del Capitale e l’economia borghese; Marx e la storia delle dottrine economiche; La struttura logica del
Capitale; Il pensiero economico di Hilferding).
&%PAGINA&