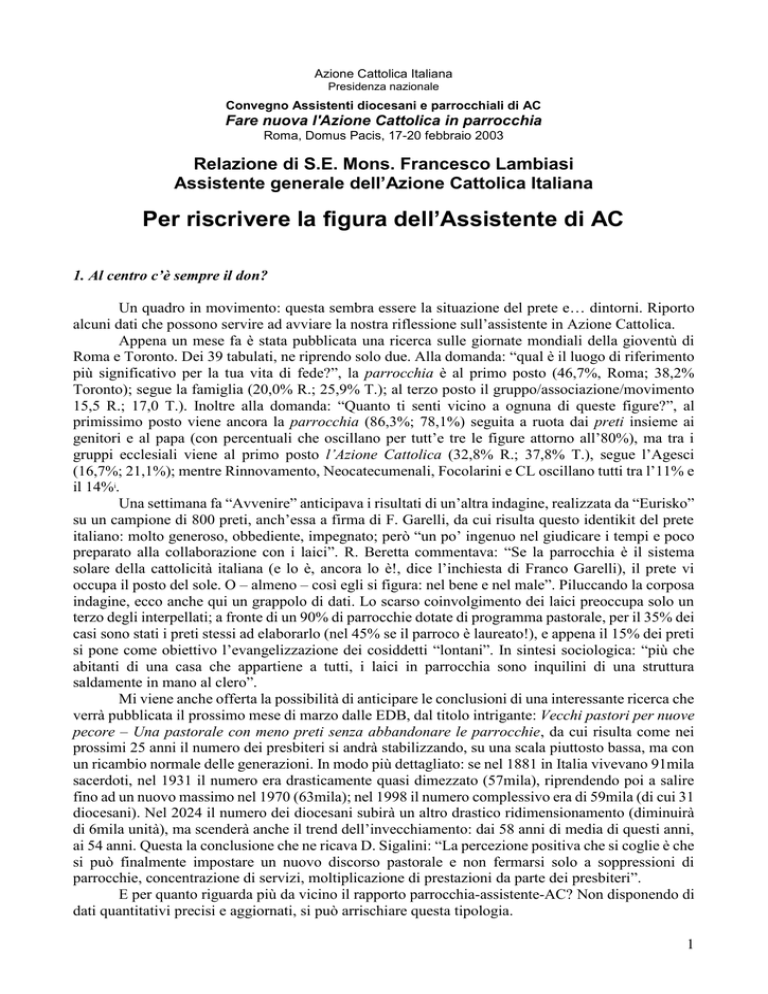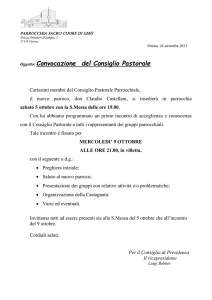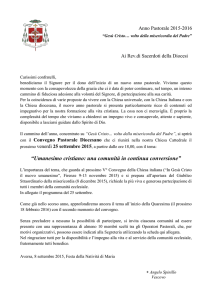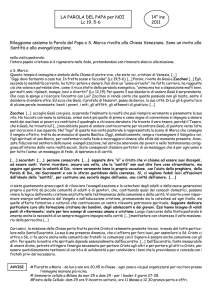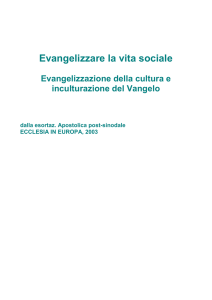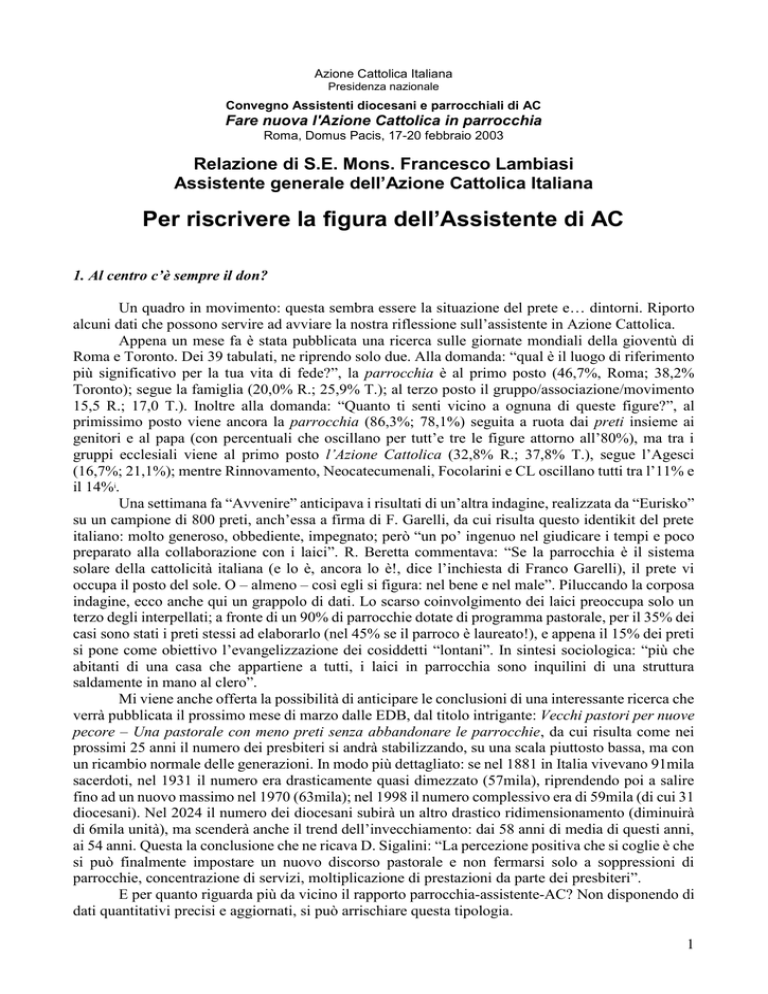
Azione Cattolica Italiana
Presidenza nazionale
Convegno Assistenti diocesani e parrocchiali di AC
Fare nuova l'Azione Cattolica in parrocchia
Roma, Domus Pacis, 17-20 febbraio 2003
Relazione di S.E. Mons. Francesco Lambiasi
Assistente generale dell’Azione Cattolica Italiana
Per riscrivere la figura dell’Assistente di AC
1. Al centro c’è sempre il don?
Un quadro in movimento: questa sembra essere la situazione del prete e… dintorni. Riporto
alcuni dati che possono servire ad avviare la nostra riflessione sull’assistente in Azione Cattolica.
Appena un mese fa è stata pubblicata una ricerca sulle giornate mondiali della gioventù di
Roma e Toronto. Dei 39 tabulati, ne riprendo solo due. Alla domanda: “qual è il luogo di riferimento
più significativo per la tua vita di fede?”, la parrocchia è al primo posto (46,7%, Roma; 38,2%
Toronto); segue la famiglia (20,0% R.; 25,9% T.); al terzo posto il gruppo/associazione/movimento
15,5 R.; 17,0 T.). Inoltre alla domanda: “Quanto ti senti vicino a ognuna di queste figure?”, al
primissimo posto viene ancora la parrocchia (86,3%; 78,1%) seguita a ruota dai preti insieme ai
genitori e al papa (con percentuali che oscillano per tutt’e tre le figure attorno all’80%), ma tra i
gruppi ecclesiali viene al primo posto l’Azione Cattolica (32,8% R.; 37,8% T.), segue l’Agesci
(16,7%; 21,1%); mentre Rinnovamento, Neocatecumenali, Focolarini e CL oscillano tutti tra l’11% e
il 14%i.
Una settimana fa “Avvenire” anticipava i risultati di un’altra indagine, realizzata da “Eurisko”
su un campione di 800 preti, anch’essa a firma di F. Garelli, da cui risulta questo identikit del prete
italiano: molto generoso, obbediente, impegnato; però “un po’ ingenuo nel giudicare i tempi e poco
preparato alla collaborazione con i laici”. R. Beretta commentava: “Se la parrocchia è il sistema
solare della cattolicità italiana (e lo è, ancora lo è!, dice l’inchiesta di Franco Garelli), il prete vi
occupa il posto del sole. O – almeno – così egli si figura: nel bene e nel male”. Piluccando la corposa
indagine, ecco anche qui un grappolo di dati. Lo scarso coinvolgimento dei laici preoccupa solo un
terzo degli interpellati; a fronte di un 90% di parrocchie dotate di programma pastorale, per il 35% dei
casi sono stati i preti stessi ad elaborarlo (nel 45% se il parroco è laureato!), e appena il 15% dei preti
si pone come obiettivo l’evangelizzazione dei cosiddetti “lontani”. In sintesi sociologica: “più che
abitanti di una casa che appartiene a tutti, i laici in parrocchia sono inquilini di una struttura
saldamente in mano al clero”.
Mi viene anche offerta la possibilità di anticipare le conclusioni di una interessante ricerca che
verrà pubblicata il prossimo mese di marzo dalle EDB, dal titolo intrigante: Vecchi pastori per nuove
pecore – Una pastorale con meno preti senza abbandonare le parrocchie, da cui risulta come nei
prossimi 25 anni il numero dei presbiteri si andrà stabilizzando, su una scala piuttosto bassa, ma con
un ricambio normale delle generazioni. In modo più dettagliato: se nel 1881 in Italia vivevano 91mila
sacerdoti, nel 1931 il numero era drasticamente quasi dimezzato (57mila), riprendendo poi a salire
fino ad un nuovo massimo nel 1970 (63mila); nel 1998 il numero complessivo era di 59mila (di cui 31
diocesani). Nel 2024 il numero dei diocesani subirà un altro drastico ridimensionamento (diminuirà
di 6mila unità), ma scenderà anche il trend dell’invecchiamento: dai 58 anni di media di questi anni,
ai 54 anni. Questa la conclusione che ne ricava D. Sigalini: “La percezione positiva che si coglie è che
si può finalmente impostare un nuovo discorso pastorale e non fermarsi solo a soppressioni di
parrocchie, concentrazione di servizi, moltiplicazione di prestazioni da parte dei presbiteri”.
E per quanto riguarda più da vicino il rapporto parrocchia-assistente-AC? Non disponendo di
dati quantitativi precisi e aggiornati, si può arrischiare questa tipologia.
1
Un primo tipo lo potremmo chiamare la figura del parroco-parroco: ritiene che tutte le attività
della parrocchia è bene ricondurle ad un unico programma e “visto che siamo già in pochi” non è
proprio il caso di moltiplicare le iniziative che rischiano solo di frammentare la comunità.
Una figura opposta ma che in realtà è una variante di questo tipo è la figura del parroco
“ecumenico”: in questa parrocchia c’è spazio per tutti, quindi “crescete e moltiplicatevi”. In questo
caso il parroco punta tutt’al più a “fare la somma” delle varie realtà e non la sintesi, come invece
dovrebbe.
Un terzo tipo è la figura del parroco “movimentista”: non si nega formalmente agli “altri” di
esistere, ma di fatto il “don” segue-cura-punta su quelli del suo movimento.
È chiaro che in questi primi tre casi non c’è spazio per l’AC.
Un quarto tipo è quello del parroco “statutario”: si limita ad applicare lo statuto dell’ACI, ma
considera l’associazione “una tra le tante” e non ne coglie – e perciò non ne coltiva – lo specifico
carisma.
È ovvio che dietro ogni tipo di parroco c’è un modo di pensare la comunità; c’è un diverso
modello di pastorale; e c’è una serie di domande che vanno esplicitate: è conciliarmente corretta la
visione di una parrocchia centrata tutta sul prete? una pastorale omogenea e livellata riesce a
“produrre” una comunità veramente missionaria? in una stagione di pluralismo culturale è possibile
una pastorale indifferenziata?
Venendo a noi, quali sono i passi concreti che oggi un assistente deve muovere per “assistere”
l’AC, cioè per curarla-alimentarla-sostenerla-valorizzarla?
2. E il parroco-seminatore uscì a… guardare il campo
Riflettere sui mutamenti che hanno segnato gli ultimi trenta/quarant’anni non è uno snob
intellettuale: è una necessità ineludibile per ogni uomo che voglia vivere e non limitarsi ad esistere;
per un cristiano poi è esercizio spirituale comandato dallo Spirito e illuminato dalla sua sapienza. La
Gaudium et spes ribadisce più volte questa attenzione alla storia: lo fa ai nn. 4.11.44: Il testo più
ampio – il n. 44 – lo ricorda espressamente:
È dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, con l’aiuto dello Spirito Santo, di ascoltare
attentamente, discernere e interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo e di saperli giudicare alla luce della
parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venire
presentata in forma più adatta.
Più vicino a noi gli Orientamenti pastorali per il decennio in corso ci richiamano il
discernimento comunitario come “metodo fondamentale per il rapporto Chiesa-mondo” (CVMC 50) e
rinviano al documento sul dopo-Palermo (n. 21).
Questo esercizio di discernimento pastorale comunitario è – tra l’altro – un doveroso esame di
coscienza. Si tratta di cogliere la portata di mutamenti che hanno segnato profondamente la vita
personale dei presbiteri e le condizioni del loro ministero; ciononostante non sembrano aver
trasformato gran che l’impostazione pastorale, in gran parte ripiegata sulla gestione del culto e sulla
cura dei praticanti.
Concretamente si tratta di interrogarsi sugli scenari che si vanno delineando, per cogliere le
forme con cui il cristiano-presbitero è chiamato a vivere sfide nuove: è meglio essere consapevoli che
ignorare i fenomeni. Senza la presunzione di dire parole definitive e stando attenti al rischio di evitare
letture troppo superficiali, si tratta di individuare gli elementi portanti e, tra questi, quelli capaci di
essere fecondati dall’incontro con la fede.
Il prolungato dibattito sulla modernità e sui suoi esiti è talmente ampio e complesso da
impedire valutazioni precise; il termine post-modernità rivela tutta la sua ambiguità, sospeso com’è
tra l’idea di un suo superamento e quella di una “surmodernità” accelerata ed esasperata. Si tratta
allora di focalizzare la riflessione sugli aspetti dell’epoca contemporanea più importanti per la
discussione sul “futuro dell’uomo”ii.
2
Il ciclo della modernità, che ha puntato prima sulla scienza e poi sulla politica per realizzare
una società razionale e perfetta, e ha creato il mito dell’avvenire e del progresso, è arrivato alla fine
negli anni Sessanta. In quel mondo il lavoro era l’elemento essenziale della realizzazione di sé.
Nietzsche diceva: “Le grandi rivoluzioni avanzano con passi di colomba”: un po’ alla volta, nel corso
degli anni Settanta grandi valori come lavoro, progresso, ragione hanno perso di interesse per i
giovani e sono stati sostituiti da edonismo, culto del corpo, attenzione alla sessualità. Lo
scivolamento dai valori moderni è stato più o meno lento, ma inarrestabile: oggi le grandi parole non
più “progresso”, ma “presente”; non più lavoro ma “piacere”; non più “ragione” ma “emozione”. I
“rave party” annunciano la fine dell’individuo razionale, asse centrale della società, e il ritorno del
piacere, del desiderio, della festa, del “carpe diem”.
Persa l’eternità, si è allungata la vita: se è vera che ogni epoca ha bisogno di un mito, il mito di
oggi non è Prometeo, ma Narciso o Pinocchio, comunque il “puer aeternus”, l’eterno fanciullo, il
nomade o il vagabondo: nell’epoca moderna l’individuo aveva un indirizzo un’identità sessuale,
professionale e ideologica; oggi c’è la moda unisex, ma è scomparsa anche l’identificazione
ideologica: non si è più né di destra né di sinistra: dalla modernità “solida” si è passati alla società
“liquida” (Bauman). E l’impossibilità di sperare fa rinascere l’idea di “destino”, che S. Agostino
aveva superato con la certezza – tutta cristiana - che la storia si inscrive in un piano divino e può
essere orientata. Oggi, secondo le statistiche, un francese su due consulta l’oroscopo…
L’epoca moderna si è esaurita con la crisi della ragione. Era cominciata all’insegna del
“sàpere aude! abbi il coraggio di pensare!” (Kant), quando nell’epoca dei lumi si sostituì il
principio-autorità (religiosa o politica) con il principio-ragione. La “religione” della dea Ragione era
fondata sull’esperimento di una ragione separata dalla/e fede/i, ma ormai è al tramonto per mancanza
di fede in se stessa. Ora si va consumando il divorzio tra verità e libertà: non solo il divorzio dalla
Verità religiosa, ma anche il divorzio da quella verità laica che era stata la grande scoperta della
modernità. Mai come oggi si è accresciuto a dismisura il senso della propria libertà e autonomia:
libertà dai condizionamenti naturali e biologici, libertà dalle leggi e dalle consuetudini fino a ieri
ritenute “naturali” e perciò invalicabili. Viviamo in tempi di pensiero debole, nella “società
dell’incertezza”: oggi il valore supremo non è la verità, ma la veracità, la sincerità, l’autenticità.
La ricerca dell’autenticità è un tratto marcato di questa nostra epoca, definita più volte da
Giovanni Paolo II “drammatica e magnifica”. Ma non si può certo dire che in questa ricerca sia “tutto
nero”, anzi! Pensiamo solo al forte senso della dignità della persona umana, con tutta la costellazione
dei valori sacrosanti: autonomia e originalità, diritto di ricerca e di espressione, rispetto della
coscienza, che anche in materia religiosa non può mai essere né violata né violentata (cf Vaticano II,
DH 2).
Un altro valore molto avvertito in questo mondo non più “uni-verso”, unitario e totalizzante,
ma massificante e globalizzato in cui “esistono 6 miliardi di solitari”, è il bisogno di relazionalità, il
bisogno di incontrare e di dialogare, di capire e di farsi capire, di farsi riconoscere. E questo avviene
solo nella relazione. Il “l’un l’altro” è costitutivo della personalizzazione. Il rischio, certo, è inseguire
la fusione, la limitazione dell’identità; ma, se si accoglie l’altro come altro, allora il mutuo
riconoscimento porta alla corresponsabilità.
Di fronte a questa situazione sono possibili tre sbocchi. Il primo è un atteggiamento di
rassegnazione, spesso sconsolata e disfattista: non possiamo farci niente; puntiamo a resistere, ma in
fondo non ci resta che attendere la catastrofe finale. Il secondo atteggiamento è quello di chi non si
rassegna, ma punta a rovesciare il corso delle cose, in particolare con proclami forti e ristabilendo
regole ferree. È la linea della cosiddetta “tolleranza zero”. Il terzo atteggiamento, senza negare quanto
c’è di valido nei primi due, punta invece non a condannare né ad esaltare il presente ma a “capirlo”
per discernere quali possibilità ci siano date per un nuovo annuncio del vangelo.
Dunque bisogna ancora “ripartire da Gesù Cristo”. Ma se il mondo è cambiato, non si tratta di
annunciare un vangelo diverso, ma di annunciare diversamente il vangelo. Per far capire questa
diversità, provo a rileggere come la modernità si è posta di fronte a Gesù Cristo. La contestazione
illuminista del cristianesimo, tentò di ridurre la fede entro i confini della “pura ragione”. I padri del
3
secolo dei lumi (Kant, Lessing, Reimarus ecc.) non eliminarono Gesù, anzi esaltarono il suo
insegnamento, ma spogliarono la vicenda storica del Nazareno di qualsiasi capacità universale di
salvezza. Dissero: non c’interessa la persona di Gesù (quella ormai appartiene al passato: tra lui e noi
è posto un “maledetto largo fossato”); tutt’al più ci interessa il suo ideale, il suo pensiero, il suo
messaggio morale. Così si diceva di salvare la predicazione di Gesù, ma si toglieva credito alla sua
persona.
In sostanza l’Illuminismo chiedeva alla fede cristiana di trasformarsi in filosofia di vita. Ma
così interpretato “il destino del Gesù di Nazareth non è molto diverso da quello che è spettato a
Socrate e a tanti grandi campioni del passato: l’uomo contemporaneo può anche commuoversi
davanti all’eroismo di queste esistenze consumate per la verità, ma ciò che rimane di loro è solo una
dottrina e il ricordo di una dedizione estrema vissuta per gli altri. Per dirla in termini ancora più
sommari, l’Illuminismo chiede di soffocare, all’interno del cristianesimo, il fuoco della
comunione”iii. Ma una fede che indossa i panni di un’anonima saggezza è ancora fede in Gesù Cristo?
Un cristianesimo senza Cristo è ancora cristianesimo? La risposta non può che essere negativa: il
cristianesimo non è una filosofia, è un’alleanza; non è un ideale astratto, ma una comunione; non è
un’ideologia, è una storia, anzi una persona.
La riduzione che oggi attenta al cuore del messaggio cristiano porta il nome di relativismo.
Bene o male l’Illuminismo aveva cercato di salvare un principio oggettivo nell’interpretazione del
fatto cristiano: la ragione, anche se di fatto il presunto Gesù storico da esso contrabbandato come
autentico rassomigliava tanto – secondo la spietata critica di A. Schweitzer – all’autore che lo aveva
“prodotto”. La versione individualista del fatto cristiano – oggi prevalente – interpreta il
cristianesimo entro i confini della “pura esperienza soggettiva” e riduce la fede ad emozione.
Un’osservazione a margine. Il quadro tracciato può sembrare che pecchi per eccesso di pessimismo;
in verità non è tutto nero nel nostro mondo che cambia; ci sono aspetti positivi, esigenze autentiche,
domande profonde che, se tenute presenti, possono aiutare a calibrare il linguaggio
dell’evangelizzazione senza né adulterare né impoverire il messaggio evangelico. Non è forse vero
che nel desiderio di vivere la fede cristiana come esperienza si può leggere l’esigenza di non relegare
l’atto di fede alla sola facoltà dell’intelletto? Certo, la fede ha una sua imprescindibile esigenza di
credibilità (fides quaerens intellectum), ma non si può circoscrivere nella “corteccia cerebrale”. E se
oggi il pendolo sembra oscillare nuovamente verso l’irrazionalismo, non si supera questo pericolo
scavalcando l’irrinunciabile domanda che la fede stessa postula, e cioè quella della personalizzazione
dell’adesione a Cristo: “io credo”.
3. Evangelizzare nel tempo presente
L’evangelizzazione è la missione permanente della Chiesa: è la sua grazia e, prima di esserne
l’attività specifica, è la sua più vera e intima identità La Chiesa è l’evangelizzazione: se per assurdo la
Chiesa smettesse di evangelizzare, cesserebbe all’istante di essere la memoria e l’attesa di Gesù
Cristo, cioè cesserebbe all’istante di essere Chiesa. L’evangelizzazione è il servizio che essa deve al
mondo, o meglio è la risposta che essa dà al Cristo di ieri, di oggi, di sempre perché salvi questo
mondo e sia il Cristo anche per il nostro oggi.
Non si può quindi distinguere tra cura pastorale ed evangelizzazione, pensando che la cura
pastorale riguardi le comunità cristiane già formate e l’evangelizzazione si riferisca alle comunità da
costituire (la implantatio Ecclesiae). In effetti per secoli si è pensato così: S. Tomaso d’Aquino,
commentando Mt 24,14, si meravigliava come mai il mondo fosse stato già evangelizzato, ma ancora
non veniva la fine (S. Th. 1.2 q.106 a.4).
Dopo il Vaticano II l’evangelizzazione è ridiventata “la” missione della Chiesa e questa
missione è rimasta ormai “la” possibilità di salvezza per il nostro vecchio mondo:
Se l’Europa tutta, tutta l’Europa non viene nuovamente evangelizzata, se non riascolta l’Annuncio, è perduta. Noi
tutti siamo perduti. Ecco l’angoscia del pontefice, che scopre il mondo andare in direzione opposta. Solo un’altra
4
evangelizzazione potrà salvarci. Qualsiasi tentazione di ripercorrere le tradizionali politiche è strumentale e
miserevole. Solo un’Europa veramente cristiana potrà salvarsiiv.
Dunque la prima carità che la Chiesa deve al mondo è la carità del vangelo, e cioè la carità
della buona notizia che Dio è amore; questo è il vangelo della carità: “non siamo stati noi ad amare
Dio… è lui che ci ha amati per primo” (1Gv 4,10.19). Non si tratta di dire al mondo cosa è il mondo,
ma cosa è Dio, o, certo, anche cosa è il mondo, ma alla luce di Dio.
Ma questo succede di fatto oggi nelle nostre parrocchie o l’annuncio evangelico che vi risuona
ha perso la freschezza di una notizia lieta e sorprendente ed è diventato stanco e spento e sa di
scontato e imparaticcio? La cosa può avvenire in diversi modi. Per esempio quando si riduce il
vangelo a “dottrina” su Dio, su Cristo, sull’uomo, mentre è innanzitutto un evento. Certamente il
cristianesimo è anche insegnamento e dottrina, ma questa è contenuta nell’evento e non può mai
prendere il posto fondante e fondamentale dell’evento. Ma se il cristianesimo è una storia, allora
dovrà essere innanzitutto raccontato, e poi insegnato. Una volta operata la riduzione da evento a
dottrina è poi facile passare ad un’ulteriore riduzione del messaggio: da dottrina a morale, da “serie di
verità” a “serie di precetti”. Ma cosa diventa la morale cristiana quando la si stacca dal gesto salvifico
di Dio che la suscita e la giustifica? Ricordiamo la lezione di Sartre: “Bisogna aver scoperto l’amore
prima della morale, altrimenti è lo strazio”. Si deve quindi sempre ritornare all’evento originale e
originante, qual è appunto una storia infinita di infinito amore: l’amore di Dio fatto carne in Gesù, che
ci ha amato fino alla morte e alla morte di croce...
Di fronte al naufragio della ragione che caratterizza la nostra epoca, si aprono davanti alla
Chiesa due vie “non alternative”:
L’una, quella di convincere gli uomini e quindi la società post-moderna a tornare alla ragione. L’altra: quella di
proporre se stessa, cioè le proprie forme e il proprio stile di vita. In altri termini, invece di impegnarsi nel
tentativo di convincere gli uomini a tornare alla ragione, impegnarsi a convincere i cristiani a praticare il
cristianesimo nella sua autenticità; propriamente a vivere l’esistenza umana come l’ha vissuta Gesù Cristov.
Questo è infatti il kerygma, quello che la nostra associazione ha chiamato l’essenziale (della
fede): è la storia dell’esistenza umana di Gesù Cristo, come esistenza felice: felice perché “beata” e
perché “riuscita”. Ma si può proporre di vivere l’esistenza umana come l’ha vissuta Gesù Cristo senza
la testimonianza della santità? Palermo docet: per la nuova evangelizzazione e per il rinnovamento
della società, la prima risorsa e la più necessaria sono uomini e donne nuovi immersi nel mistero di
Dio e inseriti nella società, santi e santificatori” (n. 10).
4. “Assistere” il rinnovamento dell'AC
Il rinnovamento in atto nell’AC non può essere attuato senza il decisivo contributo degli
assistenti, ma anche dei parroci nelle cui parrocchie l’AC vive. Ma in che modo essi possono
contribuire? Se è vero che una delle parole con cui l’AC si impegna a tradurre in atto il suo
rinnovamento è la parola conversione, è chiaro allora che il contributo degli assistenti è decisivo.
Penso allora che si possa dire sinteticamente che il contributo degli assistenti al rinnovamento dell'AC
è sostenere lo spirito e il processo di conversione presente in essa; conversione secondo una triplice
accezione: conversione pastorale, conversione spirituale, conversione della formazione.
“In primo luogo – ha affermato il Papa nella Novo millennio inenunte - non esito a dire che la
prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino pastorale è quella della santità”. “Ma – si chiedeva
subito dopo – si può forse programmare la santità? Che cosa può significare questa parola nella
logica di un piano pastorale?” (NMI 30s). Riassumendo, il “teorema” di Giovanni Paolo II e della CEI
si potrebbe concentrare in questo sillogismo: a. il programma della comunità cristiana per il terzo
5
millennio è quello di sempre: si incentra in ultima analisi in Cristo stesso; b. perché questo
programma diventi attuabile, si deve tradurre in alcune priorità pastorali, di cui la prima in assoluto è
la santità; c. bisogna quindi pianificare e programmare una pastorale della santità. Ma come l’AC
interpreta questa pastorale della santità e come un Assistente la può concretamente servire?
A me pare che l’AC faccia sua questa pastorale attraverso il suo stesso rinnovamento.
La prima conversione dunque è quella pastorale, che richiede a sua volta una conversione dei
pastori e di quanti sono impegnati nell’opera di evangelizzazione. Mi limito solo a qualche aspetto.
Oggi una “eresia” che affligge la nostra pastorale è il “semipelagianesimo”, quella concezione della
pastorale come opera “a fin di bene”, anche se si tratta del bene più grande, qual è il bene della
salvezza, insomma come opera a favore di Cristo e non invece come opera di Cristo, “il grande
pastore”, che proprio perché “assunto in cielo” continua ad “operare con” la Chiesa e ad agire con le
sue mani (cf Mc 16,19-20; Mt 28,20). Il patrono dei parroci, il santo curato d’Ars, diceva che durante
la processione del Corpus Domini non era lui a portare Cristo, ma Cristo a portare lui. Vale anche per
la missione: è l’evangelo che porta l’evangelizzatore, non il contrario. Prima di essere dovere e
impegno, la missione è grazia, dono gratuito e immeritato. Certo, la grazia non anestetizza dalla fatica
e quindi nemmeno dalla stanchezza né tanto meno dalla sofferenza, ma se si getta davvero la rete sulla
Sua parola, allora non solo si può scongiurare il rischio di cadere nello “stress da pastorale”, ma si
regge bene alla tensione e non si sprofonda nelle sabbie mobili del triangolo micidiale:
desolazione-frustrazione-depressione. Vissuto in luce di fede, il servizio del pastore
(l’evangelizzazione) e la collaborazione corresponsabile dei laici alla missione può stancare ma non
pesa, impegna ma non tormenta, affatica ma non affligge.
Anche perché la fede nella grazia aiuta a prendere coscienza della finitudine: non posso fare
tutto, anzi, se non rimango in Cristo, non posso fare niente. È proprio del tutto vero che certi preti
lavorano troppo? forse non troppo, ma pensano troppo che devono fare tutto loro. Allora il servizio
pastorale diventa un gioco di scacchi in cui ogni mossa va calcolata, un complicato teorema che ci fa
rompere la testa. Se invece si ha il “cuore a posto”, si arriva addirittura a vivere positivamente la
debolezza apostolica, accettando con pazienza le cose che non si possono cambiare, cercando di
cambiare con coraggio le cose che si possono cambiare, ma sempre con l’equilibrio di chi non
confonde le prime con le seconde. Questo è veramente l’essenziale: “Giova di più alla Chiesa il più
piccolo atto d’amore che non tutte le sue opere messe insieme”, diceva con linguaggio martellante
Giovanni della Croce.
Se la pastorale viene intesa come opera di Cristo, la missione non si ridurrà mai a fare
pubblicità a un prodotto o propaganda per una idea. Missione non è fare colpo, ma fare mistero:
perciò l’evangelizzazione non può non avere qualcosa di incomprensibile, per essere comprensibile.
Questa opzione fondamentale si reduplica nella passione per la contemplazione del volto del
Signore Gesù: non basta dire al mondo che cambia quello che abbiamo imparato del Signore; occorre
annunciare quello che come discepoli – chiamati innanzitutto per “stare con lui” e, dopo, solo dopo
per andare a predicare – quello che abbiamo appreso dal Signore. La liturgia e la preghiera sono il
momento più alto del nostro stare con Lui: la relazione con il Signore è il fine della vita del discepolo
e non il mezzo per compiere meglio il suo servizio. Altrimenti, anziché immergersi nel mondo, ci si
lascia inesorabilmente sommergere dal mondo.
Senza questa contemplazione permanente è ineluttabile che la catechesi scada ad
indottrinamento intellettualistico o ad informazione più o meno erudita; che la liturgia si riduca a rito
freddo, spento, noioso o a spettacolo più o meno gradito e non sia piuttosto vera “azione”: partecipata,
coinvolgente, fruttuosa; è inevitabile che la carità venga interpretata come gesto episodico per aiutare
qualcuno senza accoglierlo pienamente, o si riduca ad intervento superficiale che non riesce ad
aggredire le cause dei tanti mali che pesano sulla carne e sul cuore dei poveri.
La seconda conversione riguarda la spiritualità, che va riplasmata secondo il “primato della
grazia” di cui parla il papa nella Novo millennio ineunte (n. 38)? Concretamente significa superare
due concezioni “datate” di spiritualità cristiana. Una prima figura corrisponde alla spiritualità
6
dell’osservanza. È il cristianesimo imparato e vissuto dai nostri nonni e, prima di loro, da numerose
generazioni di cristiani. È il cristianesimo del precetto e del dovere. Come cristiani siamo tenuti ai tre
grandi obblighi: a credere determinate verità, a osservare dei comandamenti, a celebrare i sacramenti.
La vita cristiana appariva come una serie di ordini da eseguire, di precetti da rispettare, di norme da
praticare, e Dio veniva visto come il “signore-padrone” alla cui ferrea, fatale volontà non restava che
sottomettersi ciecamente con timore e tremore. Questo cristianesimo ha educato e modellato la
coscienza di numerose generazioni di credenti. Molti vi hanno trovato un itinerario di vita e tanti laici
vi hanno riconosciuto non solo un dovere, ma un ideale che perseguito con fedeltà e passione poteva
rendere e di fatto ha reso le persone serene, appagate e, perché no? intimamente felici. Ma sappiamo
pure che questo cristianesimo di osservanza ha generato anime depresse e cristiani tristi, ha lacerato
non poche coscienze rendendole timide e scrupolose, ossessionate da angosciosi sensi di colpa,
complessate da un doverismo frustrante, a dispetto della buona notizia evangelica.
Una seconda figura è quella della spiritualità della militanza. È il cristianesimo di coloro che
hanno trovato nel messaggio cristiano più che un dovere da compiere, un appello a impegnarsi
liberamente nella diffusione del vangelo e nella promozione dell’uomo. Questo cristianesimo del
servizio e dell’azione, che assume e persegue la nobile causa di una Chiesa viva e partecipata e di un
mondo migliore, ha di fatto mobilitato masse di cristiani militanti – come non ricordare la “falange di
Cristo redentore” a cui erano fieri di appartenere tanti nostri genitori? – che si sono impegnati
nell’apostolato e hanno vissuto con coerenza spesso eroica la scelta radicale dei poveri e degli ultimi.
Ma bisogna anche riconoscere che un servizio pastorale troppe volte ridotto a “cose da fare” ha
estenuato molti laici rischiando di ridurli a “truppe di riserva”. D’altra parte la lotta per la giustizia e
l’impegno appassionato per la promozione umana si sono non poche volte reduplicati in esistenze
deluse, in coscienze amare e insoddisfatte.
Oggi si impone una terza forma di spiritualità cristiana, più vicina alla spiritualità biblica e
genuinamente cattolica, il cristianesimo della grazia. Dentro questa prospettiva, essere cristiano non
è prima di tutto un dovere da assolvere o una causa da perseguire, ma un dono da ricevere, secondo il
dettato evangelico: “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). Questo
cristianesimo della grazia non esclude, ma ingloba le altre due dimensioni del dovere e dell’impegno:
la grazia infatti mentre ci fa sentire amati, ci rende capaci di amare. L’osservanza dei comandamenti,
la pratica delle buone opere, o meglio la vita secondo le beatitudini evangeliche non diventano il
prezzo da pagare per conseguire la salvezza, ma il frutto che si può cogliere con gratitudine dal seme
di una esistenza “graziata” e riconciliata.
Volendo dire le cose in una formula che faccia cogliere la radicalità della spiritualità della
grazia, possiamo affermare che mentre una certa spiritualità tradizionale si muove attorno all’asse del
desiderio umano di Dio, la spiritualità pasquale-pentecostale si sviluppa attorno all’amore divino per
l’uomo: “Non è un ritocco: è un capovolgimento. La posta in gioco è di abbozzare la
de-ellenizzazione dell’impianto della vita spirituale” per ricondurla sotto il segno della spiritualità
biblico-liturgicavi. L’inculturazione del messaggio cristiano nel quadro del pensiero greco ha portato
a strutturare il rapporto uomo-Dio in termini di ascesi, ossia di salita verso Dio. L’uomo infatti è
costitutivamente desiderio di Dio, un desiderio inquinato dal peccato – nella visione cristiana – ma
sanato e sostenuto dalla grazia, e che però, per arrivare al suo approdo in Dio, deve affrontare una
serie di rinunce che si riassumono nella fuga mundi. Sotteso a questa concezione è il dualismo
anima/corpo, che si reduplica nella divisione spirituales/carnales: gli “spirituali” sono monaci e
preti, i “carnali” sono ovviamente i laici. L’ascesi è dimensione imprescindibile per il cristiano, ma
non è premessa, bensì frutto e conseguenza della mistica.
La terza conversione riguarda la formazione, e anch’essa dev’essere capita dall’assistente per
poter essere adeguatamente sostenuta e accompagnata. Al riguardo mi limito a riprendere due
passaggi dell’ultimo Documento assembleare (nn. 20-21). La formazione va “ripensata” innanzitutto
nel suo obiettivo: si tratta di farsi carico della “non-fede” di credenti e non credenti; va ripensata
anche nel suo modello: occorre passare da un modello ”scolastico” a un modello “familiare”, dove il
cammino di crescita avviene attraverso l’accompagnamento personale, il calore delle relazioni e il
7
dialogo tra le generazioni. Il rinnovamento riguarda anche la ri-presentazione del nucleo del vangelo,
che non è una formula, ma una persona, da contemplare, amare, seguire. Ma questo rinnovamento
resterà un sogno destinato a diventare incubo se non passerà attraverso persone nuove, se cioè
l’associazione non riuscirà ad esprimere “una nuova generazione di responsabili, educatori e
animatori”: questo richiederà “forti scelte di novità” (n. 25).
La domanda che resta è: si potrà attuare questo rinnovamento, pastorale e apostolico,
formativo e spirituale, senza l’apporto convinto, competente e generoso degli assistenti?
5. Essere e fare l’assistente di AC
La Lettera del Consiglio Permanente della CEI dedica una riflessione piuttosto ampia alla
figura dell’assistente, spendendo parole impegnative. Ricordo alcune delle affermazioni che sono
contenute nel n. 4 della Lettera. Vi si legge:
Ai parroci chiediamo di stimare e di promuovere l’Azione Cattolica: nessuno ostacoli la nascita o lo sviluppo di
gruppi parrocchiali di Azione Cattolica, ma al contrario li sostenga in un impegno formativo che arricchisce
l’intera comunità. Ai sacerdoti assistenti chiediamo vicinanza e condivisione verso questa esperienza laicale,
sperimentando una relazione fraterna che, nell’incontro di vocazioni distinte, possa continuare a dare frutti di
santità.
Nel rivolgermi ai rappresentanti di questi due soggetti ecclesiali – i parroci e i sacerdoti
assistenti – penso di intercettare la loro domanda: ha senso per un prete dedicare un po’ del suo
impegno pastorale a promuovere un’associazione come l’AC? E da che parte cominciare? Dedico
allora le ultime considerazioni e dire alcune ragioni che ritengo possano costituire risposta a queste
domande. Ritengo che “riscrivere” la figura dell’assistente non richieda di ridire quanto gà detto nello
Statuto (art. 10) e nel Vademecum dell’assistente. Penso che quelle note, più che da riperete, siano da
riprendere, riscoprendone le radici originarie e aggiornandole.
1. Un prete che non è il tutto
È vero: nella comunità solo il prete è… prete, ma il prete è solo prete, non è il tutto della
comunità. Egli non può mai dimenticare che il titolo più alto della sua dignità non è tanto quello di
essere pastore, ma di appartenere al gregge del Signore. La sostanziale uguaglianza tra tutti i
battezzati viene prima di ogni carisma, di ogni ministero, di ogni missione. Il fatto di essere pastori
non annulla il dato di base che restiamo sempre appartenenti all’unico ovile: anche i preti partecipano
al sacerdozio battesimale. Ma, d’altra parte, tutti i battezzati sono chiamati all’unica missione e quindi
partecipano alla funzione pastorale: è il principio della corresponsabilità, non nel senso che tutti
siamo pastori per ministero (lo sono solo alcuni) ma nel senso che tutti sono chiamati a partecipare
all’unica azione pastorale di Cristo, secondo il carisma di cui sono gratificati, la carità di cui sono
animati, il servizio di cui sono stati incaricati. Non ci sono quindi nella Chiesa né puri esecutori né
semplici collaboratori, ma tutti sono responsabili di tutto, secondo il dono ricevuto. Così si può
vincere la tentazione sempre in agguato del clericalismo, che consiste nel fare da “padroni” del
gregge e della sua fede (cf 1Pt 5,3; 2Cor 1,24). Se è vero che il rischio mortale di ogni fraternità
cristiana è l’individualismo estremo (dove ognuno vuol essere il tutto) è altrettanto vero che questo
rischio non si supera cadendo nello scoglio opposto, il centralismo estremo (dove uno vuol essere
tutto), ma con il servizio alla crescita della comunità e dei suoi componenti.
2. Un prete per e con i laici
8
Il ministero del prete non è autoreferenziale, ma consiste nel servire i laici perché esercitino il
sacerdozio battesimale. Il sacerdozio dei laici non è metaforico, ma reale: il sacerdozio ordinato è
“ministeriale” nel senso che è a servizio di quello battesimale, in modo che tutti i battezzati possano
offrire “sacrifici spirituali” (1Pt 2,5). Questi sono “sacrifici” in quanto atti sacri, ma sono “spirituali”
in quanto atti esistenziali offerti sotto l’azione dello Spirito Santo. Ecco come li descrive il concilio:
“Tutte le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro
giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e persino le molestie
della vita se sono sopportate con pazienza, diventano spirituali sacrifici graditi a Dio per Gesù Cristo
(…). Così anche i laici consacrano a Dio il mondo stesso” (LG 34).
Come ha affermato chiaramente la Pastores dabo vobis (n. 15): “I presbiteri sono nella chiesa
e per la chiesa una ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo nella sua funzione di mediatore”. Si
può quindi dire che “il sacerdozio battesimale è offerta esistenziale, mentre il sacerdozio ordinato è
mediazione sacramentale”vii.
È dalle sue opzioni concrete, dal modo di affrontare la sua situazione oggettiva, dal modo di
inserirsi nell’ambiente in cui vive e di portare le sue responsabilità personali, familiari, sociali,
mondiali, nell’azione o nella sofferenza, è da tutte le realtà che il cristiano è messo in relazione
autentica con Dio e così rende un culto a lui gradito. I sacramenti sono nell’ordine dei mezzi, la
partecipazione alla messa non è un fine a sé. I cristiani avanzano verso Dio con tutta la realtà umana
della vita e della morte di Cristo. Quindi sacerdozio è l’esistenza cristiana, fondata su Gesù Cristo e
vivificata dallo Spirito.
Se l’intero popolo di Dio non potesse essere detto sacerdotale, la missione “non avrebbe essa
stessa valore salvifico, ma consisterebbe esclusivamente nello sforzo di condurre gli uomini dentro lo
spazio ecclesiale dove, a sua volta, il credente troverebbe, attraverso la mediazione dei sacerdoti, la
possibilità di entrare in comunione con Dio”viii. Questo fatto comporta l’assunzione di tutta la laicità
dentro la sacralità della missione o, che è la stessa cosa, la dispersione della sacralità della missione in
tutti gli spazi della laicità. Quindi la chiesa non potrà sentire come suoi spazi particolari quelli della
liturgia o quelli dell’evangelizzazione diretta e sentirsi in qualche maniera estranea negli spazi del
sociale, del caritativo, del culturale, del politico.
Il prete è prete per sempre ma non è… sempre prete, cioè agisce sempre in persona Christi,
ma non sempre in persona Christi capitis. S. Paolo ha detto: “Sia che mangiate, sia che beviate, sia
che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio” (1Cor 10,31): questo è il sacerdozio
battesimale. Quindi quando il prete mangia o si diverte (!) non è segno di Cristo mediatore come
invece quando presiede l’eucaristia.
L’eucaristia è l’atto più grande della Chiesa in cui si fa più evidente la legge della comunione.
Infatti se ciò che deve impregnare tutta l’esistenza è il sacerdozio battesimale-esistenziale, e questo
deve impregnare anche gli atti tipicamente ministeriali, nel caso di un prete che presiede in stato di
peccato grave si avrebbe un prete in-fedele al suo battesimo nell’esercizio del ministero: quel prete
esercita il ministero validamente ma sacrilegamente perché rompe la comunione con i fedeli che
esercitano il sacerdozio battesimale.
Di qui la domanda: può un prete che per missione è chiamato a vivere per servire il sacerdozio
dei laici, fare meno di vivere con i laici?
3. Il sogno di un parroco e l’AC
“Ogni prete semplice / porta in cuore un sogno…”. Il sogno è quello della comunità: realizzare
in parrocchia l’ideale della “fraternità totale” come quella del libro degli Atti. Ogni parroco ha il
diritto di sapere se e a quali condizioni questo sogno si può realizzare e se e a quali condizioni l’AC lo
può aiutare a realizzare il sogno. Per questo può essere utile passare in rassegna i tre modelli di
9
parrocchia che un parroco di sessant’anni circa (è l’età media dei preti italiani) può aver incontrato nel
corso del suo cammino.
Il primo è quello che si potrebbe chiamare modello ascetico, predominante fino alla
conclusione del Vaticano II: consiste nel mettere al centro della vita comunitaria l’acetica, secondo la
quale il responsabile della vita comunitaria è il soggetto. Il modello ascetico si basa su due virtù
fondamentali: l’obbedienza verso l’autorità, la carità fraterna verso il prossimo. È una formazione che
responsabilizza al massimo la persona, la quale deve sempre dirsi: il primo responsabile del buon
andamento delle cose sono io, sia parroco che semplice fedele; e se riscontro lacune e incoerenze,
devo sempre domandarmi: cosa posso fare di più e di meglio? Di qui l’importanza data alla preghiera,
ai ritiri, alla pratica delle virtù.
Il secondo modello è quello teologico-giuridico, predominante nell’immediato postconcilio.
Il concilio aveva messo in luce l’insufficienza della domanda sul “come” far funzionare
l’istituzione-parrocchia; occorreva ripresentare il “perché” della parrocchia e la motivazione “ideale”
della sua ragion d’essere. Sorge allora una vera e propria teologia della “comunità”, desunta sin
dall’inizio dalla riscoperta dell’ecclesiologia di comunione. Di qui il ricorso all’aggiornamento
teologico e all’ammodernamento strutturale (consigli pastorali).
Il terzo è il modello antropologico, emerso a metà degli anni ’70 ed esploso in seguito: tiene
realisticamente presente la fragilità dei vecchi e nuovi soggetti, della vita parrocchiale (parroco
compreso!) per i quali non basta lo sforzo ascetico o il rinnovamento teologico. Corrisponde al
crescere dell’influenza della sociologia e della psicologia, che possono fornire supporti più efficaci
alle accresciute difficoltà nel dialogo tra le generazioni, nella fedeltà agli impegni, nella resistenza di
fronte agli ostacoli che la vita sempre più frenetica e inquieta della società frappone al cammino della
comunità cristiana. Al riguardo si potrebbe aggiornare una citazione di Bonhoeffer: invece di fare
comunità animate dallo Spirito (“pneumatiche”) e quindi rese ferventi e apostoliche, si adottano
soluzioni sempre più secolaristiche, di tipo operativo, tecnico, sociologico o psicologico (comunità
“psichiche”).
È ovvio che i tre modelli possono convivere normalmente, perché non sono “sbagliati”, ma
complementari. E di solito convivono sino a quando non sorgono grosse difficoltà, come quando si
fanno rigidi o esclusivi.
L’AC ha conosciuto e conosce essa stessa al suo interno la convivenza di queste anime, dal
momento che essa risulta composta da persone di tutte le età, in maggioranza non più giovanissime, e
questa situazione è una delle ragioni della sua debolezza, quando l’associazione non riesce a
imboccare la strada dell’unitarietà e prende invece la scorciatoia della settorializzazione o
dell’assemblaggio dei pezzi. Ma paradossalmente proprio questa potrebbe essere la sua forza, ma a
determinate condizioni, tra cui qui – visto il contesto – si prova ad elencare quelle che riguardano il
parroco, immaginandole come una sorta di “decalogo” dettato (questa volta!) dai laici.
1. “Abbi il coraggio della tua identità!”: tu sei il parroco di tutti e noi dell’AC non vogliamo farti da
nido caldo o da gabbia soffocante. Vogliamo aiutarti a fare non la somma dei gruppi e dei movimenti,
ma ad esercitare io ministero della sintesi. Se tieni presente che per l’AC tu non sei né il “cappellano”
che fa dire le preghiere, né l’organizzatore del campo-scuola, ma quello che dice il nostro Statuto (art.
1°) e il Vademecum…
2. “Attenzione al sogno della comunità perfetta!: potrebbe diventare un incubo! E se invece
l’imperfezione della nostra comunità fosse la “spina” che il Signore ci mette in cuore per far crescere
il nostro desiderio verso la comunione definitiva e beatificante della patria trinitaria?
3. “L’AC è una pianta delicata”: non complicata, ma complessa. Non è come un movimento o un altro
gruppo ecclesiale: se non la coltiva il pastore, da sola non cresce. Come si fa poi ad andare sotto
l’albero e a maledirlo perché non produce frutto?
10
4. “Riconosci senza paura la nostra identità”: l’avere nella tua comunità un’associazione con un suo
profilo spirituale e progettuale non complica la vita pastorale ma la arricchisce; e le dà quella
ricchezza che un gruppo di collaboratori non può dare. I collaboratori finirebbero con il raccogliersi
attorno a te!
5. “Abbi la fierezza di crescere dei figli che ti stanno di fronte da adulti e da persone libere”. E se
qualche volta proverai disappunto perché non ti diranno sempre di sì, sappi che il loro sentirsi
valorizzati come figli li porta ad esercitare la loro partecipazione sempre con affetto da figli. Temi
piuttosto di avere attorno a te dei laici che con il tempo diventano la tua fotocopia e sono solo
esecutori.
6. 7. 8. 9. L’esercizio si potrebbe continuare…
10. “E credi che tutto questo ti aiuta a dar corpo al tuo sogno!”. E a trasformare il tuo desiderio di una
comunità bella nel progetto di una Chiesa che sia davvero casa abitabile…
F. GARELLI – R. FERRERO CAMOLETTO (a c. di), Una spiritualità in movimento. Le Giornate Mondiali della Gioventù da
Roma a Toronto, Padova 2003, 306.311.
ii
La letteratura sulla modernità e post-modernità si è fatta in questi anni sterminata. Mi limito ad alcuni riferimenti
essenziali: I. SANNA, L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Brescia 2001; G. COLOMBO, Sulla
evangelizzazione, Milano 1997; SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE (CEI), Cambiamento culturale e
fede cristiana, Leumann-Torino 2000. Cf anche S. LANZA, La nube e il fuoco, Roma 1995; G. COLZANI,
Un’interpretazione dell’oggi, in G. CANOBBIO ED ALTRI, Introdurre gli adulti alla fede. La logica catecumenale nella
pastorale ordinaria, Milano 1997, 21-43.
iii
G. CAZZULANI, Giovanni Moioli: Gesù di Nazareth, il cristianesimo e la storia, Milano 2002, 28.
iv
M. CACCIARI, nel quotidiano l’Unità, del 27 febbraio 1991.
v
G. COLOMBO, op. cit., 49s.
vi
A. RIZZI, Dio in cerca dell’uomo – Rifare la spiritualità, Cinisello B. 1987, 19.
vii
A. VANHOYE, Il sacerdozio della Nuova Alleanza, Milano 1999, 133.
viii
S. DIANICH, Chiesa in missione, Cinisello B., 1985, 266.
i
Roma, Domus Pacis, Convegno Naz. Assistenti di ACI, 19 febbraio 2003
11