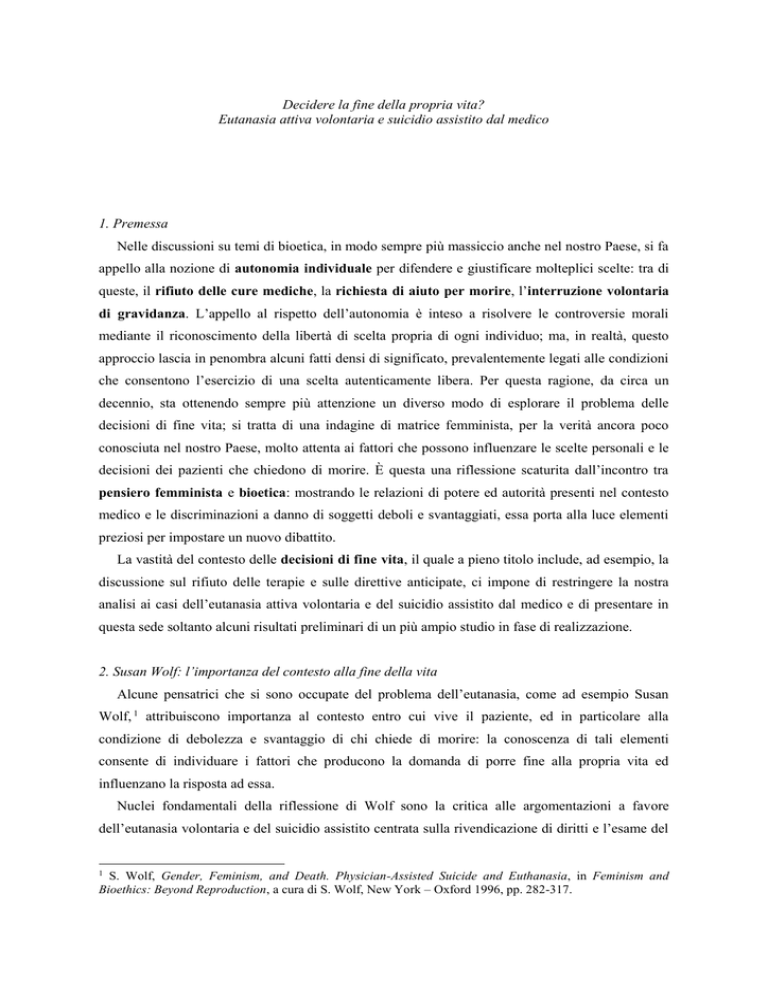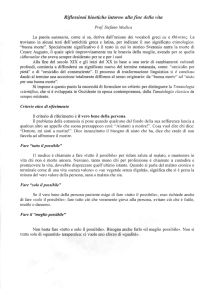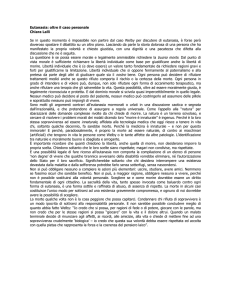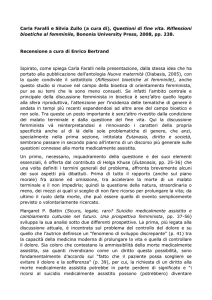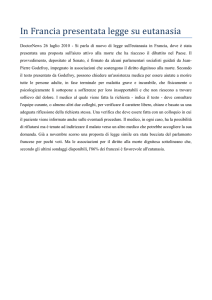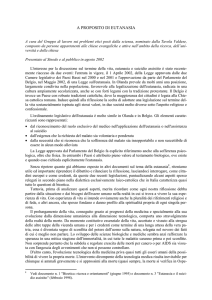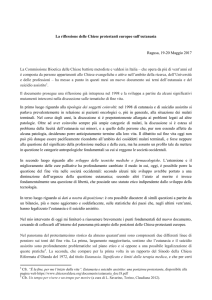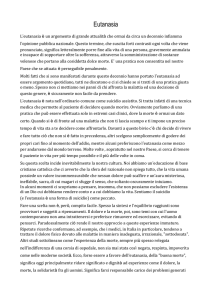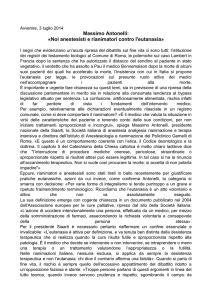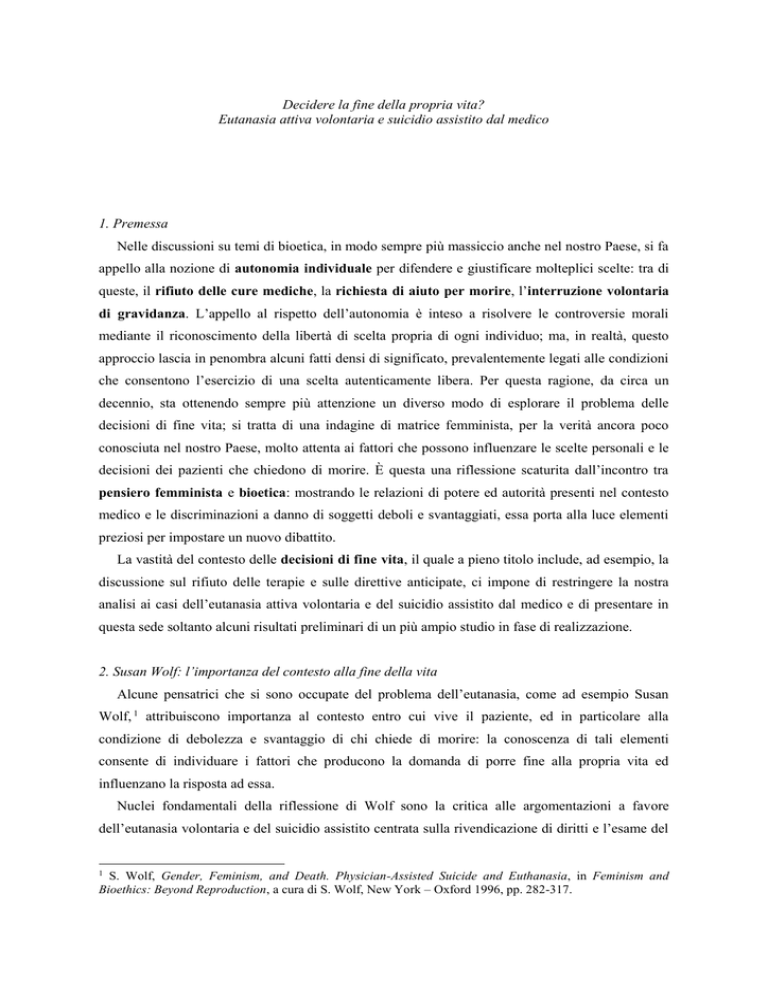
Decidere la fine della propria vita?
Eutanasia attiva volontaria e suicidio assistito dal medico
1. Premessa
Nelle discussioni su temi di bioetica, in modo sempre più massiccio anche nel nostro Paese, si fa
appello alla nozione di autonomia individuale per difendere e giustificare molteplici scelte: tra di
queste, il rifiuto delle cure mediche, la richiesta di aiuto per morire, l’interruzione volontaria
di gravidanza. L’appello al rispetto dell’autonomia è inteso a risolvere le controversie morali
mediante il riconoscimento della libertà di scelta propria di ogni individuo; ma, in realtà, questo
approccio lascia in penombra alcuni fatti densi di significato, prevalentemente legati alle condizioni
che consentono l’esercizio di una scelta autenticamente libera. Per questa ragione, da circa un
decennio, sta ottenendo sempre più attenzione un diverso modo di esplorare il problema delle
decisioni di fine vita; si tratta di una indagine di matrice femminista, per la verità ancora poco
conosciuta nel nostro Paese, molto attenta ai fattori che possono influenzare le scelte personali e le
decisioni dei pazienti che chiedono di morire. È questa una riflessione scaturita dall’incontro tra
pensiero femminista e bioetica: mostrando le relazioni di potere ed autorità presenti nel contesto
medico e le discriminazioni a danno di soggetti deboli e svantaggiati, essa porta alla luce elementi
preziosi per impostare un nuovo dibattito.
La vastità del contesto delle decisioni di fine vita, il quale a pieno titolo include, ad esempio, la
discussione sul rifiuto delle terapie e sulle direttive anticipate, ci impone di restringere la nostra
analisi ai casi dell’eutanasia attiva volontaria e del suicidio assistito dal medico e di presentare in
questa sede soltanto alcuni risultati preliminari di un più ampio studio in fase di realizzazione.
2. Susan Wolf: l’importanza del contesto alla fine della vita
Alcune pensatrici che si sono occupate del problema dell’eutanasia, come ad esempio Susan
Wolf, 1 attribuiscono importanza al contesto entro cui vive il paziente, ed in particolare alla
condizione di debolezza e svantaggio di chi chiede di morire: la conoscenza di tali elementi
consente di individuare i fattori che producono la domanda di porre fine alla propria vita ed
influenzano la risposta ad essa.
Nuclei fondamentali della riflessione di Wolf sono la critica alle argomentazioni a favore
dell’eutanasia volontaria e del suicidio assistito centrata sulla rivendicazione di diritti e l’esame del
1
S. Wolf, Gender, Feminism, and Death. Physician-Assisted Suicide and Euthanasia, in Feminism and
Bioethics: Beyond Reproduction, a cura di S. Wolf, New York – Oxford 1996, pp. 282-317.
significato della differenza di genere nel contesto dell’analisi su tali argomenti, un esame che viene
condotto con gli strumenti propri del pensiero femminista e con l’attenzione rivolta alla paziente.
Wolf critica l’approccio noto come “etica dei diritti”, 2 sostenendo che esso è basato su un
modello astratto di individuo, il quale è dotato di un’unica caratterizzazione: quella di essere titolare
di diritti. Secondo Wolf l’approccio ai quesiti morali attraverso l’etica dei diritti non consente di
affrontare in modo adeguato le problematiche che si originano nell’ambito della salute, dal
momento che non sempre è possibile risolvere le controversie morali mediante l’applicazione
“meccanica” di diritti. Wolf rileva infatti che sull’esercizio di un diritto influiscono contesto
sociale, relazioni o limiti dell’assistenza effettivamente erogabile al paziente e questi fattori non
possono essere trascurati quando si discute di suicidio assistito e di eutanasia volontaria.
In risposta all’etica dei diritti, Wolf adotta invece un approccio etico del “prendersi cura”, basato
sulla relazioni tra individui ed teso a rispondere empaticamente ai bisogni del malato; 3 da esso
scaturisce l’attenzione alla differenza di genere e al contesto entro cui compare la richiesta del
malato di essere aiutato a morire. L’autrice si chiede quali implicazioni possa avere il genere nel
contesto medico, quali ragioni giustificherebbero il rifiuto del medico di prestare assistenza per
concludere la vita di un paziente che lo chieda esplicitamente, quali ragioni giustificherebbero
invece l’accoglimento di tale richiesta, soprattutto qualora fosse espressa da un paziente di sesso
femminile. Innanzitutto Wolf ricorda che possono esistere fattori che producono condizioni di
svantaggio per le donne: la storia della valorizzazione del sacrificio femminile, una componente non
trascurabile, spesso taciuta, del dibattito su eutanasia e suicidio assistito richiesti da donne; 4 la
mediocre qualità dell’assistenza ricevuta dalle donne, causata della mancanza di coperture
assicurative sufficienti a procurarsi prestazioni sanitarie costose; la povertà che negli U.S.A.
colpisce soprattutto soggetti di sesso femminile, anziani, bambini e gente di colore. Secondo Wolf
questi svantaggi si traducono nell’impossibilità di ricevere assistenza adeguata per affrontare
patologie come il morbo di Alzheimer, il cancro, la sclerosi multipla.5
Mettendo insieme tutti questi elementi, si ottiene un primo frammento del quadro delle
motivazioni in base alle quali le donne sceglierebbero il suicidio assistito o l’eutanasia: se morire è
l’unico modo per liberare la propria famiglia da un grave peso psicologico, economico ed
assistenziale, le donne ancora una volta si sacrificano per gli altri e scelgono di morire. Wolf sembra
sposare questa tesi: le pazienti di sesso femminile chiedono di morire anche per liberarsi dal dolore
e dalla sofferenza, e non soltanto (e soprattutto) a causa di quella condizione. In prima
La distinzione tra “etica dei diritti” ed “etica della cura” si fa risalire al lavoro di una psicologa statunitense,
Carol Gilligan, Con voce di donna. Etica e formazione della personalità, trad. it., Milano 1987.
3
Per avere una visione d’insieme della più recente letteratura, si può ad esempio ricordare un intero fascicolo
del “Journal of Medicine and Philosophy”, 23 (1998), 2 dedicato all’esplorazione del tema dell’etica della
cura e delle sue implicazioni pratiche.
4
S. Wolf, Gender, Feminism, and Death. Physician-Assisted Suicide and Euthanasia, cit., p. 289.
2
2
approssimazione, ci sembra di poter dunque affermare che, secondo l’analisi di Wolf, la capacità
delle pazienti terminali di compiere scelte autonome risulti drammaticamente in pericolo a causa di
un ambiente socio-economico che le pone in condizioni di svantaggio rispetto agli uomini.
Ma questo ancora non è sufficiente a delineare il quadro complessivo entro cui si instaura una
relazione di cura. Wolf ricorda che anche il personale che presta assistenza ai malati terminali può
subire l’influsso del contesto culturale e sociale e, quindi, rispondere in modo differente a richieste
di aiuto per morire rivolte da uomini o da donne: la valorizzazione del sacrificio femminile ed un
retroterra “sessista” possono influenzare la propensione del medico a favorire la scelta di una
paziente che chiede di morire.6 Il giudizio relativo alla mancanza di significato della vita di una
malata terminale, o l’idea che essa possa rappresentare un peso per la famiglia, possono diventare
elementi decisivi nell’orientare la risposta del medico chiamato da una donna a porre fine alla sua
vita. Inoltre un rapporto medico-paziente fondato sul potere del primo nei confronti della seconda, il
paternalismo nella sua forma arcaica di “padre-padrone”, può essere un condizionamento
psicologico e culturale decisivo nel dare la morte.
Carenze relazionali ed assistenziali, difficoltà personali ad affrontare la malattia ed il dolore
assumono importanza decisiva nell’analisi del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria: Wolf
motiva il rifiuto di tali pratiche facendo appello al contesto sociale entro cui si genera la domanda
di morire. Secondo l’autrice negli U.S.A. a molti milioni di individui sono negate le risorse per
affrontare gravi malattie, il controllo del dolore e le cure palliative sono mal gestiti, e c’è ancora una
lunga strada da percorrere prima di vedere proclamati nel contesto clinico i diritti di rifiutare i
trattamenti di sostegno ed impiegate le direttive anticipate: in queste condizioni è pericoloso pensare
alla legalizzazione dell’assistenza al suicidio e dell’eutanasia.7 Per sottolineare questo fatto Wolf
ricorda che chi scrive a sostegno delle proposte di legge per disciplinare tali pratiche propone
diversi criteri per stabilire se la richiesta di aiuto per morire di un paziente possa essere soddisfatta.
Tuttavia, le linee guida ed i criteri elaborati a tal fine non contemplano “una approfondita analisi
delle condizioni in cui vive il paziente, l’eventuale condizione di solitudine, la disponibilità di
coperture assicurative per l’assistenza sanitaria. I criteri non impongono al medico di stabilire il
genere del paziente, o se taluni stereotipi abbiano svolto un ruolo nella risposta del medico alla
richiesta del paziente”.8
Il problema dell’eutanasia e dell’assistenza al suicidio è analizzato da Wolf anche sotto il profilo
deontologico: il medico è un professionista che deve operare in base a precisi ruoli e obblighi
5
Ivi, p. 291.
Ivi, p. 293.
7
Ci sembra che questa affermazione di Wolf possa essere efficacemente impiegata per descrivere l’attuale
situazione del nostro Paese dove, nonostante gli sforzi di quanti sono impegnati nel portare sollievo al dolore
dei malati terminali, c’è ancora molto lavoro da fare per estendere sul territorio nazionale le cure palliative.
8
Ivi, p. 306.
6
3
professionali. Gli obblighi tradizionali del medico a non arrecare danno e non somministrare
farmaci letali anche se richiesti non possono certo essere ignorati o abbandonati, almeno non senza
una adeguata discussione.
Come devono comportarsi i medici di fronte alla volontà del paziente di morire ed alla sua
eventuale richiesta di essere aiutato a farlo? Wolf adotta un approccio etico fondato sul prendersi
cura (caring) associato alla beneficialità (beneficence), ritenuti parti costitutive della professione
medica; la nozione del principled caring, ovvero del “prendersi cura orientato da principi” riesce a
formulare un approccio in cui il prendersi cura, che dà una risposta empatica ai bisogni del paziente,
è coniugato alla necessità di prevedere limiti e norme, in grado di articolare degli obblighi per il
personale medico, eventualmente poi soggetti a riconsiderazione e modifiche. Secondo tale
approccio, in modo particolare quando assistono i malati terminali, i medici hanno il dovere di
aumentare il proprio impegno; adottare gli strumenti necessari per il controllo del dolore; rispettare
il diritto dei pazienti di rifiutare il sostegno vitale e di far uso delle direttive anticipate; ascoltare ed
analizzare tutte le richieste del paziente, inclusi i pensieri di suicidio perché siano di stimolo a
ricercare nuovi modi per affrontare il dolore; evitare di fuggire davanti alla sofferenza.
In conclusione Wolf, quasi ad anticipare sul tempo le critiche alla sua posizione, ricorda che i
principi della pratica medica sono soggetti a nuove valutazioni, a modifiche, ed antiche proibizioni
al suicidio assistito e all’eutanasia non eliminano “per incanto” le attuali proposte di cambiamento
che vorrebbero il medico impegnato per dare la morte ai malati che espressamente la chiedano. Ma
secondo Wolf sarebbe impensabile realizzare un cambiamento della professione medica soltanto
sulla base della fiducia che tale cambiamento non spingerà i medici verso una pratica inaccettabile.
Secondo Wolf la storia del modo di morire proprio delle donne, i significati sociali che nel corso del
tempo hanno giustificato la morte delle donne, le condizioni che possono motivare la richiesta delle
donne, e l’ovvio fatto che la medicina si esercita in un contesto sociale in grado di condizionare la
professione medica, mostrano che la fiducia nel cambiamento è mal riposta.9
L’autrice non dimentica di precisare che forse alcune pensatrici femministe potranno vedere in
modo diverso il problema dell’assistenza al suicidio e dell’eutanasia. Donne con un pieno controllo
della propria vita, insensibili all’influenza di età, razza o condizioni economiche e desiderose di
un’ulteriore opzione da aggiungere a quelle che già possiedono, potranno non condividere la sua
analisi. Ma ciò non può fare dimenticare il contesto e le dinamiche sociali che generano la domanda
di essere aiutati a morire.
Proporre l’eutanasia o il suicidio assistito ad un paziente non vulnerabile, secondo Wolf, è ben
diverso dal proporre di prestare assistenza per morire ad una donna di colore, priva di assistenza
9
Ivi, p. 307.
4
sanitaria, alla quale il personale di pronto soccorso di un ospedale cittadino comunica una diagnosi
con prognosi infausta.10
Alcuni potrebbero criticare le conclusioni di Wolf sostenendo che la concezione di professione
medica adottata dall’autrice, secondo la quale l’etica professionale di derivazione ippocratica vieta
al medico la possibilità di intervenire per concludere la vita di un malato, anche se fosse questi a
chiederlo, si può ritenere superata. Ciò meriterebbe un approfondimento che risulta impossibile in
questa la sede; ricordiamo soltanto che nel dibattito non esiste unanimità di visioni a proposito dei
divieti imposti al medico dalla sua etica professionale e rimandiamo alla letteratura che è
specificamente dedicata a questo tema.11
Il limite dell’approccio di Wolf è quello – del resto comune a molti altri – di non uscire dalla
logica bilaterale medico-paziente quando si parla dell’eutanasia: seppure presti molta attenzione
all’analisi del contesto sociale entro cui si situa la richiesta di morte, l’autrice trascura il fatto che
tale richiesta coinvolge più soggetti, non soltanto il medico ed il paziente, ma tutti coloro che hanno
legami profondi con quest’ultimo. L’unica contestualizzazione seriamente ammessa è quella del
genere del paziente e dei “pericoli” legati all’appartenenza a quel genere.
Anche l’idea femminista sottesa all’argomentazione di Wolf, il medico (maschio) uccide un
paziente (femmina) può essere facilmente criticabile: non è da escludere che, sotto il profilo dei
rapporti sociali esistenti, il dominio dell’uomo sulla donna si trasformi in questo caso nel classico
paternalismo medico (il che porta Wolf ad escludere l’eutanasia) ma, anche in questo caso, il
problema sociale va distinto da quello etico.
Si può condividere l’idea che l’eutanasia non dovrebbe essere praticata quando ci si rende conto
del fatto che la richiesta di morire non è veramente libera, perché dipendente da altri fattori
(abbandono e così via), ma non possiamo escludere che uomini e anche donne chiedano di morire
perché vogliono una morte dignitosa; vogliono morire per non essere ridotti ad una condizione che
essi reputano lesiva per la loro dignità. Ma, a questo proposito, bisognerebbe aprire una parentesi
10
Uno studio retrospettivo condotto su donne colpite da cancro o malattie croniche e di età superiore a 55
anni che, nel 1997 nella Oakland County (Michigan, U.S.A.), sono morte con l’assistenza di Jack Kevorkian,
il tristemente noto Doctor Death statunitense, ha mostrato che l’assenza di trattamenti inadeguati per il
controllo del dolore sembra essere stata determinante nell’indirizzare tali donne verso la decisione di morire.
A ciò, in alcuni casi, si è aggiunta la sensazione di isolamento e disperazione prodotta dalla condizione di
solitudine in cui vivevano alcune delle pazienti colpite da malattia cronica. Cfr. L.A. Roscoe, J.E. Malphurs,
L.J. Dragovic, D. Cohen, Antecedents of Euthanasia and Suicide Among Older Women, in “Journal of the
American Medical Women’s Association”, 58, 2003, pp. 44-48.
11
Tra i critici della visione che ricollega alla tradizione ippocratica il dovere del medico di astenersi dal
prestare assistenza per morire si possono citare ad esempio: J. Rachels, La fine della vita. La moralità
dell’eutanasia, trad. it., Torino 1989; G. Dworkin, La natura della medicina, in G. Dworkin, R. Frey, S. Bok,
Eutanasia e suicidio assistito. Pro e contro, trad. it., Torino 2001, pp. 5-17, mentre tra i suoi sostenitori L.R.
Kass, Neither for Love Nor for Money. Why Doctors Must Not Kill, in “The Public Interest”, 4 (1989), pp.
25-46; H. Jonas, Tecniche di differimento della morte e il diritto di morire, in H. Jonas, Tecnica, medicina ed
etica. Prassi del principio responsabilità, trad. it., Torino 1999, pp. 185-205; R. Barcaro, P. Becchi,
5
per chiarire che cosa si intende esattamente con l’espressione “morte dignitosa”, dal momento che
con essa si suole indicare sia la morte ottenuta dal paziente mediante iniezione letale che deve porre
termine al dolore e alla sofferenza, sia la morte che giunge dopo un efficace programma di cure
palliative.12
3. Una conclusione per un nuovo inizio
I pregiudizi sociali, gli stereotipi, le dinamiche di potere che agiscono anche sulla medicina,
come del resto su tutte le attività umane, possono orientare le decisioni politiche in generale e di
politica pubblica e sanitaria in particolare. Se i condizionamenti presentati e discussi da Wolf
divenissero potenti al punto di spingerci a pensare che per i malati terminali, soprattutto se di sesso
femminile, sarebbe ragionevole chiedere di morire e quindi ricevere aiuto per porre fine alla vita,
sarebbe gioco-forza non destinare alla loro assistenza preziose e scarse risorse. Chi ha il potere di
deliberare gli stanziamenti a favore del sistema sanitario, i direttori generali delle aziende sanitarie, i
medici che operano nei reparti ospedalieri possono tramutare i pregiudizi nei confronti del malato
terminale in un criterio allocativo: senza le risorse necessarie per erogare assistenza e cure
palliative, il malato nell’impossibilità di affrontare i costi della spesa sanitaria sarà inevitabilmente
spinto a chiedere di morire, se questa dovesse essere l’unica opzione a lui offerta. Il contesto
socio-economico finirebbe così con il negare la possibilità di una scelta autenticamente libera e
razionale ed il rispetto di quell’autonomia alla quale si è fatto riferimento nell’apertura di questo
contributo. Non si deve pensare che la decisione di togliersi la vita o di chiedere aiuto per farlo
possa essere veramente libera, se al paziente non sono state fornite le informazioni sulle possibilità
di controllo del dolore, non sono state messe in atto le condizioni affinché gli possa essere fornita
l’assistenza – farmacologica e psicologica, come pure religiosa e spirituale - di cui egli necessita,
insomma se non esiste un efficace programma di cure palliative.
La medicina palliativa forse potrà non costituire la soluzione definitiva a tutti i problemi dei
pazienti terminali. Non sono rari i casi di pazienti che, seppure sottoposti con successo alle cure
palliative, scelgono il suicidio, giustificando la decisione con la volontà di non affrontare gli ultimi
giorni o settimane che restano, di non voler dipendere dagli altri, di non voler essere soggetti al
controllo di terzi o alle limitazioni di natura fisica che la malattia terminale impone loro, dopo aver
vissuto una vita significativa ed appagante.13
Eutanasia ed etica medica, in Bioetica medica e chirurgica, a cura di L. Battaglia, G. Macellari, Noceto (PR)
2002, pp. 141-156.
12
Cfr. R. Barcaro, Dignità della morte, accanimento terapeutico ed eutanasia, Napoli 2001.
13
Cfr. C. Moretti, Competenze infermieristiche nell’accompagnamento del paziente morente, Tesi di diploma
in scienze infermieristiche, Università degli Studi di Torino, a.a. 2000/2001. L’autrice dà notizia di alcuni casi
di suicidio verificatisi tra pazienti terminali sottoposti a cure palliative e seguiti da una équipe della Lega per
la Lotta contro i Tumori della provincia di Sanremo in Liguria. Si ringrazia l’autrice per avermi permesso di
leggere il suo lavoro e citarlo nel presente contributo.
6
Questa è però una faccia della medaglia: per affrontare il problema della malattia terminale è
necessario vedere anche l’altra, e fondare su nuove basi la discussione del problema dell’eutanasia
volontaria e del suicidio assistito. Un passo certamente molto importante è quello di smascherare gli
stereotipi e le discriminazioni che agiscono nel contesto sociale ed influenzano le visioni di salute e
malattia che si trovano alla base delle scelte di ogni essere umano. Un secondo passo è cercare di
colmare il divario tra ciò che si potrebbe fare per alleviare il dolore e ciò che in realtà viene fatto: si
tratta di un divario ancora troppo ampio, che rischia di diventare incolmabile se non si attuano gli
interventi necessari per potenziare le prestazioni di medicina palliativa. Da tempo gli operatori di
cure palliative stanno lavorando in questa direzione: lo testimoniano l’attività di fondazioni ed
associazioni diffuse sul territorio nazionale (purtroppo con una maggiore concentrazione al
Centro-Nord), ed anche il Comitato Nazionale per la Bioetica, in più occasioni discutendo le
questioni di fine vita (in particolare con i documenti del 1995 e del 2001), 14 ha recepito
l’importanza morale di alleviare dolore e sofferenza in nome della dignità dell’essere umano e di
rendere gratuitamente disponibili le terapie antalgiche ai pazienti morenti.
Siamo consapevoli che la scelta di questa via è sicuramente faticosa, dispendiosa sotto il profilo
economico, sociale, politico, ma può dare luogo ad un approccio diverso alle questioni di fine vita,
autenticamente rispettoso di valori e visioni culturali e religiose differenti che si incarnano
nell’esistenza di ogni essere umano.
(Pubblicato in: Medicina ed etica di fine vita, a cura di M. Coltorti, “Centro Interuniversitario di
Ricerca Bioetica – Quaderno n. 3”, Napoli 2004, pp. 211-221).
14
Comitato Nazionale per la Bioetica, Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana, Roma, 14
luglio 1995; Id., La terapia del dolore: orientamenti bioetici, Roma, 30 marzo 2001.
7