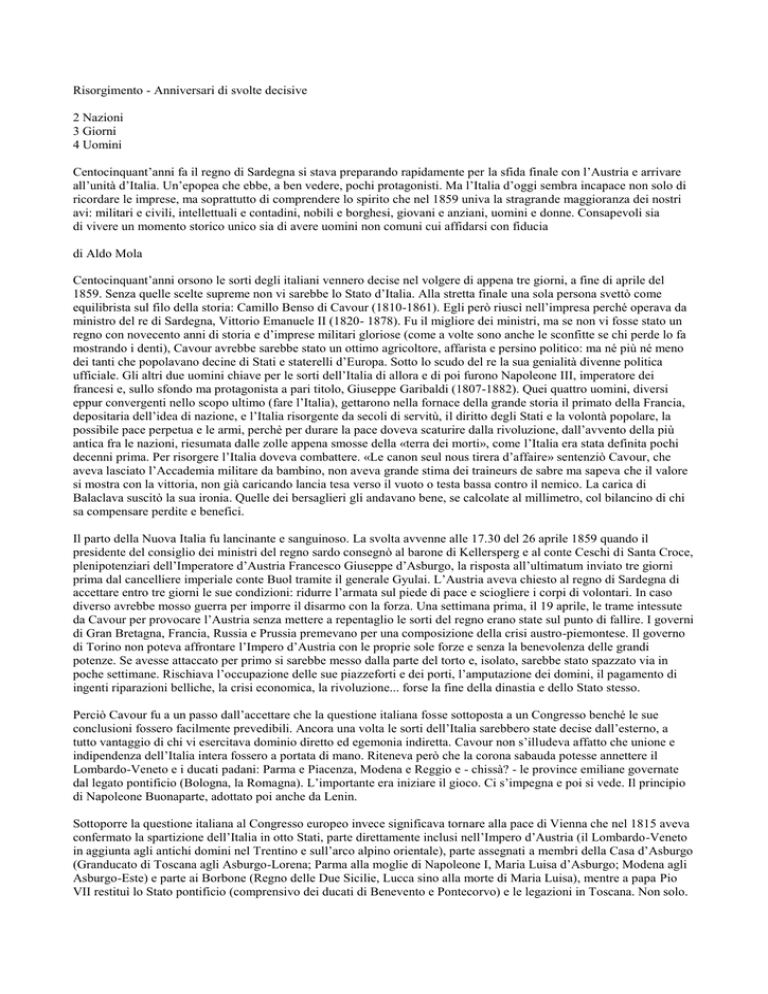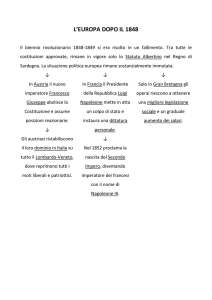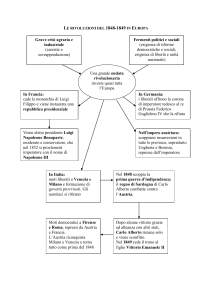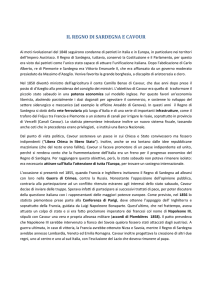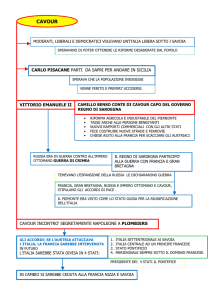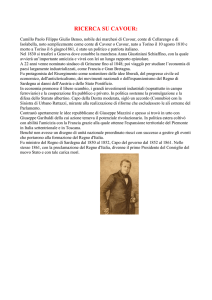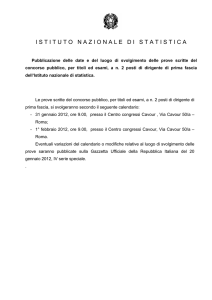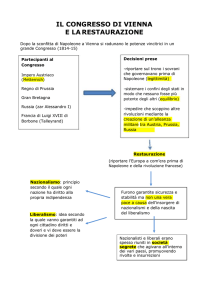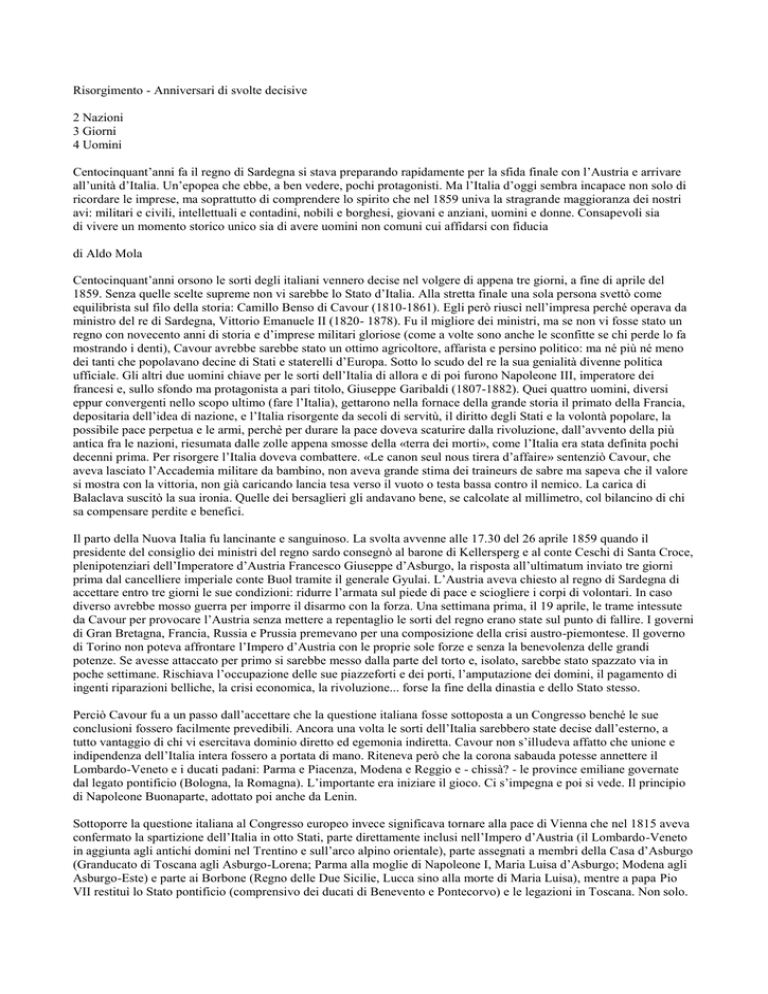
Risorgimento - Anniversari di svolte decisive
2 Nazioni
3 Giorni
4 Uomini
Centocinquant’anni fa il regno di Sardegna si stava preparando rapidamente per la sfida finale con l’Austria e arrivare
all’unità d’Italia. Un’epopea che ebbe, a ben vedere, pochi protagonisti. Ma l’Italia d’oggi sembra incapace non solo di
ricordare le imprese, ma soprattutto di comprendere lo spirito che nel 1859 univa la stragrande maggioranza dei nostri
avi: militari e civili, intellettuali e contadini, nobili e borghesi, giovani e anziani, uomini e donne. Consapevoli sia
di vivere un momento storico unico sia di avere uomini non comuni cui affidarsi con fiducia
di Aldo Mola
Centocinquant’anni orsono le sorti degli italiani vennero decise nel volgere di appena tre giorni, a fine di aprile del
1859. Senza quelle scelte supreme non vi sarebbe lo Stato d’Italia. Alla stretta finale una sola persona svettò come
equilibrista sul filo della storia: Camillo Benso di Cavour (1810-1861). Egli però riuscì nell’impresa perché operava da
ministro del re di Sardegna, Vittorio Emanuele II (1820- 1878). Fu il migliore dei ministri, ma se non vi fosse stato un
regno con novecento anni di storia e d’imprese militari gloriose (come a volte sono anche le sconfitte se chi perde lo fa
mostrando i denti), Cavour avrebbe sarebbe stato un ottimo agricoltore, affarista e persino politico: ma né più né meno
dei tanti che popolavano decine di Stati e staterelli d’Europa. Sotto lo scudo del re la sua genialità divenne politica
ufficiale. Gli altri due uomini chiave per le sorti dell’Italia di allora e di poi furono Napoleone III, imperatore dei
francesi e, sullo sfondo ma protagonista a pari titolo, Giuseppe Garibaldi (1807-1882). Quei quattro uomini, diversi
eppur convergenti nello scopo ultimo (fare l’Italia), gettarono nella fornace della grande storia il primato della Francia,
depositaria dell’idea di nazione, e l’Italia risorgente da secoli di servitù, il diritto degli Stati e la volontà popolare, la
possibile pace perpetua e le armi, perchè per durare la pace doveva scaturire dalla rivoluzione, dall’avvento della più
antica fra le nazioni, riesumata dalle zolle appena smosse della «terra dei morti», come l’Italia era stata definita pochi
decenni prima. Per risorgere l’Italia doveva combattere. «Le canon seul nous tirera d’affaire» sentenziò Cavour, che
aveva lasciato l’Accademia militare da bambino, non aveva grande stima dei traineurs de sabre ma sapeva che il valore
si mostra con la vittoria, non già caricando lancia tesa verso il vuoto o testa bassa contro il nemico. La carica di
Balaclava suscitò la sua ironia. Quelle dei bersaglieri gli andavano bene, se calcolate al millimetro, col bilancino di chi
sa compensare perdite e benefici.
Il parto della Nuova Italia fu lancinante e sanguinoso. La svolta avvenne alle 17.30 del 26 aprile 1859 quando il
presidente del consiglio dei ministri del regno sardo consegnò al barone di Kellersperg e al conte Ceschi di Santa Croce,
plenipotenziari dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe d’Asburgo, la risposta all’ultimatum inviato tre giorni
prima dal cancelliere imperiale conte Buol tramite il generale Gyulai. L’Austria aveva chiesto al regno di Sardegna di
accettare entro tre giorni le sue condizioni: ridurre l’armata sul piede di pace e sciogliere i corpi di volontari. In caso
diverso avrebbe mosso guerra per imporre il disarmo con la forza. Una settimana prima, il 19 aprile, le trame intessute
da Cavour per provocare l’Austria senza mettere a repentaglio le sorti del regno erano state sul punto di fallire. I governi
di Gran Bretagna, Francia, Russia e Prussia premevano per una composizione della crisi austro-piemontese. Il governo
di Torino non poteva affrontare l’Impero d’Austria con le proprie sole forze e senza la benevolenza delle grandi
potenze. Se avesse attaccato per primo si sarebbe messo dalla parte del torto e, isolato, sarebbe stato spazzato via in
poche settimane. Rischiava l’occupazione delle sue piazzeforti e dei porti, l’amputazione dei domini, il pagamento di
ingenti riparazioni belliche, la crisi economica, la rivoluzione... forse la fine della dinastia e dello Stato stesso.
Perciò Cavour fu a un passo dall’accettare che la questione italiana fosse sottoposta a un Congresso benché le sue
conclusioni fossero facilmente prevedibili. Ancora una volta le sorti dell’Italia sarebbero state decise dall’esterno, a
tutto vantaggio di chi vi esercitava dominio diretto ed egemonia indiretta. Cavour non s’illudeva affatto che unione e
indipendenza dell’Italia intera fossero a portata di mano. Riteneva però che la corona sabauda potesse annettere il
Lombardo-Veneto e i ducati padani: Parma e Piacenza, Modena e Reggio e - chissà? - le province emiliane governate
dal legato pontificio (Bologna, la Romagna). L’importante era iniziare il gioco. Ci s’impegna e poi si vede. Il principio
di Napoleone Buonaparte, adottato poi anche da Lenin.
Sottoporre la questione italiana al Congresso europeo invece significava tornare alla pace di Vienna che nel 1815 aveva
confermato la spartizione dell’Italia in otto Stati, parte direttamente inclusi nell’Impero d’Austria (il Lombardo-Veneto
in aggiunta agli antichi domini nel Trentino e sull’arco alpino orientale), parte assegnati a membri della Casa d’Asburgo
(Granducato di Toscana agli Asburgo-Lorena; Parma alla moglie di Napoleone I, Maria Luisa d’Asburgo; Modena agli
Asburgo-Este) e parte ai Borbone (Regno delle Due Sicilie, Lucca sino alla morte di Maria Luisa), mentre a papa Pio
VII restituì lo Stato pontificio (comprensivo dei ducati di Benevento e Pontecorvo) e le legazioni in Toscana. Non solo.
Il Congresso europeo (fortemente voluto da Napoleone III) avrebbe ribadito l’egemonia straniera instaurata sull’Italia
con la pace di Cateau-Cambrésis tra Impero e Francia (1559) e che né i moti costituzionali (1820-21), né le cospirazioni
liberali, né le associazioni repubblicane (come la Giovine Italia fondata nel 1831 da Giuseppe Mazzini) o le correnti
federaliste e le società segrete (carbonari, massoni e altri gruppi) erano riuscite a smuovere. Nel clima plumbeo della
seconda restaurazione del 1849, nuovi tentativi insurrezionali erano miseramente naufragati. Nel febbraio 1853 a
Milano fallì l’ennesima trama mazziniana. Anziché in migliaia al momento buono si contarono poche decine di
cospiratori. La repressione austriaca fu durissima: impiccagioni e carcere duro. Altri patiboli stroncarono i patrioti a
Mantova, ove vennero impiccati, tra altri, don Enrico Napoleone Tazzoli, e il medico Carlo Poma. Nel 1857 la
spedizione organizzata da Carlo Pisacane per rovesciare il governo borbonico a Napoli non ebbe miglior sorte di quella
dei fratelli Emilio ed Attilio Bandiera nel 1844. Pisacane venne ammazzato sul campo, molti suoi seguaci finirono
scannati, altri caddero prigionieri: un disastro.
L’«Italia» portava male? Sì, se avesse continuato a vestire in nero come faceva Mazzini. Dal 1855-56 tuttavia lo
scenario mutò. Il regno di Sardegna partecipò con un proprio corpo di spedizione in Crimea alla guerra di Gran
Bretagna, Francia e Impero turco contro l’Impero russo, che agognava a controllare gli Stretti fra Mar Nero e
Mediterraneo e non aveva mai rinunciato ad accampare prerogative sui Luoghi Santi. Nel congresso di pace, a Parigi, il
presidente del consiglio del governo sardo, Cavour, riuscì a togliere la questione italiana dal cono d’ombra nel quale le
grandi potenze preferivano relegarlo perché vi erano altre priorità: il futuro delle monarchie nella penisola iberica,
ormai prive delle colonie americane, il controllo del Mediterraneo, anche per le prospettive aperte dall’apertura del
Canale di Suez, ormai in progetto, gli equilibri tra potenze europee e quegli Stati Uniti d’America che nel 1854
costringevano il Giappone ad aprirsi alle esportazioni, a tacere della nuova ondata di espansionismo coloniale.
Gli eventi del 1859-60 fecero poi credere che l’intervento di Cavour al Congresso di Parigi sia stato necessario e
sufficiente all’avvento dell’unità d’Italia. In realtà esso fu solo uno dei presupposti, importante, ma solo perchè si saldò
con altri pezzi del grande gioco, non meno decisivi e solo in parte voluti dal Gran Conte. Il primo e più importante
fattore della svolta fu la forza militare del regno di Sardegna, uscito provato ma non distrutto dalla guerra del 1848-49.
L’eroismo di Carlo Alberto si sostanziò proprio nella decisione di abdicare la sera della battaglia di Novara (23 marzo
1849) ove il Piemonte ebbe meno morti feriti e dispersi di quelli dell’esercito asburgico. Il re ebbe chiaro che la
prosecuzione della guerra avrebbe condotto alla catastrofe. Lasciò la corona a chi avrebbe continuato l’impresa. A
Vittorio Emanuele II il suo «governatore» Cesare Saluzzo di Monesiglio donò la spada di Napoleone I: un pegno.
Malgrado tutto (l’occupazione austriaca della piazzaforte di Alessandria, un gravoso indennizzo, la lacerazione alla
Camera fra un’estrema sinistra parolaia e i conservatori ultrapapisti), il regno di Sardegna divenne approdo degli esuli
politici da tutta Italia. Nei loro Stati i patrioti venivano incarcerati e detenuti per anni senza processo o deportati oltre
Atlantico o persino morivano di stenti. Il «Piemonte» conservò Statuto e libertà di stampa. Sotto la sferza di Alfonso La
Marmora, organizzò un esercito sempre più preparato, anche con scuole di ginnastica obbligatorie per ufficiali e truppa.
Dopo alcuni anni di prudente esilio Giuseppe Garibaldi rientrò nei confini del regno, a Caprera. Aveva mostrato di doti
di comandante, era l’astro dei volontari e, soprattutto, non era punto dall’estro ideologico. Sapeva primeggiare senza
salire sul podio più alto, dove anche per l’Eroe dei due Mondi erano e dovevano stare «Italia e Vittorio Emanuele».
Dall’inizio del 1859, giusto centocinquant’anni fa, decine, centinaia, migliaia di giovani affluirono da varie regioni in
Piemonte per dar man forte nella guerra contro l’Austria, che ormai si sentiva nell’aria. Si sommarono alle migliaia di
regnicoli pronti a scendere in campo. Consigli provinciali e comunali, società di mutuo soccorso, circoli di lettura,
comitati patriottici diffondevano proclami, musiche, canti, entusiasmi. L’entusiasmo aveva anche una vena di
liberazione istintuale. Eran d’esempio la virtù della «Bella Gigogin» («A quindici anni facevo all’amore.../daghela
avanti un passo,/delizia del mio core!/ a sedici anni ho preso marito.../ a diciassette mi sono spartita...») e il fervore del
suo amante («Le baciai, le baciai il bel visetto,/La mi disse, la mi disse: oh che diletto!/là più basso, la più basso,/ in
quel boschetto /cium cium cium/ andremo, andremo andremo a riposà...». Di passo in passo, di mese in mese, dopo
l’attentato alla vita di Napoleone III da parte di Felice Orsini che prima di salire sul patibolo chiese all’imperatore di
schierarsi per l’Italia; dopo gli accordi segreti di Plombières tra Napoleone III e Cavour, dopo innumerevoli travagli,
ansie, trame d’ogni genere l’imperatore fu sul punto di optare per il Congresso di pace. Cavour raggiunse il culmine
della disperazione. Il 19 aprile esclamò sconsolato: «Non mi rimane che spararsi e farmi saltare le cervella». A Giacinto
Corio, che ne amministrava i beni a Livorno Vercellese, scrisse. «Non si dia più verun fastidio per la vendita dei buoi
grassi, giacché pare che la guerra più non si faccia. Salveremo le vacche ma perderemo la causa italiana, che pareva
prossima ad una soluzione favorevole. L’imperatore è stato ingannato ed è traditore. Ci ha fatto un danno irreparabile
col costringerci al disarmo. Credo che potrò fra breve abbandonare il ministero che aborro per andarmi a stabilire a Leri
in modo definitivo». Cavour sarebbe stato travolto dall’indignazione dei liberali di tutt’Italia e dei Cacciatoti delle Alpi,
agli ordini di Giuseppe Garibaldi, che aveva disciplinatamente accettato la nomina a maggior generale perché se Parigi
valeva bene una messa per l’ugonotto Enrico IV di Borbone per lui l’Italia valeva pure una divisa da generale del Regio
Esercito.
Il 26 aprile, dunque, vinse l’arroganza dell’Imperatore d’Austria che, vinta la partita diplomatica sul piano europeo,
voleva umiliare il «piccolo regno di Sardegna» esigendone il disarmo. Il governo, vale a dire la somma dei suoi tre
grandi uomini Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi, rifiutò. Scattò lo stato di guerra, non preparata, non voluta e
tuttavia dichiarata, per l’inconsulta arroganza che ispirò Francesco Giuseppe nel suo lungo regno; ed esso determinò
l’intervento di Napoleone III vincolato non solo da Plombières ma dalla sua storia personale, dall’idea incarnata dalla
Francia, dall’ombra del suo grande zio. In poche settimane arrivarono le vittorie: Magenta, l’ingresso dell’imperatore e
del re in Milano, Solferino e San Martino, insomma un moto che non sarebbe stato fermato né dall’armistizio di
Villafranca né dalla pace di Zurigo. Neppure un anno dopo l’impresa dei Mille confermò che i giovani non si
limitavano a cantare la «Bella Gigogin». Luigi Mercantini aveva insegnato il canto nuovo: «Si scopron le tombe, si
levano i morti/i martiri nostri son tutti risorti!/ Le spade nel pugno, gli allori alle chiome/ la fiamma ed il nome d’Italia
sul cor...», sino a «Va fuori d’Italia, va fuori ch’è l’ora/ va fuori d’Italia, va fuori stranier!»: in inno nazionale di sempre
vivida attualità. Anziché farsi saltare le cervella Cavour riprese la guida del governo. Il 17 marzo 1861 venne
proclamato il regno d’Italia. Il 150° della seconda guerra d’indipendenza sta passando sotto silenzio. Sarà così anche per
quello della «unità d’Italia»? Ormai manca poco all’appuntamento. Ma se confrontiamo questo 2009-2011 con quanto
seppe fare l’Italia di Giovanni Gronchi e di Segni, Tambroni e Fanfani nel 1959-1961 ci cadono le braccia e diciamo
anche noi che si stava meglio quando si stava peggio.
Aldo A. Mola
[email protected]