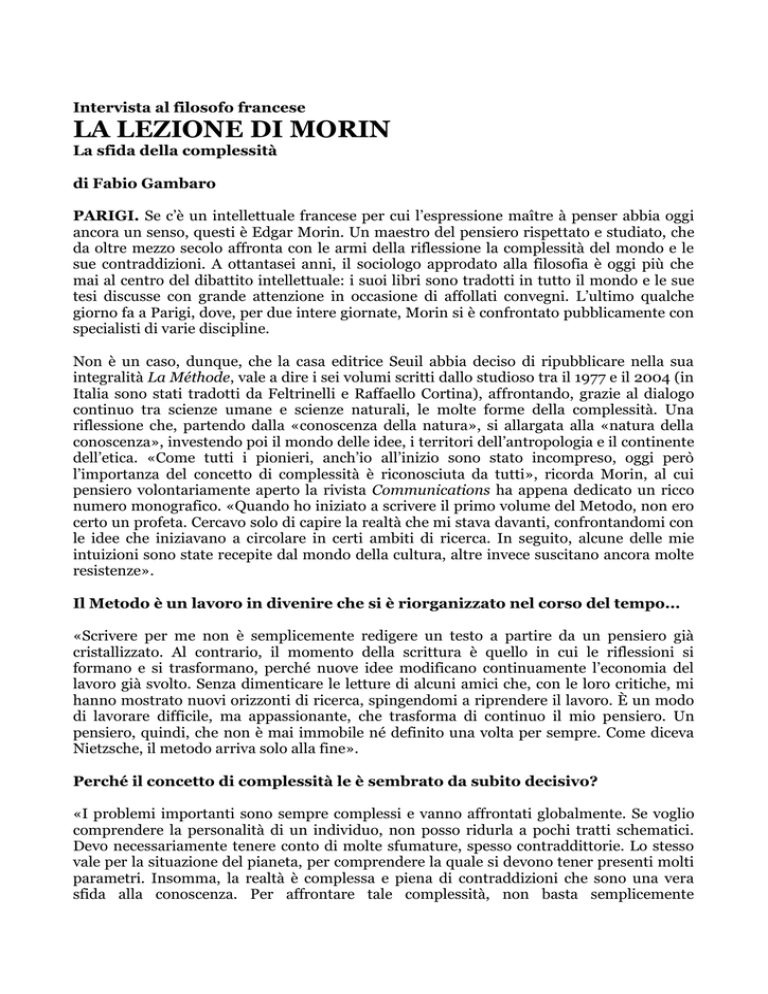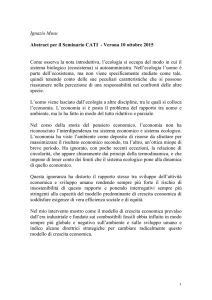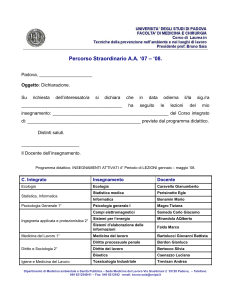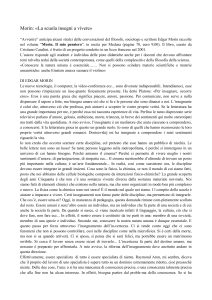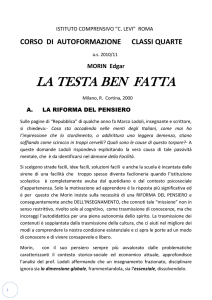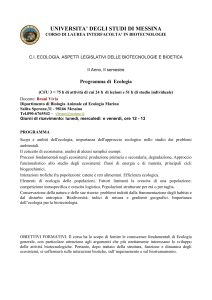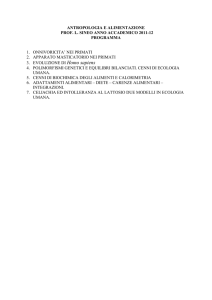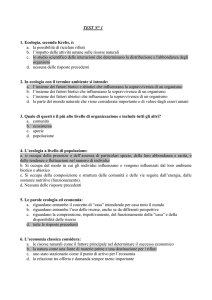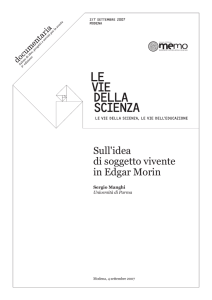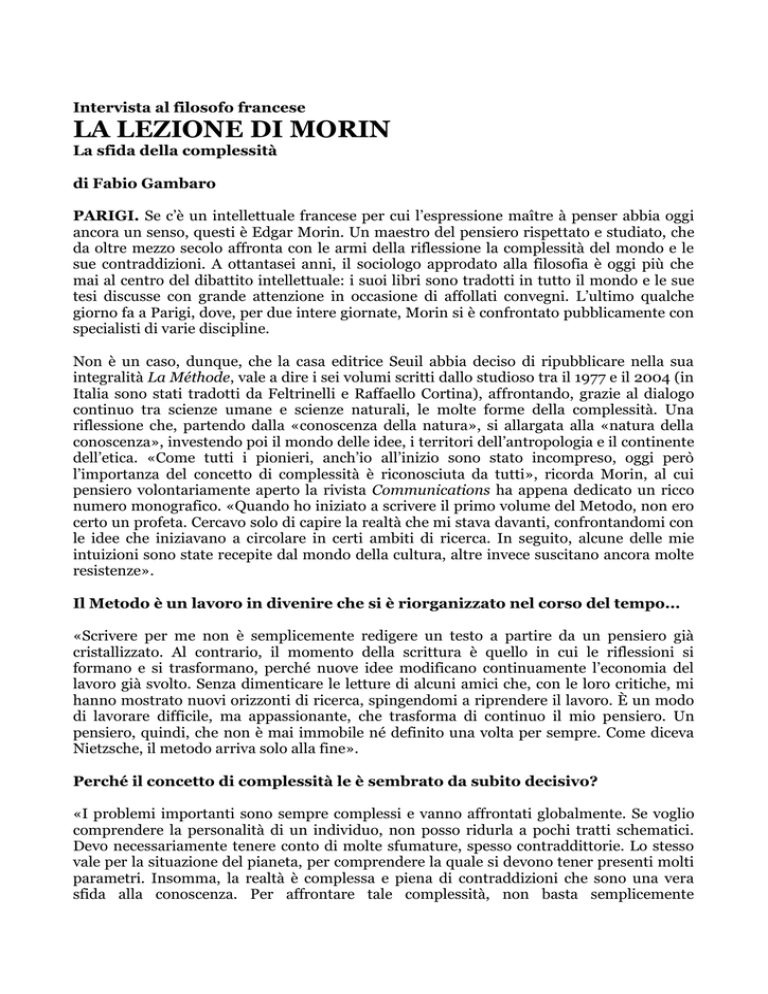
Intervista al filosofo francese
LA LEZIONE DI MORIN
La sfida della complessità
di Fabio Gambaro
PARIGI. Se c’è un intellettuale francese per cui l’espressione maître à penser abbia oggi
ancora un senso, questi è Edgar Morin. Un maestro del pensiero rispettato e studiato, che
da oltre mezzo secolo affronta con le armi della riflessione la complessità del mondo e le
sue contraddizioni. A ottantasei anni, il sociologo approdato alla filosofia è oggi più che
mai al centro del dibattito intellettuale: i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo e le sue
tesi discusse con grande attenzione in occasione di affollati convegni. L’ultimo qualche
giorno fa a Parigi, dove, per due intere giornate, Morin si è confrontato pubblicamente con
specialisti di varie discipline.
Non è un caso, dunque, che la casa editrice Seuil abbia deciso di ripubblicare nella sua
integralità La Méthode, vale a dire i sei volumi scritti dallo studioso tra il 1977 e il 2004 (in
Italia sono stati tradotti da Feltrinelli e Raffaello Cortina), affrontando, grazie al dialogo
continuo tra scienze umane e scienze naturali, le molte forme della complessità. Una
riflessione che, partendo dalla «conoscenza della natura», si allargata alla «natura della
conoscenza», investendo poi il mondo delle idee, i territori dell’antropologia e il continente
dell’etica. «Come tutti i pionieri, anch’io all’inizio sono stato incompreso, oggi però
l’importanza del concetto di complessità è riconosciuta da tutti», ricorda Morin, al cui
pensiero volontariamente aperto la rivista Communications ha appena dedicato un ricco
numero monografico. «Quando ho iniziato a scrivere il primo volume del Metodo, non ero
certo un profeta. Cercavo solo di capire la realtà che mi stava davanti, confrontandomi con
le idee che iniziavano a circolare in certi ambiti di ricerca. In seguito, alcune delle mie
intuizioni sono state recepite dal mondo della cultura, altre invece suscitano ancora molte
resistenze».
Il Metodo è un lavoro in divenire che si è riorganizzato nel corso del tempo...
«Scrivere per me non è semplicemente redigere un testo a partire da un pensiero già
cristallizzato. Al contrario, il momento della scrittura è quello in cui le riflessioni si
formano e si trasformano, perché nuove idee modificano continuamente l’economia del
lavoro già svolto. Senza dimenticare le letture di alcuni amici che, con le loro critiche, mi
hanno mostrato nuovi orizzonti di ricerca, spingendomi a riprendere il lavoro. È un modo
di lavorare difficile, ma appassionante, che trasforma di continuo il mio pensiero. Un
pensiero, quindi, che non è mai immobile né definito una volta per sempre. Come diceva
Nietzsche, il metodo arriva solo alla fine».
Perché il concetto di complessità le è sembrato da subito decisivo?
«I problemi importanti sono sempre complessi e vanno affrontati globalmente. Se voglio
comprendere la personalità di un individuo, non posso ridurla a pochi tratti schematici.
Devo necessariamente tenere conto di molte sfumature, spesso contraddittorie. Lo stesso
vale per la situazione del pianeta, per comprendere la quale si devono tener presenti molti
parametri. Insomma, la realtà è complessa e piena di contraddizioni che sono una vera
sfida alla conoscenza. Per affrontare tale complessità, non basta semplicemente
giustapporre frammenti di saperi diversi. Occorre trovare il modo per farli interagire
all’interno di una nuova prospettiva».
È ciò che ha fatto lei nel Metodo?
«In effetti, ho cercato di elaborare alcuni principi in grado di mettere in relazione quelle
conoscenze che gli strumenti tradizionali della conoscenza di solito non riescono a
collegare. Per questo ho utilizzato l’insegnamento di quei filosofi che non hanno avuto
paura di affrontare le contraddizioni, da Eraclito a Marx. Senza dimenticare Pascal, per il
quale l’uomo era l’essere più miserabile e grottesco, ma anche il più nobile».
Il terzo volume del Metodo è dedicato alla «conoscenza della conoscenza».
Perché?
«Questo è certamente il cuore del problema, giacché dobbiamo conoscere i meccanismi
della conoscenza, se vogliamo comprendere i nostri errori. Se le mie idee hanno incontrato
il favore di molte persone in ambiti diversi - dalla scienza alla letteratura, dalla filosofia alla
pedagogia - è perché costoro erano profondamente insoddisfatti di una cultura dominata
dal pensiero binario, fatta di opposizioni manichee che rimuovono ogni contraddizione.
Nel mio lavoro hanno trovato una prima risposta ai loro dubbi. Io però ho solo rivelato
intuizioni che, sebbene non formulate, erano probabilmente già presenti in molti studiosi.
Esiste un’aspirazione diffusa ad un altro modo d’intendere la conoscenza. Per questo, le
mie riflessioni hanno potuto diffondersi in molti paesi, tra cui anche l’Italia, dove il mio
lavoro è seguito ancor più che in Francia. Di ciò naturalmente sono molto soddisfatto,
anche se molto resta ancora da fare».
In quale direzione?
«Occorre occuparsi dell’insegnamento. La riforma della conoscenza e del pensiero potrà
concretizzarsi solo attraverso una riforma dell’insegnamento, una problematica a cui ho
dedicato La testa ben fatta e I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Il nostro
sistema d’insegnamento separa le discipline e spezzetta la realtà, rendendo di fatto
impossibile la comprensione del mondo e impedendoci di cogliere quei problemi
fondamentali che sono sempre globali. L’eccesso di specializzazione è diventato un
problema. Esperti molto competenti nel loro settore, non appena il loro ambito specifico è
traversato da altre problematiche, non sanno più come reagire. Avrebbero bisogno di
affrontare globalmente i problemi, ma non ne sono capaci».
Occorre un’ottica interdisciplinare?
«Certo, purtroppo però l’interdisciplinarietà avanza molto lentamente. Nel mondo della
ricerca francese i baroni delle singole discipline non sono assolutamente sensibili a tale
prospettiva. C’è però un movimento in corso, che io cerco d’incoraggiare.
L’interdisciplinarietà è positiva perché permette a persone che lavorano in campi diversi di
dialogare, ma occorrerebbe fare un ulteriore passo in avanti in direzione della
transdisciplinarietà, la sola capace di costruire un pensiero globale in grado di articolare i
diversi saperi. In fondo, esiste già una scienza che si muove in questo modo e che ci può
servire da modello».
Quale sarebbe?
«L’ecologia, che poggia sull’idea di ecosistema. Vale a dire, un’organizzazione complessa,
fondata al contempo sul conflitto e la cooperazione, che nasce dalla eco-organizzazione e
dall’implicazione reciproca delle diverse componenti del sistema. Facendo interagire molti
parametri diversi, l’ecologia è un esempio molto utile, anche se resta una scienza con una
dimensione aleatoria, dato che non siamo ancora capaci di rispondere a tutti i grandi
interrogativi che essa solleva. Tuttavia, anche le cosiddette scienze esatte sono sempre più
spesso costrette ad integrare la dimensione del dubbio e dell’incertezza. Nessuna scienza
può vantare esclusivamente certezze. Si pensi alle difficoltà dell’economia di fronte al
marasma dei mercati. Insomma, non bisogna mai eliminare il dubbio».
L’ecologia è un modello anche per il sistema della cultura? È per questo che
ha parlato di ecologia delle idee?
«È uno dei modelli, dato che anche in ambito culturale agiscono contemporaneamente i
principi di conflitto e di cooperazione. Partendo da questo punto di vista, è possibile
pensare in termini diversi anche la relazione tra autonomia e indipendenza. In natura non
si può essere indipendenti che dipendendo dal proprio ambiente. Ciò che vale per
l’ambiente biologico, vale anche per l’ambiente sociale, urbano, culturale, religioso.
Comprendere l’interdipendenza dei sistemi culturali e delle idee è oggi più che mai
necessario. Ciò contribuirà a cambiare il nostro modo di pensare, dandoci uno strumento
in più per sfuggire all’abisso verso cui il pianeta sembra essere destinato».
la Repubblica, 25.04.08