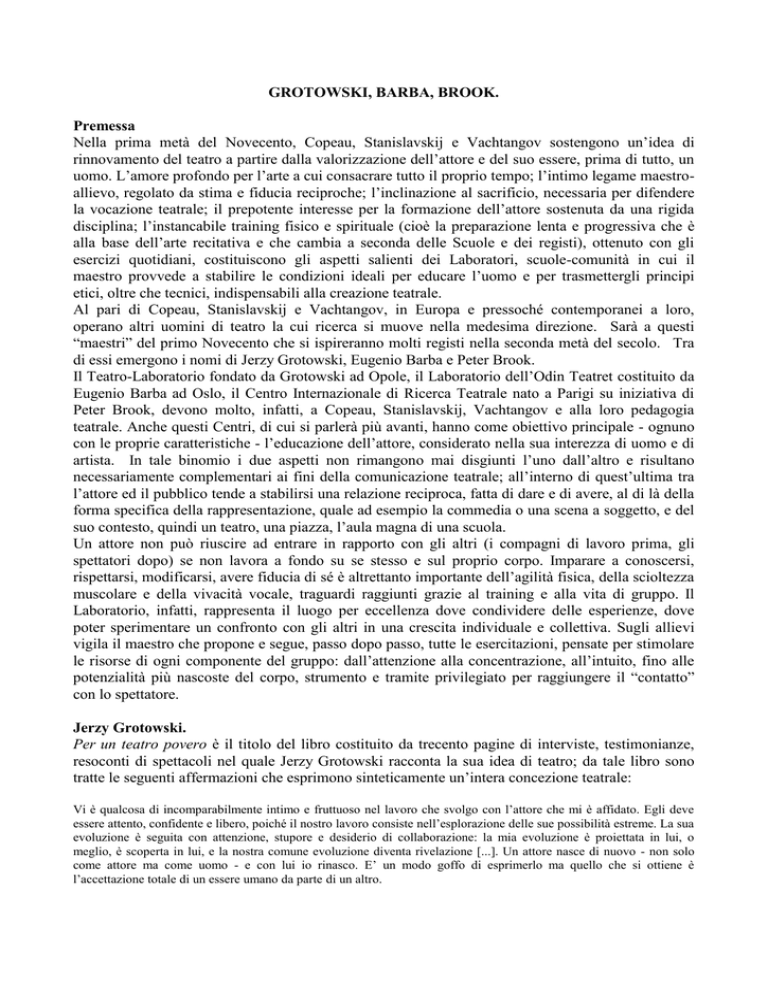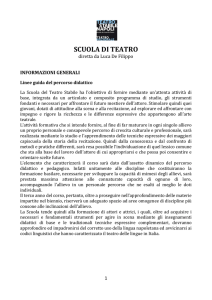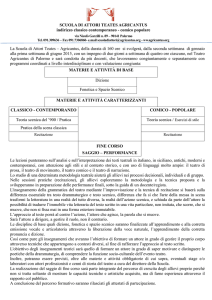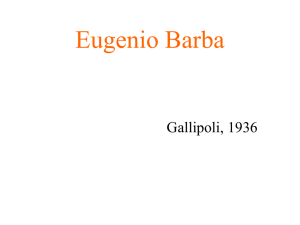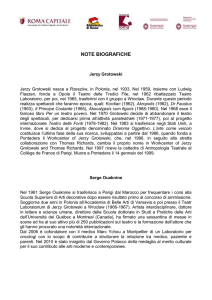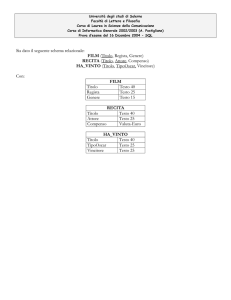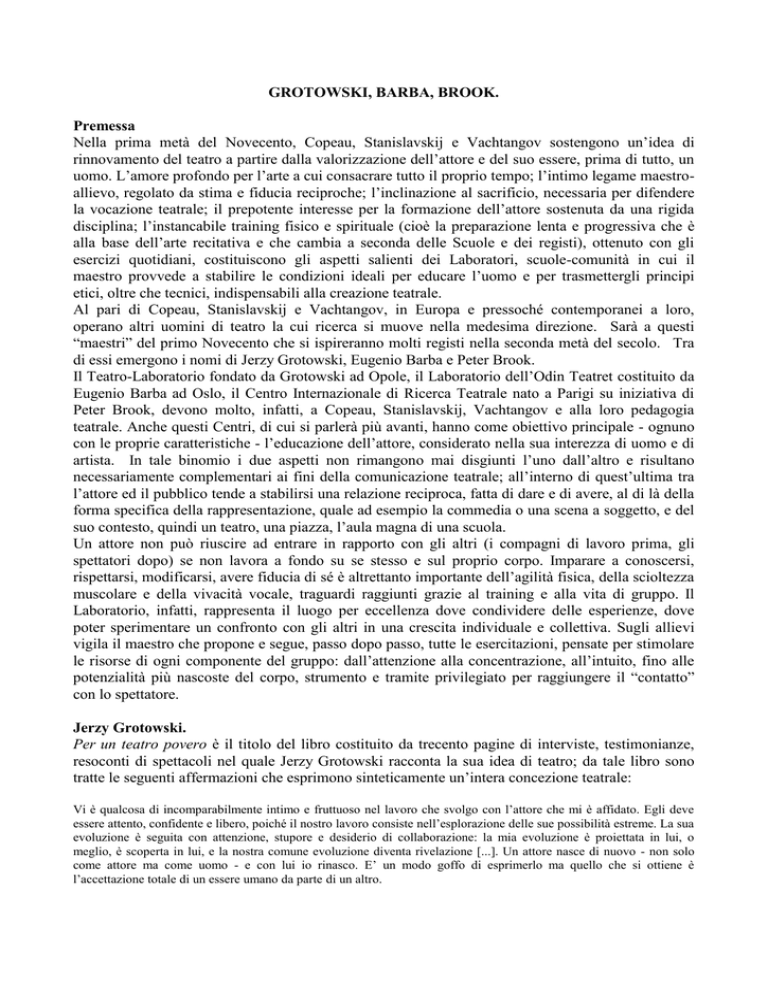
GROTOWSKI, BARBA, BROOK.
Premessa
Nella prima metà del Novecento, Copeau, Stanislavskij e Vachtangov sostengono un’idea di
rinnovamento del teatro a partire dalla valorizzazione dell’attore e del suo essere, prima di tutto, un
uomo. L’amore profondo per l’arte a cui consacrare tutto il proprio tempo; l’intimo legame maestroallievo, regolato da stima e fiducia reciproche; l’inclinazione al sacrificio, necessaria per difendere
la vocazione teatrale; il prepotente interesse per la formazione dell’attore sostenuta da una rigida
disciplina; l’instancabile training fisico e spirituale (cioè la preparazione lenta e progressiva che è
alla base dell’arte recitativa e che cambia a seconda delle Scuole e dei registi), ottenuto con gli
esercizi quotidiani, costituiscono gli aspetti salienti dei Laboratori, scuole-comunità in cui il
maestro provvede a stabilire le condizioni ideali per educare l’uomo e per trasmettergli principi
etici, oltre che tecnici, indispensabili alla creazione teatrale.
Al pari di Copeau, Stanislavskij e Vachtangov, in Europa e pressoché contemporanei a loro,
operano altri uomini di teatro la cui ricerca si muove nella medesima direzione. Sarà a questi
“maestri” del primo Novecento che si ispireranno molti registi nella seconda metà del secolo. Tra
di essi emergono i nomi di Jerzy Grotowski, Eugenio Barba e Peter Brook.
Il Teatro-Laboratorio fondato da Grotowski ad Opole, il Laboratorio dell’Odin Teatret costituito da
Eugenio Barba ad Oslo, il Centro Internazionale di Ricerca Teatrale nato a Parigi su iniziativa di
Peter Brook, devono molto, infatti, a Copeau, Stanislavskij, Vachtangov e alla loro pedagogia
teatrale. Anche questi Centri, di cui si parlerà più avanti, hanno come obiettivo principale - ognuno
con le proprie caratteristiche - l’educazione dell’attore, considerato nella sua interezza di uomo e di
artista. In tale binomio i due aspetti non rimangono mai disgiunti l’uno dall’altro e risultano
necessariamente complementari ai fini della comunicazione teatrale; all’interno di quest’ultima tra
l’attore ed il pubblico tende a stabilirsi una relazione reciproca, fatta di dare e di avere, al di là della
forma specifica della rappresentazione, quale ad esempio la commedia o una scena a soggetto, e del
suo contesto, quindi un teatro, una piazza, l’aula magna di una scuola.
Un attore non può riuscire ad entrare in rapporto con gli altri (i compagni di lavoro prima, gli
spettatori dopo) se non lavora a fondo su se stesso e sul proprio corpo. Imparare a conoscersi,
rispettarsi, modificarsi, avere fiducia di sé è altrettanto importante dell’agilità fisica, della scioltezza
muscolare e della vivacità vocale, traguardi raggiunti grazie al training e alla vita di gruppo. Il
Laboratorio, infatti, rappresenta il luogo per eccellenza dove condividere delle esperienze, dove
poter sperimentare un confronto con gli altri in una crescita individuale e collettiva. Sugli allievi
vigila il maestro che propone e segue, passo dopo passo, tutte le esercitazioni, pensate per stimolare
le risorse di ogni componente del gruppo: dall’attenzione alla concentrazione, all’intuito, fino alle
potenzialità più nascoste del corpo, strumento e tramite privilegiato per raggiungere il “contatto”
con lo spettatore.
Jerzy Grotowski.
Per un teatro povero è il titolo del libro costituito da trecento pagine di interviste, testimonianze,
resoconti di spettacoli nel quale Jerzy Grotowski racconta la sua idea di teatro; da tale libro sono
tratte le seguenti affermazioni che esprimono sinteticamente un’intera concezione teatrale:
Vi è qualcosa di incomparabilmente intimo e fruttuoso nel lavoro che svolgo con l’attore che mi è affidato. Egli deve
essere attento, confidente e libero, poiché il nostro lavoro consiste nell’esplorazione delle sue possibilità estreme. La sua
evoluzione è seguita con attenzione, stupore e desiderio di collaborazione: la mia evoluzione è proiettata in lui, o
meglio, è scoperta in lui, e la nostra comune evoluzione diventa rivelazione [...]. Un attore nasce di nuovo - non solo
come attore ma come uomo - e con lui io rinasco. E’ un modo goffo di esprimerlo ma quello che si ottiene è
l’accettazione totale di un essere umano da parte di un altro.
L’insegnamento del regista polacco è basilare per comprendere gran parte del teatro del secondo
Novecento. Innanzitutto, nel suo pensiero, un attore che sta compiendo un percorso di formazione è
fondamentalmente un uomo in crescita. Durante tale percorso il regista stesso si assume la
responsabilità di seguire l’evoluzione dei suo allievi, di condurli ad un’esplorazione totale delle
proprie capacità fisiche e psichiche e di accompagnarli lungo il percorso creativo. Grotowski
persegue la sua idea in un luogo da lui stesso fondato nel 1959, nella cittadina di Opole, situata nella
Polonia occidentale, che definisce un Teatro-Laboratorio. All’epoca in cui inizia le sue
sperimentazioni egli ha solo ventisei anni ed è ancora sconosciuto, ma la fama delle sue ricerche si
diffonde in breve tempo tanto che nel 1965 il Laboratorio si trasferisce nella città universitaria di
Wroelaw, capitale culturale polacca dei territori orientali, e consegue lo status di “Istituto di ricerche
sulla recitazione”. Ciò che rende grande il nome di Grotowski sta nel fatto che egli ha proseguito
nella ricerca iniziata all’inizio del secolo da Stanislawskij riguardante non solo le caratteristiche ed
il significato della recitazione ma anche i processi fisici ed emotivi ad essa connessi. Secondo il
regista polacco il solo modo per recuperare l’essenza del teatro consiste nel far emergere i due
elementi che rendono possibile la comunicazione teatrale e cioè l’attore ed il pubblico e rinunciare a
tutte le altre componenti. Egli definisce il suo teatro “un teatro povero”, in cui l’attore e lo spettatore
si possono confrontare attraverso un percorso interiore indirizzato alla ricerca individuale di se
stessi e di significati universali mediante il recupero di una dimensione rituale.
Il laboratorio di Grotowski.
Il laboratorio di Grotowski è caratterizzato da un silenzio assoluto e da un’atmosfera serena e calma.
Al suo interno si svolge il training quotidiano, durante il quale gli allievi provano i duri esercizi
fisici ideati espressamente dal maestro con il fine di aiutare gli attori a liberare le capacità
espressive; grazie ad essi gli allievi scoprono le possibilità del corpo, la sola cosa di cui, secondo il
regista, il teatro non può fare a meno.
Camminare ritmicamente facendo ruotare le mani e le braccia, correre sulle punte dei piedi,
camminare con le ginocchia piegate afferrandosi le caviglie o con le gambe tese e rigide come se
fossero tirate da fili immaginari, sono solo alcune delle esercitazioni con cui gli allievi “si
riscaldano”. Ne seguono altre per sciogliere i muscoli e snodare la colonna vertebrale. In questa
direzione l’esercizio più comune è “il gatto”. Esso si basa sull’osservazione di un felino che si
sveglia e si stira. L’attore è disteso bocconi in stato di rilassamento completo: le gambe sono aperte,
le braccia ad angolo retto rispetto al corpo, le palme rivolte verso terra. Piano piano “il gatto” si
desta. Avvicina le mani al petto, tenendo i gomiti in alto, e mentre accosta le gambe alle mani alza
le anche. Si solleva e distende la gamba sinistra lateralmente. Ripete lo stesso movimento con la
gamba destra. A questo punto allunga la schiena spostando il centro di gravità prima sulla colonna
vertebrale e via via sempre più in alto fino alla nuca. Infine si volta e ricade sulle spalle
rilassandosi completamente. L’allenamento procede con salti e capriole e tiro alla fune. Gli attori
immaginano di avere una corda tesa davanti ai loro occhi. Avanzano. Non sono le braccia o le
mani a tirare il corpo ma il tronco che si sposta verso le mani fino a quando la gamba che è indietro
tocca il pavimento con il ginocchio. E’ questo uno dei tanti “esercizi di plastica” basato sul
principio fondamentale dei cosiddetti “vettori contrari”.
Mediante tali esercizi, l’attore, vincendo gli ostacoli fisici, impara ad isolare le diverse parti del
corpo e a dare loro vita propria, in modo che queste non reagiscano automaticamente ma siano in
grado di produrre, ciascuno nello stesso tempo, movimenti autonomi e perfino contrari e
comunicare immagini opposte ad esempio le mani raccolgono, le gambe espellono. Durante tali
esercitazioni nella stanza nuda e silenziosa la concentrazione è al massimo. Ad un tratto quasi per
miracolo uno degli allievi “si trasforma” in un fiore: << l’intero corpo vive, trema, vibra
dell’imperioso processo di fioritura [...] i piedi sono le radici, il corpo è lo stelo e le mani formano la
corolla >>. Il maestro li chiama “esercizi di composizione”, sorta di ideogrammi gestuali che
scaturiscono da un gioco associativo tra un’immagine mentale, ad esempio quella del fiore, e il
movimento fisico che la esprime. Diventare un fiore significa, dunque, riportare alla memoria
l’immagine di un fiore, “colorarla” con la fantasia, costruire con il corpo i dettagli che la
compongono (radici, stelo, corolla, petali, ecc.) fino a quando l’attore “si trasforma” egli stesso in
un fiore.
Dopo questi esercizi il Laboratorio si anima di cinguettii di uccelli, rombi di motori, scroscii di
acqua, prodotti dagli allievi che, così facendo potenziano le proprie risorse vocali. La modulazione
di rumori meccanici e di suoni naturali eseguiti con incredibile varietà di ritmi e toni - alti, bassi,
rapidi, lenti, semiscanditi, urlati - li aiuta, infatti, a dilatare la gamma sonora e a percepire gli
impulsi profondi che provocano i suoni evocati. Oltre agli esercizi vocali, Grotowski impegna il suo
gruppo a studiare l’articolazione della dizione differenziandola, di volta in volta, a seconda del tipo
umano preso in esame; alcuni allievi fanno una parodia della dizione dei propri conoscenti; alcuni
ritraggono, con la sola pronuncia, un avaro, un ghiottone; altri ancora, parlano accentuando delle
particolarità psicosomatiche - mancanza di denti, malattie di cuore, nevrastenia. La frase viene
“somatizzata”, messa in rapporto col ritmo del polso, del cuore, della circolazione e della
respirazione. Quest’ultima, in particolare, è molto importante per ottenere la liberazione della voce e
l’aumento della portata sonora. Secondo Grotowski la respirazione più completa e più funzionale ad
accumulare una quantità d’aria sufficiente per recitare con ritmo e senza spreco di energia è quella
pettorale- addominale.
Gli spettacoli.
Le messe in scena di Grotowski sono molto note; tra esse si possono ricordare “La tragica storia del
dottor Faust” di Christpher Marlowe, “ Il principe Costante” di Pedro Calderon de La Barca,
“Apocalypsis cum figuris” di Stanislaw Wyspianski. E fondamentale notare però che per il regista
polacco il testo è semplicemente un pretesto per andare oltre: esso assume la funzione di un bisturi
che << permette di aprirci, di trascendere il nostro io [... ] di scoprire ciò che è celato in noi e di
andare verso gli altri >>; diventa una partitura che l’attore, mentre crea, ricompone con suoni, gesti
e variazioni personali. Proprio l’atto di recitare si trasforma in un’esperienza spirituale, una ricerca
che consente e richiede un itinerario dell’attore alla scoperta di se stesso attraverso il training. Il
ruolo del maestro consiste nell’osservare con pazienza i sui allievi, proporre loro gli esercizi, ma,
soprattutto, aspettare che ciascuno sia pronto per eseguirli. Il teatro allora diventa per coloro che
seguono Grotowski e per il regista stesso un incontro tra attori e spettatori e cioè tra uomini che
cercano e si aprono con fiducia ad altri uomini.
Grotowski regista: Akropolis e il Principe Costante.
Akropolis, pubblicato nel 1904, è un testo di Stanislaw Wyspianski, drammaturgo, poeta e pittore
simbolista. Di tutti gli spettacoli diretti da Grotowski, Akropolis è senz’altro quello che si distacca
maggiormente dal suo prototipo letterario: l’unica cosa che rimane del testo dell’autore è lo stile
poetico. Il dramma è stato trasferito in condizioni sceniche completamente diverse da quelle ideate
dal poeta. Secondo il metodo del contrappunto, esso è stato arricchito di associazioni di idee da cui
scaturisce, effetto collaterale, una specifica nozione del mestiere: si è dovuto trapiantare il tessuto
verbale dell’opera nell’organismo di una messa in scena che gli risulta estranea sotto molti aspetti.
Si è dovuto effettuare il trapianto in modo che il linguaggio sembrasse scaturire in modo naturale
dalle circostanze imposte dal teatro. L’azione del dramma si svolge nella Cattedrale di Cracovia.
Durante la notte della Resurrezione, i personaggi degli arazzi e delle sculture rivivono episodi
dell’Antico Testamento e dell’antichità, radici primordiali della tradizione europea. L’autore ha
pensato la sua opera come visione panoramica della cultura mediterranea la cui trama caratteristica è
simboleggiata dall’Acropoli polacca. In questa visione del “cimitero delle tribù”, come è stato
definito dallo stesso Wyspianski, le concezioni del regista e quella del poeta si trovano a coincidere:
entrambi intendono raffigurare la somma di una civiltà e verificarne i valori prendendo come
termine di paragone il contenuto dell’esperienza contemporanea. “Contemporaneo” per Grotowski,
indica la seconda metà del secolo Ventesimo. La sua esperienza è quindi di gran lunga più crudele
di quella di Wyspianski, e perciò egli sottopone i valori secolari della cultura europea ad una
verifica severa. Il loro punto in cui confluiscono non è la serena e riposante atmosfera della
cattedrale, dove il poeta fantasticava e meditava in solitudine sulla storia del mondo, ma il frastuono
di un mondo di estremi, la confusione poliglotta in cui il nostro secolo ha proiettato quegli stessi
valori: in un campo di sterminio.I personaggi fanno rivivere i momenti culminanti della nostra storia
culturale; solo non tornano in vita dalle effigi immortalate nei monumenti del passato, ma dal fumo
e dalle esalazioni di Auschwitz. Nella presentazione scenica, tutti i punti luminosi sono stati spenti
ad arte: la visione finale della speranza è annientata dall’ironia blasfema. L’opera come viene
rappresentata può essere intesa come un appello alla memoria etica dello spettatore, al suo
subconscio morale.
La produzione di Il Principe Costante, basata su un adattamento di Juliusz Slowacki del testo di
Calderòn de la Barca, ebbe un importanza notevole nell’evoluzione del teatro-laboratorio. Il regista
non intende attenersi al testo originale di “Il Principe Costante”, ma dare una sua personale versione
dell’opera; il rapporto fra la sua sceneggiatura ed il testo originale è perciò lo stesso che quello fra
una variazione musicale ed il tema originale. Nella scena d’apertura, il Primo Prigioniero collabora
con i suoi persecutori. Dapprima, mentre giace su di un letto rituale, egli viene simbolicamente
castrato e poi, dopo aver indossato un’uniforme, entra a far parte della compagnia. Questa
rappresentazione costituisce uno studio sul fenomeno dell’inflessibilità che non consiste in una
manifestazione di forza, di dignità e di coraggio. Alla gente che lo circonda e che lo guarda come se
fosse una bestia rara, il Secondo Prigioniero, il Principe, oppone solo resistenza passiva e
gentilezza, tutto volto verso un più elevato ordine spirituale. Egli sembra non reagire alle azioni
malvagie e brutali delle persone che lo circondano: non discute con loro; li ignora: rifiuta di
diventare uno di loro. Sembra in tal modo che i suoi nemici lo tengano in pugno, in realtà non
esercitano alcun potere su di lui: sebbene vittima delle loro male azioni, egli conserva intatta la sua
indipendenza e purezza fino all’estasi. La sistemazione del palcoscenico e del pubblico sta a metà
fra l’arena e la sala operatoria: per questo si può avere l’impressione di assistere, osservando
l’azione che si svolge in basso, a qualche sport crudele in un’antica arena romana, oppure ad
un’operazione chirurgica. All’inizio della rappresentazione il principe è vestito di un camice bianco
e di un mantello rosso che a tratti può essere trasformato in un sudario. Alla fine della
rappresentazione egli è nudo, privo di qualsiasi difesa tranne la sua identità umana. I sentimenti
della società verso il Principe non sono uniformemente ostili; sono piuttosto l’espressione di un
sentimento di diversità ed alienazione unito ad una specie di attrazione, e questa combinazione
contiene in sè la possibilità di reazioni estreme quali la violenza e l’adorazione. Tutti si contendono
il martire ed alla fine della rappresentazione lottano gli uni contro gli altri per possederlo come se si
trattasse di un oggetto prezioso. Nel frattempo, l’eroe assiste a infinite dispute e viene sottomesso
alla volontà dei suoi nemici. Non appena l’azione è compiuta, la gente che ha tormentato a morte il
Principe rimpiange il proprio operato e compiange il suo destino. Gli uccelli predatori si
trasformano in tortore. Alla fine, nonostante le persecuzioni e le stupide umiliazioni cui era stato
sottoposto, egli diventa un inno vivente in omaggio all’esistenza umana. L’estasi del Principe
consiste nella sua sofferenza, cui egli può resistere solo offrendo se stesso alla verità, in un atto
d’amore. Così, nonostante il paradosso, la rappresentazione vuole essere un tentativo di trascendere
l’atteggiamento tragico, il che consiste nel rigettare tutte quelle componenti che possono indurre ad
accettare l’aspetto tragico. Grotowski ritiene che, sebbene non si sia attenuto fedelmente al testo di
Calderòn, egli abbia conservato il significato profondo dell’opera. La rappresentazione è la
trasposizione delle intime contrapposizioni e dei tratti più caratteristici dell’epoca barocca come il
suo aspetto visionario, la sua musicalità, il suo apprezzamento degli aspetti concreti ed il suo
spiritualismo. Questo spettacolo è anche una specie di esercizio che permette di verificare il metodo
di recitazione di Grotowski. Tutto è fuso nell’attore: nel suo corpo, nella sua voce e nella sua anima.
Il lavoro di ricerca.
Durante il lavoro nel laboratorio, il regista si accorge che, nonostante il training, i suoi attori non
riescono a realizzare l’apertura verso il pubblico, da lui auspicata; per questo motivo egli decide di
non creare più nessun altro spettacolo ed orienta la ricerca in una direzione diversa. Nel 1970
riorganizza la sua compagnia che risulta composta da giovani senza nessuna esperienza teatrale e
finalizza la sua attività alla realizzazione di conferenze, seminari, stages, al di fuori del sistema
produttivo spettacolare:
Siamo arrivati alla conclusione [...] che dobbiamo abolire il biglietto di ingresso e che coloro che vengono da noi
dovrebbero pensare di recarsi in un luogo speciale dove è possibile lasciarsi alle spalle la propria vita quotidiana [...],
dove possiamo essere completamente noi stessi.
Due anni dopo cinquecento persone provenienti da ogni parte del mondo arrivano a Wroclaw per
partecipare ad un incontro organizzato dal regista. Intanto la sua fama continua a crescere e, mentre
numerosi gruppi teatrali si ispirano al suo insegnamento, nel 1984 per ordine del governo polacco il
Laboratorio di Wroclaw viene sciolto. Il maestro si stabilisce a Pontedera e nella cittadina toscana
prosegue tuttora la sua ricerca.
Eugenio Barba e l’Odin Teatret.
Il maggior promotore e divulgatore dell’opera di Grotowski in Europa è, senza dubbio, l’italiano
Eugenio Barba; emigrato giovanissimo, egli si forma nel Laboratorio di Opole, dove ha modo di
condurre una verifica costante delle teorie del maestro polacco e di assimilarne l’insegnamento
attraverso la pratica teatrale. Dopo quattro anni di tirocinio Barba si trasferisce a Oslo, nel 1964,
dove fonda il Laboratorio Interscandinavo per l’attore, meglio conosciuto come Odin Teatret che si
caratterizza come un Centro di preparazione dell’attore, distante dal teatro istituzionale e
accademico. Il gruppo, infatti, è selezionato tra i giovani che non hanno superato la prova di
ammissione alla Scuola Nazionale di Teatro. Lontani dagli ambienti artistici ufficiali, questi
“dilettanti” condividono con Barba l’idea di darsi compiti sempre più impervi, mai soddisfatti dei
risultati, accanendosi per superare gli ostacoli della professione. L’Odin Teatret è propriamente un
Teatro- Scuola in cui, diversamente dalle tradizionali scuole di teatro, si antepone al talento la
volontà di sacrificare se stessi per l’Arte, proprio come accade nei Teatri classici orientali dove dei
bambini di sei, otto, dieci anni sono immessi nella professione e dopo dieci anni di intenso
apprendistato e disciplina severa emergono come artisti la cui espressività suggestiva diventa il
sogno più grande di ogni grande attore europeo.
Gli allievi devono essere consapevoli della missione che vanno ad intraprendere e considerare un
onore l’esperienza di partecipare a questa avventura teatrale, tanto da rendersi disponibili a
finanziarla per proprio conto se necessario. Calmi e pazienti essi si preparano ad affrontare lunghi
anni di training, investendo completamente le proprie forze ed energie.
Ad Oslo e ad Hostelbro (in Danimarca) - dal 1966 nuova patria dell’Odin - gli attori si allenano
circa undici ore al giorno, dalle nove del mattino alle otto di sera, con una sola pausa dalle quattro
alle cinque del pomeriggio. Esercizi di acrobazia, ginnastica, sport, balletto classico, plastica,
improvvisazione, igiene vocale e concentrazione si susseguono a ritmo frenetico scandendo il tempo
all’intemo del Laboratorio.
Il training.
Anche per Barba, come per gli altri maestri del Novecento, il training rappresenta l’elemento
cardine intorno al quale ruota la sua concezione teatrale. Secondo il regista esso non è una tecnica
che insegna a recitare, che rende gli attori dei bravi attori, non è neppure un insieme di movimenti
ginnici stereotipati che preparano in modo meccanico alla creazione; il training è piuttosto un
laborioso processo di autodefinizione personale che si manifesta attraverso delle reazioni fisiche.
Egli afferma che:
Non è l’esercizio in se stesso che conta - per esempio fare delle flessioni o dei salti mortali - ma la giustificazione data
da ciascuno al proprio lavoro, una giustificazione che, anche se banale o difficile da spiegare [...], è fisiologicamente
percettibile, evidente per l’osservatore.
E’ l’attore in quanto uomo con i suoi bisogni interiori a dare significato al training e a superare la
pura e semplice fisicità del movimento. Spiega il maestro:
Questa necessità interiore determina la qualità dell’energia che permette di lavorare senza soste, senza curarsi della
stanchezza, e quando si è esausti, allora continuare, proprio in quel momento andare avanti, senza arrendersi.
Ciò non significa che si diventa creativi sottoponendo il corpo ad uno stress fisico continuo;
semplicemente il training è un test, una prova in grado di verificare, giorno dopo giorno, se l’allievo
è pronto ad impegnare se stesso come individuo, membro del gruppo e attore. Dichiara Barba:
Questa impercettibile trasformazione quotidiana del proprio modo di vedere, di avvicinare e giudicare i problemi della
propria esistenza e dell’esistenza degli altri, questo vaglio dei propri pregiudizi, dei propri dubbi - non attraverso gesti e
frasi magniloquenti, ma attraverso la silenziosa attività quotidiana - si riflette nel lavoro, che ritrova nuove
giustificazioni, nuove reazioni.
All’inizio il training è collettivo: tutti eseguono i medesimi esercizi contemporaneamente e allo
stesso modo. Poi, man mano che il lavoro procede, il regista si rende conto che ciascuno ha un ritmo
particolare (mentale e fisico) diverso nei vari componenti del gruppo. Così il training diventa
individuale e gli esercizi, pur rimanendo identici, cambiano di valore e di significato. L’attore si
autodisciplina, cerca cioè di eseguire le esercitazioni nella maniera più consona alla propria persona
e al proprio corpo.
L’allenamento si basa su azioni elementari che stimolano la reazione del corpo degli attori e
impegnano tutto il gruppo ad “aprirsi” reciprocamente con stima e spirito di collaborazione.
Una particolarità dell’Odin consiste nel fatto che non ci siano maestri e pedagoghi, ma che gli
allievi stessi elaborino il loro training, da eseguire con assiduità e costanza, pur seguendo le
indicazioni di Barba, il quale funge da guida per tutti: i più anziani mettono la loro esperienza a
disposizione dei giovani, e li aiutano, dando loro consigli, a superare le difficoltà:
Se non faccio training per un giorno, solo la mia coscienza lo sa; se non lo faccio per tre giorni, solo i miei compagni lo
notano; se non lo faccio per una settimana, tutti gli spettatori lo vedono.
In tale affermazione è espresso il principio del credo artistico degli allievi dell’Odin.
Gli esercizi.
Alcuni esempi di esercizi possono essere significativi per capire quale tipo di training svolgono gli
allievi di Barba. Uno di essi ha la finalità di obbligare alla precisione; si tratta infatti di toccare con
il piede il petto del compagno cercando di non fargli male: chi esegue l’azione si sforza di compierla
con delicatezza e meticolosità, chi la “subisce” cerca di superare il riflesso di difesa e si dispone
senza paura a “ricevere” il gesto. Questo genere di situazioni prepara gli allievi ad agire con
intelligenza fisica, a lavorare, cioè, con intuito, scrupolosità e rispetto per gli altri.
Il secondo esempio è costituito da una catena di esercizi acrobatici. Gli attori eseguono balzi,
capriole, fanno salti mortali, imparano a cadere sul pavimento senza peso. Il valore psicologico di
tali esercitazioni è molto forte: esse sembrano difficilissime da eseguire e spesso si ha la sensazione
di non poterle compiere nella maniera giusta. In fondo si tratta solo di un delicato gioco di energia.
Ancor prima di recitare, l’attore, cioè, è chiamato alla mobilitazione di tutte le sue forze fisiche,
psichiche e intellettuali. Questo impegno energetico avviene in modo invisibile a livello pre-
espressivo - prima cioè dell’espressione compiuta - e diventa poi visibile nella fase espressiva - che
per l’attore è il momento della “rappresentazione”; e fondamentale l’aiuto di tutti i membri del
gruppo.
L’ISTA (Intemational School of Theatre Anthropology).
Dopo aver raggiunto una certo grado di completezza nella preparazione dell’attore ed aver
concretizzato delle relazioni umane all’interno del gruppo, consistenti nell’avere acquisito sia il
coraggio di avvicinarsi l’uno all’altro da parte degli allievi sia un forte legame consolidato nel
tempo anche grazie alla vita in comune, Barba porta la sua attività all’estemo, fuori dal Teatro di
Hostelbro.Un’attività feconda ed eclettica che spazia dagli spettacoli alle tournées “di strada” in
paesi stranieri e in piccoli centri dell’Italia meridionale, all’organizzazione di corsi, seminari,
pubblicazione di una rivista e di libri, produzione di film didattici sul teatro, fino alla costituzione
dell’ISTA (Intemational School of Theatre Anthropology).Essa si fonda sull’idea del massimo
scambio di esperienze quali ad esempio quelle esistenti tra orientali e occidentali, tra generazioni
più anziane e generazioni più giovani, tra il teatro tradizionale e teatro di gruppo. Ogni anno, in
luoghi diversi, antropologi, studiosi, maestri e allievi di tutto il mondo si riuniscono per mettere a
confronto tecniche ed esperienze teatrali differenti.
Barba ed il suo gruppo perseguono il loro cammino sganciati dalle strutture pubbliche e distanti da
qualsiasi legge di mercato; essi cercano di superare i limiti sia fisici sia psichici individuali, di
costruire un nucleo di valori, cioè un’identìtà personale, in relazione alle proprie radici culturali, ad
una tradizione in cui si riconoscono, e per questi motivi si confrontano con realtà diverse per lingua,
ideologia, religione, modo di vita nel tentativo di ritrovare se stessi e la possibilità dello scambio
proprio nella diversità.
Peter Brook e il CIRT (Centro Internazionale di Ricerca Teatrale).
Dal 1942, quando diciassettenne dirige il Doctor Faust di Christopher Marlowe, fino al più recente
Oh les beaux jours (Giorni felici) di Samuel Beckett, il regista londinese Peter Brook ha messo in
scena più di settanta rappresentazioni. Trasferitosi da Londra a Parigi, crea il Centro Internazionale
di Ricerca Teatrale, dove convergono attori provenienti da ogni parte del mondo - inglesi,
americani, spagnoli, portoghesi, giapponesi, arabi, africani - i quali, nella babele delle loro lingue,
verificano il valore comunicativo del teatro al di là delle distanze etniche, ideologiche e linguistiche.
Questo “organismo nomade” attraversa il mondo spingendosi oltre i limiti delle ordinarie tournées
ed entra in contatto con persone che non avevano mai assistito a spettacoli teatrali prima di allora.
Memorabile resta il viaggio in Africa, una traversata di cento giorni tra Niger, Nigeria, Mali, Togo e
Dahomey, in cui la compagnia senza un copione e senza aver fissato niente a priori, recita nei
villaggi, nel deserto, nella foresta tropicale. La sfida è globale e li riguarda come attori, come
individui e come gruppo. Non solo occorre sfruttare al massimo tutti i mezzi espressivi per
coinvolgere gli abitanti del luogo ma è necessario sviluppare un grande spirito di adattabilità. Le
precarie condizioni igieniche, la carenza di acqua, la mancanza di comodità, unite agli inevitabili
problemi di convivenza, sono per loro ostacoli quotidiani.
Il teatro di Brook.
In Brook è radicata la convinzione che il teatro sia essenzialmente uno scambio vivo tra chi agisce e
chi guarda; entrambe le parti partecipano ad un “coro telepatico” all’interno del quale si trasmette
una forte energia creativa che circola e viene condivisa. Affínché tale congiunzione comunicativa
possa verificarsi ogni volta ci sia un incontro tra un pubblico ed un attore, quest’ultimo impara
attraverso un training quotidiano ad interagire con se stesso, con i partners del gruppo e con il
pubblico. Questi tre livelli di interazione sono definiti dal maestro “ le tre fedeltà”: la fedeltà della
concentrazione, sorgente profonda dell’ispirazione; la fedeltà al compagno in scena a cui bisogna
adattarsi costantemente; la fedeltà allo spettatore, in rapporto al quale l’interprete deve essere aperto
e disponibile. Tali affermazioni si avvicinano fortemente al concetto in cui può essere sintetizzata
la concezione del teatro di Brook: l’arte come relazione, anzi come una rete di relazioni in
movimento, viva, che si costituisce ogni volta che interagiscono tra loro le parti descritte in
precedenza.
L’arte come relazione: l’attore narratore.
L’attore che si forma con Brook è fondamentalmente un attore-narratore. Questo genere di
recitazione ha cominciato ad ispirare il regista fin dal suo viaggio in Africa, durante il quale ha
potuto costatare come le culture africane e quelle orientali hanno da sempre praticato l’arte del
narrare, piuttosto che possedere un vero e proprio teatro. Egli pensa pertanto ad un attore che,
mettendosi in relazione con il pubblico mentre si accinge a recitare un testo qualsiasi, sia in grado di
mantenersi a metà tra l’immedesimazione nella storia, nel personaggio ed una totale estraneità ad
essi, in una sorta di alternanza reciproca caratterizzata da un’identificazione solo incompleta e da
una distanza momentanea; l’arte del narratore infatti consiste nel tenere gli spettatori con il fiato
sospeso mediante la sua abilità interpretativa. Per questi motivi indica un training in cui si alternano
esercizi vocali e gestuali. Gli esercizi vocali, ad esempio, tendono a preparare la voce mediante un
allenamento costante sulla respirazione, sui ritmi delle sillabe e delle vocali, in modo che la
“parola” risulti più incisiva. Gli esercizi gestuali spaziando dal “comune riscaldamento” a tecniche
più specifiche - yoga, tai-chi, kathakali (particolare danza indiana) - educano l’attore a percepire le
intenzioni dei compagni. Esemplare, in questo senso, l’esercizio con le canne di bambù. In cerchio
(per eccellenza modello di comunione e comunicazione) il gruppo si scambia delle canne di bambù
velocemente. Ognuno, in pochi secondi, deve intuire i proponimenti di colui che gli sta accanto ed
essere pronto ad accogliere qualsiasi variante introdotta; per raggiungere tale obiettivo sono
indispensabili attenzione e massima concentrazione. A sviluppare queste doti collaborano anche gli
esercizi di improvvisazione, che preparano gli attori ad essere pronti all’imprevisto, a saper creare,
cioè, in qualsiasi momento e luogo un evento teatrale.
Tuttavia, un evento teatrale oltrepassa sempre il Teatro. La Conferenza degli uccelli per la
compagnia di Brook come sessant’anni prima le feste dei Copiaus nei villaggi della Borgogna evoca
in simboli e nel suo concreto realizzarsi l’avventura individuale dell’attore in scena e fuori scena.
Laddove, nell’incontro con lo Spettatore - al confine dello spazio contrassegnato dalla “finzione”,
quell’avventura assomiglia emblematicamente al viaggio di ogni Uomo: incessante ricerca di sé e
del proprio personale Simorg sulla scena della vita.
La Conferenza degli uccelli.
Tra tutte le opere di Brook, La Conferenza degli uccelli - ispirata dall’antico poema persiano di
Farid Ad-Din Attar - è quella che meglio riassume l’attività del grande maestro e del suo gruppo di
attori. Il debutto dello spettacolo avviene ad Avignone nel 1979.
Per Brook e la sua compagnia, il testo costituisce un punto di riferimento importante e consente di
suscitare una serie di riflessioni sul lavoro che i componenti del Centro hanno intrapreso ormai da
anni. “Un oceano” è l’immagine usata dal regista per definire il poema persiano; uno “sconfinato
insieme”, profondo e misterioso, liberamente percorribile in ogni senso e direzione.
Per capire più a fondo il significato di tali affermazioni è opportuno soffermarsi, a questo punto, sul
racconto di Attar. In quattromilacinquecento versi il poeta, di professione profumiere e uomo assai
dotto, narra un viaggio intrapreso da uno stormo di uccelli guidati da un’Upupa. Un viaggio molto
particolare che prende spunto da una situazione di crisi: i volatili hanno bisogno di un re. Riuniti in
conferenza lo individuano nel favoloso uccello Simorg (uccello mitico e dai magici poteri che vive
su un albero presso il lago Varksk) e si mettono in cammino per raggiungere la sua corte. Mille
dubbi assalgono gli uccelli prima della partenza e numerosi sono i tentativi dell’Upupa di impartire
regole e disciplina ai volatili restii a rinunciare alle abitudini della vita giornaliera:
sordi
al
richiamo del viaggio, l’anitra preferisce il suo stagno, la pernice le sue pietre, l’usignolo la sua rosa,
il gufo il suo ramo, la cocorita la sua gabbia. Soltanto quando l’Upupa, l’unica capace di non
accontentarsi del quotidiano, ammonisce la loro superbia e il loro orgoglio, il viaggio ha inizio
davvero. Gli insegnamenti morali dell’uccello-guida saranno fondamentali per lo stormo e li
aiuteranno a varcare le sette Valli che conducono al regno del Simorg. Il “Grande uccello”, infatti, si
rivelerà a coloro che sapranno vincere le difficoltà della valle della Ricerca, dell’Amore, della
Comprensione, dell’Indipendenza, dell’Unità, dello Stupore e della Povertà. Molti non riusciranno a
sopportare le fatiche di un tale percorso e si ritireranno; altri, incoraggiati a resistere alla passioni,
perverranno alla meta. Nella fiaba di Attar la gioia della scoperta del Simorg è riservata infatti a
pochi eletti. Trenta uccelli su centomila riescono ad arrivare a destinazione e una sorpresa
incredibile colpirà i loro occhi. Arrivati alla soglia della settima valle si accorgono che il Simorg è
uno specchio in cui si riflette la loro immagine (non è un caso che in persiano la parola si morg
significhi trenta) e soltanto in quel momento capiscono che il fine del viaggio è la ricerca di se
stessi. La metafora è esplicita. Coerentemente con i mistici di ogni razza e credo, Attar descrive la
vita spirituale dell’uomo come un pellegrinaggio alla ricerca della Divinità. Il viaggio,
l’avanzarnento lento per gradi, il sentiero formato da sette valli sono le tappe simboliche che
conducono alla “fusione” tra l’uomo e l’Essere Superiore.
Gli attori si allenano, ognuno sceglie un uccello-personaggio, ne mette a punto una prima
caratterizzazione e, infine, si confronta con gli altri dando vita a scene collettive. Brook suggerisce
l’uso di maschere balinesi, costruite appositamente per l’occasione, come espediente per
“costringere” gli interpreti ad entrare in contatto con le proprie capacità motorie ed espressive
liberandosi da canoni e cliché. Ricorda uno degli attori:
La maschera mi ha aiutato perché al primo colpo mi ha dato l’essenza del personaggio da rappresentare, la sua stessa
presenza [...], credo, mi abbia dato il senso di una forma precisa che mi è servita come base per la recitazione.
Oltre alle maschere, il regista si serve di marionette costituite di elementi mobili - scialli e sciarpe che rappresentano una sorta di “estensione del corpo” dell’attore suggerendogli spunti per il lavoro
di creazione.