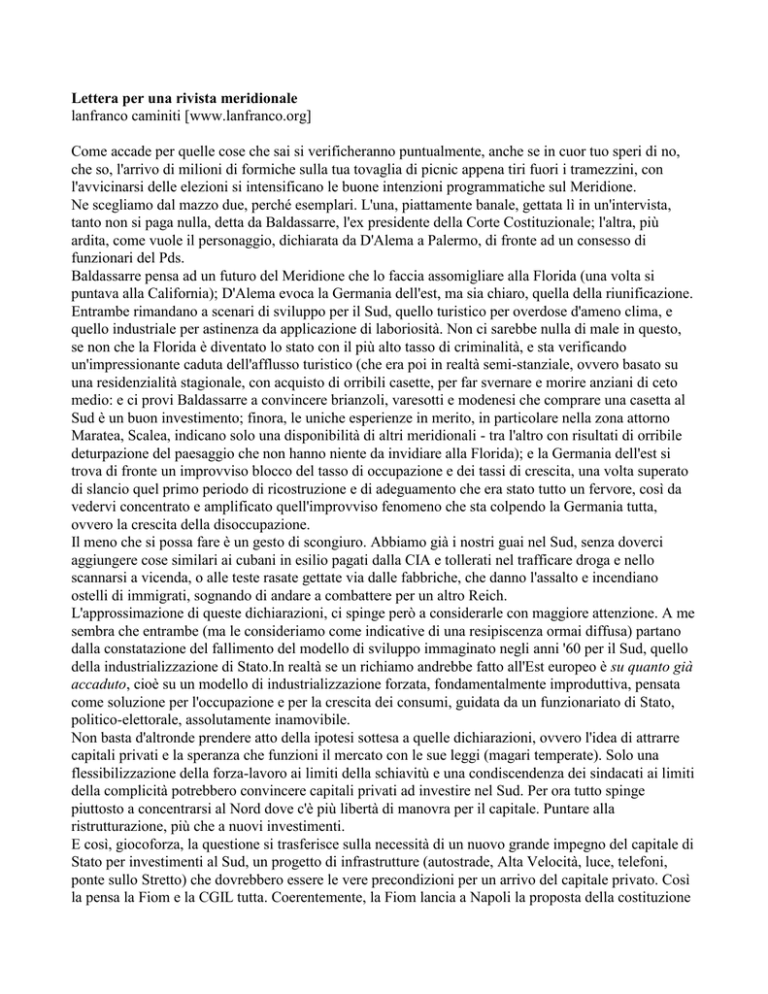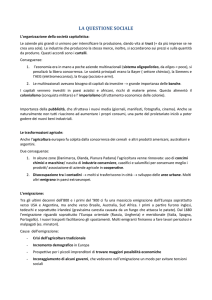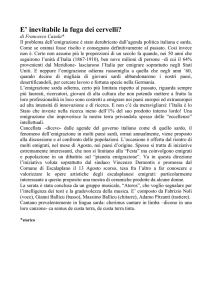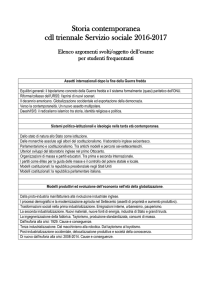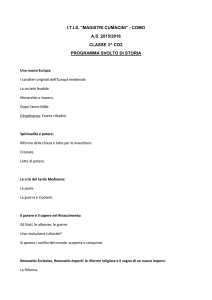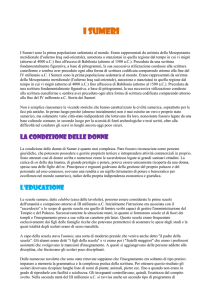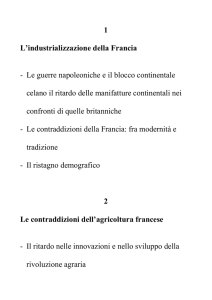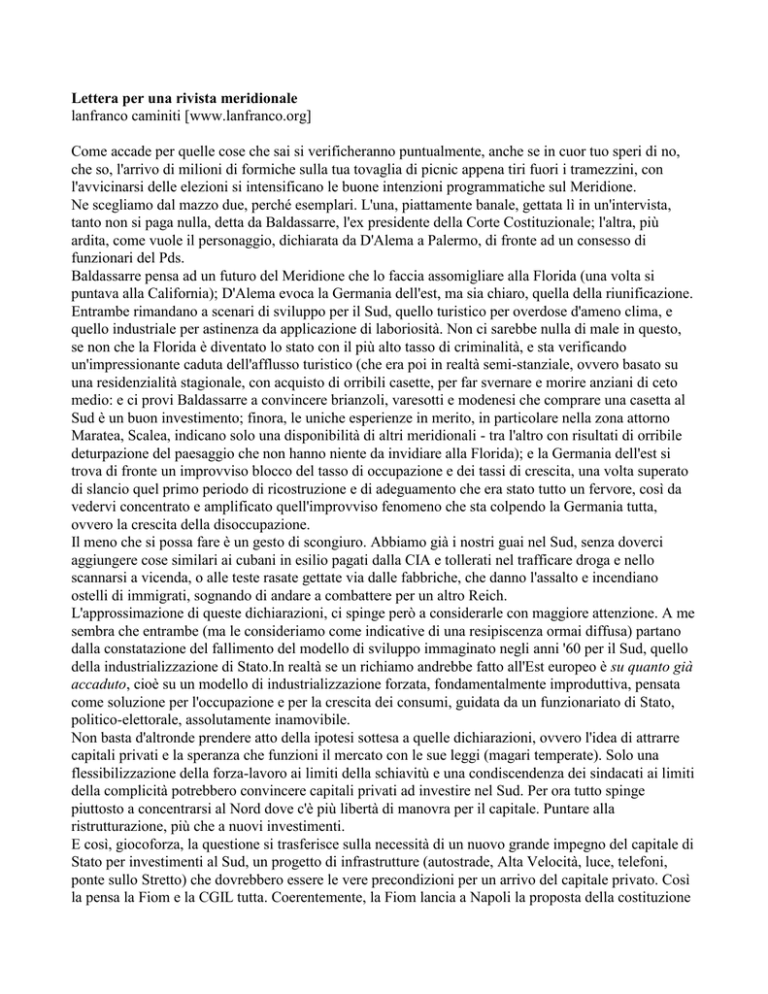
Lettera per una rivista meridionale
lanfranco caminiti [www.lanfranco.org]
Come accade per quelle cose che sai si verificheranno puntualmente, anche se in cuor tuo speri di no,
che so, l'arrivo di milioni di formiche sulla tua tovaglia di picnic appena tiri fuori i tramezzini, con
l'avvicinarsi delle elezioni si intensificano le buone intenzioni programmatiche sul Meridione.
Ne scegliamo dal mazzo due, perché esemplari. L'una, piattamente banale, gettata lì in un'intervista,
tanto non si paga nulla, detta da Baldassarre, l'ex presidente della Corte Costituzionale; l'altra, più
ardita, come vuole il personaggio, dichiarata da D'Alema a Palermo, di fronte ad un consesso di
funzionari del Pds.
Baldassarre pensa ad un futuro del Meridione che lo faccia assomigliare alla Florida (una volta si
puntava alla California); D'Alema evoca la Germania dell'est, ma sia chiaro, quella della riunificazione.
Entrambe rimandano a scenari di sviluppo per il Sud, quello turistico per overdose d'ameno clima, e
quello industriale per astinenza da applicazione di laboriosità. Non ci sarebbe nulla di male in questo,
se non che la Florida è diventato lo stato con il più alto tasso di criminalità, e sta verificando
un'impressionante caduta dell'afflusso turistico (che era poi in realtà semi-stanziale, ovvero basato su
una residenzialità stagionale, con acquisto di orribili casette, per far svernare e morire anziani di ceto
medio: e ci provi Baldassarre a convincere brianzoli, varesotti e modenesi che comprare una casetta al
Sud è un buon investimento; finora, le uniche esperienze in merito, in particolare nella zona attorno
Maratea, Scalea, indicano solo una disponibilità di altri meridionali - tra l'altro con risultati di orribile
deturpazione del paesaggio che non hanno niente da invidiare alla Florida); e la Germania dell'est si
trova di fronte un improvviso blocco del tasso di occupazione e dei tassi di crescita, una volta superato
di slancio quel primo periodo di ricostruzione e di adeguamento che era stato tutto un fervore, così da
vedervi concentrato e amplificato quell'improvviso fenomeno che sta colpendo la Germania tutta,
ovvero la crescita della disoccupazione.
Il meno che si possa fare è un gesto di scongiuro. Abbiamo già i nostri guai nel Sud, senza doverci
aggiungere cose similari ai cubani in esilio pagati dalla CIA e tollerati nel trafficare droga e nello
scannarsi a vicenda, o alle teste rasate gettate via dalle fabbriche, che danno l'assalto e incendiano
ostelli di immigrati, sognando di andare a combattere per un altro Reich.
L'approssimazione di queste dichiarazioni, ci spinge però a considerarle con maggiore attenzione. A me
sembra che entrambe (ma le consideriamo come indicative di una resipiscenza ormai diffusa) partano
dalla constatazione del fallimento del modello di sviluppo immaginato negli anni '60 per il Sud, quello
della industrializzazione di Stato.In realtà se un richiamo andrebbe fatto all'Est europeo è su quanto già
accaduto, cioè su un modello di industrializzazione forzata, fondamentalmente improduttiva, pensata
come soluzione per l'occupazione e per la crescita dei consumi, guidata da un funzionariato di Stato,
politico-elettorale, assolutamente inamovibile.
Non basta d'altronde prendere atto della ipotesi sottesa a quelle dichiarazioni, ovvero l'idea di attrarre
capitali privati e la speranza che funzioni il mercato con le sue leggi (magari temperate). Solo una
flessibilizzazione della forza-lavoro ai limiti della schiavitù e una condiscendenza dei sindacati ai limiti
della complicità potrebbero convincere capitali privati ad investire nel Sud. Per ora tutto spinge
piuttosto a concentrarsi al Nord dove c'è più libertà di manovra per il capitale. Puntare alla
ristrutturazione, più che a nuovi investimenti.
E così, giocoforza, la questione si trasferisce sulla necessità di un nuovo grande impegno del capitale di
Stato per investimenti al Sud, un progetto di infrastrutture (autostrade, Alta Velocità, luce, telefoni,
ponte sullo Stretto) che dovrebbero essere le vere precondizioni per un arrivo del capitale privato. Così
la pensa la Fiom e la CGIL tutta. Coerentemente, la Fiom lancia a Napoli la proposta della costituzione
di un'Authority per il Sud, che già nel suo esotismo di denominazione dovrebbe richiamare i grandi
progetti del New Deal roosveltiano (la Tennesse Valley Authority ecc.), e che comunque dichiara la
disposizione ad un forte impegno centralizzato, dall'alto, magari concertato ma sempre statuale.
Mi sembra sia notevolmente discutibile già la premessa stessa della possibilità oggi per il capitale di
Stato di affrontare un piano di investimenti davvero significativo, impantanate come sono la teoria
economica e la pratica politica ad adorare il feticcio del controllo della circolazione monetaria e della
stabilità dell'inflazione (e questo vale a maggior ragione a livello europeo, dove si potrebbe pensare di
reperire capitali, a meno di non aspettare la rottura del trattato di Maastricht e la fine d'ogni moneta
europea). Ma interessa qui sottolineare che, per quanto diversi possano essere i modelli di sviluppo
immaginati,c'è un'attestazione generale -come già negli anni '50 e '60- riguardo il tramite di questo
sviluppo, ovvero lo Stato, e, per suo tramite, riguardo l'indispensabilità decisionale del ceto politico.
Ora, propongo alla riflessione un argomento a più facce. L'industrializzazione del Sud negli anni '50 e
'60 non causò una crescita generale dei dati occupazionali, ma semmai un restringimento. D'altronde,
basta pensare all'alto tasso di capitale fisso investito, che caratterizzava quella industrializzazione
(Ottana, Taranto, Gela, Pomigliano ecc.), per capire quanto poca manodopera essa mobilitasse.
Tuttavia, certo, non solo produsse una crescita dei tenori consumistici di vita, ma scombussolò le
geografie (in molti luoghi addirittura le geologie), le abitudini, le costumanze. Ma essa non sarebbe mai
passata (come non passò il primo tentativo di industrializzazione fatto dai Borboni) se non avesse
intercettato una disponibilità al movimento e allo sradicamento che il Sud manifestava in quegli anni.
L'esodo massiccio, verso il Nord, verso le Americhe, verso l'Europa, verso le città, verso la fabbrica,
non era sintomo di disperazione (una resa incondizionata) ma uno straordinario fenomeno di curiosità,
di apprendimento, di rottura epistemologica collettiva contro il Tempo e contro lo Spazio quali si erano
perennemente dati (e quindi contro l'autorità, persino quella sulle anime). Un grande movimento di
generosità.
Esso veniva dal ciclo di lotte contadine per la terra (le occupazioni, l'imponibile di manodopera, contro
il caporalato, le cooperative). Un ciclo di lotte che venne sconfitto (con gli eccidi e con una riforma
fasulla), ma che aveva comportato uno straordinario afflusso di energie, di qualità umane, l'emergere di
soggetti politici. Quel movimento constatò la propria sconfitta (non è qui il luogo per approfondirne le
responsabilità e le possibilità), ma certo non poteva tornare indietro nella coscienza acquisita e nella
rottura dei paradigmi sociali che aveva provocato. Come ogni movimento sociale, esso poté convincersi
di avere perso, ma certo non poté, collettivamente, fare proprie le ragioni del nemico, pentirsi. Cercò
una linea di fuga (come successe per le grandi lotte sociali all'inizio del secolo e come succederà, più
tardi, nel Settantasette). E la trovò nell'emigrazione, nell'abbandono della campagna verso la città e la
fabbrica, che, proprio essendo un andare via , era anche un non tornare indietro. E' ovvio che tutto ciò
non si manifestò in una decisione collettiva, ma nei comportamenti individuali dell'emigrazione
meridionale negli anni successivi (e nelle storie personali) è possibile constatare come essi portassero i
segni di quanto era storia collettiva.
Si può fare un parallelo non forzato con l'esito delle lotte degli anni Settanta: toccato il plafond delle
lotte e dei comportamenti e non verificandosi uno spostamento d'autorità e di decisione, una
ridistribuzione di potere, un allargamento e rafforzamento di democrazia, il movimento legge la propria
sconfitta, o comunque la consapevolezza dell'impasse (anche in questo caso, non è qui il luogo per un
approfondimento delle responsabilità e delle possibilità). Ma, e qui è il dato nuovo, esso non ha
praticato collettivamente percorsi di emigrazione, ma anzi intrapreso un sentiero di stanzialità. I dati
semmai stanno lì a certificarlo, ma credo sia stata la prima volta che il risultato di un lungo periodo di
scontro di classe nel Meridione abbia provocato una sorta (mi si passi l'ossimoro) di esodo sul posto.
Se questa ipotesi è intesa come plausibile, proviamo a ricavarne alcune considerazioni: 1) la
consapevolezza collettiva non è tornata indietro (come accade appunto a tutti i movimenti), ma non è
andata altrove; 2) c'è una duratura lacerazione che non ha trovato forme risolutive, fissandosi in una
sorta di fotografia a lunga esposizione. Per meglio dire: il fatto che il conflitto degli anni Settanta (e la
coscienza collettiva delle poste in gioco) non sia addivenuto ad una forma qualsiasi di superamento di
se stesso (fosse l'emigrazione, fosse una radicale trasformazione produttiva, fosse il sopravvenire di un
qualunque fenomeno politico innovativo) lascia la pesante eredità di una situazione bloccata. Credo si
possa leggere così il lungo periodo degli anni '80 e questo primo lustro degli anni '90, cioè altrimenti
come un lungo periodo di sperimentazione, di tenuta d'una linea di galleggiamento.
Ma il cauto parallelo tra i due periodi, ed il confronto con questi anni, fa emergere soprattutto una
questione: il primo ciclo di industrializzazione e il secondo, diciamo,di «metropolizzazione» (crescita
dei consumi, dei redditi, dell'alfabetizzazione, del ruolo dei media, di costumi «moderni»),
intercettarono comunque un soggetto sociale, deformandone bisogni e talenti. Era un soggetto
economico ma anche politico, che si era costruito, nel primo caso, attorno le battaglie per la terra, e nel
secondo attorno le lotte per il reddito. Ed il confronto con questi anni più recenti mostra la spaventosa
assenza di un soggetto politico. Fossero i cafoni di Di Vittorio e i braccianti di Melissa, o fossero gli
studenti di Palermo e gli operai dell'Italsider, nel primo e nel secondo caso la programmazione statale di
interventi al Sud si confrontava con una soggettività politica, la inseguiva, la anticipava, vi si
commisurava. Mai come adesso le proposte (e i possibili interventi) d'un ceto politico statale verso il
Sud agiscono in assenza di gravità. E questo ci rinvia ad un nocciolo di questione: il problema più serio
non è la veridicità dei programmi che questo o quel partito intende agitare per il riscatto del
Mezzogiorno (beninteso, ne vanno denunciate le oscenità o apprezzate particolari intuizioni), ma il
fatto che questi programmi possano essere detti impunemente, senza cioè dover fare i conti con un
soggetto sociale in tensione, assumendo così proprio il tono della programmazione astratta, dove è
possibile dire tutto e il contrario, assolutamente impolitica (perché priva di un referente concreto per la
contrattazione, e allora si parla di «giovani», di «commercianti», di «artigiani», di «donne», soggetti
categoriali senza carne e sangue).
Aggiungo a questo quadro una sensazione (non ho statistiche in merito e quindi la pongo solo come una
nota): che, dopo un lungo periodo di indisponibilità al muoversi, stia per ricominciare un ciclo di
emigrazione che riguardi i più giovani (la generazione appunto che è cresciuta dopo gli anni Settanta),
fatto che ci porrebbe di fronte ad un fenomeno curiosamente nuovo, una emigrazione che parte dalla
delusione, non dalla sconfitta, e disposta quindi a rinnegare . Se questo dato fosse vero potremmo
descrivere così quanto accade: una generazione politica (quella degli anni '70) che ha rinunciato alle
proprie ambizioni, fino alla barricata del proprio privato, che è stanzializzata; una generazione
(l'ultima), privata dell'esperienza politica delle lotte, dell'organizzazione, che si allontana da un
territorio bloccato, ma senza ambizioni, senza memoria. Non è detto che tutto ciò sia obbligatoriamente
catastrofico, ma i segni non sono confortanti. Penso ad esempio che quelli che resteranno potrebbero
essere caratterizzati da un segno di rancore, da una disponibilità al sotterfugio, che sono i segni tipici di
un consenso sociale ad un autoritarismo che pesca dove non si sono combattute lotte sociali. La
compresenza di aspetti così contraddittori (una durevolezza della lacerazione e della coscienza d'essa,
ma anche un suo sotterraneo acquattarsi; un affacciarsi di delusione nella nuova generazione) ma
soprattutto così paralleli, cioè senza corti circuiti (ne parliamo in termini generali, senza voler
sottovalutare importanti esperienze), disegna un quadro da dove. mi pare, emergano alcune necessità:
1) un discorso radicale;
2) la visibilità di questo discorso;
3) l'individuazione di un soggetto politico (economico) capace di esprimere un'opzione forte sui
processi di produzione e riproduzione sociali;
4) la tessitura delle sperimentazioni, come precondizione perché esse acquistino rilevanza.
Sono, ovviamente, tutte questioni che ci rinviano ad una riflessione più complessa, documentata, ricca
di pregiudizi. E che in buona parte esulano dai compiti propri di una rivista, che è la cosa concreta a cui
oggi possiamo dedicarci. Ma almeno sul primo punto mi preme dire qualcosa. Un discorso radicale,
ovvero che ha a cuore le radici, i luoghi del suo esplicitarsi, mi appare sempre più come l'unico gesto di
buon senso oggi possibile. Esso non può immaginarsi altro che discorso ideologico , ovvero come un
discorso che pone le basi del suo stesso superarsi (della sua verificabilità) solo in una trasformazione
complessiva delle sue premesse; quindi, tutt'altro che millenaristico e catecumeno, si riflette
nell'attualità, nelle lente modificazioni, nel continuo riproporsi delle contraddizioni, ma non avendo
oggi la configurazione e l'onerosità d'un movimento politico può con maggiore libertà esprimere un
rigore assoluto di giudizio , una presunzione di insoddisfazione. In un mondo politico ed intellettuale
che si affanna a dichiararsi ex e post, come a porre una normalità comune, esigere l'eccellenza della
qualità d'un discorso meridionale è l'unico modo per opporsi a un'idea conformistica e pigra delle masse
e schierarsi per una immagine ambiziosa della democrazia. Per una democrazia talentuosa.
Penso a questo "numero zero" come - oltre ad una dichiarazione di cornice - ad una collazione. Ci sono
alcuni argomenti che potrebbero comunque essere significativi:
1) l'immigrazione nel Sud, trattandola per quel tanto di particolare che essa produce nel Sud: un
fenomeno «a specchio» rispetto un territorio abituato all'emigrazione e al ritorno; cioè molto diverso da
quello che accade o è accaduto in Francia, Germania, Usa, i cui parametri sociologici di comportamento
possono quindi essere usati per capire e fare, e abbastanza diverso da quanto sta accadendo in
Portogallo o Spagna - per i fenomeni storici di colonialismo e quindi di abitudine a una presenza
«altra»- sì da configurarne tratti assolutamente caratteristici e quindi «esemplarmente » significativi.
Anche la verifica del contrario, ovvero che c'è assoluta o notevole conformità tra l'immigrazione nel
Varesotto e quella, ad esempio, nel Casertano potrebbe darci una chiave di lettura importante:
l'avvicinarsi di comportamenti omologhi, e quindi di condizioni omologhe, tra il Varesotto e il
Casertano. Dovremmo cioè pensare l'immigrazione non soltanto per quel che esso significa per sé, ma
per quel che essa aiuta a scoprire, a rilevare di mutato nei luoghi e nei comportamenti dove si verifica.
Mi sembrerebbe ulteriormente interessante mettere in parallelo queste considerazioni, questi dati con
un analogo lavoro da svolgere nei quartieri meridionali del Nord (per esempio, Nichelino, San
Casciano, Barriera ecc. ecc.), e metterne in risalto le differenze. L'immigrazione potrebbe servirci così
da terribile evidenza dello scontrarsi di due concezioni che lì si intrecciano e scontrano: quella del
miglioramento sociale come avanzamento verso l'alto di uno status sociale ed economico individuale, e
quella che - sul fallimento di questa ipotesi, per il continuo sommuoversi degli stati sociali, attorno il
criterio di esclusione di una loro parte - dovrebbe indurre a pensare ad un miglioramento allargato,
orizzontale, collettivo.
2) il rapporto lavoro-territorio. C'é un impatto, visibile, indagabile tra i mutamenti della produzione e
il territorio? Spiego meglio, questa ipotesi di lavoro. Come è esistito un rapporto tra il lavoro agricolo e
il territorio (i rapporti sociali e di proprietà, i metodi di lavoro, il tempo di lavoro, la struttura familiare
nel suo collocarsi spaziale, i modi e i tempi dello spostamento, i tempi delle pause e dell'intensificarsi
della fatica in relazione ad una spazialità più larga o più ristretta del lavoratore, le differenze stesse
interne al lavoro - basti pensare ai nomadismi della pastorizia e alle stanzialità della campagna -, ecc.) ,
e inoltre un preciso circoscriversi dello spazio attorno la questione dello scambio (la fiera, il mercato,
dove portare le merci, la piazza dove vendere la forza-lavoro), così l'industrializzazione ha conformato
non solo il tempo, ma persino lo spazio attorno ad essa (e non solo dentro essa). In un certo senso è
anche stato possibile leggere meglio i mutamenti produttivi e antropologici attraverso le modificazioni
indotte dalla produzione sull'organizzazione spaziale della vita umana (basti pensare al tempo di
movimento dalla casa alla fabbrica). Mi domando: esiste una precipua trasformazione dello spazio, del
territorio meridionale attorno le nuove modificazioni produttive? E' possibile individuarla? O essa è
ancora troppo isolata, troppo attutita, per provocare mutamenti sensibili? O essa invece può
sagacemente sfruttare un territorio che, per le imperfezioni ereditate dalla strutturazione fabbrichista, è
invece eccellentemente già «arato» al modo giusto? Propongo insomma un'ipotesi di lavoro per una
lettura del postfordismo nel Sud, che parta dal suo lato «esterno». Convinto che possa essere un punto
di vista altrettanto efficace di indagine, anche se più difficile. I movimenti nello spazio che il lavoratore
fa per produrre sono strettamente intrecciati al tempo della produzione, non solo dentro il luogo della
produzione stessa. A maggior ragione adesso, quando la volontà di potenza della produzione tende a
considerare tutto lo spazio come suo proprio. Interessante è capire come ciò sta accadendo (e se sta
accadendo) nel Sud: voglio dire che certo è più evidente leggerlo nel rivolgimento urbano di città come
Detroit, Wolfsburg, persino Milano. Cosa accadrà ai quartieri che raccoglievano gli operai dell'Italsider,
dell'Anic di Gela, o a quelli degli edili che fabbricavano l'espansione urbana di Catania, di Palermo?
Finiranno abbandonati come le campagne negli anni Cinquanta? Finiranno tutti come i Sassi di Matera?
C'è una ristrutturazione della mobilità del lavoro ? Per esempio, si chiudono i ministeri al centro di
Roma e li si spostano, comportando cambiamenti in abitudini di vita, di quartiere, che attorno quel
«posto fisso» s'erano costruite; alcune scuole al centro sono in crisi perché mancano i ragazzi e si
trasferiscono nelle periferie più lontane, cercando di intercettare scolarità per i propri insegnanti.
Oppure nel Sud stiamo assistendo solo ad un processo di deindustrializzazione senza che intervenga
altro?
Penso che un lavoro attorno la fabbrica Fiat di Melfi (esemplare proprio per la sua solitudine) potrebbe
farci capire differenze, con lo spazio lavorativo d'un tempo anche vicino, e similitudini, con uno spazio
lavorativo che è altrove. Ma anche un lavoro di indagine attorno un ipermercato - e nel rapporto di
comparazione tra abitudini spaziali dei lavoratori e dei clienti, potrebbe essere interessante, per vedere
come lo spazio dello scambio, del mercato si sta modificando nel Sud (dove questo spazio, il piccolo
commercio, il rapporto personale, la pausa della chiacchiera e delle informazioni e del commento,
aveva resistito più a lungo).
Insomma, seguendo il rapporto lavoro/territorio, dovremmo trovare le modificazioni della catena di
comando sul lavoro.
3) il ruolo del sapere nel Sud, le modificazioni nella gerarchia sociale della figura del possessore di
sapere, di tecniche di conoscenza, a livello basso (impiegatizio), medio (insegnante), alto
(professionista), e il mutamento della percezione sociale del sapere come potere, come capitale
spendibile, ovvero il rapporto formazione/scuola e università (esperienza delle università concepite
come innovative quali Reggio, Cosenza, Bari); è ancora il «posto», il concentrato dell'immaginario dei
giovani studenti meridionali (i concorsi, le clientele, lo Stato, gli studi generici e a scarsa connotazione
scientifica)?
4) come riprodurre questo interessante fenomeno di ridiscussione delle autonomie gestionali e
decisionali che coinvolge un buon numero di sindaci meridionali e di tutt'Italia, a partire
dall'allentamento del carattere centralistico dei Comuni verso le «proprie» periferie, e quindi
dall'invenzione di strutture autonome decentrate per territorio o tematica, capaci di decisione e
amministrazione? Come cioè scartare una possibile distorsione dell'idea repubblicana e federale, per cui
il Comune chiede democrazia verso l'alto, ma è dispotico verso il basso (che è esattamente il succo
dell'esperienza leghista dove ha governato)? Non può esserci richiesta di trasparenza verso un lato e di
opacità verso l'altro. Bisognerebbe pensare a lavorare su una qualche esperienza di quartiere, di zona,
immaginandone l'ambizione a governarsi. L’agitazione ideologica che viene fatta in alcuni quartieri del
Nord da Comitati dei cittadini, su problemi della sicurezza (caccia ai negri e agli spacciatori ecc.) in
una finzione mostruosa di democrazia dal basso e di difesa di interessi, dovrebbe essere piuttosto
rovesciata in una dimensione politica ed amministrativa (come pagare le tasse, a chi, come destinarne
l'uso nel quartiere, come ristrutturare gli appartamenti, come garantirne la distribuzione, come inventare
dei lavori e come pagarli, come migliorare il traffico interno e i collegamenti) esautorando le
circoscrizioni, i consigli di zona, anzi facendone la propria controparte.
5) spazio alla narrativa, alla critica letteraria, alla musica, al cinema e al teatro meridionali in relazione
diretta con una dimensione europea da un lato e mediterranea dall'altro.
Bene, basta. A presto, a sentirci, buon lavoro.
Roma, 10 marzo 1996