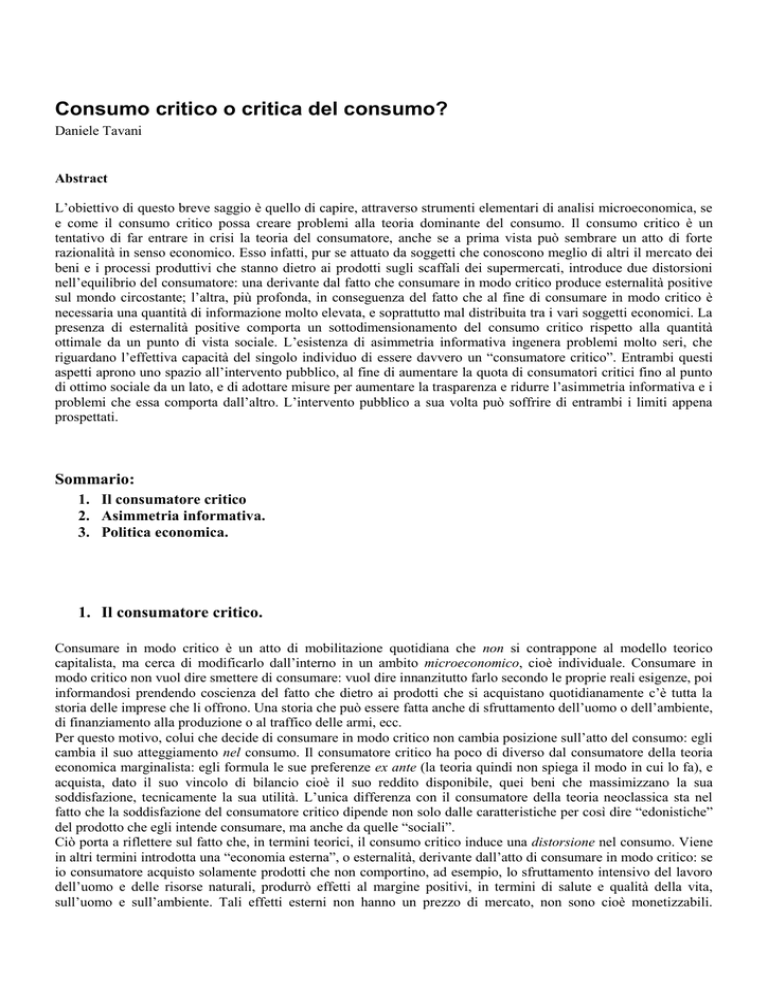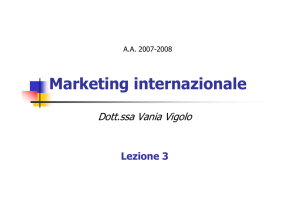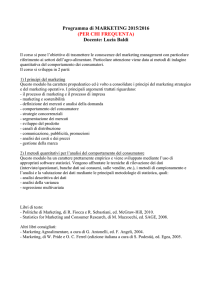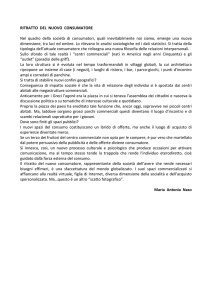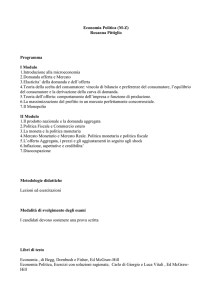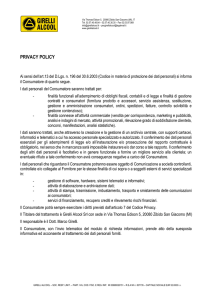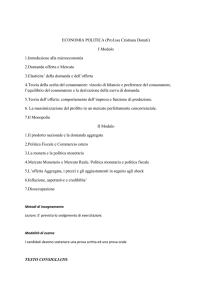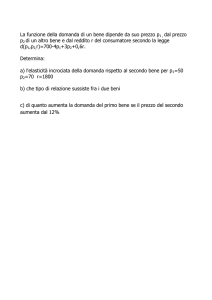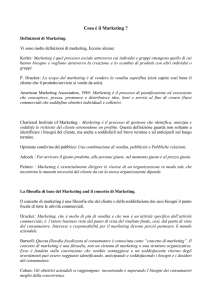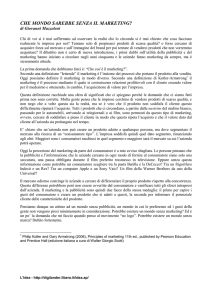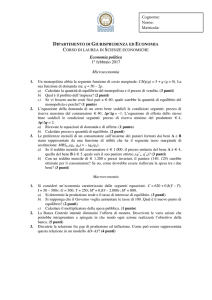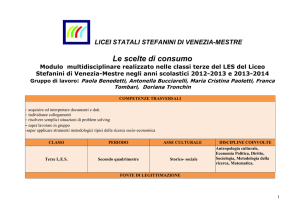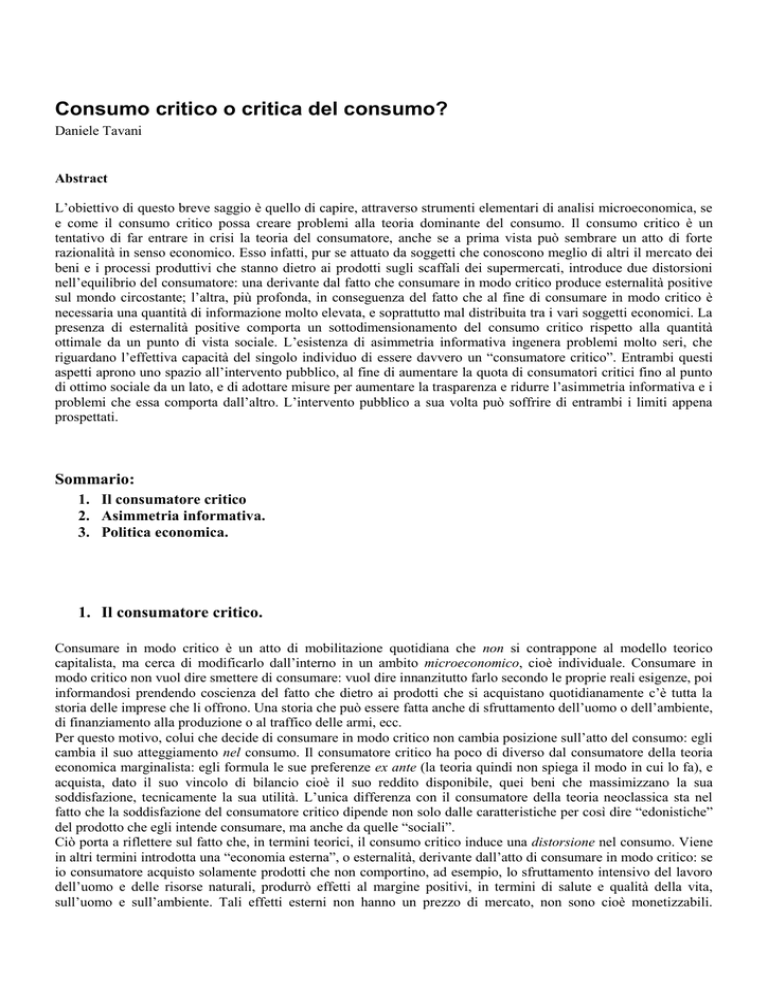
Consumo critico o critica del consumo?
Daniele Tavani
Abstract
L’obiettivo di questo breve saggio è quello di capire, attraverso strumenti elementari di analisi microeconomica, se
e come il consumo critico possa creare problemi alla teoria dominante del consumo. Il consumo critico è un
tentativo di far entrare in crisi la teoria del consumatore, anche se a prima vista può sembrare un atto di forte
razionalità in senso economico. Esso infatti, pur se attuato da soggetti che conoscono meglio di altri il mercato dei
beni e i processi produttivi che stanno dietro ai prodotti sugli scaffali dei supermercati, introduce due distorsioni
nell’equilibrio del consumatore: una derivante dal fatto che consumare in modo critico produce esternalità positive
sul mondo circostante; l’altra, più profonda, in conseguenza del fatto che al fine di consumare in modo critico è
necessaria una quantità di informazione molto elevata, e soprattutto mal distribuita tra i vari soggetti economici. La
presenza di esternalità positive comporta un sottodimensionamento del consumo critico rispetto alla quantità
ottimale da un punto di vista sociale. L’esistenza di asimmetria informativa ingenera problemi molto seri, che
riguardano l’effettiva capacità del singolo individuo di essere davvero un “consumatore critico”. Entrambi questi
aspetti aprono uno spazio all’intervento pubblico, al fine di aumentare la quota di consumatori critici fino al punto
di ottimo sociale da un lato, e di adottare misure per aumentare la trasparenza e ridurre l’asimmetria informativa e i
problemi che essa comporta dall’altro. L’intervento pubblico a sua volta può soffrire di entrambi i limiti appena
prospettati.
Sommario:
1. Il consumatore critico
2. Asimmetria informativa.
3. Politica economica.
1. Il consumatore critico.
Consumare in modo critico è un atto di mobilitazione quotidiana che non si contrappone al modello teorico
capitalista, ma cerca di modificarlo dall’interno in un ambito microeconomico, cioè individuale. Consumare in
modo critico non vuol dire smettere di consumare: vuol dire innanzitutto farlo secondo le proprie reali esigenze, poi
informandosi prendendo coscienza del fatto che dietro ai prodotti che si acquistano quotidianamente c’è tutta la
storia delle imprese che li offrono. Una storia che può essere fatta anche di sfruttamento dell’uomo o dell’ambiente,
di finanziamento alla produzione o al traffico delle armi, ecc.
Per questo motivo, colui che decide di consumare in modo critico non cambia posizione sull’atto del consumo: egli
cambia il suo atteggiamento nel consumo. Il consumatore critico ha poco di diverso dal consumatore della teoria
economica marginalista: egli formula le sue preferenze ex ante (la teoria quindi non spiega il modo in cui lo fa), e
acquista, dato il suo vincolo di bilancio cioè il suo reddito disponibile, quei beni che massimizzano la sua
soddisfazione, tecnicamente la sua utilità. L’unica differenza con il consumatore della teoria neoclassica sta nel
fatto che la soddisfazione del consumatore critico dipende non solo dalle caratteristiche per così dire “edonistiche”
del prodotto che egli intende consumare, ma anche da quelle “sociali”.
Ciò porta a riflettere sul fatto che, in termini teorici, il consumo critico induce una distorsione nel consumo. Viene
in altri termini introdotta una “economia esterna”, o esternalità, derivante dall’atto di consumare in modo critico: se
io consumatore acquisto solamente prodotti che non comportino, ad esempio, lo sfruttamento intensivo del lavoro
dell’uomo e delle risorse naturali, produrrò effetti al margine positivi, in termini di salute e qualità della vita,
sull’uomo e sull’ambiente. Tali effetti esterni non hanno un prezzo di mercato, non sono cioè monetizzabili.
Proprio per questo si chiamano infatti economie “esterne”: esse sono esterne al mercato perché non riflesse nei
prezzi che il mercato forma. Questo per la teoria economica marginalista è un classico caso di “fallimento del
mercato”.
Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire brevemente perché il mercato fallisce, cioè perché non riesce ad
allocare le risorse in modo efficiente in presenza di un’economia esterna. Per fare questo abbiamo bisogno di
conoscere 2 concetti: quello di equilibrio del consumatore e quello di ottimo paretiano. Partiamo dal primo.
Il consumatore neoclassico massimizza la sua utilità sotto il vincolo del reddito di cui dispone. Egli cioè desidera
consumare le quantità massime di beni che si può permettere con quanto guadagna, fatte alcune ipotesi sulla sua
funzione di utilità. Supponiamo quindi per semplificare che non esista il risparmio, anche perché questa
semplificazione non comporta perdita di generalità nell’analisi. Nel nostro mondo semplificato di consumo,
immaginiamo di avere solo 2 beni (il pane e la tela); ipotizziamo anche che la moneta non svolga funzioni sue
proprie a parte quelle di fungere da mezzo di pagamento, e quindi che si possano rapportare i beni tra loro
attraverso i loro prezzi. Questo significa che, facendo il rapporto tra i prezzi dei due beni, si abbia un numero
“puro” e non un valore in moneta. Chiamiamo “prezzo relativo” il rapporto tra i prezzi dei beni in questione. Il
nostro consumatore tipo misura la sua soddisfazione, per ogni combinazione di beni che può acquistare con il suo
reddito, mediante il concetto di “saggio marginale di sostituzione” (sms), che esprime la quantità marginale di pane
a cui si deve rinunciare se si vuole ottenere un’unità addizionale di tela e viceversa. Ora il massimo dell’utilità
(l’equilibrio) per il nostro consumatore-tipo, dato il reddito complessivo di cui egli dispone, sarà ottenuto quando il
prezzo relativo eguaglia il sms: questo vuol dire che il soggetto vede in quel momento perfettamente riflesse nei
prezzi le sue preferenze nel consumo. Per chiarire il concetto, pensiamo che il prezzo del pane aumenti rispetto a
quello della tela: se il consumatore è in equilibrio, egli modificherà la composizione della sua spesa in una
proporzione esattamente uguale al nuovo rapporto tra i due prezzi, mantenendo invariata la sua soddisfazione, che
peraltro è quella massima. Come lui, si comporteranno anche gli altri consumatori del nostro semplice mondo in
cui si acquistano solo pane e tela.
Supponiamo che nel nostro mondo ci siano solo due individui, facciamo l’ipotesi che il pane e la tela “piovano dal
cielo”, cioè disinteressiamoci degli aspetti legati alla produzione, e pensiamo di fare incontrare i nostri amici sul
mercato per scambiarsi le loro dotazioni di pane e di tela. L’equilibrio nello scambio tra questi due soggetti si avrà
quando i saggi marginali di sostituzione tra il pane e la tela dei due si eguagliano, e sono uguali al prezzo relativo
dei beni scambiati sul mercato, cioè al rapporto tra i prezzi dei due beni.
In questo modo, ognuno scambia i due beni nel modo migliore per sé: una situazione bellissima nella quale i prezzi
riflettono esattamente le preferenze degli individui; costoro poi sono soddisfatti pienamente dallo scambio
reciproco di beni di consumo. Questa situazione gode pure della proprietà di essere ottima per la collettività
(sempre di due persone, ma è estendibile facilmente a n individui), nel senso che non è possibile che uno dei due
individui migliori la sua soddisfazione senza peggiorare quella dell’altro (ottimo paretiano). Che vogliamo di più
dalla vita?
La favola entra in crisi se i prezzi non riflettono più solo le caratteristiche economiche del pane e della tela: se ad
esempio la produzione di tela inquina l’ambiente, il prezzo della tela continua ad essere lo stesso; tuttavia la
collettività paga un prezzo non economico in termini di peggior qualità dell’aria che respira. Questo è un costo per
la collettività, indubbiamente: non essendo esso monetizzabile, tuttavia, non è riflesso nel prezzo di mercato della
tela, e quindi si può verificare una situazione in cui, pur se i saggi marginali di sostituzione calcolati senza tener
conto dell’inquinamento sono uguali tra i due individui, e sono anche uguali al prezzo relativo, uno dei due si
ritrova con un cancro al polmone. In termini economici, si ha una differenza tra il saggio marginale “privato” e il
saggio marginale “sociale”. La soddisfazione privata richiederebbe per esempio un certo consumo di tela, l’utilità
(benessere) sociale invece ne comporterebbe un consumo minore, a causa dell’impatto ambientale elevato della
produzione della tela. La situazione ottima per il singolo individuo non è ottima per la società. L’ottimo privato è
soddisfatto dall’eguaglianza tra i saggi marginali di sostituzione “privati”; l’ottimo “sociale” richiederebbe che
fossero uguali i saggi marginali sociali.
Ciò che vale per le esternalità negative vale anche, cambiando quel che c’è da cambiare, per gli effetti esterni
positivi. Quindi assumere che il consumo critico produce un miglioramento per la qualità della vita della collettività
vuol dire che esso è fonte di un’esternalità positiva che non ha un prezzo, e che comporta una differenza tra il
saggio marginale privato e quello sociale. In particolare, come ben dimostrato dalla teoria delle esternalità, in
questo caso il saggio marginale privato è minore del saggio marginale sociale: questo comporta che la quantità di
consumo critico sia minore di quella ottima per la società. Infatti, il soggetto che consuma in modo critico non può
consumare quantità del bene eccessive per alcuni motivi: in primo luogo perché ad un certo punto possiamo
pensare che oltre un certo limite il consumo lo sazi; in secondo luogo perché la filosofia del consumo critico sta
anche nel cercare di consumare il più possibile secondo i propri bisogni, evitando gli sprechi. Infine si potrebbe
pensare che il bene che produce esternalità positive sia un prodotto equo, e quindi abbia un prezzo, anche se di
poco, superiore a quello dei suoi sostituti; se come abbiamo supposto all’inizio il reddito è dato, e non esiste il
risparmio, né positivo né negativo, ci sarà un ammontare massimo di bene che il consumatore può permettersi, e
sarà inferiore a quello che sarebbe ottimo per la collettività. Potremmo allora dire: troppo poche persone sono
virtuose, perché i non virtuosi si beccano comunque un certo vantaggio dai comportamenti virtuosi dei “bravi”.
Una considerazione di questo tipo, a dire il vero fa straripare l’analisi del consumo critico come
esternalità verso un’altra branca dell’analisi economica: quella dei beni pubblici. Per completezza, vorrei
spendere due parole nello spiegare perché potremmo considerare l'atto del consumo critico tra il novero
dei beni pubblici; il lettore che ritenga la trattazione eccessivamente appesantita da questa breve
digressione, può passare al prossimo capoverso. Le caratteristiche fondamentali dei beni pubblici
cosiddetti “puri” sono la non-rivalità e la non-escludibilità. La prima caratteristica significa che il
consumo di un bene pubblico da parte di un individuo non avviene a scapito del consumo di un altro
individuo: la difesa nazionale ad esempio non può essere erogata ad un cittadino piuttosto che ad un altro.
La non-escludibilità è qualcosa di simile a questo ma non proprio identico: essa infatti passa attraverso i
prezzi. Cioè se un contribuente paga le tasse per avere delle forze dell’ordine che mantengano la sicurezza
e un altro no, nel momento in cui sorgesse un bisogno di difesa da un attacco militare, entrambi i cittadini
sarebbero comunque difesi dalle forze dell’ordine. Un bene privato invece non gode di queste proprietà:
quando vado a comprare un filone di pane al forno, nessun altro può comprare lo stesso identico filone di
pane (e quindi c’è rivalità nel consumo); se poi non pago il prezzo del pane, il panettiere il pane non me
lo darà di certo (e quindi c’è escludibilità del consumo del bene privato-pane). Il tipico problema che
scaturisce dalle caratteristiche dei beni pubblici è la presenza di comportamenti parassitari da free riders.
Chi produce un bene pubblico, in soldoni, sapendo che non potrà discriminare in base al prezzo i suoi
eventuali acquirenti, non avrà convenienza a farlo, perché se fosse il primo a cominciare la produzione ne
sosterrebbe tutti i costi fissi. Se fossero in due, tre, n, dividerebbero il costo fisso per due, tre, n. Ma
poiché non ci sono accordi o vincoli a ripartire la produzione, ciascuno "aspetta" che inizi qualcun altro
per evitare di sostenere i costi fissi e godere invece dei benefici del consumo del bene pubblico. La mia
opinione è quindi che il consumo critico in quanto tale, e non i prodotti consumati, sia un bene pubblico
puro (samuelsoniano), in quanto non rivale e non escludibile. I beni che sono consumati in un’ottica di
consumo critico sono certamente beni privati: se non si paga il loro prezzo, non si possono consumare.
Anzi, nel caso del commercio equo e solidale la caratteristica fondamentale dei beni offerti sta proprio
nella loro qualità di avere un prezzo che risponda a certi requisiti. Tuttavia, considerando l’atto del
consumare in modo critico, esso sarà da ritenere come non escludibile. Infatti, pensando al fatto che per
essere consumatori critici bisogna informarsi, si vede chiaramente che il consumatore critico sonstiene un
costo d’informazione in termini di tempo per reperire studi sulle aziende produttrici, o in termini di
denaro per acquistare “guide al consumo critico”. Pur tuttavia, il consumo critico produce effetti (in
termini di miglior qualità dell'ambiente, dei lavoratori impiegati nella produzione di beni che rispondono
a determinate caratteristiche, ecc.), in particolare se diviene un fenomeno diffuso, che sono non
escludibili.
Riassumendo, dal lato della teoria del consumatore, il consumo critico è un atto del tutto spiegabile all’interno della
teoria marginalista del consumo: esso è un modo di inserire valutazioni sociali nell’atto del consumo, attraverso ad
esempio il boicottaggio di tutti quei prodotti che non rispondono alle preferenze del consumatore critico. Come
nelle ipotesi della teoria marginalista, tali preferenze sono formulate precedentemente all’atto del consumo, e
quindi non è necessario che la teoria le spieghi. Allo stesso modo, abbiamo visto come sia possibile dar conto del
processo di scelta sempre restando all’interno di questo mondo teorico di riferimento: il consumatore sceglie il mix
di beni che massimizza la sua utilità, dato il reddito di cui dispone. Abbiamo poi mostrato il punto centrale, e cioè
che consumando in modo critico si introducono delle economie esterne (esternalità) nel sistema. Tali esternalità
sono spiegate anch’esse all’interno dello schema neoclassico: esse non hanno un prezzo in moneta e quindi non
trovano spazio in una logica che sia meramente di mercato. Esse comportano inoltre che la quantità di consumo
critico di un’economia sarà minore di quella socialmente ottima. La conclusione, anche questa in linea con la teoria
dominante, è che, dove il mercato fallisce, c’è spazio per l’intervento pubblico: il settore pubblico può migliorare i
risultati del mercato conducendo quest’ultimo verso un obiettivo desiderabile da un punto di vista sociale. Di
questo mi occuperò nella terza parte del lavoro.
2. Asimmetria informativa.
Il secondo aspetto di cui vorrei occuparmi riguarda i problemi informativi connessi con il consumo critico. Come è
evidente, al fine di valutare se il prodotto di una certa azienda rispetta dei parametri di desiderabilità sociale, oltre
che meramente individuale, sono necessarie informazioni aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal prezzo e a quelle
presenti sull’etichetta del prodotto stesso. Queste sono infatti le due informazioni principali sulla cui base la scelta
del consumatore ha luogo: prezzo e etichetta. Soffermandoci un attimo sulla seconda, è evidente che essa non
contiene tutte le informazioni di cui il consumatore “critico” ha bisogno. Si potrebbe dire che le etichette sono
povere di informazione anche per il consumatore qualunque, ma ci sono già le associazioni di tutela che si
occupano di questo aspetto: non è questo il punto centrale della nostra analisi. Ciò che interessa noi in questo
ambito, piuttosto, è il fatto che nessuno obbliga infatti le aziende a dichiarare espressamente le tecniche produttive
utilizzate. Ciò ha lo scopo di mantenere la differenziazione tra i prodotti. La differenziazione ha lo scopo di
assicurare ai produttori una fetta del mercato, ed eventualmente di ampliarla: se tutti sapessero cosa sono i famosi
“aromi naturali” della coca-cola, tutti potrebbero produrla e la Coca-Cola Company non avrebbe motivo di esistere
(certamente questa sarebbe una situazione desiderabile per alcuni, però i giudizi di valore preferirei lasciarli fuori
dalla porta).
Il consumatore critico è una persona che vuole sapere tutto o quasi del prodotto che acquista, e perciò ha necessità
di acquisire informazioni aggiuntive rispetto al prezzo e all’etichetta. Il verbo acquisire non è utilizzato
casualmente: la raccolta di informazioni non immediatamente reperibili presenta dei costi per il consumatore. Basti
pensare al tempo necessario per reperire notizie, al costo della connessione internet per fare ricerche online sul
prodotto in questione, al costo che ha l’acquisto di una guida ai prodotti, ecc. Questo significa che l’informazione
sul mercato è ben lontana dall’essere perfetta. L’esistenza di perfetta informazione richiederebbe infatti che tutte le
notizie utili alla scelta dei beni da consumare fossero immediatamente reperibili senza costi.
Proviamo allora a vedere il problema del rapporto tra produttore e consumatore sotto un profilo diverso rispetto a
quello dello scambio di beni contro denaro. Le imperfezioni nella possibilità di informarsi completamente, infatti,
rendono molto difficoltoso parlare dei rapporti tra produzione e consumo in questi termini. Una via più proficua,
anche se a prima vista non proprio facile, è quella di considerare il rapporto tra produttore e consumatore come un
rapporto di agenzia. Questo trova la sua giustificazione nel considerare che l’esistenza di asimmetria informativa,
tradizionalmente, origina due ordini di problemi: la selezione avversa e il rischio morale.La prima riguarda
caratteristiche della prestazione o di uno dei contraenti che preesistono alla stipula del contratto; il secondo
afferisce a comportamenti opportunistici post-contrattuali.
Il consumatore esplicita i suoi bisogni di consumo e trova nell’imprenditore il soggetto che, attraverso la
produzione di beni, può soddisfare i suoi desiderata. In termini di rapporto di agenzia, si può allora dire che il
consumatore è il principale dell’imprenditore, perché delega a lui il compito di soddisfare le sue necessità di
consumo. L’imprenditore sarà invece il suo agente. Il consumatore-principale però non è in grado di controllare
perfettamente l’operato dell’imprenditore-agente: il primo manifesta le sue esigenze, il secondo è libero di produrre
come meglio crede. Per l’imprenditore il prezzo sicuramente rifletterà le tecniche produttive (infatti il prezzo del
bene deriva dalla condizione di massimizzazione del profitto sotto il vincolo della tecnica produttiva utilizzata), ma
il consumatore, quando andrà al mercato, si troverà davanti solo il prezzo, e non le tecniche utilizzate per produrre
il bene in questione. Anche considerando l’etichetta del bene di consumo, il consumatore ci troverà scritti gli
ingredienti, lo stabilimento, ma non il processo produttivo. C’è pertanto un “buco” fondamentale nell’informazione
accessibile al consumatore: egli, dagli elementi che ha a disposizione, non è in grado di sapere come avviene
materialmente la produzione del bene che desidera acquistare. Tutto ciò non ha particolari implicazioni per un
consumatore qualsiasi, che al momento dell’acquisto si accontenti degli elementi immediatamente visibili come
parametri della sua scelta. Per il consumatore critico, invece, le informazioni circa il processo produttivo sono
essenziali al fine di acquistare un prodotto piuttosto che un altro. Chiaramente, il consumatore critico non vorrà
sapere proprio tutto sui prodotti, ma si farà alcune domande che certamente ingeriscono nel merito del modo in cui
l’imprenditore impiega le risorse necessarie alla produzione. Esempi di questa ingerenza possono essere la
necessità di conoscere il trattamento dei lavoratori impiegati, l’utilizzo di fertilizzanti chimici, il testing su animali,
ecc. Tutti questi elementi sono informazioni la cui diffusione, nella maggior parte dei casi, non è obbligatoria per il
produttore.
Quindi il produttore ha in mano elementi informativi che non è interessato a diffondere, per una serie di motivi: uno
di questi è sicuramente il fatto che il processo produttivo utilizzato può essere un forte fattore di differenziazione
rispetto agli altri produttori; ma anche il fatto che ad esempio il reperimento di manodopera a basso costo e non
sindacalizzata nei paesi in via di sviluppo può permettere di realizzare margini di profitto più elevati. Il nodo della
questione è tutto qui: l’informazione necessaria per consumare in modo critico è mal distribuita, è asimmetrica.
Essa “pende” fortemente dal lato dell’imprenditore. Qui comincia la ricerca di informazioni da parte del
consumatore: ricerca che, come abbiamo appena detto, presenta dei costi. Sono proprio questi costi che “scremano”
i consumatori: i più pigri penseranno che sia inutile mettersi a fare le pulci agli imprenditori, i più critici invece
spenderanno una parte del loro tempo a farlo. È chiaro che in questa fase, di scelta della controparte, il consumatore
è soggetto al rischio di effettuare una selezione avversa, nel senso di non riuscire a scegliere il produttore che
davvero lo “meriterebbe” secondo certi parametri di eticità, ecc.
Nel momento in cui il numero di consumatori critici diventasse rilevante, tanto da suscitare l’interesse degli
imprenditori da un punto di vista del marketing, si avrà un mutamento parziale della situazione descritta in
precedenza. L’imprenditore comincerà, al fine di catturare il target dei consumatori critici, a scrivere un numero
maggiore di informazioni relative al processo produttivo sull’etichetta, lancerà campagne pubblicitarie in cui appaia
che il prodotto è un prodotto “etico”, o rispettoso dell’uomo e dell’ambiente, ecc. Eppure, l’incentivo per
l’imprenditore a “dire di più” derivante dalla possibilità di catturare un nuovo target di mercato non è di per sé
sufficiente a far sì che l’imprenditore diffonda informazioni del tutto veritiere. Infatti, più cha la veridicità delle
informazioni che si danno, conta per l’imprenditore la capacità di persuasione degli strumenti comunicativi che si
utilizzano. Si potrebbe dire sinteticamente: non è importante che ciò che si comunica sia vero, l’importante è che
sia convincente. Molti individui, infatti, non avranno motivo (o non avranno voglia) di dubitare della buona fede di
una campagna pubblicitaria, e il fatto che in essa si affermi che il prodotto reclamizzato risponde a certi requisiti di
carattere etico sarà per loro un elemento sufficiente al fine di orientare le loro scelte verso il prodotto reclamizzato.
Analogamente a quanto detto prima sulla selezione avversa, situazioni di questo tipo possono essere annoverate tra
i problemi di rischio morale (moral hazard), in quanto originati da considerazioni opportunistiche che avvengono
dopo la conclusione del contratto.
Su questo punto, centrale per la nostra discussione, si concentra il nodo principale della trattazione in termini di
rapporto principale-agente. A causa della carenza di informazioni totalmente attendibili sulle caratteristiche
dell’impresa e del suo processo produttivo, è perfettamente verosimile che il consumatore, anche quando si attivi
per effettuare una scelta “critica”, non riesca a farlo fino in fondo. Egli, in altri termini, potrebbe trovarsi spesso a
compiere quella che si chiama selezione avversa: limitandosi a compiere un’indagine per così dire superficiale sui
prodotti, scremerà le imprese che meglio lo convincono dei loro presupposti morali, e non invece quelle che
realmente attuano delle scelte condivisibili su come svolgere il processo produttivo. La selezione avversa, che trova
origine nell’esistenza di asimmetria informativa, afferisce quindi alle caratteristiche dell’oggetto in questione, che
in questo caso riguardano il processo produttivo e che preesistono alla conclusione del contratto d’acquisto.
Ma proviamo ad immaginare che il consumatore sia riuscito a superare il problema della selezione avversa, ed
abbia compiuto una scelta che ex post si rilevi quella realmente “giusta”: l’impresa il cui prodotto sia stato
prescelto, che per il momento si è comportata “bene”, potrebbe comunque sfruttare questa situazione a suo
vantaggio, in un secondo momento. La sua reputazione sarebbe sufficiente a spingere il consumatore a servirsi
nuovamente presso di lei, e magari a spingere altri consumatori a farlo. Siccome la reputazione è difficile da
cancellare, a meno di vicende eclatanti, l’impresa in questione potrebbe adottare comportamenti meno vincolanti da
un punto di vista etico il cui accertamento non fosse così immediato da parte dei consumatori, in modo ad esempio
da trarre maggiori profitti rispetto alla situazione iniziale in cui faceva la “brava”. Facciamo un esempio: l’impresa
tal dei tali che produce in Bangla Desh si vanta in un primo momento (ed è vero) di produrre senza l’impiego di
minori sotto i 13 anni. I consumatori sono contenti e scelgono i suoi prodotti. In un secondo momento, data la
buona reputazione acquisita, l’impresa, sapendo che l’accertamento sull’effettivo modo di produzione non è
semplice, comincia ad impiegare minori sotto i 13 anni perché chiedono un salario inferiore, vende il prodotto allo
stesso prezzo e quindi lucra un ricarico maggiore. Questo problema, legato all’asimmetria informativa, riguarda il
comportamento della controparte dopo la conclusione del contratto, e si denota con l’espressione moral hazard
(rischio morale). Potremmo pensare che prima o poi i consumatori subodoreranno qualcosa, ma anche se questo
fosse il caso l’impresa, che utilizza spesso metodologie di accertamento della soddisfazione dei sui clienti, quando
sentisse puzza dell’arrivo di un controllo (o di qualcosa di analogo), potrebbe ripristinare le condizioni di partenza
in modo da risultare ancora “pulita”. Essa, in un futuro ancora ulteriore, potrebbe ciclicamente “barare” in modo da
mantenere intatta la sua reputazione pur se il suo comportamento non vi corrisponde.
I problemi legati all’asimmetria informativa presente nel consumo critico sono allora molto grossi, e minano alla
base l’effettiva possibilità di consumare secondo criteri non meramente edonistici ma piuttosto sociali. Da un lato
la reale possibilità di effettuare selezioni avverse, dall’altro fenomeni di rischio morale sembrano essere ostacoli
troppo forti per compiere una scelta corretta. La rimozione delle asimmetrie informative attraverso l’introduzione
di incentivi a “non barare”, siano essi premi per l’adozione di un comportamento cooperativo con i consumatori o
meccanismi repressivi per le imprese che lo fanno, è sicuramente un compito difficile di cui potrebbe farsi carico
l’azione pubblica. Questo aspetto, insieme a quello relativo all’internalizzazione delle esternalità del consumo (vedi
articolo precedente), sarà oggetto della terza parte del saggio.
3. Politica Economica
La trattazione svolta finora ci consente di dire che il consumo critico fa “fallire” il mercato almeno sotto due punti
di vista: da un lato quello delle esternalità (o beni pubblici), dall’altro quello dell’asimmetria informativa.
Considerando entrambe queste situazioni abbiamo visto che la presenza di consumatori critici è un “fallimento” del
mercato perché implica una situazione in cui esiste la possibilità che migliori il benessere sociale di alcune persone
senza che peggiori quello di altre: questo vuol dire che il mercato, lasciato a se stesso, non riesce a raggiungere
l’ottimo paretiano. Abbiamo poi accennato al fatto che la presenza di fallimenti del mercato, in un ambito teorico
neoclassico, qual è quello all’interno del quale ci stiamo movendo, costituisce una giustificazione per l’intervento
pubblico. Esso deve consistere da un lato nell’internalizzazione delle esternalità, dall’altro nella rimozione delle
asimmetrie informative: andiamo per ordine.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’internalizzazione delle esternalità può avvenire classicamente in 4 modi: a)
l’introduzione di tasse/sussidi a seconda che l’esternalità sia rispettivamente negativa o positiva (tassazione
pigouviana); b) la fissazione di incentivi; c) l’introduzione di diritti negoziabili; d) la regolamentazione. Mi
occuperò in questa sede delle prime due possibilità.
Considerando la tassazione/sussidiazione, si potrebbero in prima approssimazione sussidiare i consumatori critici
che dimostrano di esserlo, in modo da arrivare all’ottimo paretiano. Andando più in profondità, però, si potrebbe
obiettare che già le imprese inquinanti vengono in qualche modo tassate per i danni prodotti sull’ambiente, e quindi
vi sarebbe uno spreco di risorse perché per lo stesso problema vengono adottati due provvedimenti, sopportando
due volte i costi amministrativi: bisogna allora valutare se la somma dei costi amministrativi più il costo del
sussidio per i consumatori critici supera il valore economico del beneficio di avere un numero socialmente
desiderabile di consumatori critici. Quando anche ciò fosse verificato, come si potrebbe venire a conoscenza di
quali sono realmente i consumatori critici? Il modo più semplice sarebbe con gli scontrini della spesa, ma questo
potrebbe configgere con il rispetto della libertà personale e della privacy. In generale, anche ad un livello “basso”
di analisi come quello che si sta affrontando qui, strumenti come la tassazione non sembrano facilmente
realizzabili.
Dal punto di vista degli incentivi, la questione diviene più interessante, soprattutto perché getta un ponte con l’altro
problema di cui ci siamo occupati precedentemente: quello dell’asimmetria informativa. Con riferimento alla tutela
del consumatore, soprattutto riguardo alla selezione avversa delle imprese, possiamo allora immaginare due vie,
una “diretta” e una “indiretta”. Su questo punto mi servirò degli strumenti forniti dalla teoria del signalling di
Spence. La via indiretta consiste nell’istituire una certificazione pubblica, o semipubblica, o privata, per le imprese
che utilizzano processi produttivi etici, sul modello del marchio Trans Fair o AltroMercato, in modo tale che i
consumatori sappiano che quando vanno a fare la spesa si possono orientare in base ai prodotti che presentano il
segnale di eticità. Il segnale deve essere il più possibile dissipativo, cioè tale da eliminare la verifica da parte del
consumatore della rispondenza dell’impresa ai requisiti richiesti dal segnale stesso. Il consumatore dovrebbe
dunque “fidarsi” del segnale, in modo da scegliere solamente in base al fatto che il segnale sia presente o meno. Il
segnale poi dovrebbe essere architettato in modo tale che il costo dell’ottenimento sia basso per le imprese che
adottano effettivamente un processo produttivo etico e alto per coloro che non lo fanno, in modo da evitare
pericolosi “green washing” da parte di imprese che non rispondano ai requisiti richiesti dal segnale ma che
potrebbero ugualmente procurarselo a causa dei suoi bassi costi. Un segnale che discrimini perfettamente le
imprese e costituisca un titolo sulla base del quale compiere una scelta, tuttavia, pur essendo auspicabile, potrebbe
non essere sufficiente ad aumentare la quota di consumatori critici: l’ottenimento di esso da parte delle imprese
virtuose presenterà certamente dei costi, anche se bassi (qualora il segnale fosse costruito bene), che con tutta
probabilità andranno a scaricarsi sul prezzo di mercato portandolo in alto. In questo modo si toglierebbe la
possibilità a fasce di consumatori con redditi medi o medio-bassi di partecipare a questo mercato di prodotti di
consumo critico, e li si costringerebbe a servirsi sul mercato normale.
Si potrebbe pertanto ipotizzare una tutela diretta, cioè riferita direttamente al consumatore, come ad esempio
l’istituzione di un segnale per il consumatore critico, come una certificazione o altro, che attesti che la persona ha
certi stili di consumo e come tale va in qualche modo tutelato, beneficiando magari di uno sconto sui prodotti critici
che compra presso determinati negozi convenzionati. Immaginiamo che questo segnale sia acquistabile sul
mercato, ad un certo costo, non necessariamente economico (come ad esempio la partecipazione ad un corso
specifico di consumo critico e l’ottenimento di un diploma). Il segnale, come ho detto poco sopra, dovrebbe essere
il più possibile dissipativo, cioè perfettamente discriminante, in modo che lo Stato non debba andare a verificare la
sua credibilità, ma semplicemente il possesso o meno del segnale stesso da parte dei cittadini. Questo segnale,
inoltre, deve essere costruito in modo che la sua acquisizione risulti conveniente solo per i cittadini che siano
veramente consumatori critici, perché se ottenerlo fosse troppo facile anche per gli altri tutti se ne doterebbero in
modo da avere gli sconti ai “supermercati etici” che abbiamo immaginato prima. Cioè, il segnale deve costare poco
ai consumatori realmente critici e molto ai consumatori “all’americana”, per intenderci.
In conclusione, allora, ho provato a spiegare il consumo critico con gli strumenti propri della teoria del consumo
più utilizzata, ed ho mostrato i suoi caratteri di fallimento del mercato. Nel pensare a soluzioni per questo tipo di
problemi, come quelle che ho prospettato in questa terza parte del saggio, bisogna sempre tenere presente che dove
il mercato fallisce non è detto che lo Stato possa automaticamente far meglio: anche al suo interno i problemi di
agenzia sono molto rilevanti. In particolare i rapporti di agenzia non intercorrono solo tra il principale-cittadino e
l’agente-politico, ma anche tra il principale-politico e l’agente-burocrate. Poiché né politici né burocrati, quando
sono considerati nella loro veste di agenti, si comportano da agenti “fedeli” rispettando interamente il loro mandato,
ma anzi hanno sempre una funzione propria di utilità rispetto a certi bisogni che non condividono con i cittadini,
bisogna sempre stare attenti nel momento in cui si attribuisce all’azione pubblica il compito di risolvere i problemi
creati dall’operare del mercato. Questo non toglie la fiducia nell’operato del settore pubblico: significa però
utilizzare strumenti che limitino la possibilità per gli operatori pubblici di perseguire obiettivi loro propri, o almeno
li incentivino a rispettare gli impegni presi con i loro “principali”, siano essi i cittadini o il governo.