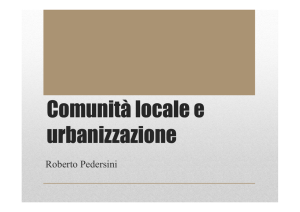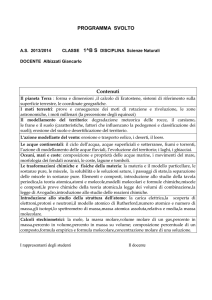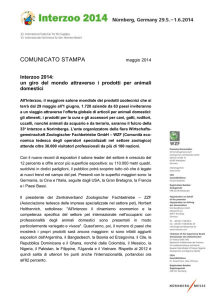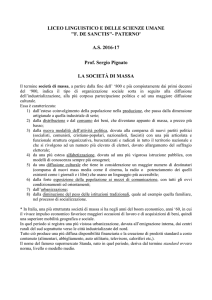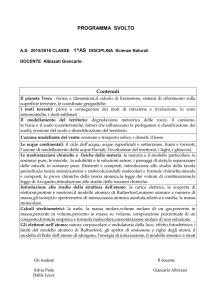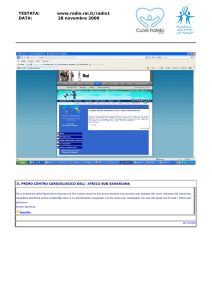Mike Davis, Il pianeta degli slum
dal cap. 1 Il climaterio urbano
Ritorno a Dickens
La dinamica dell’urbanizzazione del Terzo mondo ricapitola e al contempo fonde i precedenti di
Europa e Nord America del Diciannovesimo e dell’inizio del Ventesimo secolo. In Cina, la più grande
rivoluzione industriale nella storia è la leva di Archimede che sposta una popolazione grande quanto
quella dell’Europa dai villaggi rurali alle città soffocate dallo smog e che si inerpicano verso il cielo:
dalle riforme di mercato dei tardi anni settanta a oggi, si stima che più di duecento milioni di cinesi si
siano trasferiti dalle aree rurali alle città. Altri duecentocinquanta o trecento milioni di persone – la
successiva “ondata contadina” – dovrebbero seguire nei decenni in arrivo. In seguito a questo colossale
afflusso, 166 città cinesi nel 2005 (contro appena nove città statunitensi) avevano una popolazione
superiore al milione. Città che hanno vissuto un boom industriale come Dongguan, Shenzhen, Fushan e
Chengchow sono le Sheffield e Pittsburgh del postmoderno. Come ha recentemente messo in evidenza
il “Financial Times”, nell’arco di un decennio “la Cina cesserà di essere il paese prevalentemente rurale
che è stato per millenni”. In effetti, il grande finestrone del World Financial Centre di Shanghai
potrebbe ben presto affacciarsi su un vasto mondo urbano mai immaginato non solo da Mao ma
neppure da Le Corbusier.
È improbabile che anche solo cinquant’anni fa qualcuno potesse presagire che Seoul, con i suoi campi
profughi e le sue macerie di guerra, avrebbe compiuto una metamorfosi così vertiginosa (un incredibile
11,4 percento l’anno durante gli anni sessanta) trasformandosi in una megalopoli grande quanto la
Greater New York – ma d’altra parte quale vittoriano avrebbe potuto prefigurarsi che negli anni venti
sarebbe esistita una città come Los Angeles? Comunque, imprevedibile quanto le sue specifiche storie
locali e i suoi miracoli urbani, l’urbanizzazione contemporanea dell’Asia orientale, accompagnata da un
Pil triplicato negli ultimi quarant’anni, conserva una relazione quasi classica tra crescita manifatturiera
e migrazione urbana. L’ottanta percento del proletariato industriale di Marx oggi vive in Cina o in altri
luoghi al di fuori dell’Europa occidentale e degli Stati Uniti.
In gran parte del mondo in via di sviluppo, però, la crescita delle città è priva dei potenti motori di
esportazione manifatturiera posseduti dalla Cina, dalla Corea e da Taiwan, oltre che del vasto afflusso
di capitale estero di cui dispone la Cina (attualmente pari a metà dell’investimento estero totale
nell’intero mondo in via di sviluppo). Dalla metà degli anni ottanta, le grandi città industriali del Sud
del mondo – Bombay, Johannesburg, Buenos Aires, Belo Horizonte e San Paolo – sono state tutte
colpite da pesanti chiusure di impianti e da una tendenziale deindustrializzazione. Altrove,
l’urbanizzazione è stata separata più radicalmente dall’industrializzazione, perfino dallo sviluppo in sé
e, nell’Africa subsahariana, da quel presunto sine qua non dell’urbanizzazione che è l’aumento della
produttività agricola. La dimensione dell’economia di una città, come risultato, spesso mostra
scarsissima relazione con l’entità della sua popolazione, e viceversa. La figura 5 illustra questa disparità
tra livelli di popolazione e Pil per le maggiori aree metropolitane.
Qualcuno potrebbe sostenere che l’urbanizzazione senza industrializzazione è l’espressione di una
tendenza inesorabile: la tendenza, insita nel capitalismo del silicio, a sganciare la crescita della
produzione da quella dell’occupazione. Ma in Africa, in America Latina, in Medio Oriente e in gran
parte dell’Asia meridionale, l’urbanizzazione senza crescita, come vedremo più avanti, rappresenta più
palesemente l’eredità di una congiuntura politica globale – la crisi debitoria mondiale dei tardi anni
settanta e la conseguente ristrutturazione, guidata dal Fmi, delle economie del Terzo mondo negli anni
ottanta – che non il risultato di una qualche ipotetica ferrea legge del progresso tecnologico.
L’urbanizzazione del Terzo mondo, inoltre, ha continuato la sua corsa a rotta di collo (3,8 percento
l’anno dal 1960 al 1993) per tutto il periodo delle locuste degli anni ottanta e dei primi anni novanta,
nonostante la caduta dei salari reali, l’aumento dei prezzi e una disoccupazione urbana alle stelle.
Questo perverso boom urbano ha colto di sorpresa quasi tutti gli esperti e ha contraddetto i modelli
economici ortodossi che predicevano che il feedback negativo della recessione urbana avrebbe
rallentato o addirittura rovesciato la migrazione dalle campagne. “Sembrerebbe,” commentava
interdetto l’economista Niger Harris nel 1990, “che per i paesi a basso reddito una caduta significativa
nei redditi urbani non debba produrre necessariamente, nel breve periodo, un declino nella migrazione
rurale-urbana.”
Particolarmente paradossale era la situazione in Africa: come facevano città della Costa d’Avorio, della
Tanzania, del Congo-Kinshasa, del Gabon, dell’Angola, e di altri paesi – dove le economie si andavano
contraendo a un tasso tra il due e il cinque percento l’anno – a sostenere una crescita di popolazione
annua tra il quattro e l’otto percento? Come faceva Lagos negli anni ottanta a crescere a un ritmo
doppio della popolazione nigeriana, mentre la sua economia urbana era in profonda recessione? Anzi,
come ha potuto l’Africa nel suo insieme, attualmente in un’epoca buia di occupazione urbana stagnante
e di produttività agricola ferma, sostenere un tasso di urbanizzazione annuo (dal 3,5 al 4,0 percento)
considerevolmente più alto della media di quasi tutte le città europee (2,1 percento) all’apice degli anni
della crescita vittoriana?
Una parte del segreto, ovviamente, sta nel fatto che le politiche di deregulation agricola e di disciplina
finanziaria imposte dal Fmi e dalla Banca mondiale hanno continuato a generare un esodo del surplus
di manodopera rurale verso gli slum urbani proprio quando le città cessavano di essere delle macchine
produttrici di posti di lavoro. Come sottolinea nella sua rassegna di recenti ricerche agrarie Deborah
Bryceson, importante africanista europea, gli anni ottanta e novanta sono stati segnati da una
generazione di sconvolgimenti senza precedenti nella campagna globale:
A uno a uno i governi nazionali, strangolati dai debiti, sono finiti soggetti ai programmi di
aggiustamento strutturale (Pas) e alle condizioni del Fondo monetario internazionale. I pacchetti di
miglioramento sovvenzionato della produzione agricola e della edificazione infrastrutturale rurale sono
stati drasticamente ridotti. Con l’abbandono dello sforzo di “modernizzazione” nelle nazioni
latinoamericane e africane, i contadini si sono trovati sottoposti alla strategia economica del “nuota o
annega” delle istituzioni finanziarie internazionali. La deregulation dei mercati nazionali ha spinto i
produttori agricoli sui mercati globali delle merci, dove non solo i contadini poveri ma anche quelli di
medio reddito trovavano poco sostenibile la competizione. I Pas e le politiche di liberalizzazione
economica rappresentavano la convergenza delle forze mondiali della deagrarizzazione e delle politiche
nazionali che promuovevano la decontadinizzazione.
Con la scomparsa delle reti di sicurezza, i contadini poveri sono diventati sempre più esposti a qualsiasi
tipo di shock esogeno: come le siccità, l’inflazione, i tassi d’interesse crescenti e la caduta dei prezzi
delle materie prime. (O come le malattie: secondo le stime, il sessanta percento dei piccoli coltivatori
cambogiani che vendono la terra e si trasferiscono in città lo fa perché costretto dai debiti contratti per
pagare le cure mediche.)
Contemporaneamente, i rapaci signori della guerra e le croniche guerre civili, spesso scaturite dalle
dislocazioni economiche dell’aggiustamento strutturale imposto dal debito o da predatori economici
stranieri (come nel Congo e in Angola), sradicano intere campagne. Le città – nonostante la loro
crescita economica stagnante o negativa, e prive dei necessari investimenti in nuove infrastrutture,
strutture scolastiche o sistemi di sanità pubblica – hanno semplicemente raccolto i frutti di questa crisi
agraria mondiale. Anziché lo stereotipo classico della campagna ad alta intensità di manodopera e della
metropoli ad alta intensità di capitale, il Terzo mondo oggi contiene molti esempi di campagne ad alta
intensità di capitale e di città deindustrializzate ad alta intensità di forza lavoro:
l’“iperindustrializzazione”, in altre parole, è trainata dalla riproduzione della povertà e non dall’offerta
di posti di lavoro. Questo è uno degli imprevisti binari sui quali l’ordine mondiale neoliberista sta
smistando il futuro.
Da Karl Marx a Max Weber la teoria sociale ha sempre pensato che le grandi città del futuro avrebbero
seguito i passi di Manchester, Berlino e Chicago – e in effetti Los Angeles, San Paolo, Pusan, e oggi
Ciudad Juarez, Bangalore e Guangzhou, si sono avvicinate a questa traiettoria canonica. La maggior
parte delle città del Sud, però, ricordano più la Dublino vittoriana, che come ha rilevato lo storico
Emmer Larkin era unica tra “tutte le realtà di slum che hanno preso vita nel mondo occidentale nel
Diciannovesimo secolo... [perché] i suoi slum non erano un prodotto della rivoluzione industriale. Tra
il 1800 e il 1850, in effetti, Dublino ha sofferto più dei problemi della deindustrializzazione che
dell’industrializzazione”.
Analogamente, Kinshasa, Luanda, Khartoum, Dar-es-Salaam, Guayaquil e Lima continuano a crescere
in maniera prodigiosa nonostante lo stato disastroso delle industrie di sostituzione delle importazioni, i
settori pubblici ridimensionati e le classi medie in mobilità verso il basso. Le forze globali che
“espellono” la popolazione dalle campagne – la meccanizzazione dell’agricoltura a Giava e in India, le
importazioni alimentari in Messico, Haiti e Kenya, la guerra civile e la siccità in tutta l’Africa, e i
fenomeni ormai globali della fusione delle piccole proprietà in proprietà grandi e della concorrenza di
agribusiness di scala industriale – sembrano sostenere l’urbanizzazione anche quando l’“attrazione”
della città appare drasticamente indebolita dal debito e dalla depressione economica. Di conseguenza, la
rapida crescita urbana in un contesto di aggiustamenti strutturali, svalutazione monetaria e tagli statali è
stata inevitabilmente una ricetta per la produzione di massa di slum. Un ricercatore dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (Oil) ha calcolato che i mercati ufficiali immobiliari nel Terzo mondo
raramente forniscono più del venti percento del nuovo stock abitativo, per cui la gente per necessità
ripiega sulle baracche improvvisate, gli affitti in nero, le lottizzazioni pirata o i marciapiedi. “Illegali o
informali mercati dei suoli,” dice l’Onu, “hanno fornito i siti per la maggior parte degli incrementi dello
stock abitativo, nella maggior parte delle città del Sud del mondo nel corso degli ultimi trenta o
quarant’anni.”
Dal 1970, la crescita degli slum in tutto il Sud ha superato l’urbanizzazione in sé. Così, a proposito
della Città del Messico del tardo Novecento, l’urbanista Priscilla Connolly osserva che “fino al sessanta
percento, la crescita della città è riconducibile all’attività di persone, soprattutto donne, che eroicamente
costruiscono le proprie abitazioni su terreni periferici privi di servizi, mentre il lavoro informale di
sussistenza ha sempre rappresentato una grande fetta dell’occupazione totale”. Le favelas di San Paolo
– appena l’1,2 percento della popolazione totale della città nel 1973 ma il 19,8 percento nel 1993 –
sono cresciute negli anni novanta al tasso esplosivo del 16,4 percento all’anno. In Amazzonia, una delle
frontiere urbane a più rapida crescita che esista al mondo, l’ottanta percento dello sviluppo delle città si
è avuto in baraccopoli in larga misura non servite da strutture istituzionali e dai trasporti municipali,
cosa che ha trasformato l’“urbanizzazione” in un sinonimo di “favelizzazione”.
Le stesse tendenze sono riscontrabili in tutta l’Asia. Le autorità di polizia di Pechino stimano che ogni
anno arrivano in città duecentomila “fluttuanti” (migranti rurali non registrati), molti dei quali affollano
slum illegali lungo il margine meridionale della capitale. Nell’Asia meridionale, intanto, uno studio
della fine degli anni ottanta indicava che fino al novanta percento della crescita delle famiglie urbane ha
avuto luogo negli slum. La vastissima popolazione di katchi abadi (occupanti abusivi) di Karachi
raddoppia ogni decennio, e gli slum indiani continuano a crescere a un ritmo del duecentocinquanta
percento più rapido della popolazione complessiva. Il deficit abitativo annuo di Bombay, stimato in
quarantacinquemila unità nel settore ufficiale, si traduce in un corrispondente incremento nelle
abitazioni informali degli slum. Del mezzo milione di persone che migrano a Delhi ogni anno, si
calcola che quattrocentomila finiscono negli slum; entro il 2015 la capitale dell’India avrà una
popolazione di slum di oltre dieci milioni. “Se la tendenza prosegue con lo stesso ritmo,” avverte
Gautam Chatterjee, esperto di pianificazione, “avremo solo slum e non più città.”
La situazione dell’Africa, si capisce, è ancora più estrema. Gli slum africani stanno crescendo a una
velocità doppia della deflagrazione delle città del continente. In pratica, un incredibile ottantacinque
percento della crescita di popolazione del Kenya tra il 1989 e il 1999 è stato assorbito dai fetidi e
sovraffollati slum di Nairobi e Mombasa. Intanto, ogni realistica speranza di una mitigazione della
povertà urbana dell’Africa è svanita dall’orizzonte ufficiale. Alla riunione congiunta annuale del Fmi e
della Banca mondiale nell’ottobre del 2004, Gordon Brown, cancelliere dello Scacchiere del Regno
Unito e probabile successore di Tony Blair, osservava che l’iniziativa dell’Onu Millennium
Development Goals per l’Africa, la cui realizzazione era originariamente prevista per il 2015, non
sarebbe stata portata a compimento per generazioni: “L’Africa subsahariana raggiungerà l’istruzione
elementare universale solo nel 2130, la riduzione della povertà del cinquanta percento nel 2150 e
l’eliminazione delle morti infantili evitabili nel 2165”. Nel 2015 l’Africa nera avrà 332 milioni di
abitanti negli slum, una cifra che continuerà a raddoppiare ogni quindici anni.
Così, le città del futuro, lungi dall’essere fatte di vetro e acciaio secondo le previsioni di generazioni di
urbanisti, saranno in gran parte costruite di mattoni grezzi, paglia, plastica riciclata, blocchi di cemento
e legname di recupero. Al posto delle città di luce che si slanciano verso il cielo, gran parte del mondo
urbano del Ventunesimo secolo vivrà nello squallore, circondato da inquinamento, escrementi e
sfacelo. Anzi, il miliardo di cittadini che abitano gli slum postmoderni guarderà molto probabilmente
con invidia le rovine delle solide case di fango di Catal Hayuk in Anatolia, erette all’alba della vita
urbana, ottomila anni fa.