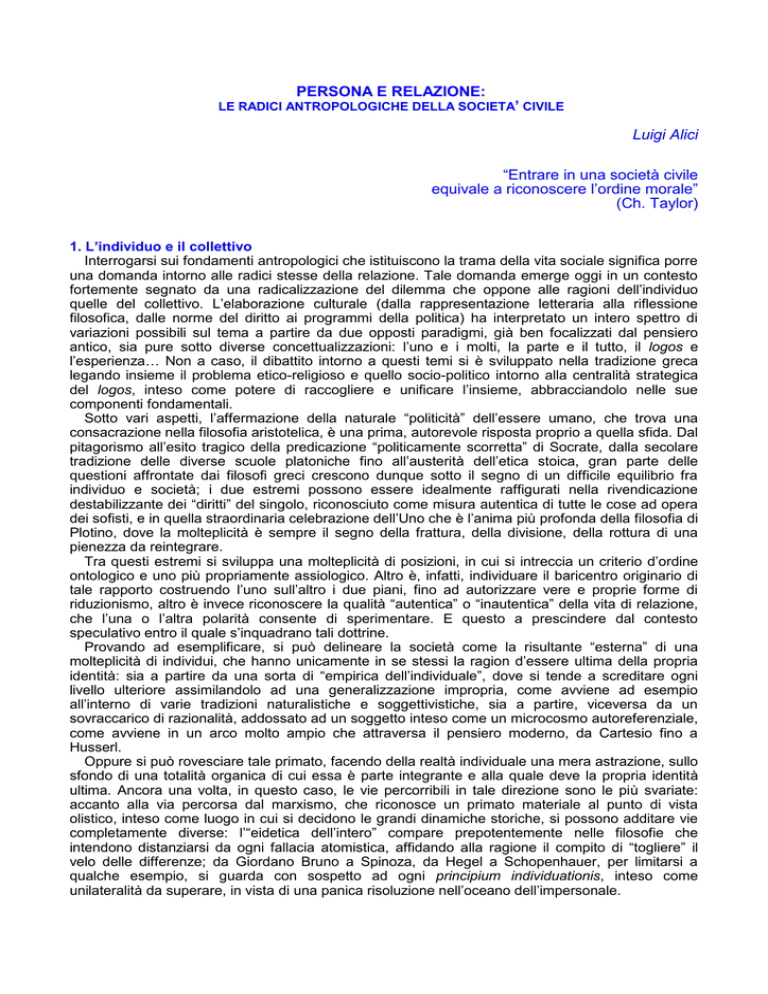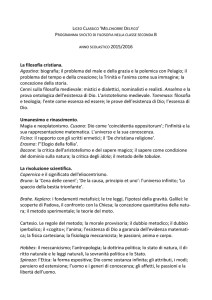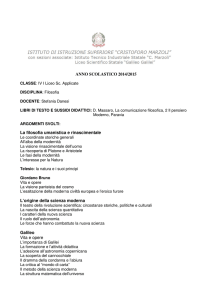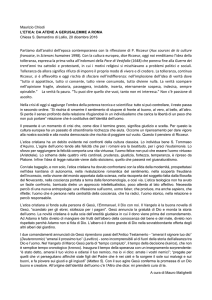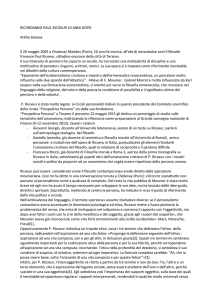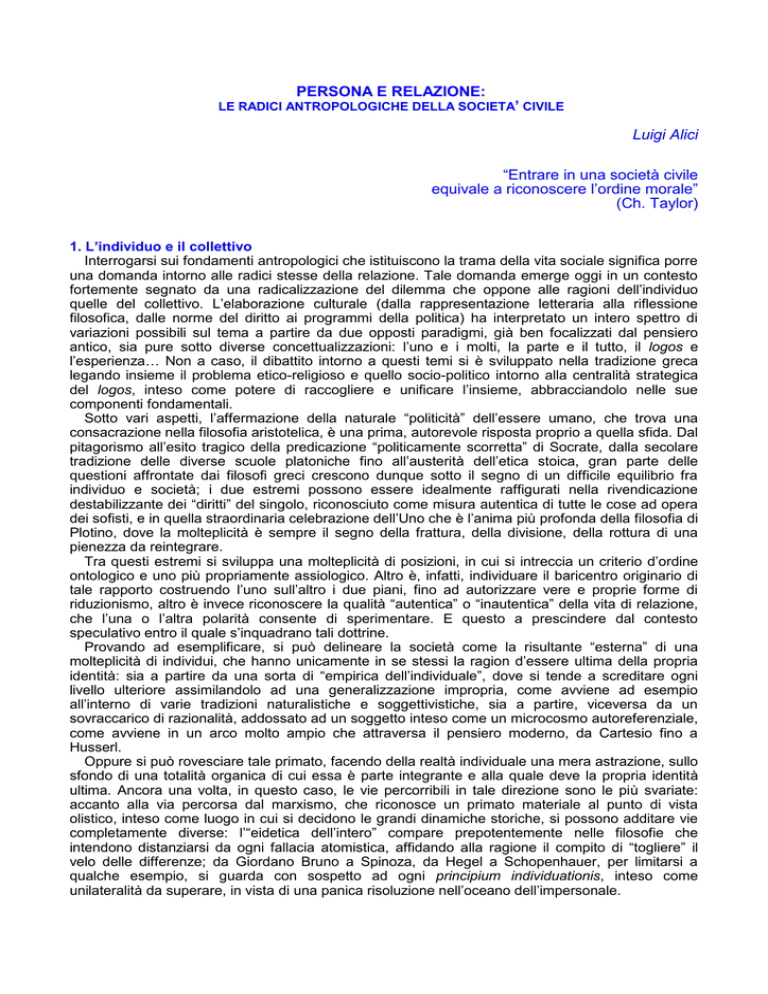
PERSONA E RELAZIONE:
LE RADICI ANTROPOLOGICHE DELLA SOCIETA’ CIVILE
Luigi Alici
“Entrare in una società civile
equivale a riconoscere l’ordine morale”
(Ch. Taylor)
1. L’individuo e il collettivo
Interrogarsi sui fondamenti antropologici che istituiscono la trama della vita sociale significa porre
una domanda intorno alle radici stesse della relazione. Tale domanda emerge oggi in un contesto
fortemente segnato da una radicalizzazione del dilemma che oppone alle ragioni dell’individuo
quelle del collettivo. L’elaborazione culturale (dalla rappresentazione letteraria alla riflessione
filosofica, dalle norme del diritto ai programmi della politica) ha interpretato un intero spettro di
variazioni possibili sul tema a partire da due opposti paradigmi, già ben focalizzati dal pensiero
antico, sia pure sotto diverse concettualizzazioni: l’uno e i molti, la parte e il tutto, il logos e
l’esperienza… Non a caso, il dibattito intorno a questi temi si è sviluppato nella tradizione greca
legando insieme il problema etico-religioso e quello socio-politico intorno alla centralità strategica
del logos, inteso come potere di raccogliere e unificare l’insieme, abbracciandolo nelle sue
componenti fondamentali.
Sotto vari aspetti, l’affermazione della naturale “politicità” dell’essere umano, che trova una
consacrazione nella filosofia aristotelica, è una prima, autorevole risposta proprio a quella sfida. Dal
pitagorismo all’esito tragico della predicazione “politicamente scorretta” di Socrate, dalla secolare
tradizione delle diverse scuole platoniche fino all’austerità dell’etica stoica, gran parte delle
questioni affrontate dai filosofi greci crescono dunque sotto il segno di un difficile equilibrio fra
individuo e società; i due estremi possono essere idealmente raffigurati nella rivendicazione
destabilizzante dei “diritti” del singolo, riconosciuto come misura autentica di tutte le cose ad opera
dei sofisti, e in quella straordinaria celebrazione dell’Uno che è l’anima più profonda della filosofia di
Plotino, dove la molteplicità è sempre il segno della frattura, della divisione, della rottura di una
pienezza da reintegrare.
Tra questi estremi si sviluppa una molteplicità di posizioni, in cui si intreccia un criterio d’ordine
ontologico e uno più propriamente assiologico. Altro è, infatti, individuare il baricentro originario di
tale rapporto costruendo l’uno sull’altro i due piani, fino ad autorizzare vere e proprie forme di
riduzionismo, altro è invece riconoscere la qualità “autentica” o “inautentica” della vita di relazione,
che l’una o l’altra polarità consente di sperimentare. E questo a prescindere dal contesto
speculativo entro il quale s’inquadrano tali dottrine.
Provando ad esemplificare, si può delineare la società come la risultante “esterna” di una
molteplicità di individui, che hanno unicamente in se stessi la ragion d’essere ultima della propria
identità: sia a partire da una sorta di “empirica dell’individuale”, dove si tende a screditare ogni
livello ulteriore assimilandolo ad una generalizzazione impropria, come avviene ad esempio
all’interno di varie tradizioni naturalistiche e soggettivistiche, sia a partire, viceversa da un
sovraccarico di razionalità, addossato ad un soggetto inteso come un microcosmo autoreferenziale,
come avviene in un arco molto ampio che attraversa il pensiero moderno, da Cartesio fino a
Husserl.
Oppure si può rovesciare tale primato, facendo della realtà individuale una mera astrazione, sullo
sfondo di una totalità organica di cui essa è parte integrante e alla quale deve la propria identità
ultima. Ancora una volta, in questo caso, le vie percorribili in tale direzione sono le più svariate:
accanto alla via percorsa dal marxismo, che riconosce un primato materiale al punto di vista
olistico, inteso come luogo in cui si decidono le grandi dinamiche storiche, si possono additare vie
completamente diverse: l’“eidetica dell’intero” compare prepotentemente nelle filosofie che
intendono distanziarsi da ogni fallacia atomistica, affidando alla ragione il compito di “togliere” il
velo delle differenze; da Giordano Bruno a Spinoza, da Hegel a Schopenhauer, per limitarsi a
qualche esempio, si guarda con sospetto ad ogni principium individuationis, inteso come
unilateralità da superare, in vista di una panica risoluzione nell’oceano dell’impersonale.
In entrambi i casi insomma, variamente declinati al loro interno, il nesso individuo-società appare
fondamentalmente riducibile, anche se in direzioni opposte. Non sempre, però, a queste diverse
gerarchie corrisponde una valutazione univoca: sia la dimensione individuale che quella sociale si
configurano come contesti dinamici e polivalenti; non solo: quasi sempre il vertice ritenuto più alto
della scala assiologica è quello che “apre” alla polarità reciproca. Si assiste in tal modo al tentativo
di distinguere tra dottrine “aperte” e “chiuse”, relative sia alla nozione d’individuo che a quella di
società; individua-lismo e collettivismo sarebbero i modelli estremi di un paradigma chiuso, mentre,
in senso contrario, si ritiene possibile preservare tali dimensioni da un’involuzione interna proprio
appellandosi alla polarità complementare: sarebbe quindi accettabile quella nozione d’individuo che
permette un’equilibrata apertura al sociale, e viceversa.
In ogni caso, rispetto alla tradizione classica il pensiero moderno registra una cesura
fondamentale nel modo d’intendere il rapporto tra persona e società. Mentre a partire da Aristotele
era proprio la polis, la comunità politica, in quanto unione di molti uomini aventi un fine comune, il
luogo in cui si rendeva possibile il “vivere bene”, all’altezza cioè della perfezione umana1, in epoca
moderna viene meno progressivamente l’idea di una “società per natura”, che esprime cioè una
tendenza naturale dell’essere umano. Con Hobbes, ad esempio, la società civile diventa l’antitesi
assoluta di uno stato di natura attraversato da una “guerra di tutti contro tutti”, che sconfessa in
radice l’idea dell’uomo come “animale politico”. Tale contrapposizione tra “natura e artificio”
ricompare in Locke, che però ne ricava conseguenze opposte, cercando di ridurre al minimo il
potere dello Stato in favore della massima libertà dei singoli, e ancor più in Rousseau, anche se la
gerarchia valutativa tra i due stati qui si rovescia2.
Quel legame sociale che non sembra espressione naturale della convivenza umana dev’essere
quindi rinforzato ideologicamente e “protetto” dalla politica. In entrambi i casi, per motivi opposti, la
modernità ha alimentato forme estreme di collettivismo, rinforzando indirettamente un’aspra
reazione individualistica. Più di un autore ha messo in luce come il secolo che ormai abbiamo alle
spalle sembra essere in larga misura dominato da questa spinta: “il XX secolo è stata
manifestamente l’epoca dei fenomeni collettivi”3. Dietro ai movimenti di massa, alle pressioni
ideologiche forti e alle politiche totalitarie sta indubbiamente una crisi profonda: “La crisi della
ragione – ha scritto Horkheimer – trova espressione nella crisi dell’individuo, come strumento del
quale la ragione aveva conosciuto i suoi trionfi […] Un tempo l’individuo vedeva nella ragione solo
uno strumento dell’io; ora si trova davanti al rovesciamento di questa deificazione dell’io. La
macchina ha gettato a terra il conducente, e corre cieca nello spazio”4. Gli fa eco anche Adorno:
“Tra le grandi unità standardizzate e amministrate l’individuo continua a vegetare […] Ma non è più,
in realtà, che la funzione della propria unicità, un pezzo da esposizione, come i mostri che
suscitavano lo stupore e le risa dei bambini […] Viene custodito in una specie di parco naturale, e
diventa oggetto di oziosa contemplazione”5.
Non è possibile seguire il filo di una riflessione filosofica che denuncia l’antropocentrismo
moderno e il suo esito nichilistico, frutto di quello che Heidegger ha chiamato l’“imperialismo
planetario dell’uomo tecnicamente organizzato”6. La fine del secolo, tuttavia, sembra chiudersi nel
segno opposto: quello di un ritorno impetuoso, a tratti selvaggio, ai “diritti” dell’individuo, che
imprime alla stessa riflessione etico-giuridica un nuovo carattere “situazionale”, come osserva
anche Viola, secondo il quale oggi “i diritti umani non sono più definiti a prescindere dalle differenze
(di sesso, di religione, di lingua, di razza…) ma come veri e proprio “diritti delle differenze””7. La
celebrazione moderna di tali diritti in chiave universalista conosce una duplice erosione, prodotta
per un verso da istanze decostruttive che indeboliscono la fiducia nelle competenze
sintetico-progettuali e nell’intenzionalità veritativa della ragione, per l’altro verso da una crisi sempre
più estesa dello Stato nazionale, delegittimato al suo interno dal venir meno del senso comunitario
e all’esterno dalle pressioni della globalizzazione.
Qual è la radice di quest’oscillazione, che ripropone in termini nuovi un dilemma antico e
ricorrente? Se è vero che la persona umana è l’unico essere che può dire: “io”, che si riconosce
inchiodato, come dice Jankélévitch, a quella “misteriosa tautologia che si riassume
nell’espressione: “io sono il solo ad essere me stesso””8, è altrettanto vero che questo atto
elementare di riconoscimento appare inseparabile da un contesto più ampio, nel quale la pluralità
degli individui confluisce entro una pluralità interconnessa di sfere partecipative.
Ci stiamo avvicinando, per gradi, al centro di questo contributo: lo storico pendolarismo tra le
ragioni dell’uno e quelle dei molti non depone forse a favore di un’irriducibile reciprocità tra le due
dimensioni? Lo stesso tentativo di moderare ogni estremismo, condannandone la unilateralità e
cercando in qualche modo di aprire alla polarità complementare, sembra confermare tale
interpretazione. Ma in questa sede si vorrebbe andare oltre, provando ad interrogarsi intorno alle
radici di un difficile equilibrio, che non può essere risolto semplicemente inseguendo un precario
bilanciamento esterno: individuo non è soltanto termine antagonista di società, quasi un deterrente
ideologico-politico contro il totalitarismo, né la società può essere ridotta ad un argine negativo nei
confronti di prevaricazioni egoistiche.
Il dato storico sicuramente non è trascurabile, ma, al di là del suo peso obiettivo, il compito di una
ricognizione etico-filosofica è un altro. Su questa linea è preziosa una fondamentale annotazione di
Tommaso, fatta a margine di una “quaestio de pluralitate personarum in divinis”; egli infatti ricorda:
“unum non est remotivum multitudinis, sed divisionis”9. La via analogica preserva le differenze, le
quali trovano nell’unità un fondamentale centro di riferimento. Provando ad attualizzare: tutte le
visioni irriducibilmente conflittuali della convivenza scambiano la molteplicità con l’ostilità; i molti
s’oppongono all’uno non in sé, ma in quanto si lasciano disunire dalla divisione.
La tesi attorno alla quale cercherò di abbozzare una pista di riflessione può essere, a questo
punto, scandita attraverso tre passaggi internamente collegati. Anzitutto: il nodo radicale dal quale
dipende una riconsiderazione equilibrata e positiva del nesso persona-società sembra essere
costituito essenzialmente dal tema della relazione. Individualismo e collettivismo sono, da questo
punto di vista, due estremismi prodotti da una rimozione indebita del tema della relazione. In
secondo luogo: se è vero che la relazione “si dice in molti modi”, non bisogna però lasciarsi
catturare dalla “cattiva infinità” delle differenze. Accanto allo spettro amplissimo delle differenze
d’ordine fattuale (relazioni di natura amicale, affettiva, economica, politica ecc), occorre riconoscere
il livello più alto, che, oltre la rete delle relazioni di fatto, individua l’orizzonte trascendentale delle
condizioni universali e necessarie che rendono possibile la relazione, e con ciò ogni potenzialità
partecipativa.
Infine, occorre trovare nella relazione intrapersonale (dell’io con se stesso) l’ambito in cui
s’incrociano il movimento orizzontale della relazione, che investe il vasto campo dei rapporti
interpersonali, e quello verticale, che si sporge verso il dislivello assoluto di un’Alterità
trascendente. Quest’ultimo approdo non solo non “chiude” alla dimensione sociale, ma lascia
intravedere l’autentico fondamento intersoggettivo della società civile, inscrivendolo all’interno di
una scala partecipativa che va dal riconoscimento alla cooperazione. È questa, in fondo, la ragione
ultima del dibattito tra liberali e comunitari, e insieme la misura della sua irrisolta parzialità.
2. Il fulcro delle relazioni
Più che inseguire, a questo punto, lo spettro amplissimo delle diversificazioni storiche sul tema,
sarà opportuno puntare direttamente al nodo cruciale della relazione, che nasce, in un certo senso,
nel momento stesso in cui la riflessione filosofica riconosce al logos il compito di articolare il
molteplice dell’esperienza in un plesso unificabile proprio in virtù della facoltà di attraversarlo
formalmente, alla ricerca delle sue interne connessioni. In un certo senso, sembra “cominciare” già
qui il confronto tra ragione e relazione, perché la ragione è in sé relazione, in quanto medium per
eccellenza, capace di distanziare l’immediato in direzione dell’universale. In questo senso non solo i
dibattiti speculativamente più produttivi, ma anche gli scontri politicamente più accesi si sono
sempre concentrati intorno all’interpretazione della “potenza” dialettica della razionalità. Fino a che
punto, in altri termini, il potere vincolante del logos deve sottostare alla natura intrinsecamente
indeducibile della realtà data o, al contrario, non solo può, ma deve oltrepassarla come apparenza
inautentica, che rinvia ad un originario di cui esso solo, il logos, può vantare di essere il custode e
l’unica via d’accesso legittima?
Una svolta decisiva, ai fini del nostro discorso, si determina quando il baricentro della riflessione
viene posto sull’essere umano e sulla sua capacità non solo di “trovarsi” in relazione, ma anche di
essere esso stesso origine di legami relazionali. In quest’ultimo caso, infatti, non si tratta soltanto di
interrogarsi intorno alla natura di un rapporto tra enti, bensì intorno alla natura di quegli enti che
propriamente non “stanno” in rapporto, ma hanno la facoltà di vivere un rapporto, nel duplice senso
di assumerlo e/o generarlo. A questo punto la questione riguarda la possibilità di correlare la rete
delle relazioni “passive”, che gli individui “trovano” come un orizzonte dato, entro il quale si
distribuiscono tutte le loro esperienze comunicative, con l’intero volume delle relazioni “attive”,
poste in essere dalle loro potenzialità pratiche e poietiche.
Su questo punto è davvero difficile sottovalutare il peso determinante del pensiero cristiano, che
ha appreso la grammatica della relazione misurandosi teologicamente con la cifra trinitaria, che
custodisce l’identità stessa di Dio, in cui circola il dinamismo inesauribile della carità, e
scommettendo sulla densità semantica del termine persona10. Se è vero che nella vita divina la
trinità non rappresenta una caduta dall’unità, ma il culmine della sua perfezione, anche a livello
umano ogni dinamica che può essere letta secondo uno schema trinitario contiene, sia pure
secondo piani diversi, un tratto di approssimazione analogica a quella perfezione.
Non a caso, il consolidarsi, dopo Tertulliano, della formula “una substantia, tres personae”
testimonia la ricerca di un difficile equilibrio tra unità e trinità di Dio, lasciando intuire nella
comunione trinitaria la densità irraggiungibile di un mistero in cui convergono identità e differenza.
Lo stesso Agostino affiderà con estrema prudenza al termine persona il compito di alludere ad una
scansione interpersonale della vita trinitaria, nella consapevolezza, continuamente ribadita, di un
uso fondamentalmente improprio11. Del termine, quindi, si può accettare solo un uso regolativo,
non costitutivo, che offre però una formidabile opportunità analogica, aprendo il campo della
relazione possibile tra il Creatore e la creatura, la quale può dirsi “immagine nel senso che è ad
immagine-di, vale a dire non lo raggiunge per l’uguaglianza, ma vi si avvicina per una certa
rassomiglianza”12.
Il valore antropologico di questo confronto è facilmente intuibile: nella persona umana si riflette il
vertice della gratuità oblativa che è all’origine dell’atto creatore e che consiste nel suscitare un alter
ego, segnato ontologicamente della finitezza e storicamente dal peccato, capace di una risposta
libera al sì di Dio. In tal senso si può affermare che il Dio Trinità della rivelazione cristiana, che non
arretra dinanzi allo scacco della colpa, spingendosi al contrario sino all’“eccesso” misericordioso
della redenzione, crea e salva non solo le persone, ma anche il rapporto tra le persone. Il mistero
dell’alleanza suppone quindi una reciprocità, per quanto inaudita ed anomala, che costituisce
l’essere umano all’interno di un rapporto ontologicamente asimmetrico e promette di riscattarne le
potenzialità relazionali da ogni caduta egocentrica.
All’interno di questo contesto matura la conquista cristiana della nozione di persona. Non a caso
la definizione elaborata da Severino Boezio (“Persona est naturae rationabilis individua
substantia”13), che pure segna un importante punto d’arrivo nell’analisi filosofica, riceverà una serie
di rettifiche e correzioni non secondarie: a cominciare da quella introdotta da Riccardo di S. Vittore,
che, attraverso l’uso della formula “individua existentia”14, sembra esprimere ancor meglio
l’orizzonte ultimo di provenienza del sistere, lasciando pensare ad un consistere relazionale della
persona. Tale rettifica è ulteriormente rafforzata in Tommaso, che vede nella dignità della ragione
la radice dello statuto relazionale della persona e della sua apertura metafisica: “Quia magnae
dignitatis est in rationali natura subsistere, ideo omne individuum rationalis naturae dicitur
persona”15. In altri termini, commenta Melchiorre, al quale dobbiamo questo richiamo fondamentale
alla lezione tommasiana, la relazionalità personale “è per un verso una struttura trascendentale, ma
per altro verso, sul piano dell’esistere, mera contingenza storica: un “non ancora” più che un “già”,
un dover essere più che un essere”16. Questo statuto relazionale, insomma, distanzia l’io da se
stesso, impedendogli di padroneggiare la radice ultima del suo ex-sistere: in altri termini, “la
persona dell’uomo, come maschera di una profondità che la supera, trova all’origine la propria
condizione di possibilità in un rapporto trascendentale al Fondamento”17.
In tale prospettiva si ridimensiona una delle questioni che ha attraversato in modo dilacerante
la modernità e che riguarda precisamente la natura della relazione tra l’io e l’altro e la possibilità di
fondarne la priorità genetica: il movimento d’incontro e di riconoscimento segue un andamento
deduttivo, dall’io all’altro, o, al contrario, induttivo, dall’altro all’io? In un certo senso una nozione
moderna di soggettività ha tentato di privilegiare la prima via, correndo però il pericolo di ridurre il
rapporto con l’altro ad un riflesso depotenziato dell’Io, come avviene ad esempio, in modo
paradigmatico, nella filosofia di Fichte. Tutte le molteplici declinazioni di questo fondamentale
“paradigma cartesiano” tradiscono quindi un medesimo problema: quello di legittimare una forma
soddisfacente di “deduzione trascendentale dell’intersoggettività”18. Il tentativo kantiano di
“riformare” l’idea leibniziana di un “regno della grazia”, trasformandolo in un “mondo di esseri
ragionevoli (mundus intelligibilis) come un regno dei fini, fondato sulla legislazione di tutte le
persone che ne sono membri”19 è una delle risposte più note al problema.
Nel pensiero contemporaneo, la sfida si radicalizza e trova forse la sua divaricazione più forte in
un arco di posizioni che ha i suoi termini estremi in Husserl e Lévinas: come osserva Ricoeur,
Husserl ha situato il movimento dal Medesimo all’Altro nella dimensione gnoseologica del senso,
mentre Lévinas ha inscritto il movimento dall’Altro al Medesimo nella dimensione etica
dell’ingiunzione. In entrambi i casi si assiste ad una radicalizzazione iperbolica di tale dialettica: in
Husserl dall’iperbole del dubbio e della riduzione si giunge al residuo del “più proprio”, che media
l’apertura all’altro. Il movimento contrario è invece centrato sull’“iperbole dell’alterità”: l’Altro si
sottrae ad ogni ottica egocentrica, sconfessando l’identità del Medesimo, proprio come l’Infinito si
sottrae ad ogni ontologia della Totalità20.
Il confronto tra questi due modelli mette a nudo il loro carattere radicalmente alternativo, che
finisce per rinforzarne l’unilateralità, postulando un superamento in radice del dualismo. Detto con
le parole di Marcel: l’idea di partecipazione “non può trovare posto che al di qua o al di là della
relazione soggetto-oggetto”21. Anche l’invito appassionato di Lévinas a “pensare questa differenza
tra me e l’altro, questa disuguaglianza, in un senso assolutamente opposto all’oppressione” 22
sembra tradire un deficit di relazione, difficilmente colmabile in assenza di un contesto comune e
condiviso, dal quale nasce il vincolo della societas. Qui, potremmo dire ancora con Ricoeur, “la
separazione ha reso sterile l’interiorità”23, neutralizzando quelle capacità di discernimento, di
riconoscimento, di accoglienza, che suppongono una irrinunciabile partecipazione riflessiva. In caso
contrario, “chi, dunque, distinguerà il maestro dal boia?”24. I due movimenti, del Medesimo verso
l’Altro e dell’Altro verso il Medesimo, possono quindi essere considerati “dialetticamente
complementari”, come vuole Ricoeur, che qui interpreta ovviamente istanze presenti anche in altri
orientamenti. Basterebbe ricordare, tra gli altri, Emmanuel Mounier: “La prima esperienza della
persona è l’esperienza della seconda persona: il tu, e quindi il noi, viene prima dell’io, o per lo meno
l’accompagna”25; oppure Karl Jaspers: “La scelta di me si accompagna alla scelta dell’altro”26; o
ancora Martin Buber, secondo il quale non c’è “vita reale” senza incontro con l’altro27.
La relazione interpersonale, così intesa, può considerarsi come espressione di un’originaria
relazione intrapersonale, che attraversa cioè l’identità interiore della persona, come attesta
un’ininterrotta tradizione di filosofia riflessiva, da Agostino fino a Ricoeur. Ma su questo punto non è
difficile allargare l’orizzonte; possiamo affidarci, ad esempio, anche alle parole di Hannah Arendt:
“Io non sono solo per-gli-altri, bensì anche per-me; e in quest’ultimo caso, è evidente, io non sono
soltanto uno, nella mia Unità si è insinuata una differenza […]. Ed è questa dualità di me con me
stesso che rende il pensare un’attività vera e propria, nella quale sono insieme colui che domanda
e colui che risponde”28. In tale direzione basta insistere, con Taylor, sul carattere attivo di questo
movimento di partecipazione, per esplicitarne immediatamente le conseguenze morali: “quando
sondo la profondità della memoria, non mi limito a riprodurre un ordine che era già là, ma partecipo
alla sua costruzione”29.
Non è possibile impegnarci in questa sede in una ricognizione dei piani diversi attraverso i quali
si manifesta questa duplicità dell’io, nel suo equilibrio instabile e precario di passività e attività, dal
piano psicologico a quello morale; può essere sufficiente, per il nostro discorso, riconoscere che in
questo scarto, attraverso il quale l’io scopre la propria distanza da se stesso, s’annuncia una
vocazione partecipativa che accomuna il riconoscimento di sé e dell’altro, facendo procedere di pari
passo la dialettica di estraneità e prossimità, fino al punto in cui l’ego incontra un alter ego, che è
insieme ulteriorità infinita e infinita prossimità30: “interior intimo meo et superior summo meo”,
potremmo dire con Agostino31. Emerge precisamente a questo punto quella che Taylor ha
chiamato “una struttura argomentativa tipicamente agostiniana: io posso conoscere me stesso
soltanto alla luce di una perfezione che trascende infinitamente i miei poteri”32.
Riconoscendo che la mia identità più profonda appare come irraggiungibile a se stessa e
antropologicamente segnata da un incontro con l’altro, è possibile quindi porre la relazione
esteriore con gli altri sotto il segno della prossimità, anziché dell’estraneità. Io riconosco l’estraneo
come prossimo, perché il mio movimento costitutivo è essenzialmente un movimento
d’approssimazione, in cui l’alterità non è il termine finale del processo, ma una sua modalità
originaria. Qui potremmo riprendere la suggestione mouneriana del “volume totale”, che fa
dipendere la crescita dell’universo personale dall’equilibrio espansivo di tre dimensioni: la
profondità dell’incarnazione, la larghezza della comunione, l’altezza della vocazione. Dimensioni,
tutte, che attingono la responsabilità etica della persona (non a caso Mounier chiama in causa
rispettivamente l’impegno, la rinuncia, la meditazione), ancorandola ad un solido fondamento
ontologico: l’essere della persona, l’essere delle altre persone, l’Essere assoluto e trascendente33.
In tal modo l’essere personale si riconosce nello stesso tempo (ma non nello stesso senso) come
“animale politico” e “animale religioso”. In virtù di questo doppio legame, che appartiene alla
medesima costituzione antropologica in virtù della quale l’io si riconosce vincolato a se stesso,
l’homo homini lupus è sconfessato in radice, ma nello stesso tempo ritrovato a un livello diverso:
appartiene infatti non alla sfera dell’originario, ma a quella del possibile; non esprime una
necessità, ma rimanda ad una responsabilità. Con questo non chiudiamo gli occhi dinanzi alle tante
forme di patologia degenerativa del rapporto interpersonale. Basterebbe ricordare l’amara
fenomenologia della intersoggettività che ci viene offerta nella Critica della ragione dialettica di
Sartre, dove l’esaltante avventura del “gruppo in fusione”, nel momento stesso in cui giunge
all’acme di massima intensità rivoluzionaria e si pone il problema maledetto della propria
istituzionalizzazione, libera inevitabilmente le tossine micidiali di quella “fraternità-terrore” in cui si
consuma il suo processo di involuzione inarrestabile34.
Ma quella che Sartre, e con lui un’antica tradizione, considera un’intrinseca alienazione
istituzionale, nel nostro discorso assume invece lo statuto di un fenomeno degenerativo della vita
morale, attraverso il quale “l’alter diventa alienus, ed io a mia volta divento estraneo a me stesso,
alienato”35, come scrive Mounier. È questa la genesi del male politico36, che ci porta a misurarci
duramente con insidiose “strutture di peccato”37. In ogni caso, anche nella dinamica interpersonale
si può dire, con Ricoeur, che “il male non è simmetrico al bene […]. Per quanto radicale, il male non
potrà mai essere originario come la bontà”38.
3. Dono e giustizia
Può sembrare che la via seguita sino a questo punto ci abbia portato fuori strada rispetto
all’obiettivo di partenza; ma la deviazione, a ben guardare, è solo apparente, nella misura in cui si è
potuto intravedere nella trama dei rapporti storicamente determinati che costituiscono il tessuto
della vita sociale e civile il frutto di una comune condizione antropologica. Qui è possibile trovare un
punto di saldatura non estrinseco tra un’antropologia relazionale, che vede la relazione con l’altro
come costitutiva dello statuto dell’io, e una nozione di società civile aperta, come ambito
storico-culturale in cui s’incarnano forme molteplici di responsabilità condivise.
La società civile infatti accoglie e riflette, in forme esistenzialmente vitali, culturalmente mediate e
storicamente dinamiche, proprio quest’intreccio fra relazionalità orizzontale e verticale in cui si può
ravvisare il costitutivo antropologico originario: “La persona – scrive Viola – non potrà avere stima e
cura di sé (self respect) se non attraverso strutture oggettive di riconoscimento, che si
concretizzano oggi tra l’altro in quelli che chiamiamo “diritti dell’uomo”. L’intersoggettività
cooperativa si dispiega attraverso strutture comunicative, in cui il carattere spontaneo o vitale e
quello artificiale o convenzionale si mescolano inscindibilmente”39.
Per questo la rete dei rapporti che vincolano un insieme di persone entro una “società civile”,
arrivando a ricreare un nuovo ambiente di vita, evidenzia una complessità irriducibile ad ogni
tentativo di spiegazione univoca e semplificata. In estensione, tali rapporti non si riducono ad una
dimensione duale, che investe soltanto la prima e la seconda persona, ma appaiono
strutturalmente aperti alla terza persona; solo su questa base, infatti, è possibile edificare la
dimensione del noi, che vive di un incessante interscambio di ruoli attivi e passivi, di processi
comunicativi e funzioni cooperative, in una reciprocità dinamica d’interiore ed esteriore. In
profondità, alla base di questa stratificazione di mondi vitali, forme d’amicizia, comunità locali, reti di
associazioni elettive, for profit e non profit, s’intravede un contesto di pratiche di vita virtuose e
condivise, che si avvalgono anche di un’ampia trama di garanzie giuridiche ed istituzionali, alla
ricerca continua di un punto critico d’equilibrio tra tensione comunitaria ed esteriorità legale, al
quale si dà comunemente il nome di ethos40.
Su questo versante, ha ragione Michael Walzer, quando ricorda che sarebbe un errore
assolutizzare il valore di un mondo in cui tutte le associazioni fossero volontarie e l’unione sociale
risultasse esclusivamente da rapporti liberamente costituiti. È vero, continua Walzer, che la libertà
esige di per sé la rottura dei legami involontari, ma la rottura effettiva di tali legami non sempre
deve considerarsi buona. In particolare, ci sono almeno quattro tipi di legami che possono essere
considerati come involontari: quelli d’ordine naturale, come famiglia e società; quelli d’ordine
culturale, che riguardano forme associative preesistenti; quelli di natura politica, in virtù dei quali
ognuno di noi nasce già come cittadino e, infine, quelli d’ordine morale, che rappresentano però
una forma di costrizione in qualche modo anomala rispetto alle precedenti, poiché è presente nei
precedenti, pur essendo in qualche modo indipendente da essi41.
Non basta però accontentarsi di riconoscere il valore identificante di legami preesistenti: la
qualità positiva della relazione non dipende univocamente dalla sua anteriorità cronologica e dalla
sua determinatezza storica. Ciò che conta è riuscire a distinguere l’originario dall’anteriore e, su
questa base, assumersi la responsabilità di un atto personale di “ripresa”42. Il mondo dell’ethos
esige un costante ricambio interno, che sia in grado di compensare, con l’immissione di sempre
nuove idealità rigeneratrici e di irrinunciabili responsabilità morali, l’inevitabile processo di sclerosi e
di logoramento, cui è strutturalmente esposto, quasi per una sorta di decadenza entropica. Senza
questa circolazione vitale, il nomos in cui l’ethos si esprime s’irrigidisce in senso ideologico e il
comportamento che presume di ispirare si sfigura nella passività ottusa dell’abitudine,
imprigionando le istituzioni in quel processo di degradazione alienante, contro il quale una certa
cultura del sospetto ci ha abituato, a volte con qualche eccesso di legittima difesa, a non abbassare
mai la guardia.
Una delle ultime e più impegnative opere di Paul Ricoeur c’invita precisamente ad incamminarci
in questa direzione, collegando la irriducibilità della dimensione riflessiva personale ad un percorso
etico che egli riassume nella formula: “Tendere alla “vita buona”, con e per l’altro, entro istituzioni
giuste”43. Ma anche le istituzioni necessitano di una rigenerazione endogena, resa possibile
dall’immissione continua di benefici fermenti di socialità virtuosa: “Le virtù – ci ricorda MacIntyre –
vanno intese come quelle disposizioni che non solo sorreggono le pratiche e ci consentono di
raggiungere i valori interni ad esse, ma ci aiutano anche nel genere di ricerca del bene […]
permettendoci di superare i mali, i pericoli, le tentazioni e le distrazioni in cui ci imbattiamo, e ci
forniscono una conoscenza crescente di noi stessi e del bene”44.
Questa rete di relazioni istituite protegge dalle infiltrazioni torbide dell’interesse e rappresenta
l’insostituibile apprendistato della vita di relazione, sullo sfondo di una vocazione universalista,
senza la quale sarebbe impossibile ogni forma di autentica promozione della persona, come
insegnano, a livello diverso, sia la rivelazione cristiana, che invita a superare ogni distinzione tra
Giudei e Greci, tra schiavi e liberi, sia le moderne carte universali dei diritti umani. Il paradosso di
un’epoca in cui il “villaggio globale”, con le sue illimitate possibilità comunicative, fino alla evasione
telematica nella realtà virtuale, non riesce a gestire le convivenze multiculturali, a volte
inasprendole fino alle forme più deteriori di egoismo etnico e di violenza sanguinosa, è dinanzi agli
occhi di tutti: la sintesi tra universalità dei diritti e relatività delle culture, esige di cogliere in
controluce, entro l’apparente opacità dell’ethos, il richiamo alto e trascendente del valore, che può
spingersi fino al riconoscimento di una laicità religiosamente ispirata. In tal senso, una religione non
privatizzata può diventare fattore insostituibile di animazione della società civile, in quanto riesce a
mantenere aperta una domanda intorno al senso ultimo dell’agire strategico, sussidiandola con
mediazioni formative autenticamente liberanti45.
Se la ricerca antropologica può approdare per questa via al riconoscimento dello statuto riflessivo
e relazionale della persona umana, un confronto ancora più audace con la migliore eredità del
pensiero cristiano può spalancare un’ulteriore opportunità ermeneutica, trovando nella cifra
dell’amore la rivelazione più profonda di quest’identità: la relazione è in un certo senso la
condizione trascendentale che esprime il bisogno di un legame radicale, di una comunione intensa
e significativa, che può essere implementata o indebolita, celebrata o stravolta, ma mai azzerata46.
La tensione dell’amore, in questo senso, è l’origine e insieme il telos della relazione.
C’è dunque una superiore ipoteca morale che sovrasta ogni forma di vita aggregata e che nasce
dal valore primario e paradigmatico della persona umana nel suo “volume totale”, che racchiude in
sé la dignità di tutta la persona e di tutte le persone. A questo proposito è sempre attuale
l’insegnamento di Antonio Rosmini: “Se dunque la persona è attività suprema per natura sua […] si
deve trovare nell’altre persone il dovere morale corrispondente di non lederla, di non fare pure un
pensiero, un tentativo volto ad offenderla o sottometterla, spogliandola della sua supremazia
naturale […] la persona ha nella sua natura stessa tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto
sussistente, l’essenza del diritto”47.
A partire dal primato della persona umana si può quindi tracciare una gerarchia di mediazioni
normative che si dispongono lungo l’asse disegnato dal rapporto tra natura e cultura, e che
potremmo articolare secondo la gerarchia espansiva di domus, urbs ed orbis, attorno alla quale nel
XIX libro del De civitate Dei di Agostino viene sapientemente disegnata la topografia etica dei
diversi livelli della societas48. La relazione tra cives qui diventa uno snodo centrale tra la comunità
familiare e la più ampia sfera politica, i cui confini debbono essere sempre più spostati in avanti,
verso l’orizzonte internazionale. Da un lato, infatti, la famiglia, intesa come forma primaria di
“società naturale”, in cui l’evento biologico della generazione viene inscritto nel superiore contesto
di una comunione di vita e di amore, attesta la relazione più elementare, a partire dalla quale la
persona umana è chiamata alla vita e accompagnata, attraverso un’adeguata tutela educativa, alle
soglie della maturità responsabile, con quella costellazione di valori vissuti che hanno nella gratuità
dell’amore la loro prima sorgente. Da un altro lato, troviamo invece la più ampia rete di vincoli
giuridico-politici, che dagli Stati nazionali si stanno rapidamente allargando alla sfera
sovranazionale, dove l’imperativo supremo della giustizia è l’unico presidio legittimo contro una
strisciante globalizzazione delle disuguaglianze.
Per la sua natura “intermedia”, la dimensione “civile” è quella in cui le persone si “associano”
sulla base di un circolo virtuoso di competizione e cooperazione, coniugando in una sintesi sempre
nuova il buono e il giusto, la gratuità del dono e la reciprocità dello scambio. Quando tale circolo si
esprime in forme alte e condivise, raggiungendo momenti esemplari e riproducibili, allora il “civile”
diventa fonte di “civiltà”. In senso generale, nessuna forma di convivenza può edificarsi all’insegna
di un’assoluta neutralità morale: né abbandonandosi ad una spontaneità immediata, né, al
contrario, confidando in una pura efficienza funzionale; tutto ciò che attiene alla dinamica personale
è originariamente segnato da una responsabilità ineludibile. In senso specifico, poi, proprio la
società civile sembra assolvere ad una preziosa funzione di cerniera fra il mondo vitale dei “rapporti
corti”, che privilegia la logica del dono, e la severa economia dei “rapporti lunghi”, che affida alla
logica dell’equivalenza il compito di garantire una vera equità distributiva, chiamando la politica a
resistere alle suggestioni dell’agnosticismo e a non farsi complice di una cieca e impersonale
mercificazione.
Proprio per questo il vincolo della convivenza civile deve intrecciare il paradigma verticale del
ricevere e del donare, riassumibile nella cifra della gratuità, che racchiude anche l’enigma
dell’essere donati a se stessi49, con il paradigma orizzontale del prendere e del dare, che il
principio dello scambio ha il dovere di custodire con un giusto bilanciamento. Di conseguenza, lo
spazio morale in cui la comunità dei cives può attestarsi si distende tra l’orizzonte minimale della
tutela di una convivenza pacifica, come dovere primario, e l’orizzonte massimale della promozione
della persona, come valore ultimo.
Il rifiuto di autorizzare una deriva libertaria, frutto di un’antropologia assolutamente svincolata,
non nasce dunque da un’inaccettabile invadenza moralistica, ma da un’esigenza interna alla stessa
relazionalità interpersonale: “L’ordine degli affetti implica giustificate gerarchie delle relazioni” 50. Il
rapporto fra persona e società sembra quindi trovare in un circolo virtuoso d’amore e giustizia il suo
più alto punto d’equilibrio etico-politico. Per un verso ciò significa rifiutarsi di declassare il legame
dell’amore ad una funzione fragile e periferica di retroguardia assistenziale, attribuendogli il compito
alto di avanguardia profetica, capace d’innalzare il tasso di socialità fraterna di ogni comunità
politica e di ricordare alla giustizia le sue irrinunciabili mire universaliste; per altro verso, anche la
giustizia è chiamata ad evitare ogni involuzione formalista, che rischia di ridurla ad un’odiosa
sentinella degli egoismi privati, trasformandosi invece in una suprema istanza strutturale e
qualitativa della vita di relazione, capace di accreditare il valore economico della solidarietà nel
cuore stesso della dinamica politico-istituzionale.
Per tutti questi motivi, “il sistema sociale implica, in termini di qualità etica, e non solo di
compromesso legale, – è ancora Sequeri – una ricca articolazione delle modalità di donazione e di
scambio. In questo senso parliamo appunto di reciprocità limitata, di analogie affettive e di
differenziazioni legittime: esse infatti concorrono all’armonia etica dell’insieme sociale e allo
sviluppo differenziato che arricchisce la qualità dei legami”51.
1 Su questo punto si può rinviare all’ottima sintesi di E. BERTI, Società civile-Società politica, in AA.VV., Dizionario delle idee
politiche, AVE, Roma 1993, pp. 812-824.
2 Su quest’ultimo aspetto cf R. GATTI, Natura umana e artificio politico. Saggio su Jean-Jacques Rousseau, Porziuncola, Assisi
1988.
3 Cf M. WALZER, Individu et communauté, in AA.VV., Un siècle de philosophie. 1900-2000, Gallimard, Paris 2000, p. 407.
4 M. HORKHEIMER, Eclissi della ragione, tr. it., Torino 1969, p. 113.
5 T. W. ADORNO, Minima moralia, tr. it., Torino 1954, pp. 129-130.
6 M. HEIDEGGER, L’epoca dell’immagine del mondo, in Sentieri interrotti, tr. it., Firenze 1968, p. 97, nota 9.
7 F. VIOLA, Etica e metaetica dei diritti umani, Torino 2000, p. 24.
8 V. JANKÉLÉVITCH, La cattiva coscienza, tr. it., Bari, 2000, p. 130.
9 S. Th., I, q. 30, 3 ad 3m.
10 Cf su questo punto, l’ampia ricerca di A. MILANO, Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo
antico, Dehoniane, Napoli 1984, che è ritornato sul tema nel saggio La Trinità dei teologi e dei filosofi. L’intelligenza della persona
in Dio, in Persona e personalismi, a cura di A. PAVAN e A. MILANO, Dehoniane, Napoli 1987, pp. 3-286.
11 “Dictum est tamen “tres personae”, non ut illud diceretur, sed ne taceretur” (De Trin., V, 9, 10). La distinzione fondamentale, in
Agostino, è fra la struttura trinitaria riscontrabile nell’homo exterior (res, species corporis, voluntas; memoria, interna visio,
voluntas), che può dirsi solo un vestigium Trinitatis per la sua natura percettiva e temporale, e quella che emerge nell’interiorità
spirituale (esse, nosse, velle; mens, notitia, amor; memoria, intellegentia, voluntas), che non è adventicia, ma assurge al valore di
imago indelebile di Dio, permettendoci di incontrarlo per speculum et in aenigmate.
12 De Trin., VI, 6,12.
13 De duabus naturis et una persona Christi, 3: PL 64,1345.
14 Cf De Trin., IV, 21: PL 196, 945 A-B. Mi lascio guidare su questo punto dalla puntuale ricognizione operata da G. DOTTO, La
persona tra “essentia” ed “existentia”: Boezio e gli autori del secolo XII, “Prosopon. La persona e il volto”, I (1989), pp. 61-82, e
dalla interessante rilettura di V. MELCHIORRE, Corpo e persona, Genova 1987, pp. 21-36.
15 Sum. theol., I, q. 29, a. 3, ad 2.
16 MELCHIORRE, Corpo e persona, p. 35.
17 MELCHIORRE, Corpo e persona, p. 32.
18 Nascono da qui, secondo Olivetti, “le difficoltà a cui va incontro il tentativo di teorizzare l’intersoggettività a partire dalla
filosofia moderna della soggettività […] Il problema del rapporto fra monade e monade delle monadi, soggetto empirico e soggetto
trascendentale, coscienza empirica e coscienza trascendentale, ecc. è in realtà – egli conclude – il problema stesso di una
insoddisfacente deduzione dell’intersoggettività” (M. M. OLIVETTI, Etica comunicativa e asimmetria della comunicazione, “Archivio di
filosofia”, 52 (1984), pp. 603-604).
19 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi, tr. it., Rusconi, Milano 1982, p. 97 (Ak IV, BA 83). Su questo aspetto rinvio al
mio studio: “Regno della grazia” e “Regno dei fini”: da Leibniz a Kant, in AA.VV., Il “Regno dei fini” in Kant, a cura di A.
RIGOBELLO, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1996, pp. 53-83.
20 Cf P. RICOEUR, Sé come un altro, tr. it., Jaca Book, Milano 1993, pp. 444 ss.
21 G. MARCEL, Per una filosofia dell’amore, in E. LEVINAS – G. MARCEL – P. RICOEUR, Il pensiero dell’altro, a cura di F. RIVA,
Edizioni Lavoro, Roma 1999, p. 5.
22 LÉVINAS, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, tr. it., Jaca Book, Milano 1983, pp. 219-220.
23 P. RICOEUR, Sé come un altro, p. 453.
24 P. RICOEUR, Sé come un altro, p. 455.
25 E. MOUNIER, Il personalismo, tr. it., AVE, Roma 19806, p. 47.
26 K. JASPERS, Filosofia, tr. it., UTET, Torino 1978, p. 657.
27 Cf M. BUBER, Il principio dialogico e altri saggi, tr. it., San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, p. 67.
28 H. ARENDT, La vita della mente, tr. it., Il Mulino, Bologna 1987, pp. 278-280.
29 C. TAYLOR, Radici dell’io. La costruzione del’identità moderna, tr. it., Feltrinelli, Milano 1993, p. 184.
30 Osserva anche Vigna: “La soggettività altra, infatti, è solo formalmente o intenzionalmente infinita, e quindi è, nella sua onticità
complessiva (la singolarità personale), un che di finito. Ma il desiderio, in quanto orizzonte trascendentale, cioè infinito, non può
contentarsi di un oggetto onticamente finito” (C. VIGNA, Etica del desiderio umano, in AA. VV., Introduzione all’etica, Vita e Pensiero,
Milano 2001, pp. 134-135).
31 Conf. 3,6,11: NBA 1,66. Di quest’idea, che è al centro dell’opera di RICOEUR, Sé come un altro, ho cercato recentemente di
sviluppare le radici agostiniane nel volume L’altro nell’io. In dialogo con Agostino, Città Nuova, Roma 1999.
32 Cf TAYLOR, Radici dell’io, p. 183.
33 Cf E. MOUNIER, Rivoluzione personalista e comunitaria, tr. it., Ed. di Comunità, Milano 1955, pp. 87-92.
34 Cf J.-P. SARTRE, Critica della ragione dialettica, tr. it., Il saggiatore, Milano 1990.
35 E. MOUNIER, Il personalismo, p. 47.
36 Sul problema cf AA.VV., Il male politico. La riflessione sul totalitarismo nella filosofia del Novecento, a cura di R. GATTI, Città
Nuova, Roma 2000.
37 GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis, 36.
38 P. RICOEUR, Finitudine e colpa, tr. it., il Mulino, Bologna 1970, p. 415.
39 F. VIOLA, Identità e comunità. Il senso morale della politica, Vita e Pensiero, Milano 1999, 61.
40 Mi permetto di rinviare su questo punto al mio saggio Uomo, “ethos”, educazione: una prospettiva di antropologia filosofica, in
AA.VV., Uomo “ethos” educazione, Editrice La Scuola, Brescia 1996, pp. 35-56.
41 Cf WALZER, Individu et communauté, pp. 410-422.
42 Mi sono soffermato in particolare su quest’aspetto nei due scritti: Metamorfosi della libertà tra moderno e postmoderno, in L.
ALICI, F. BOTTURI, R. MANCINI, Per una libertà responsabile, a cura di G. L. BRENA e R. PRESILLA, Edizioni Messaggero, Padova 2000,
pp. 39–71; I vincoli della libertà in L. ALICI, M. CHIODI, R. MANCINI, F. RIVA, Interpersonalità e libertà, a cura di G. L. BRENA,Edizioni
Messaggero, Padova 2001, pp. 25-61.
43 Cf P. RICOEUR, Sé come un altro, pp. 263-300.
44 A. MACINTYRE, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, tr. it., Feltrinelli, Milano 1988, p. 262.
45 Sul valore strategico di un impegno educativo cristianamente ispirato, e insieme socialmente e politicamente orientato, ha
insistito con forza il pensiero personalista, da Mounier a Maritain. Per un’analisi attenta delle implicazioni più attuali dell’intera
questione cf P. DONATI, Pensiero sociale cristiano e società post-moderna, Editrice AVE, Roma 1997 e ID., La cittadinanza societaria,
Laterza, Roma-Bari 2000.
46 Insiste su quest’aspetto, evidenziandone soprattutto le motivazioni teologiche e antropologiche U. BORGHELLO, Liberare l’amore.
La comune idolatria, l’angoscia in agguato, la salvezza cristiana, Ares, Milano 1997.
47 A. ROSMINI, Filosofia del diritto, Cedam, Padova 1967, p. 192.
48 Cf De civ. Dei, XIX, 3,2 ss.
49 Per alcune considerazioni interessanti su questo tema cf J. L. MARION, Etant donné. Essai d’una phénoménologie de la donation,
Puf, Paris 19982.
50 P. SEQUERI, Dono verticale e orizzontale: fra teologia, filosofia e antropologia, in AA. VV., Il dono tra etica e scienze sociali, a
cura di G. GASPARINI, Edizioni Lavoro, Roma 1999, p. 137. L’intero saggio di Sequeri (pp. 105-155) costituisce un’ottima sintesi, che
argomenta in modo convincente in favore di “una cultura integrata della dialettica fra valori dell’oblatività e valori dell’equivalenza”.
51 P. SEQUERI, Dono verticale e orizzontale, p. 137.