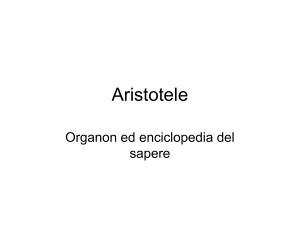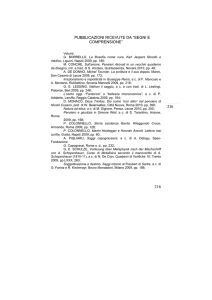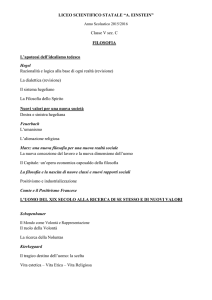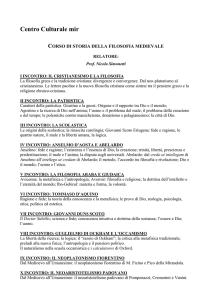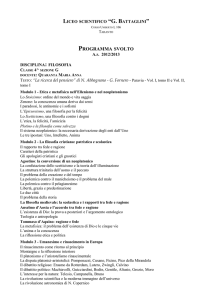Mario Perniola (Asti 1941) ha pubblicato II metaromanzo (Milano 1967),
L'alienazione artistica (Milano 1971 e Parigi 1977), Bataille e il negativo
(Milano 1977), La società dei simulacri (Bologna 1980). È professore
ordinario di estetica all'università di Salerno. Vive a Roma.
Mario Perniola
Dopo Heidegger
Filosofia e organizzazione della cultura
Feltrinelli
Prima edizione: settembre 1982
Copyright by
©
Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano
Copertina di: Bob Noorda
Premessa
Il nome del pensatore, cui questo libro è dedicato, è rimasto non
scritto. Valga come infedele obbedienza al suo invito di pensare
la cosa stessa. In altri tempi, in altri luoghi.
M. P.
Rio de Janeiro, maggio 1982
7
Introduzione
Non sempre la noncuranza dello statuto sociale e istituzionale di
una forma di pensiero costituisce un ostacolo allo sviluppo di
questa, né sempre la noncuranza delle premesse teoriche di una
organizzazione costituisce un limite alla sua affermazione. Lo
statuto socio-istituzionale della metafisica, dell'umanismo, della
scienza è rimasto non pensato per secoli senza che ciò abbia
costituito uno ostacolo al pensiero metafisico, alla formazione
umanistica, alla ricerca scientifica e viceversa si è potuto operare
all'edificazione di chiese, di partiti, di università senza
interrogarsi sui presupposti filosofici che tali istituzioni
implicano. Filosofia ed organizzazione della cultura, sapere e
potere, hanno potuto credersi relativamente indipendenti l'uno
dall'altro; e tale vicendevole incuria è stata sotto molti aspetti
proficua ad entrambi. Pensare l'essere senza nel contempo
pensare la chiesa, pensare l'uomo senza nel contempo pensare il
partito, pensare il sapere senza nel contempo pensare l'università
e la professione, e reciprocamente essere uomini di chiesa,
esponenti di partito, ordinatori di sapere universitario e
professionale senza sentirsi coinvolti nell'interrogazione
sull'essenza della metafisica, dell'umanismo e della scienza,
questa divisione di competenze e di compiti ha permesso a
generazioni di metafisici, di ideologi e di scienziati, di preti, di
politici e di professionisti una eccezionale concentrazione di
energie intellettuali e l'esercizio di una operatività senza pari. Ma
oggi la trascuratezza del rapporto tra filosofia ed organizzazione
della cultura è esiziale per entrambe. Infatti è venuta meno la
certezza non detta, anzi nemmeno pensata, ma saldissima nella
sua implicitezza, che un popolo di Dio raccolga e conservi il
messaggio proveniente da una vita interamente dedicata
all'ascolto dell'essere, che una società di individui raziocinanti
8
consenta e convenga intorno a un progetto riguardante l'avvenire
dell'uomo, che una comunità di dotti trasmetta e sviluppi il
contributo recato dal singolo studioso al progresso della
conoscenza. Reciprocamente è venuta meno la certezza,
anch'essa non detta, anzi nemmeno pensata, ma saldissima nella
sua implicitezza, che al concetto di chiesa sia essenzialmente
inerente un patrimonio dottrinale organico, che al concetto di
partito sia strettamente congiunto un programma ideologico
coerente, che al concetto di professione sia necessariamente
legato un sapere scientifico sistematico. Ciò che è diventata problematica non è tanto la loro mera esistenza, quanto la
corrispondenza, un tempo strettamente operante, anche se non
pensata, tra forme di pensiero e forme di organizzazione
culturale: il dubbio riguarda da un lato la socialità essenziale
della filosofia, dall'altro la teoricità essenziale delle istituzioni.
Per socialità essenziale della filosofia qui non s'intende il fatto
che la vita collettiva, la società, la comunità, siano oggetto,
materia, tema di riflessione filosofica, né ovviamente che il suo
venir meno sia connesso con l'imporsi all'attenzione dei filosofi
di altri oggetti, materie, temi attinenti alla vita individuale, al
soggetto, al singolo; analogamente per teoricità essenziale delle
istituzioni qui non s'intende il fatto che la formulazione esplicita
di principi, di fondamenti', di idee generali, sia indispensabile
alla nascita e alla prosperità delle istituzioni, né ovviamente che
il suo venir meno sia congiunto col prevalere di un empirismo
alieno dalla enunciazione di principi, di fondamenti, di idee
generali e sollecito solo alla soluzione di problemi specifici e alla
soddisfazione di esigenze particolari. La questione è più radicale
e non riducibile al mero passaggio da interessi e problematiche
politiche a interessi e problematiche morali, né dal razionalismo
organizzativo all'empirismo organizzativo.
La socialità essenziale della filosofia garantiva alle esperienze
spirituali più eremitiche, alle avventure culturali più intimistiche
e private, alle ricerche più specialistiche ed estranee ad ogni
applicazione pratica, la stessa dimensione che riservava alle
teorie generali dell'essere, dell'uomo, del sapere: il filosofo
monastico e il filosofo politico partecipavano ad uno stesso
io
mondo, il mondo dello spirito, della cultura, della conoscenza,
che mediava il loro rapporto col mondo empirico, col mondo di
tutti. Non c'era bisogno perciò che il singolo studioso si
preoccupasse di riflettere sullo statuto organizzativoistituzionale del suo pensiero, perché esso era già garantito in
partenza, per quanto solitario fosse il suo cammino: la sua
filosofia non era mai esposta direttamente al rapporto col mondo
empirico, alla mancanza di presupposti e di punti di riferimento
sicuri, al cinismo, alla corruzione, alla contraffazione, alla
superficialità arrogante, al fraintendimento interessato,
all'ignoranza presuntuosa, e per quanto tutti questi aspetti si
manifestassero anche nelle organizzazioni culturali, nella chiesa,
nel partito, nella professione, restava tuttavia sempre possibile
l'appello al principio logico che le fondava, ad una loro intima
razionalità destinata prima o poi a prevalere. E sebbene i
destinatari della metafisica, dell'ideologia e della scienza fossero
in ultima analisi un numero relativamente piccolo di persone
colte, era indiscutibile e indiscusso il fatto che la salvezza,
l'educazione e il sapere riguardassero in linea di principio ed
essenzialmente l'intera società. Perciò attraverso e grazie
all'esistenza di organizzazioni e di istituzioni, di ambiti sociali
ben individuabili e delimitati, l'esperienza, la voce e l'attività del
filosofo era l'esperienza, la voce e l'attività della società stessa.
La teoricità essenziale delle istituzioni garantiva agli organizzatori una piena indipendenza nei confronti delle
discussioni teologiche, ideologiche e scientifiche che si
svolgevano all'interno della chiesa, del partito e dell'università:
essi in fondo erano i custodi dell'unità e della coerenza
dell'istituzione e potevano mantenersi neutrali senza per questo
cadere nel lassismo, nell'opportunismo, nella cialtroneria. Anzi,
la molteplicità di interessi e di idee era essenziale allo stesso
concetto di organizzazione culturale: il rispetto della pluralità
delle vocazioni, delle strategie, delle scuole è proprio ciò che distingueva la chiesa, il partito, l'università dalla setta, dalla
fazione, dalla conventicola. L'esistenza di un nucleo teorico
intrinseco all'istituzione consentiva all'organizzatore un
disimpegno e una irresponsabilità nei confronti della teoria che si
12
manifestavano altresì nell'uso meramente tattico del sapere,
dettato da ragioni di opportunità contingente o di sagacia
politica: non c'era bisogno che il singolo organizzatore si
preoccupasse di riflettere sui fondamenti della conoscenza o sui
presupposti su cui si fondava la sua organizzazione, giacché
questi erano garantiti in partenza dal suo status di prete, di
membro del partito, di professionista del sapere. Del resto se
andava ad onore di un filosofo l'essere rimasto della stessa
opinione o l'aver sviluppato coerentemente il suo pensiero senza
influenze occasionali, si chiedeva al contrario ad un
organizzatore una estrema duttilità e disponibilità a sostenere le
tesi, le prospettive, le teorie via via prevalenti all'interno della
chiesa, del partito, dell'università. Questi mutamenti erano in
fondo imposti dalla razionalità del processo storico, cui
innanzitutto l'organizzatore doveva obbedienza. Ma oggi questo
equilibrio rassicurante ed armonico tra filosofia ed
organizzazione della cultura, tra sapere e potere, che garantiva
l'operosa e serena continuità del lavoro filosofico e tutelava la
buona coscienza dell'indefessa attività organizzativa si è rotta. Il
filosofo non può sottrarsi al dubbio che il lavoro filosofico sia
paragonabile ad un innocente trastullo, se non ad una personale
privata follia; né l'organizzatore al dubbio che quasi nulla
distingua la sua organizzazione da una qualsiasi mafia, se non da
una banda o da una organizzazione a delinquere. È come se
all'improvviso la lotta contro l'isolamento e contro la barbarie,
che da secoli la cultura conduce, fosse perduta per sempre e per
tutti. Paradossalmente il filosofo si sente disperatamente isolato
proprio nel momento in cui la filosofia diventa popolare come
mai in passato, in cui si spezza la condizione di tradizionale
separazione che aveva mantenuto il sapere in ambiti sociali,
organizzativi ed istituzionali ben precisi. Il fatto che tali ambiti
non riescano più a svolgere una effettiva mediazione culturale tra
la filosofia e la società nel suo complesso può a prima vista
sembrare una liberazione da forme di condizionamento e di
costrizione talora particolarmente gravose e limitative: per
esempio, la possibilità di rivolgersi direttamente attraverso la
televisione a milioni di persone anziché a poche migliaia di
13
uomini di buona volontà, di persone colte o di ricercatori e
scienziati, appare come la tanto attesa e tanto bramata
realizzazione della vocazione universalistica della filosofia. In
realtà parlando a tutti, il filosofo non parla più a nessuno: non
tanto per la difficoltà di trovare un linguaggio accessibile ad
uditori cosi sterminati, cosi vari ed eterogenei, quanto perché
ormai dovrebbe porsi come un aspirante alla direzione della
società, della chiesa, del governo, delle istituzioni internazionali,
per poter avere l'impressione di soddisfare la domanda che
proviene da un pubblico cosi immerso nel mondo empirico. E se
egli non può o non vuole porsi come un candidato al potere, non
gli resta che essere un membro della società dello spettacolo
insieme a cantanti, sportivi, e saltimbanchi, tutte persone che
esercitano mestieri degnissimi, ma non particolarmente affini
alla filosofia, né particolarmente adatti a ricostituire il rapporto
tra sapere e società. La possibilità che gli viene preclusa è proprio
quella più semplice e più ovvia, la possibilità cioè di fare il
mestiere che ha imparato, di essere semplicemente un teologo, un
ideologo, uno scienziato.
Paradossalmente l'organizzatore culturale si sente disperatamente impotente proprio nel momento in cui cadono i limiti
che la razionalità intrinseca delle istituzioni ponevano alla sua
attività, proprio nel momento in cui gli si aprono possibilità
d'intervento estremamente più ampie ed articolate. A partire dal
momento in cui la chiesa, il partito, la professione attenuano e
rarefanno i presupposti dogmatici, ideologici e scientifici su cui
si fondano, all'organizzatore è consentita una mobilità e una
spregiudicatezza di interventi senza paragone più ampia che nel
passato. Ciò avviene sia mediante la dilatazione dei ruoli, per cui
il prete diventa operatore pastorale, il politico operatore
culturale, il professore consigliere scientifico, sia mediante la
loro estensione, per cui le figure tradizionali si trasformano in
managers di faccende spirituali, culturali e scientifiche, sia
mediante il loro intrecciarsi e sommarsi per cui cadono molte
incompatibilità strutturali, sicché, per esempio, par quasi ovvio
che un professore di successo possa essere anche
contemporaneamente giornalista, direttore di collane editoriali,
14
libero professionista, membro influente di un partito e cosi via,
sia infine soprattutto mediante le pressioni, le sollecitazioni e le
seduzioni che gli strumenti di comunicazione di massa
esercitano sulle funzioni organizzative tradizionali. Sempre più
appare evidente che condizione fondamentale della penetrazione
dell'organizzazione culturale è la trasversalità, cioè la sua capacità di stabilire connessioni e legami tra ambiti disparati e
lontani. Ma cosi va perduta completamente la ragion d'essere
stessa dell'organizzazione culturale: l'apostolato, la propaganda,
la divulgazione di una verità scientifica sono sostituite
dall'intrecciarsi di trame prive di specifici connotati religiosi,
politici o culturali, proprio perché devono attraversare tutti
questi ambiti. Le istituzioni culturali tradizionali diventano
forme vuote suscettibili di essere riempite di qualsiasi contenuto.
L'organizzatore culturale è costretto ad assimilarsi e confondersi
con faccendieri e mestatori d'affari, il suo potere diventa
paragonabile a quello di un boss mafioso. E se egli non vuole o
non può rassegnarsi all'impotenza della chiesa, del partito e
dell'università intese come forze culturali autonome, non gli
resta che diventare filosofo, cioè di cercare da solo un senso alla
propria attività. La possibilità che anche a lui viene preclusa è
proprio quella più semplice e più ovvia, di fare cioè il mestiere
che ha imparato, di essere semplicemente un prete, un politico,
un professionista. Certo si possono individuare con profitto le
cause di questo profondo sovvertimento, che toglie alla filosofia
la sua socialità intrinseca, costringendola a scegliere tra lo
spettacolo, la ricerca di strumenti di potere e uno estremo
isolamento, e che toglie all'organizzazione della cultura la sua
razionalità intrinseca, costringendola a scegliere tra la mafia, la
ricerca di fondamenti teorici e un'estrema impotenza, nelle
profonde trasformazioni storiche in atto, negli odierni radicali
mutamenti sociali, nell'avvento e nella diffusione capillare degli
strumenti di comunicazione di massa. Ma attribuendo esclusivamente a fenomeni storici, sociali, tecnici, la causa di tale
sovvertimento, da un lato non ci si rende conto pienamente del
significato essenziale che essi hanno, dall'altro non si spiega la
profondità del turbamento che ha investito il mondo del sapere e
15
dell'organizzazione culturale. Nasce allora il sospetto che la
situazione presente abbia origini antiche e radici profonde, che
l'attuale trionfo della decorazione e della barbarie sia il punto di
arrivo di processi secolari, se non millenari, che il filosofo sia
sempre stato isolato, nonostante i suoi discepoli, seguaci ed
allievi, che l'organizzatore di cultura sia sempre stato impotente
nei confronti della violenza, della corruzione e della
falsificazione, infine che metafisica, umanismo e scienza siano
sempre state forme di pensiero incapaci di garantire la socialità
del sapere, che chiesa, partito e professione siano sempre state
organizzazioni troppo deboli per garantire la razionalità della
società.
Questo sospetto si fa strada nonostante e contro inveterate
abitudini mentali che vedono nella metafisica, nell'umanismo e
nella scienza, forme di pensiero antitetiche tra loro: la storia del
pensiero filosofico sembra infatti essere stata segnata dal
conflitto tra la metafisica e l'umanismo, tra la metafisica e la
scienza, tra l'umanismo e la scienza. La causa dell'essere, la
causa dell'uomo, la causa del sapere sono lungamente apparse incompatibili tra loro e il loro contrasto ha condizionato lo
svolgimento e determinato il senso stesso dell'attività filosofica.
Nel superamento di tali opposizioni sta la grandezza della
dialettica, la quale ha costituito il più superbo e inaudito tentativo
di affermazione della socialità intrinseca della filosofia:
l'identificazione tra sostanza, autocoscienza e sapere nello spirito
assoluto e nel suo divenire storico, la definizione della storia del
mondo come lo svolgimento dell'idea universale dello spirito
nella sua realtà costituiscono il punto culminante della
metafisica, dell'umanismo e della scienza finalmente conciliate
tra loro nel sapere assoluto. Eppure benché il filosofo dialettico
non sia la mera somma dei ruoli tradizionali di sacerdote, guida e
sapiente, ma costituisca un fatto nuovo di enorme rilevanza nella
storia dei rapporti tra sapere e potere, il suo statuto non è tuttavia
in ultima analisi separabile dalle premesse da cui sono nate e su
cui si sono sviluppate la metafisica, l'umanismo e la scienza: di
queste forme di pensiero egli costituisce piuttosto il coronamento
e il compimento ed è grazie ad esse che egli può essere
16
riconosciuto come l'autocoscienza della storia universale. Perciò
a partire dal momento in cui tali premesse vengono meno, il suo
isolamento è infinito tanto quanto lo era la sua perenta pretesa
alla centralità storico-sociale. Non diversamente l'importanza e il
rilievo che in passato hanno avuto i conflitti tra l'organizzazione
ecclesiastica, l'organizzazione laica e l'organizzazione professionale, i contrasti tra gruppi turcimanni ed interpreti della
razionalità teocratica, della razionalità democratica e della
razionalità scientifica che paiono ancora in varie parti della terra
contendersi il potere in asprissime lotte, sembrano meno
essenziali e più regionali, a partire dal momento in cui s'impone
la razionalità intrinseca dello stato, che ingloba e supera in se
stesso le istituzioni particolari, ponendosi come l'ingresso di Dio
nel mondo, come la totalità garante dell'esistenza razionale degli
individui, come la potenza della ragione realizzan- tesi in quanto
volontà. Non vi è dubbio che lo stato, cosi inteso, rappresenti la
più alta e comprensiva affermazione della teoricità essenziale
dell'istituzione culturale, il coronamento e il compimento delle
premesse implicite nel concetto di chiesa, di partito e di
professione. Ma proprio perciò il dubbio che corrode le
fondamenta su cui si regge il potere di queste istituzioni è nei
suoi confronti tanto più forte e tanto più insinuante: clamorosa
infatti appare la sproporzione tra la pretesa di avere il monopolio
di tutta la razionalità effettuale e la carenza di organicità, di
coerenza e di sistematicità che mette in mostra. Sicché l'enormità
stessa della sfida che
10 stato inteso come massima e assoluta organizzazione
culturale rivolge alla barbarie della violenza, della corruzione e
dell'ignoranza favorisce la sua resa incondizionata a questi suoi
antagonisti storici.
11processo che trasforma il filosofo dialettico nell'uomo più
isolato e il capo dello stato centralistico nell'uomo più impotente
a garantire la razionalità della storia non lascia scampo nemmeno
al filosofo eclettico e al capo dello stato pluralistico. È infatti
illusorio credere che le opposizioni tra metafisica, umanismo e
scienza possano essere conciliate in un eclettismo compiacente e
bonario, il quale opina di pacificare tutto e tutti in nome di qual-
17
che ideale cosi ampio da comprendere ed assimilare essere,
uomo e sapere. Al contrario metafisica, umanismo e scienza
appaiono oggi essenzialmente affini tra loro, perché emerge un
conflitto più ampio e più profondo di tutti quelli conosciuti
finora, perché s'impone una differenza che il concetto metafisico
di essere, il concetto umanistico di uomo, il concetto scientifico
di sapere non riescono a pensare, né tantomeno a contenere,
perché compare un'opposizione più radicale della contraddizione
dialettica. L'eclettismo non è un rimedio alla perdita della
socialità essenziale del filosofare: non si tratta affatto di stringere
i ranghi nella difesa della filosofia occidentale prescindendo
dalla diversità dei suoi orientamenti e delle sue tendenze, bensì
di differenziarsi e di separarsi da un modo di pensare che,
nonostante la diversità dei suoi orientamenti e delle sue
tendenze, ha presupposto come ovvia la propria socialità.
Parimenti illusorio è opinare che laddove fallisce lo stato
centralistico, il quale assomma in se stesso le funzioni della
chiesa, del partito e della professione, riesca lo stato pluralistico,
il quale presuppone l'emergere di una razionalità sociale dalla
concorrenza di molte organizzazioni religiose, politiche ed
editoriali, scientifiche e professionali. Infatti tali organizzazioni
solo ad una considerazione molto superficiale possono apparire
come effettive unità culturali: il vero confronto, incontro o
scontro non avviene tra loro in modo palese e trasparente
secondo il riferimento ai principi su cui pretendono di fondarsi,
ma tra aggruppamenti occulti, che, creando complicità e
connivenze, le attraversano tutte secondo una logica inespressa e
inconfessabile. Il pluralismo non è un rimedio alla perdita della
teoricità essenziale delle organizzazioni: se nulla di
essenzialmente teorico fonda più la loro esistenza, nulla di
essenzialmente teorico può saltar fuori dalla loro concorrenza e
articolazione nello stato pluralistico. Non si tratta perciò
evidentemente di moltiplicare le organizzazioni ecclesiastiche,
partitiche o professionali, ma proprio al contrario di dar voce e
corpo a quell'unica logica inespressa e inconfessabile che le
attraversa tutte.
18
La dialettica e l'eclettismo sono le ultime filosofie essenzialmente sociali, cosi come lo stato centralistico e quello
pluralistico sono le ultime organizzazioni culturali essenzialmente teoriche. Essi segnano la prima fase del
compimento delle premesse implicite nel concetto di metafisica
e di chiesa. A questa succede una seconda fase che segna il
passaggio dalla dialettica al nichilismo, dallo stato al populismo.
In questa seconda fase di compimento della metafisica e della
chiesa il rapporto tra la filosofia e l'organizzazione della cultura
si pone in termini completamente differenti dal modo in cui si
poneva nella prima fase. Mentre nella prima fase da un lato la
filosofia era realizzata nello stato e dall'altro lo stato aveva
acquisito la consapevolezza della propria razionalità, sicché
esisteva un rapporto di corrispondenza reciproca tra sapere e
potere, tra forme del filosofare e forme del governare, per quanto
non privo di ambiguità e di doppiezze, nella seconda fase tale
rapporto viene completamente meno, perché la filosofia e
l'organizzazione della cultura conoscono un compimento più
profondo e radicale che rende inutile la loro prosecuzione nelle
forme tradizionali di sapere organico, coerente, sistematico, di
potere comunitario, prospettante, competente. Certo si continua
a parlare di filosofia e di stato, e segnatamente di filosofia della
volontà di potenza e dell'eterno ritorno, di stato totalitario e di
stato debole. Ma, se esiste un rapporto di profonda connessione
reciproca tra dialettica e stato centralistico, tra eclettismo e stato
pluralistico, nessun legame verticale sussiste più tra la nuova
sedicente filosofia e il nuovo sedicente stato. Ognuno dei due
procede per proprio conto mirando ad una estensione orizzontale
del proprio ambito che copra anche e soprattutto ciò che
tradizionalmente apparteneva all'altro.
Volontà di potenza ed eterno ritorno sembrano a prima vista
orientamenti opposti, in realtà sono due diverse accentuazioni di
uno stesso fenomeno: infatti la prima può esercitarsi senza
ostacoli solo quando si è raggiunta una completa indifferenza al
significato intrinseco del pensare e viceversa il secondo procede
ad un completo livellamento di tutte le forme del filosofare sotto
la spinta di una volontà di affermazione incontenibile. Stato
19
totalitario e stato debole sembrano a prima vista forme sociali
opposte, in realtà sono due diversi aspetti di uno stesso
fenomeno: il fatto che una singola mafia si appropri delle
strutture istituzionali disponendone a proprio piacimento implica
già il completo decadimento della razionalità intrinseca di queste
e viceversa la debolezza delle strutture istituzionali dipende
appunto dall'esistenza di una lotta tra mafie nessuna delle quali è
certa della vittoria. In questo secondo compimento non c'è più
bisogno di una filosofia tradizionalmente intesa come riflessione
coerente ed originale sull'essere, sull'uomo, sul sapere, né di una
organizzazione culturale, tradizionalmente intesa come
istituzione che ha in se stessa la propria legittimità e razionalità.
Il nichilismo presume di possedere già una sua socialità
intrinseca che gli consenta di dare o togliere legittimità
indifferentemente a qualsiasi potere, ma proprio questo
opportunismo e qualunquismo lo spoglia di ogni teoricità
essenziale: va perduta non solo l'incompatibilità originaria tra
metafisica, umanismo e scienza, ma anche il superamento
dialettico delle loro contraddizioni e perfino l'armonizzazione
eclettica delle loro diversità. Pensiero dell'essere, pensiero
dell'uomo e pensiero del sapere diventano intercambiabili tra
loro, non già perché si fa valere la possibilità di un pensiero
differente, nei confronti del quale le loro distinzioni perdono
rilievo, né tantomeno perché si sostiene la loro sintesi dialettica o
la loro conciliazione eclettica, bensì perché sciolta da tutti i
legami che possono ancorarla ad una qualsivoglia razionalità,
confondendo tutto con tutto, la garrula voce di una sedicente
filosofia possa aggiungersi al valore o al fatto che dà maggiore
garanzia di forza, di stabilità, di successo. Il ruolo della sedicente
filosofia non è nemmeno più quello della legittimazione della
forza, ma soltanto dello spettacolo e dell'ornamento.
Analogamente il populismo presume di possedere già una sua
teoricità intrinseca che gli consenta di incorporare qualsiasi
componente favorisca la sua espansione; questo cinismo e questa
indifferenza teorica lo spoglia altresì di ogni socialità essenziale:
va perduta non solo l'incompatibilità originaria tra chiesa, partito
e professione, ma anche il superamento dialettico delle loro
20
contraddizioni come avviene nello stato centralistico, nonché
l'armonizzazione eclettica delle loro diversità come avviene
nello stato pluralistico. Chiesa, partito e professione sono
assimilati tra loro non perché emerga la possibilità di una
istituzione differente, nei confronti della quale le loro distinzioni
perdono rilievo, né tantomeno perché appaia all'orizzonte la loro
sintesi dialettica o la loro conciliazione eclettica, bensì perché
sciolta da ogni organicità, da ogni coerenza, da ogni rigore, la
sedicente organizzazione culturale possa essere libera di fare e di
disfare, di tessere e di spezzare, di congiungere e di disgiungere
tutte le trame religiose, politiche e scientifiche che l'opportunità
momentanea le suggerisce. È evidente che una aggregazione
simile è incapace di creare e di mantenere una qualsiasi socialità:
la sua logica non è nemmeno più quella della mafia tradizionale,
in cui tanta importanza aveva la fedeltà, ma soltanto quella della
macchinazione e della banda. Ovviamente la filosofia dello
spettacolo è una delle tante pseudo-filosofie in cui si compie il
nichilismo. Esso si compie altrettanto bene in una riproposizione
della scolastica medioevale, dell'antropologia o del positivismo:
nessuna filosofia tradizionale è immune dal pericolo di un simile
trattamento riattualizzante che la riduce ad ornamento. Perfino la
dialettica può essere riciclata dal nichilismo. Analogamente
l'organizzazione della macchinazione può riproporsi come
comunità, come unità ideologica, come gruppo professionale,
oltre che ovviamente spacciarsi per stato centralistico o stato
pluralistico, senza perciò perdere il proprio carattere essenziale
di banda. Anzi tutte le organizzazioni culturali tradizionali
possono essere riciclate in un contesto che toglie ad esse ogni
razionalità ed ogni socialità. Errori politico-filosofici fatali
derivano appunto dal presupporre che quella connessione
essenziale tra filosofia ed organizzazione della cultura che è
esistita nel rapporto metafisica-chiesa, umanismo-partito,
scienza- professione, prosegua anche in questa ultima fase. Essa
però annuncia un nuovo legame tra cultura e società che è di
tutt'altra natura di quello esistente tra una filosofia ed
un'organizzazione della cultura: nella scomparsa della filosofia e
21
dell'organizzazione della cultura, distinte e separate, appare la
possibilità di un pensiero effettivo e di una effettività pensante.
Se perciò in nessuna età filosofia ed organizzazione della cultura
sono state cosi inutili ed insensate come oggi, nessuna età è stata
tanto profondamente filosofica e culturale quanto la presente.
1. L'ordine metafisico-ecclesiastico
Nel momento in cui da un lato i filosofi prendono le distanze
dalla metafisica in nome di un pensiero più essenziale e
comprensivo dell'essere, e dall'altro gli uomini di chi,esa
prendono le distanze dalla nozione tradizionale di chiesa in nome
di una dimensione più essenziale e comprensiva di questa,
sembra che si metta in moto un processo di grande rilevanza
filosofica e storica. Si scopre cosi che la metafisica ha potuto
affermarsi come tale solo attraverso una limitazione dell'essere,
che lo ha costituito come ente, separandolo dal nulla, dal
divenire, dall'apparenza, dal pensare, dal dovere e facendo dipendere la sua necessità da un fondamento, da una causa che
costituisce la sua ragion d'essere. Si scopre cosi anche che la
chiesa ha potuto affermarsi come tale solo attraverso una
limitazione della società umana, che la ha costituita come
istituzione, separandola dall'umanità, determinandola come
unica, infallibile, visibile, missionaria, ed ancorando la sua
ragion d'essere ad una solida e perspicua struttura gerarchica.
Tali considerazioni possono essere sviluppate col mettere in
evidenza vuoi le implicazioni ecclesiastiche della metafisica,
vuoi le implicazioni metafisiche della chiesa tradizionale. Se
viene facilmente concesso che la struttura fondamentale della
metafisica è stata stabilita da Platone attraverso la sua
interpretazione dell'essere come idea, non altrettanto ovvio è il
significato essenzialmente ecclesiastico della sua concezione
della politica, che assegna ai filosofi il ruolo di reggitori della
22
città. L'importanza e l'originalità di Platone, rispetto a più antiche
tradizioni indo-europee consiste tuttavia nell'assegnare tale ruolo
ai filosofi non in quanto sacerdoti o eredi di una classe
sacerdotale, bensì in quanto depositari di una verità che implica
radicali innovazioni organizzative e profondi mutamenti sociali.
Inoltre tale pretesa di forgiare l'intera società secondo un ordine
metafisico non è privo di rapporto con la dimensione socio-organizzativa che la filosofia platonica assume nella fase
della sua elaborazione più compiuta e della sua trasmissione. La
scuola platonica, l'Accademia, è già la chiesa, non tanto perché è
costituita giuridicamente nella forma del tiaso, dell'associazione
religiosa greca, quanto perché è una società in espansione che
esige da tutti i suoi aderenti una unità dottrinale, culturale e vitale
indipendentemente dalle origini etniche e sociali di ciascuno. Si
deve perciò arrivare a ritenere implicita alla metafisica e alla
concezione dell'essere come ente, la nozione di una dimensione
collettiva unitaria, alla cui partecipazione è essenziale
l'apprendimento di verità fondamentali. Il fatto che solo il
cristianesimo riuscì a realizzare compiutamente tale
organizzazione è forse meno importante del fatto di avere posto
le condizioni della sua possibilità.
Reciprocamente s'impone all'attenzione il carattere essenzialmente metafisico della nozione tradizionale di chiesa,
quale essa si è determinata dai primi tempi del cristianesimo fino
al concilio Vaticano II: essa ha potuto organizzarsi come
istituzione, costituita gerarchicamente, che si attribuisce pretese
di dominio universale e sovratemporale unicamente sulla base di
una concezione metafisico-teologica dell'essere, la quale è stata
si pensata e sviluppata nel corso del Medioevo con la massima
ampiezza e profondità, ma solo in una prospettiva teorica
autonoma senza che emergesse il suo rapporto essenziale con la
struttura organizzativa. Non basta comprendere che metafisica e
teologia abbiano potuto nascere ed essere coltivate soltanto
all'interno della chiesa, se rimane celato il fatto che la chiesa è
possibile soltanto nell'ambito di un preesistente orizzonte
metafisico-teologico. Il radicamento della metafisica e della
teologia in seno alla società ecclesiastica non spiega ancora la di-
23
pendenza della società ecclesiastica da fondamenti metafisico-teologici.
L'emancipazione della filosofia dalla metafisica, che avviene
attraverso la scoperta della radicale differenza dell'essere rispetto
all'ente, porta dunque al rifiuto della pretesa ecclesiastica latente
in ogni metafisica, cosi come l'emancipazione dell'ecclesiologia
dalla nozione tradizionale di chiesa, che avviene attraverso la
scoperta dell'alterità ecumenica ed ecclesiale rispetto
all'istituzione, porta al rifiuto del fondamento metafisico
implicito in ogni istituzione ecclesiastica. Cosi è stato senza
dubbio compiuto il primo passo verso la comprensione dei
rapporti intrinseci esistenti tra filosofia ed organizzazione della
cultura.
Ma il legame tra metafisica e chiesa contiene aspetti più profondi
ed essenziali di quanto l'ontologia e l'ecclesiologia
contemporanee sospettino. C'è infatti nella pretesa tipica
dell'ontologia contemporanea di pensare l'essere
indipendentemente da ogni riferimento sociale visibile e nella
pretesa tipica dell'ecclesiologia contemporanea di organizzare la
chiesa indipendentemente da ogni fondamento filosofico
costrittivo, una disattenzione al problema della socialità della
filosofia e della razionalità dell'organizzazione culturale, la quale
è connessa al misconoscimento dell'enorme rilevanza
teorico-sociale del- 1 ' ordine metafisico-ecclesiastico.
La convinzione che tale ordine appartenga irrevocabilmente al
passato e non sia più in nessun modo riproponibile non dovrebbe
escludere il riconoscimento della necessità con cui esso si è
imposto dapprima nella filosofia greca e poi nella civiltà
cristiana. Il fatto che la metafisica pensi l'essere come ente, e la
chiesa organizzi la società in modo riduttivo e limitativo non è
infatti derivato certo da una leggerezza teorica o da una incapacità organizzativa; tali riduzioni e limitazioni sono state le
condizioni imprescindibili affinché fosse garantita la socialità del
filosofare e la razionalità dell'organizzazione. Possono
l'ontologia e l'ecclesiologia contemporanee assicurare in modo
diverso l'una e l'altra? E se sono in grado di rispondere a tale
quesito solo con l'appello al mistero, non è troppo frettoloso e
24
disinvolto il loro rifiuto della metafisica e della chiesa istituzionale?
Una volta ammesso che il processo attraverso cui l'essere è
pensato come ente non è soltanto di natura teorica, ma contiene
implicitamente anche una limitazione sociale non tanto perché
sceglie e distingue coloro che vengono riconosciuti degni di
essere membri della scuola filosofica da tutti gli altri, ma
soprattutto perché si prefigge di allontanare e di escludere dalla
città ideale coloro che come i poeti sono irriducibili ad una
identità e si presentano sempre sotto nuove forme, occorre altresì
sottolineare che la metafisica non prende la sua origine da
conoscenze iniziatiche trasmesse occultamente, bensì nasce da
un dialogo cui tutti possono partecipare. Certo questa
partecipazione è ambigua: essa implica insieme la distinzione tra
maestro ed allievo e il suo superamento nell'apprendimento di
una verità unica, così come è ambiguo il rapporto di
partecipazione che lega nella filosofia platonica la cosa sensibile
all'idea. Ma la descrizione di una città alla quale la filosofia dà la
misura e che costituisce perciò un criterio per ben giudicare le
città realmente esistenti appare il cammino obbligato per legare
strettamente filosofia e società, per fare della filosofia la più alta
e degna attività che si possa svolgere nel consorzio umano.
Analogamente una volta ammesso che il processo attraverso cui
la società è organizzata come chiesa non è soltanto di natura
sociale, ma contiene implicitamente anche una limitazione
teorica, non tanto perché comporta l'enunciazione di
proposizioni dogmatiche, la cui professione è obbligatoria, ma
soprattutto perché implica la condanna di quanto è differente
come eresia o apostasia, occorre tuttavia sottolineare che la
chiesa è depositaria di una verità universale che testimonia
apertamente, non di un segreto gelosamente custodito e
amministrato da pochi. Per quanto la determinazione e la formulazione di tale verità sia poi compito più del magistero che
dell'intero popolo di Dio, più del clero che della totalità dei fedeli
ed implichi la distinzione e separazione tra una chiesa docente e
una chiesa discente, tuttavia la chiesa resta essenzialmente
differente dalla setta proprio per la pretesa di unicità e di
25
universalità della sua dottrina. La difesa intransigente e
l'affermazione militante di una ortodossia appare perciò il
cammino obbligato perché l'intera società sia investita da una
fitta rete di coordinate culturali capaci di conferire valore e significato alla vita di ogni suo membro, qualsiasi sia il posto da lui
occupato nella gerarchia sociale. A partire dall'avvento della
metafisica il pensiero cessa di essere un affare privato; a partire
dall'avvento della chiesa non esiste più vita umana culturalmente
irrilevante: da un lato l'ecclesiasticità intrinseca della metafisica
conferisce effettualità sociale al filosofare, in quanto pensiero
che coinvolge tutti i membri della società ecclesiastica, dall'altro
il presupposto metafisico implicito nella chiesa rende coloro che
ne fanno parte culturalmente comparabili e perciò ordinabili
gerarchicamente. La socializzazione della filosofia e la
culturalizzazione della società introdotte dall'ordine
metafisico-ecclesia- stico appaiono in tutta la loro evidenza se si
riflette alla distinzione che esso pone tra essenza ed esistenza ed
al rapporto di coappartenenza reciproca che sussiste tra questi
due termini. Infatti la determinazione platonica dell'essenza
dell'ente come idea, come l'uno che è comune ad una molteplicità
di cose sensibili, trova la propria integrazione nella
determinazione aristotelica dell'esistenza dell'ente come
enérgheia, come realtà effettuale che si possiede nella semplice
ed immediata presenza. Nondimeno la determinazione
apostolica e subapostolica dell'essenza della chiesa come società
di professanti trova la propria integrazione nella determinazione
dell'esistenza della chiesa come istituzione reale che comprende
tutti i battezzati: l'unità della prima risponde alla domanda su che
cosa essa sia, l'operatività della seconda alla domanda sul fatto
che essa sia oppure non sia. Non a caso lo sviluppo successivo
della metafisica occidentale ha privilegiato il problema
dell'essenza dell'ente rispetto al problema dell'esistenza di
questo, mentre viceversa lo sviluppo successivo della chiesa si è
preoccupato più dell'esistenza dell'istituzione che dell'essenza di
questa. Cosi la filosofia e l'organizzazione della cultura si
dividevano le parti, senza tuttavia smentire l'intima
coappartenenza reciproca di essenza ed esistenza, ma rendendola
26
occulta, implicita, sottintesa. Questa divisione diventa cosi
strutturale da essere individuabile addirittura nella stessa
persona, a seconda che essa svolga l'attività di filosofo oppure
l'ufficio di uomo di chiesa: l'Agostino pensatore è tutto teso a
definire l'essenza della città di Dio nella sua radicale opposizione
alla città terrena, mentre l'Agostino vescovo è cosi preoccupato
di affermare l'esistenza della chiesa da sollecitare al potere
pubblico l'esecuzione delle risoluzioni dell'autorità ecclesiastica.
Né si può parlare di una contraddizione tra teoria e pratica,
proprio perché in tal caso il filosofare è anche implicitamente
pratico e l'organizzazione implicitamente teorica. Dal carattere
implicito della coappartenenza di essenza ed esistenza emerge la
grandezza della metafisica e della chiesa istituzionale. Infatti da
un lato esso dispensa i filosofi da ogni dubbio sull'esistenza del
loro pensare radicandoli nella società, dall'altro esime gli
organizzatori da ogni interrogativo sull'essenza del loro operare,
garantendoli dall'insensatezza. Ne deriva che il metafisico è
vicario di una razionalità sociale che, pur non arrivando ad
esprimersi come tale, è però sempre presupposta come esistente,
mentre il prete è l'interprete di una ortoprassi che non ha bisogno
di formularsi come tale perché la sua essenza ultima riposa
sull'ortodossia: il primo può parlare al posto di tutti ed il secondo
agire per la verità, perché c'è un unico ordine che autorizza e
giustifica l'attività di entrambi. La condizione però dell'efficacia
di tale ordine è che una delle due parti in cui si articola resti in
ombra, sia taciuta, venga data per ovvia: è necessario che
l'esistenza di una società razionale rimanga non pensata dalla
metafisica e che viceversa l'essenza dell'essere rimanga non
pensata dalla chiesa istituzionale.
Dal carattere implicito della coappartenenza di essenza ed
esistenza emerge perciò non solo la grandezza, ma altresì la
miseria della metafisica e della chiesa istituzionale. Infatti una
riflessione sull'essenza dell'essere che non sopporti
l'interrogativo circa il suo statuto sociale è astratta, metastorica,
tautologica: le sfugge tutto ciò che non può essere costretto
nell'orizzonte delineatorz dai principi di identità, di non
contraddizione, del te o escluso; cade al di fuori delle sue
27
possibilità di comprensione tutto ciò che non ha il modo di essere
dell'ente, che non è riducibile al significato nominale del
participio del verbo essere, vale a dire il nulla, l'altro, il differente. Analogamente una istituzione che non sopporti
l'interrogativo circa il suo statuto teorico è autoritaria, legalistica,
formalistica: le sfugge tutto ciò che non può essere costretto
nell'orizzonte delineato dalla gerarchia, dalla legge, dai
sacramenti; cade al di fuori delle sue possibilità di operare ciò
che non è suscettibile di fissazione univoca e definitiva, come
appunto l'immaginario, il quotidiano, l'indeterminato. Perciò il
radicamento della metafisica nella società si rivela in ultima
analisi assai debole; la razionalità della chiesa istituzionale assai
superficiale.
Paradossalmente miseria e grandezza, debolezza e forza della
metafisica e della chiesa istituzionale sono tra loro strettamente
connesse ed intrecciate. Infatti non bisogna dimenticare che la
metafisica, a differenza dell'ontologia contemporanea, ha uno
statuto sociale, anche se non può accedere mai alla sua
comprensione, e parimenti la chiesa istituzionale, a differenza
dell'ecclesiologia contemporanea, ha uno statuto teorico, anche
se non arriva mai a coglierlo. Questa ambiguità spiega la potenza
nella civiltà occidentale di tutto ciò che è sotterraneo e rimosso:
secoli di signoria e di dominio sulla società dei sapienti e dei preti
non riescono ad eliminare un'opposizione che è tanto più
insidiosa e forte quanto più è occulta e repressa e che riemerge di
tanto in tanto in forme teoriche e sociali sempre diverse. Perciò la
metafisica e la chiesa istituzionale sono sempre caratterizzate da
un atteggiamento reattivo e risentito: la metafisica è in fondo
sempre teologia apologetica, o come anche significativamente
veniva chiamata, teologia fondamentale, che determina se stessa
giudicando e condannando le ragioni dell'altro; nello stesso
modo la chiesa istituzionale è sempre in fondo anche chiesa
militante che determina se stessa escludendo e allontanando da sé
la condotta dell'altro. Metafisica e chiesa istituzionale sono
costantemente sotto il peso di una minaccia la quale viene dal
loro interno, dalla filosofia e dalla società che esse pensano di
possedere in modo esclusivo. La struttura di occultamento su cui
28
si reggono produce incessantemente una opposizione occulta,
che esse estirpano da se stesse e rigettano fuori, smentendo cosi
l'unicità e l'universalità teorica e sociale che esse pretendono di
avere. Perciò la metafisica e la chiesa sono rispettivamente una
filosofia e una società incompiuta e interminabile: esse aspirano
ad una totalità che non potranno mai raggiungere, perché essa
implicherebbe il trionfo di ciò che pregiudica rispettivamente la
loro socialità e la loro effettualità.
Appartiene alla stessa struttura il fatto che il trionfo dell'opposto
non possa mai avvenire, se non a condizione di cambiarsi in
metafisica e in chiesa: il trionfo del negativo, dell'altro, del
differente è nella storia della filosofia occidentale e nella storia
del cristianesimo il suo capovolgersi in ente, il trionfo
dell'immaginario, del quotidiano, dell'indeterminato il suo
capovolgersi in istituzione.
L'ontologia e l'ecclesiologia contemporanee pensano di poter
risolvere l'ambiguità strutturale della metafisica e della chiesa
istituzionale pronunciandosi a favore rispettivamente di una
nozione di essere ora più ampia ora più ristretta dell'ente della
metafisica, di una nozione di società ecclesiale ora più ampia ora
più ristretta della società ecclesiastica. Ma questo ampliamento
verso l'interezza dell'essere e verso l'ecumenicità della chiesa,
questo restringimento verso la piccolezza, la semplicità e la
povertà dell'essere e verso l'interpersonalità, la comunicazione e
la comunione della comunità non costituiscono risposte adeguate
alla radicalità e alla profondità della crisi che scuote l'ordine
metafisico-ecclesiasti- co. Resta infatti non pensato, occultato,
taciuto ciò che più importa: quella socialità della filosofia e
quella teoricità dell'organizzazione culturale che l'ordine metafisico-ecclesiastico garantiva in modo insufficiente e troppo
spesso inefficace, vengono completamente meno nell'ontologia e
nell'ecclesiologia contemporanee. La cosa più grave è che
permane in queste l'illusione di poter usufruire dei vantaggi che
l'implicitezza della coappartenenza di essenza ed esistenza
elargiva alla metafisica e alla chiesa istituzionale: ontologia ed
ecclesiologia contemporanee presuppongono erroneamente di
potersi sostenere a vicenda in modo implicito, quasi che l'interez-
29
za o la piccolezza fossero l'essenza di un essere insieme
filosofico e sociale, del quale l'ecumenicità e la comunità
costituirebbero l'esistenza. Ma esse dimenticano che l'intima
coappartenenza reciproca di essenza ed esistenza vale soltanto
fin che vige l'ordine metafisico-ecclesiastico, fintanto che
l'essere è pensato come ente e la società come chiesa. Nell'ordine
metafisico-ecclesiastico era stata possibile una divisione di
compiti tra filosofia ed organizzazione della cultura perché già
all'inizio la filosofia aveva pensato con Platone l'essenza e con
Aristotele l'esistenza dell'ente, e perché già la chiesa aveva
pensato nel suo momento apostolico l'essenza e nel suo momento
costantiniano l'esistenza della società ecclesiastica. Ma questi
privilegi non sussistono più a partire dal momento in cui ci si
rifiuta di continuare a pensare l'essere come ente e a organizzare
la chiesa come istituzione: metafisici e preti potevano a ragione
tacere sulla parte occulta del loro discorso e della loro attività;
non lo possono più fare gli ontologi contemporanei pena l'esperienza di un isolamento, che è tale proprio nella misura in cui
essi tacitamente presuppongono la permanenza dei rapporti
istituiti da una società da loro negata, né gli ecclesiologi
contemporanei, pena la caduta in un irrazionalismo che è tale
proprio nella misura in cui tacitamente essi presuppongono la
permanenza dei rapporti istituiti da una ragione metafisica da
loro negata. Perciò ontologia ed ecclesiologia contemporanee
sono più i sintomi di un malessere che punti di partenza di grande
rilevanza filosofica e storica. La loro pars de- struens, gli
argomenti del loro rifiuto della metafisica e della chiesa
istituzionale, è persuasiva e convincente, ma la loro pars
construens, i caratteri che essi attribuiscono all'essere e alla
chiesa, si rivela insostenibile a causa del conflitto tra la pretesa di
poter
prescindere
completamente
dall'ordine
metafisico-ecclesiastico e la necessità di accogliere occultamente
i suoi presupposti. Per procedere veramente oltre la metafisica e
la chiesa istituzionale, occorre rendere maggiormente giustizia
ad entrambe, di quanto non facciano l'ontologia e l'ecclesiologia.
30
2. L'ordinamento umanistico-partitico
La connessione tra umanismo e partito è, a prima vista, tanto
teoricamente quanto storicamente assai meno plausibile di quella
tra metafisica e chiesa. Infatti da un punto di vista teorico,
umanismo e partito sembrano fenomeni nettamente diversi se
non antitetici: l'umanismo, inteso come forma di pensiero che
pone al centro delle proprie preoccupazioni il problema
dell'uomo, pare sottolineare e propugnare l'unità del genere
umano, la presenza di elementi di libertà e di dignità essenzialmente comuni a tutti gli uomini, mentre il partito, inteso come
forma di organizzazione che pone al centro delle proprie
preoccupazioni il problema del potere, pare accettare e ratificare
la divisione della società in parti in concorrenza e in conflitto tra
loro per la conquista e il mantenimento del controllo politico. Da
un punto di vista storico poi colpisce la diversità tra la
dimensione rinascimentale dell'umanismo che nato a cavallo tra
il XIV e il XV secolo si è sviluppato nelle sue implicazioni
filosofiche nei due secoli successivi e il carattere assai recente del
fenomeno partitico al quale i politologi assegnano a mala pena,
con riluttanza, uno o al massimo due secoli di vita: sicché il
secondo sembra cominciare a profilarsi soltanto quando il primo
si è completamente esaurito.
Eppure nonostante queste immediate difficoltà, la connessione
tra umanismo e partito si rivela ad una analisi più approfondita
come una coappartenenza essenzialmente operante nella storia
dei tempi moderni. Da un punto di vista teorico occorre infatti
tener presente che l'unità cui fa riferimento l'umanismo non è
affatto cosi incondizionata e universale come appare a prima
vista: essa si costituisce come unità proprio attraverso una implicita, ma rigorosa limitazione sociale che esclude coloro che
"umani" non sono, che risultano cioè non conformi al modello di
31
umanità, di educazione, di moralità, elaborato e proposto dagli
umanisti. L'unità del genere umano presuppone la separazione da
ciò che è presunto come in-umano, come barbaro, come
immorale e si regge perciò su una divisione sociale che è molto
più netta e precisa di quella conosciuta e praticata dai partiti
dell'ultimo secolo.
Reciprocamente la divisione sociale instaurata dal partito
rimanda implicitamente all'esistenza di un nucleo comune di
idee, di convinzioni, di orientamenti teorici che costituisce la sua
ragion d'essere. Infatti il partito si distingue dalla fazione e dalla
banda proprio perché si pone come organizzazione culturale,
cioè come società la cui essenza e i cui limiti sono determinati da
principi dotati di validità generale. A differenza perciò di altre
associazioni che avendo esclusivamente come fine l'acquisizione
o la gestione del potere, limitano il numero dei loro membri, il
partito ha una vocazione universalistica che si manifesta nella
propaganda. Nel partito perciò la lotta per il potere è
condizionata dall'esistenza di una ideologia che chiede di essere
condivisa e sostenuta dal maggior numero di persone possibile, e
tendenzialmente da tutti.
I dati storici non contraddicono, ma anzi confermano sia il
carattere implicitamente partitico dell'umanismo, sia il carattere
implicitamente umanistico del partito. La dimensione
implicitamente partitica, e non solo genericamente politica
dell'umanismo, la si coglie proprio là dove come nel
contrattualismo giusnaturalistico più ampia e universalistica
sembra la prospettiva storico-filo- sofica: i contrattualisti,
ponendo un'adesione libera e volontaria come condizione del
contratto sociale, credono di pensare l'origine della società civile
o dello stato, mentre in realtà formulano le condizioni della possibilità del partito: la razionalizzazione e la legittimazione della
vita politica, di cui essi si fanno portavoce, passa infatti
attraverso l'idea di una organizzazione costituita per iniziativa
volontaria dei singoli individui. Reciprocamente la riluttanza di
tutti gli uomini politici di parte fino all'Ottocento di dichiararsi
tali, lo sforzo indefesso e continuo di presentarsi come esponenti
di un "partito nazionale" o di una "volontà generale" al di sopra
32
delle fazioni, dimostra che la domanda di consenso che essi
rivolgono ai loro sostenitori implica il riferimento a principi cui
viene attribuita una validità generale: ciò è particolarmente
evidente nelle vicende politiche del Settecento inglese e in quelle
della Rivoluzione francese. Ovunque non appena con
l'allargamento del suffragio l'opinione pubblica acquista un peso
politico, il riferimento più o meno enfatico e patetico all'immagine umanistica del mondo diventa indispensabile. Il passaggio
dalla politica delle cose alla politica delle idee,
dall'organizzazione degli interessi all'organizzazione culturale,
dalla fazione al partito, che una cosi grande meraviglia destava in
tanti acuti osservatori politici tra il Settecento e l'Ottocento, da
Hume a Tocqueville, avviene appunto attraverso l'adozione
dell'umanismo, adozione inconsapevole proprio per l'ovvietà e la
necessità con cui si presenta. Non a caso del resto il primo partito
che si pone esplicitamente e radicalmente come partito di classe,
il partito comunista, implica anche una rifondazione
dell'umanismo, che partendo dall'umanismo classico, giunga a
una concezione ancora più universale dell'uomo.
Perciò da un lato non si può limitare l'umanismo all'età
rinascimentale perché, dopo la parentesi del Barocco, non solo
esso si afferma nel Settecento come un aspetto importante della
cultura letteraria e filosofica, ma costituisce la forma di pensiero
fondamentale su cui si struttura l'opinione pubblica e il consenso
politico, dall'altro non si può separare il partito politico dalle
premesse teoriche generali che consentono la sua nascita e il suo
sviluppo non soltanto perché i raggruppamenti inglesi degli
Whigs e dei Tories, oppure in modo più sicuro ed evidente il club
dei Giacobini durante la Rivoluzione francese hanno già
costituito partiti ante litteram, ma soprattutto perché una società
costituita sull'adesione ideologica volontaria non è pensabile
senza le premesse filosofiche poste e sviluppate dall'umanismo
in quasi mezzo millennio.
Se l'ordine metafisico-ecclesiastico aveva il proprio centro nel
concetto di ente, rispettivamente inteso come significato
nominale del participio del verbo essere e come istituzione,
l'ordinamento umanistico-partitico trova il proprio centro nel
33
concetto di soggetto. Il soggetto dei tempi moderni non è tuttavia
l'io empirico: non si potrebbe in tal caso capire né la socialità
implicita dell'umanismo né la razionalità implicita del partito,
mentre è proprio il soggetto che costituisce il loro fondamento.
Che la socialità dell'umanismo sia limitata non meno della
razionalità del partito non dipende da una supposta dimensione
individualistica o arbitraria del soggetto, ma al contrario proprio
dal fatto che il soggetto implica una obbligatorietà sociale e
intellettuale rigorosamente determinata, la quale è certo diversa
da quella dell'ordine metafisico-ecclesiastico, ma non più
elastica e più imprecisa di essa. La liberazione dalla metafisica
dell'ente e dalla istituzionalità della chiesa non avviene che
attraverso la formulazione delle regole del metodo e la
fondazione del loro valore assoluto e universale. La posizione
sovrana assunta dall'uomo nei confronti di tutti gli altri enti e
dell'associazione volontaria nei confronti di tutte le società
precostituite e indipendenti dall'adesione, si realizza attraverso
l'assunzione dell'eredità dell'unico ente che implica la
socializzazione, l'idea platonica, e dell'unica società che è stata
essenzialmente culturale, la chiesa. Il soggetto cartesiano
risponde al bisogno di una fondazione più rigorosa di quella che
garantiva il subiectum, il sostrato, la sostanza della metafisica; in
tal modo quindi non indebolisce, ma anzi rafforza il presupposto
della necessità di un fondamento assoluto ed inconcusso.
Analogamente il partito politico risponde al bisogno di una
organizzazione culturale più coinvolgente di quella che
garantiva la chiesa istituzionale; in tal modo quindi non
indebolisce, ma anzi rafforza il presupposto della necessità di
una unità dottrinale. Non a torto perciò umanismo e partito sono
stati considerati più la continuazione della metafisica e della
chiesa, che il loro oltrepassamento. Umanismo e partito
ereditano non solo la rigorosità, ma anche l'ambiguità strutturale
della metafisica e della chiesa. L'esistenza di una obbligatorietà
che implica la dimensione sociale di un legame, di un impegno,
di un'alleanza, pur essendo sempre presupposta dall'umanismo
non può essere mai da questo esplicitamente ammessa e pensata,
proprio perché comprometterebbe la sua pretesa universalistica:
34
il fatto che il metodo colleghi non tutta l'umanità, ma solo coloro
che lo possono e che lo vogliono seguire, costituisce un'evidenza
che non può mai essere pienamente da questo riconosciuta
perché pregiudica inesorabilmente la sua certezza di lottare
contro il particolarismo oscurantistico. Cosi l'esistenza di un
fondamento che trasforma il partito da mera associazione di
volontà singole in soggetto storico e gli conferisce una salda
dimensione teorica, è destinata a restare implicita perché un
completo sviluppo di tale dimensione teorica porterebbe al
progetto dell'estensione del partito al di là dei confini della
nazione fino ad inglobare l'umanità intera; ma la formulazione di
un tale proposito equivale all'estinzione del partito stesso per il
venir meno di ogni conflittualità. L'ordinamento
umanistico-partitico è perciò non meno paradossale dell'ordine
metafisico-ecclesiastico: come in quello anche in questo
filosofia ed organizzazione della cultura si presuppongono
reciprocamente senza potersi mai incontrare. Tale ambiguità è
già presente in Platone e in Aristotele, i quali possono essere
giustamente considerati non solo come i fondatori dell'ordine
metafisico-ecclesiastico, ma altresì come i remoti progenitori
della concezione umanistica del mondo e dell'impegno politico
nella loro reciproca taciuta coappartenenza. Infatti il mito
platonico della caverna, in cui si considera la paideia,
l'educazione, come condizione della liberazione dagli errori e
della visione della verità, si conclude con l'ipotesi di un
intervento, che può avere perfino conseguenze violente, diretto
al fine di sciogliere dalle catene i prigionieri; reciprocamente,
nell'opera aristotelica dedicata alla politica, la tesi della
essenziale socievolezza dell'uomo, della sua tendenza ad
associarsi con altri, rimanda al fatto che l'uomo, solo tra gli
animali, possiede il logos, e quindi la percezione del bene e del
male, del giusto e dell'ingiusto, nonché degli altri valori. Eppure
né Platone può attribuire all'impegno liberatorio quel significato
di parte che esso in effetti ha, perché sono in gioco gli interessi
universali dell'umanità, né Aristotele può dedurre dal bisogno
umano di unirsi con altri quell'universalismo filantropico e
cosmopolitico che sembra implicito nel suo appello alla ragione
35
e alla morale, perché vuole fondare razionalmente le comunità
preideologiche, e perciò ancor più empiricamente determinate,
della famiglia e della polis. L'ambiguità strutturale
dell'ordinamento umanistico- partitico non è passato inosservato
al pensiero contemporaneo il quale, analogamente a quanto è
avvenuto per l'ordine metafisico-ecclesiastico, ha spezzato i due
termini del rapporto, separando l'una dall'altra la filosofia
dall'organizzazione della cultura. È nato cosi un umanismo senza
partito, che si chiama universalismo ermeneutico, e una
partiticità senza umanismo, che si chiama autonomia del
politico. Nell'ermeneutica universalistica la comprensione non è
più il punto di arrivo che, provvisoriamente assicura la solidità
del legame intersoggettivo, come nell'umanismo classico, ma, in
quanto essenzialmente connessa col linguaggio, il carattere
preliminare che definisce in generale ogni rapporto dell'uomo col
mondo. Tale estrema generalizzazione dissolve appunto la
possibilità di fondare sulla comprensione l'associazione
volontaria impegnativa, il partito, e blocca il compito metodico e
infinito del soggetto teso verso l'appropriazione collettiva del
mondo. Tuttavia sebbene l'ermeneutica proponga di pensare una
realtà di fronte alla quale la pretesa onnipotenza della riflessione
si trovi limitata, non attribuisce mai però a tale realtà il carattere
di una differenza, teologica, artistica o storica, completamente
altra, ma la riconduce sempre, proprio in quanto linguaggio
umano, nell'ambito di una antropologia estetica che eredita
dall'umanismo le nozioni di socialità, di paideia, di gusto.
L'ermeneutica universalistica è insomma un umanismo che
lascia cadere le implicazioni socio-politiche e organizzative più
impegnative presenti nel soggetto, nel metodo, nella
progettualità, e si accontenta di connotazioni desunte dallo stesso
contesto storico-culturale che critica. Reciprocamente le correnti
che rivendicano l'autonomia del politico pensano il partito
prescindendo dalle implicazioni filosofiche e teoriche
dell'umanismo. Esse vedono l'essenza del politico nel rapporto
amico-nemico e quindi considerano la divisione sociale non già,
come nella concezione classica del partito, la conseguenza
inevitabile e provvisoria di un conflitto teorico, ma in quanto
36
essenzialmente connessa con la lotta per il potere, il presupposto
sempre presente che determina in generale l'azione dell'uomo nel
mondo. Tale estrema generalizzazione della partiticità mostra
che essa non ha più nessun rapporto con l'adesione collettiva ad
un programma, ad una ideologia, ad un progetto generale
dell'uomo vincolante ed impegnativo, e blocca il compito
metodico ed infinito del soggetto teso verso la comprensione
delle ragioni degli altri e la ricerca di un consenso razionale.
Tuttavia questo emanciparsi del politico dalla teoria, il quale mostra l'impossibilità di una estensione del partito all'umanità
intera, sebbene ridicolizzi la pretesa illuministica di spacciare
per volontà generale ciò che è volontà di parte, conserva tuttavia
un nucleo teorico che è desunto interamente dalla politica delle
idee aperta dall'Illuminismo e dalla Rivoluzione francese: non
tanto perché pone un limite alla lotta rifiutando l'esito estremo di
un annientamento totale della parte nemica, il quale ricreando
perciò l'unità abolirebbe l'essenza partitica del politico, ma
soprattutto perché attribuisce un significato e un valore
fondamentale alla pubblicità del conflitto, perché distingue con
la massima nettezza tra nemico pubblico e palese e nemico
privato ed occulto. L'autonomia del politico è perciò un
universalismo organizzativo a struttura polemologica che lascia
cadere le implicazioni teoriche più cogenti connesse col partito
inteso come soggetto storico e si accontenta di connotazioni
teoriche più generali desunte dallo stesso contesto storico-culturale che critica.
Ermeneutica e autonomia del politico hanno una chiara
percezione dei limiti e delle ambiguità strutturali dell'ordinamento umanistico-partitico, ma ritengono a torto di poterle
risolvere isolando rispettivamente la filosofia dall'organizzazione
della cultura e l'organizzazione della cultura dalla filosofia: la
connessione implicita tra umanismo e partito si rivela certo oggi
sempre più insostenibile, ma ancor meno soddisfacente è la
frammentazione desocializzante e derazionalizzante di un ordinamento che ha continuato, sviluppato e approfondito,
coinvolgendovi intere nazioni, quell'attività di socializzazione
della filosofia e di razionalizzazione della società svolta nei
37
secoli precedenti dalla metafisica e dalla chiesa. Ciò risulta
evidente anche nell'analisi delle trasformazioni che le nozioni
fondamentali in cui si articola l'ordinamento umanistico-partitico
subiscono nella frammentazione autonomizzante cui li sottopone
l'ermeneutico e il politico.
Tali nozioni sono quelle di rappresentazione e di rappresentanza.
La prima è per la concezione umanistica del mondo la
condizione stessa della conoscenza: essa indica sia il porre
dinanzi al soggetto l'oggetto da rappresentare, sia ciò che è posto
come oggetto da rappresentare dinanzi al soggetto. La seconda è
per l'organizzazione partitica la condizione stessa del suo
funzionamento: essa indica il rapporto reciproco che lega l'eletto
all'elettore, il dirigente al militante di base, il rappresentante al
rappresentato. Nell'ordinamento umanistico- partitico
socializzazione del pensiero e razionalità dell'organizzazione
non sono garantite direttamente come nell'intuizione intellettuale
o nella democrazia diretta: esse sembrano assicurate
indirettamente attraverso la mediazione, attraverso
l'imprescindibilità di un rinvio vicendevole tra soggetto ed
oggetto, tra rappresentante e rappresentato. Tuttavia questo
reciproco rimando da solo non è sufficiente a garantire la
socialità dell'umanismo e la razionalità del partito. Tali
caratteristiche dipendono da una implicita partiticità della
rappresentazione e universalità della rappresentanza. Infatti in
primo luogo la rappresentazione non è soltanto l'atto soggettivo
di rappresentare l'oggetto, o il risultato oggettivo di tale atto, ma
più occultamente un rappresentarsi in anticipo in quanto
rappresentanti il rappresentato, cioè un decidere su se stessi
come soggetti della rappresentazione e su ciò che si pone dinanzi
a se stessi come oggetto di essa. L'uomo è certo e sicuro della
propria rappresentazione perché procede con metodo: l'esattezza
del rappresentato è assicurata da una decisione inespressa e
impensata, il cui significato è politico, perché implica l'adozione
di un modo di essere che garantisce l'esattezza dello sguardo, e le
obbligazioni, i legami, le solidarietà con quello connesse. In
secondo luogo la rappresentanza non è soltanto l'emancipazione
del rappresentante da un ruolo di mera esecuzione o del rap-
38
presentato da una condizione di mera inefficacia, ma implica più
occultamente il fatto che tanto il rappresentante quanto il
rappresentato rappresentino un modello che sta al di sopra di
entrambi per la sua normatività e cogenza razionale. In tanto si
può stabilire tra i due un rapporto fiduciario in quanto entrambi
riproducono e attualizzano tacitamente un ideale che costituisce
il fondamento del loro essere insieme nel partito. Questo ideale si
impone ad entrambi con una pretesa di validità universale e li
solleva dal ristretto ambito delle lotte locali e degli interessi
particolari sulla scena della storia. La legittimità della loro
azione riposa in ultima analisi su un fondamento filosofico: essi
rappresentano un copione che è stato scritto dalla ragione e che
chiede di essere recitato da tutti gli uomini.
L'implicita coappartenenza del concetto filosofico di
rappresentazione e di quello politico di rappresentanza è dissolta
sia dall'universalismo ermeneutico sia dall'autonomia del
politico. Il primo infatti recide il legame occulto che congiungeva
la rappresentazione al metodo e alla decisione e conferisce a
questa nozione un significato eminentemente
estetico-linguistico: la rappresentazione è un autorappresentarsi
dell'immagine e del linguaggio, il movimento attraverso cui essi
vengono all'essere e alla verità, sottraendosi alla distinzione tra
soggetto ed oggetto. Perciò l'ermeneutica contemporanea
universalizza il concetto di gioco emancipandolo dalla
soggettività del giocatore, ma non dall'esistenza anche
meramente ipotetica di uno spettatore. Il secondo inversamente
recide il legame occulto che congiungeva la rappresentanza al
modello normativo e ideale e serra il rapporto tra rappresentante
e rappresentato in una solidarietà per la vita e per la morte: la
rappresentanza diventa lo specchio in cui dirigente e militante di
base si raffigurano e si riconoscono l'uno nell'altro. Ciò che
consente tale identificazione è l'autopresentarsi e l'autodichiararsi nemici dei due partiti contrapposti tra loro: al loro
interno non è più possibile nessuna indeterminazione, perché al
di sopra di tutti s'impone l'estrema verità e serietà risolutiva del
conflitto. Perciò il politico autonomizza il concetto di guerra
emancipandolo dalla soggettività dei combattenti, ma non
39
dall'ingiunzione rivolta al terzo interessato di favorire
occultamente l'uno o l'altro.
Cosi certo l'ambiguità su cui si reggevano l'umanismo e il partito
sembra risolta, ma si è gettato il bimbo con l'acqua senza poter
poi nemmeno uscire dal bagno. Infatti la pretesa dell'ermeneutico
di creare una socialità indipendente dalla politica e la pretesa del
politico di creare una razionalità indipendente dall'umanismo restano ancora debitrici all'esistenza di un presupposto su cui nasce
e si sviluppa l'ordinamento umanistico-parti- tico: l'opinione
pubblica, la società pensata come soggetto. Il gioco e la guerra
hanno ancora bisogno di un soggetto dinanzi a cui svolgersi che
si rappresenti lo splendore della rappresentazione o che consideri
segretamente uno dei due combattenti come il proprio rappresentante. Essi cosi tradiscono la loro natura epigo- nica e
offrono lo spettacolo di una modernità dimidiata.
3. Il sistema scientifico-professionale
Per quanto la scienza, intesa come forma di pensiero che si
propone di conoscere sistematicamente il mondo, e la
professione, intesa come forma di organizzazione della cultura
che pone una conoscenza detenuta monopolisticamente al
servizio della società, abbiano una storia secolare che risale al
sorgere delle prime università nel Medioevo, tuttavia il sistema
scientifico-professionale inteso come struttura che permea e
determina profondamente il sapere e la società, ha vissuto un
lunghissimo periodo d'incubazione storica e solo a partire dal
primo decennio del secolo scorso, con la fondazione delle
università moderne, ha cominciato a delinearsi nettamente. Ciò
che caratterizza tale sistema è insieme una socializzazione
radicale della scienza per cui questa non è più vista come una
investigazione personale e privata del singolo, ma come
un'impresa in cui tutta la società è coinvolta e da cui dipende il
40
suo destino, e una scien- tificizzazione altrettanto radicale della
società, per cui la condizione di ogni azione efficace implica una
completa subordinazione ai criteri, alle prospettive e ai procedimenti della conoscenza scientifica. È importante osservare che a
partire dall'Ottocento la scienza diventa sociale non perché utile,
né perché la maggior parte della società o la parte più influente di
essa si rende conto della sua utilità: utile non lo è mai stata, né
mai lo è diventata, se si pensa al presupposto che l'ha sempre
animata, di essere perseguita per se stessa e non per le
conseguenze che comporta; oppure lo è sempre stata, se si pensa
alle applicazioni pratiche che da essa sempre sono state tratte.
Sociale la scienza è diventata perché si è appropriata
completamente della realtà, escludendo da questa tutto ciò che
restava irriducibile al suo approccio metodico: la sua socialità
non è separabile da una intuizione metafisica fondamentale che
pensa l'essere dell'ente come oggettività del reale. Parimenti
importante è osservare che la società è diventata scientifica non
perché abbia acquistato un grado di complessità tale da sollecitare una considerazione sistematica: complessa la società lo è
sempre stata almeno dall'avvento della divisione del lavoro,
oppure non lo è mai stata, né è successivamente mutata, se si
pensa al controllo che sul lavoro essa ha sempre in qualche modo
esercitato. Scientifica la società è diventata mediante
l'introduzione di un sistema scolastico e universitario che
conferisce a coloro che hanno seguito e superato l'intero corso di
studi il monopolio non solo dell'esercizio delle professioni colte,
ma anche della direzione del lavoro esecutivo: la scientificità
non è separabile da una organizzazione della cultura che rende
scientifico tutto il lavoro umano e che fa della scientificità la
condizione della sua efficacia.
Il sistema scientifico-professionale ha potuto assumere l'eredità
dell'ordine scientifico-ecclesiastico e far concorrenza
all'ordinamento umanistico-partitico, perché possiede come
questi una dinamicità intrinseca che rende il suo compito sempre
incompiuto e interminabile. Non si tratta infatti di trasmettere e
di applicare un insieme di conoscenze stabilite una volta per
tutte, ma di essere coinvolti, per quanto concerne sia l'attività
41
scientifica che quella professionale, in un processo di continuo
approfondimento e ampliamento del sapere e della sua
operatività. Perciò il concetto fondamentale su cui si costruisce il
sistema scientifico-professionale è la ricerca: ciò che la
caratterizza essenzialmente è lo sforzo continuo di tenere sotto
controllo il mutamento, delineandolo innanzitutto in un progetto,
seguendolo attraverso un procedimento, facendolo pervenire ad
un risultato. Sebbene filosofia ed organizzazione della cultura,
scienza e professione, elaborazione di nuove conoscenze e loro
applicazione sociale siano distinte, esse si coappartengono
reciprocamente in modo occulto. Da un lato infatti la scienza è
intrinsecamente operativa perché il suo progetto deve essere
verificato attraverso l'esperimento, attraverso la critica delle
fonti, attraverso la comparazione: proprio questa operatività
intrinseca la separa dalla mera osservazione, dalla mera
erudizione, dalla mera cronaca. Dall'altro la professione è
intrinsecamente scientifica, perché la sua prestazione si fonda su
un corpo di conoscenze sistematicamente ordinate e in continuo
sviluppo: proprio questa costante innovazione rigorosamente
controllata la separa dal mestiere, oltre che ovviamente dal
ciarlatanismo e dalla magia. La scienza si costituisce come
professione parallelamente al costituirsi della professione come
scienza. Questa coappartenenza risulta evidente nell'università
moderna e nella figura del professore universitario, che è insieme
docente e ricercatore, docente di un sapere professionale proprio
perché professionalmente dedito all'incremento di questo sapere,
e ricercatore di una conoscenza sperimentale al servizio di tutti
perché libero professionista della scienza. Viceversa la riduzione
del professore ad impiegato dell'università è parallela alla
recisione di ogni legame tra attività professionale e ricerca: tale
fenomeno mostra a contrario in primo luogo che la dimensione
scientifica che distingue il professore dall'insegnante è proprio
derivata dal carattere professionale delle conoscenze che egli
trasmette e in secondo luogo che la dimensione etica che
distingue il professionista dagli altri lavoratori è proprio derivata
dal carattere scientifico delle conoscenze che detiene. Attraverso
il sistema scientifico-professionale l'intero sapere diventa sociale
42
e l'intera società diventa culturale, perché l'umanità stessa è
coinvolta in un progresso illimitato il cui motore è il lavoro.
Questo non ha più nulla di privato o di naturale: la ricerca fonda
la sua socialità e la sua culturalità separandolo dal passatempo o
dalla operosità degli animali. Questo processo di socializzazione
del sapere e di culturalizzazione della società non riguarda solo
gli scienziati e i professionisti, ma coinvolge tutti. La progressiva
scientificizzazione di tutti i campi del sapere è evidente nella
trasformazione delle discipline umanistiche in scienze dello
spirito e di queste in scienze umane, processo che non è solo
nominale, ma implica una progressiva estensione dell'attitudine
scientifica a tutti gli ambiti della vita, contemporaneamente allo
svolgersi di un processo che trasforma in lavori professionali
attività precedentemente praticate in modo meramente privato,
come la psicoterapia o l'osservazione della società...: non a caso
perciò i nuovi oggetti della ricerca scientifica sono proprio quei
fenomeni che sono rimasti finora estranei ad un'indagine sistematica, come la vita quotidiana. Rispettivamente la scolarizzazione universale non è soltanto l'alfabetizzazione, ma il
coinvolgimento dell'umanità intera in un processo di promozione
culturale ininterrotta che, attraverso corsi di perfezionamento, di
aggiornamento, di riqualificazione, tende a conferire un alto
livello specialistico e quindi uno statuto professionale a tutte le
attività: anche in questo caso lo sforzo è orientato verso la
creazione di nuove carriere che soddisfino le carenze lasciate
dall'esercizio corrente delle professioni tradizionali non solo
nell'assistenza tecnica ma soprattutto nella partecipazione
personale ed emotiva ai problemi del cliente. La coappartenenza
di scienza e professione, come il rapporto che lega metafisica e
chiesa, umanismo e partito, resta tuttavia implicita: una completa
esplicitazione di tale reciproco rimando metterebbe in mostra la
sostanziale ambiguità su cui l'intero sistema scientifico-professionale si regge. Infatti la scienza rivendica una totale
autonomia, indipendenza e precedenza nei confronti di qualsiasi
uso o applicazione, e, per quanto esili e gracili possano sembrare
i suoi appelli ad un puro valore del sapere, tuttavia essi mostrano
che la sua dimensione teorica è qualcosa di essenziale e non di
43
meramente autocelebrativo; analogamente la professione
rivendica una totale dedizione al servizio e alla società, un totale
rifiuto delle attività dilettantesche o meramente ludiche e per
quanto esili e gracili possano sembrare i suoi riferimenti alla
vocazione e alla completa dedizione ad un compito sociale,
tuttavia essi mettono in evidenza che la sua dimensione pratica è
qualcosa di essenziale e non di meramente autoapologetico. Da
un lato abbiamo dunque una teoria che subordina a sé la pratica,
dall'altro una pratica che subordina a sé la teoria. Il luogo in cui
queste opposte esigenze dovrebbero trovare una conciliazione e
un'armonizzazione è l'università, perché in essa da un lato la
scienza nella sua dimensione più teorica è perseguita come
professione, dall'altro la professione consiste proprio nella
formazione e nella comunicazione di un sapere professionale: in
realtà l'università è proprio perciò anche il luogo della massima
ambiguità non tanto o non soltanto per il sommarsi dei compiti di
ricerca e dei compiti di docenza nella figura del professore
universitario, ma più essenzialmente perché da un lato la scienza
universitaria è nella sua stessa struttura più profonda al servizio
del fare e del produrre, e dall'altro la professione è nella sua
stessa essenza più profonda, professione della conoscenza. È
tuttavia impossibile alla scienza riconoscere esplicitamente il
fatto di essere scienza delle professioni senza oscurare l'aspetto
essenziale della ricerca disinteressata e ridurre cosi l'università
ad una scuola superiore, e parimenti è impossibile alla
professione riconoscere esplicitamente il fatto di essere
professione di scienza, senza oscurare l'aspetto essenziale del
servizio fornito a clienti ben determinati e ridurre cosi
l'università ad una accademia. Di questa ambiguità si rende
conto il pensiero contemporaneo quando fa oggetto il sistema
scientifico-profes- sionale di una critica più che mai convincente
e perspicua. Da un lato la nuova epistemologia mostra che la
pretesa della scienza di identificare la realtà con l'oggettività non
ha affatto un valore razionale assoluto, che la stessa opposizione
fondamentale tra scienza e mito è priva di giustificazione, che
perfino l'idea più antica o assurda può migliorare la conoscenza.
Dall'altro il movimento per l'educazione permanente sostiene
44
che la scolarizzazione universale della società, secondo cui il
ruolo professionale di ciascuno è stabilito da un curriculum
scolastico e universitario, è insieme antieducativa e antisociale,
che la concezione scientifico-progressiva del lavoro e del sapere
è in realtà fonte infinita di frustrazioni, che lo sviluppo attuale del
professionismo e della specializzazione è causa di nuovi errori e
di nuovi insuccessi, mentre le istituzioni delegate a pianificare e
a risolvere scientificamente un qualsiasi problema provocano il
risultato opposto a quello che si propongono. L'interesse delle
critiche rivolte alla scienza e al lavoro professionale dalla nuova
epistemologia e dal movimento per l'educazione permanente sta
nel fatto che esse nascono all'interno stesso della problematica
scientifica e formativa: da ciò tuttavia deriva anche il loro limite,
perché, nutrendo rispettivamente interessi solamente scientifici e
solamente educativi ed operazionali, spezzano la connessione
che nel sistema scientifico-profes- sionale legava implicitamente
la filosofia all'organizzazione della cultura. Di tale sistema essi
perciò avvertono solo la miseria, non la grandezza. Il fatto che la
scienza intesa come teoria della razionalità costituisca un
ostacolo allo stesso progresso scientifico e che la professione
intesa come esercizio pubblico di una competenza fondata sul
percorso di un curriculum universitario finisca coll'essere
inefficiente, può anche avere in fondo un'importanza molto
relativa, dal momento in cui ci si pone fuori dalle prospettive
teoriche e organizzative del sistema scientifico-professionale:
proprio l'estraneità rispetto a tale sistema e alle preoccupazioni
che ne hanno influenzato la dinamica consente di comprendere la
sua enorme rilevanza filosofica e storica assai meglio di quanto
possano fare i nuovi epistemologi e i nuovi educatori, i quali
restano sostanzialmente prigionieri dei moventi che lo hanno
animato e quindi non sono in grado di cogliere la sua grandezza
che è extra-scientifica ed extra-professionale quanto la sua
miseria.
Col sistema scientifico-professionale il pensiero viene
socializzato non solo più nella forma di una verità sull'essere,
come nella metafisica, o di una verità sull'uomo, come
nell'umanismo, ma come verità sul mondo: questa verità non è
45
segreta, ma appartiene a tutti coloro che hanno la volontà e la
costanza di impararla in modo sistematico e progressivo e di
svilupparla in modo ordinato e metodico. La scienza eredita ed
amplia il carattere sociale della metafisica e dell'umanismo: essa
conferisce a tutti la possibilità di porsi come padroni dell'oggettità del reale. Analogamente in questo sistema la società
viene culturalizzata, non solo più nella forma del popolo di Dio,
come nella chiesa, o nella forma del soggetto collettivo, come nel
partito, ma come noosfera, cioè come un universo la cui continua
evoluzione è determinata dalla scolarizzazione di tutti e dalla
progressiva scientificizzazione del lavoro. Così la noosfera
eredita ed amplia la culturalizzazione della società avviata dalla
chiesa e dal partito: la lotta contro l'ignoranza e l'insuccesso
conferisce un significato culturale anche ai lavori più umili e
modesti.
Sfugge tuttavia a tale socializzazione e culturalizzazione quanto
non può essere calcolato, né fondato: per quanto il sistema
scientifico-professionale tenda incessantemente ad ampliare i
suoi limiti, annettendosi nuovi oggetti e creando nuove
specializzazioni, sempre si ricostituisce un resto che si sottrae ad
ogni indagine e che smentisce ogni progetto: la storia della
modernità che è scandita dai successi della ragione scientifica e
del lavoro intellettuale è anche segnata dalla ineliminabilità di
una opposizione poetica che nessuna estetica riesce a sopprimere
e di una opposizione sociale contro la scuola e il lavoro che
nessun incentivo professionale e nessuna organizzazione
sindacale riesce ad abolire. Contro il razionalismo
leibniziano-kantiano nasce e si sviluppa la rivolta poetica dallo
Sturm und Drang in poi; contro il movimento che promuove le
nuove università e le nuove classi produttive sorge e continua per
tutta la modernità il movimento che contesta radicalmente
l'organizzazione del lavoro professionale e industriale. La
pretesa di totalità del sistema scientifico-professionale è perciò
sempre frustrata: il suo carattere progressivo nasconde
l'incompiutezza e l'interminabilità del suo compito. Insieme alla
ricerca e ai curricula scolastici, il sistema
46
scientifico-professionale crea un'opposizione strutturale a se
stesso, che si manifesta nella rivolta poetica e nel luddismo.
Lo sforzo per andare al di là del sistema scientifico-professionale deve partire da una considerazione più approfondita
dell'ambiguità strutturale di una teoria che è esplicitamente pura
teoria mentre è implicitamente anche pratica e di una pratica che
è esplicitamente pura pratica mentre è implicitamente anche
teoria. Questa ambivalenza che ha caratterizzato la filosofia
occidentale fin da Platone e da Aristotele è rimasta in uno stato
d'incubazione sino all'età moderna, quando ha trovato la sua
manifestazione nel principio di ragion sufficiente formulato da
Leibniz, secondo cui nulla è senza ragione. Tale principio su cui
si basano le verità di fatto, implica la distinzione tra due nozioni
fondamentali che si coappartengono reciprocamente, la ragione e
il fondamento. La ragione è appunto la facoltà dinanzi alla quale
vengono presentate, rese, esposte le proposizioni riguardanti
questioni di fatto, le quali perciò non sono necessarie, ma
contingenti, cioè possono essere sottoposte ad essa in modo
opposto senza che sorga una contraddizione: essa funziona come
un tribunale che calcola, pesa, confronta ciò che gli viene
proposto e quindi dà un giudizio sulla sua razionalità; ha quindi
un compito eminentemente teorico, proprio nel senso di stare a
guardare soppesando, ponderando e riflettendo. Il fondamento è
invece la cosa che viene presentata alla ragione come causa,
ragion d'essere, condizione della possibilità delle proposizioni di
fatto su cui essa è chiamata a giudicare: il fondamento è il
risultato di un mettere, di un produrre, di un effettuare, è il punto
di arrivo di un fare che si presuppone poter essere approvato
dalla ragione, proprio perché già intanto ha una sua ragion
sufficiente per esistere; esso è la base di un compito
eminentemente pratico, proprio nel senso di compiere
proponendo, promuovendo e trattando. La ragione è la
dimensione teorica del sistema scientifico-professionale, è la
scienza; il fondamento è la dimensione pratica del sistema
scientifico-professionale, è la professione. La loro
coappartenenza non è solo quella esplicita che sussiste tra chi
giudica e chi è giudicato, tra chi sanziona e chi fonda, tra chi
47
guarda e chi fa; tra ragione e fondamento, tra scienza e
professione c'è una coappartenenza implicita che non può essere
riconosciuta apertamente da loro, sia perché metterebbe in
evidenza il circolo vizioso su cui in ultima analisi il loro rapporto
si struttura, sia perché compromettendo l'autonomia della scienza e l'efficacia della professione dissolverebbe il sistema. Questa
coappartenenza implicita, da loro impensata ma segretamente
operante, dipende da due fattori. In primo luogo la ragione in
tanto può sapere, in quanto sa fare: essa ha il suo fondamento in
un saper potere, che sebbene non abbia mai l'autorizzazione
all'esercizio, tuttavia costituisce la base ultima del suo giudicare.
In secondo luogo il fondamento in tanto può fare, in quanto fa
sapere: il resoconto che viene presentato alla ragione presuppone
un conto e una ragione che l'abbia già trovato giusto; sebbene
questa produzione di sapere resti senza legittimazione esplicita,
essa costituisce la razionalità del fondamento. Oppure detto
altrimenti: in primo luogo la scienza è sapere puro di una realtà
che è già scientifica e quindi il possesso della scienza garantisce
la possibilità di operare all'interno di tale realtà; in secondo
luogo, la professione è fare puro che può fare non solo perché
può mostrare in ogni momento di sapere ciò che sta facendo, ma
soprattutto perché produce effetti nella misura in cui ha prodotto
sapere. Tutto ciò mostra che scienza e professione formano una
struttura le cui singole parti sono inseparabili l'una dall'altra.
Esse costituiscono un sistema teorico-pratico nel senso più
profondo: cioè le stesse nozioni di teoria e di pratica sono nella
loro fondamentale ambiguità poste da un modo di filosofare che
presuppone occultamente l'organizzazione professionale della
cultura e da un modo di organizzazione della cultura che
viceversa presuppone occultamente la scienza. Tanto più
insostenibili e inefficaci appaiono le posizioni difese dalla nuova
epistemologia e dal movimento per l'educazione permanente: la
prima, sostenendo i diritti di una scienza più ampia della ragione
perviene ad esiti ultra-teorici, perché taglia quegli occulti
rapporti col fare professionale che conferivano alla ragione una
dimensione implicitamente pratica. La seconda inversamente,
sostenendo i diritti di una operatività più ampia della
48
professione, perviene ad esiti ultra-pratici, perché taglia quegli
occulti rapporti con la ragione che conferivano alla professione
una dimensione implicitamente teorica. Ma ultra-teoria e ultra-pratica, scienza senza ragione e lavoro senza fondamento,
sciolto ogni legame col principio di ragion sufficiente, diventano
frammenti che non si sostengono, bensì si confondono l'un
l'altro: il principio secondo cui qualsiasi cosa può andar bene è
suscettibile di una interpretazione ultra-teorica o di una
interpretazione ultrapratica, ma in ambedue i casi resta
prigioniero della concezione scientifico-professionale di un
progresso illimitato di cui l'umanità è la protagonista.
4. Il compimento dialettico-statale
Nell'avvento della dialettica hegeliana e dello stato come cosa
razionale in sé, la filosofia e l'organizzazione della cultura
trovano il loro compimento. Le tre forme di pensiero che si
ponevano in un rapporto di reciproca opposizione tra loro, il
pensiero dell'essere, cioè la metafisica, il pensiero dell'uomo,
cioè l'umanismo, e il pensiero del sapere, cioè la scienza, sono
intese come momenti necessari di un movimento che le ingloba e
che termina, trova il suo punto di arrivo, si compie nella sintesi
realizzata dal pensiero del pensiero, dal pensiero che pensa la sua
storia e storicità. Questa unificazione di forme di pensiero cosi
diverse avviene non perché la dialettica sia una forma di pensiero
cosi altra e differente rispetto ad esse da mostrare la loro
sostanziale affinità e continuità, ma proprio al contrario perché
essa penetra e ripete quanto esse hanno pensato cosi bene che
nello stesso tempo toglie la loro unilateralità e le conserva in
quanto suoi momenti, sue tappe, suoi gradini. La dialettica
compie le forme di pensiero che l'hanno preceduta proprio perché
pone termine a quella incompiutezza e interminabilità che le
metteva in contraddizione con se stesse e le rendeva simili e
49
affini proprio quando e dove esse ritenevano di essere diverse ed
estranee; la dialettica riesce a conferire a quella pretesa di totalità
che metafisica, umanismo e scienza hanno sempre visto frustrata
una assolutezza effettuale perché identifica il pensiero con la
storia del pensiero, la filosofia con la storia della filosofia.
Attraverso questa identificazione il filosofare è storico, non
perché racconta il passato, ma perché esso ha già, indipendentemente dai suoi effetti, uno statuto storico-effettuale soltanto in
virtù di se stesso. La storicità e l'effettualità sono inseparabili
dalla sua assolutezza: se esso non fosse fin dall'inizio sciolto,
affrancato, liberato dalla relatività empirica, nessuno e nulla
potrebbe dargli a posteriori la dimensione storico-effettuale che
gli mancava. La dialettica è il colmo della metafisica, il colmo
dell'umanismo, il colmo della scienza, perché pone come verità
assoluta già data, certezza assoluta già data, sapere assoluto già
dato, ciò che nella metafisica, nell'umanismo e nella scienza si
presentava come un compito interminabile e in fondo
impossibile, come un non-ancora realizzato, ma obbligatorio:
cioè l'identità tra ente e tutto, tra soggetto e universalità, tra
ricerca e teoria generale. In questo modo la dialettica emancipa
ed assolve la metafisica, l'umanismo e la scienza dai loro occulti
legami con la chiesa, col partito e con la professione: essa spezza
la coappartenenza tra queste tre forme di filosofia e le forme di
organizzazione della cultura corrispondenti, non perché
supponga, come il pensiero contemporaneo, che le prime
possano svilupparsi meglio da sole in una presunta purezza
incontaminata, ma proprio al contrario perché garantisce loro
apertamente e incondizionatamente, ciò che quelle tre
organizzazioni le davano di nascosto. La dialettica fa cadere
quelle autolimitazioni che il pensiero dell'essere, il pensiero
dell'uomo e il pensiero del sapere erano costrette a stabilire per
mantenere la loro socialità: il concetto, lo spirito, il sapere
dialettico possono affermare pienamente la loro assolutezza
perché sono già storia.
Lo stato moderno inteso come organizzazione culturale
costituisce una radicale rottura nei confronti delle altre forme
precedenti di esercizio del potere, il significato razionale delle
50
quali era solo accessorio ed aggiunto. Lo stato moderno è
piuttosto il compimento di quelle organizzazioni della cultura
che, come la chiesa, il partito e la professione, aggregano gli
individui sulla base di principi universali e conferiscono alla vita
dei singoli un valore socio-razionale privatamente vissuto con
intensità e pubblicamente riconosciuto da tutti. Lo stato moderno
compie la chiesa perché dà già in partenza ai suoi membri per il
semplice fatto di essere nati la condizione di cittadini; esso
conferisce loro a priori una esistenza razionale inalienabile
indipendentemente dal rapporto con una dottrina, un sistema di
credenze, una verità dogmatica. Esso attribuisce ai suoi membri
tutto ciò senza essere una teocrazia, anzi sciogliendo ogni
relazione nei confronti della metafisica, con la quale la chiesa
manteneva necessariamente un occulto legame. L'unità dello
stato moderno è garantita dal suo essere patria. Analogamente lo
stato moderno compie il partito perché la sua unità implica già in
partenza un legame, un impegno, un'alleanza cui i suoi membri
sono soggettivamente obbligati per la vita e per la morte,
indipendentemente dall'adesione ad un programma, ad un manifesto, ad una causa. Esso non è un principato, non ha più bisogno
dell'umanismo per legittimare implicitamente la lotta cui chiama.
La limitazione sociale che esso implica dipende dal suo essere
nazione. Infine lo stato moderno compie la professione perché il
suo fondamento razionale è già dato in partenza nella sua costituzione e nel suo ordinamento; la razionalità dello stato non
dipende nascostamente da una scienza in continuo progresso:
esso è di per se stesso sapiente in virtù delle sue leggi senza
essere per questa una tecnocrazia. La sua efficacia pratica deriva
dal suo essere l'istituzione organica per eccellenza. Sciolto
perciò dai limiti che metafisica, umanismo e scienza ponevano
alla chiesa, al partito e alla professione, lo stato deve la propria
universalità all'identificazione che in esso si compie tra organizzazione della cultura e organizzazione della storia. La sua
socialità è già razionale, perché tale è già la storia. Che la ragione
governi la storia costituiva il compito interminabile e in fondo
impossibile, il non ancora realizzato, ma obbligatorio della
chiesa, del partito e della professione: che la ragione governi la
51
storia è invece il presupposto già dato su cui si muove lo stato.
Lo stato è quindi organizzazione dell'organizzazione: esso sa ciò
che vuole e lo sa esplicitamente. L'infinita indifferenza e
sufficienza del vero uomo di stato, mostrata per esempio da
Napoleone Bonaparte, nei confronti della metafisica,
dell'ideologia e della ricerca scientifica, si fonda sulla
convinzione che queste non possano dargli nulla di più di quanto
egli stesso già abbia. La sovranità, la guerra e il lavoro dello stato
non hanno bisogno di legittimazioni: la sua effettualità è
razionale in quanto reale, in quanto riesce, vince, in quanto si
organizza nella sua compiutezza e si rende stabile nella sua
presen- zialità storica.
Dialettica e stato si pongono dunque entrambi come il
compimento delle forme di filosofia e di organizzazione della
cultura che li hanno preceduti. In ambedue i casi tale
compimento è conseguito grazie all'appropriazione della storia
nella sua totalità in forma più radicale e completa di quanto non
sia riuscito all'ordine metafisi- co-ecclesiastico, all'ordinamento
umanistico-partitico, al sistema scientifico-professionale. La
nozione che in ambedue i casi consente questa appropriazione è
la storia: identificandosi con essa tanto la filosofia quanto
l'organizzazione della cultura pervengono ad uscir fuori da se
stesse e mediante tale estraniazione a raggiungere una
effettualità, una realizzazione, un compimento che sarebbe stato
loro diversamente impossibile. I filosofi dialettici e gli uomini di
stato proprio per la radicalità e il carattere estremo
dell'estraniazione cui espongono la filosofia e l'organizzazione
della cultura, si affermano attraverso il proseguimento di un
immane processo di negazione e di negazione della negazione
come i padroni della storia; certo questa padronanza non ha nulla
di arbitrario e di capriccioso. Anzi in tal modo essi riescono a
socializzare la filosofia e a culturalizzare la società nel modo più
completo e totale.
Tuttavia la padronanza della storia non può essere tenuta a
mezzadria tra filosofi dialettici e uomini di stato. Per quanto non
sia impossibile pensare un filosofo dialettico che sia anche uomo
di stato, né un uomo di stato che sia anche filosofo dialettico, e
52
per quanto ciò sia anche storicamente avvenuto, resta che
dialettica e stato non sono né assolutamente differenti, né
assolutamente identici: le unisce certamente una comune
nozione di storia intesa come processo, come divenire, il cui
carattere essenziale è determinato dalla estraniazione e dal ricupero, dalla negazione e dalla negazione della negazione, ma
altrettanto certamente le separa la concorrenza su chi dei due
debba pronunciare il giudizio finale in nome dello spirito e della
storia universale. Il fatto è che tra dialettica e stato esiste lo stesso
rapporto di coappartenenza reciproca, implicita ma
profondamente operante, che collega ambiguamente metafisica e
chiesa, umanismo e partito, scienza e professione. Non solo
perché mai la filosofia avrebbe potuto porsi come la parusia
dell'assoluto ed intendere il suo lavoro come una lotta storica
effettuale condotta da questo, se una nuova specie di
organizzatori della cultura non avessero sulle ceneri dell’àncien
régime, preteso di fondare razionalmente la convivenza di
individui che abitano lo stesso territorio e parlano la stessa
lingua; né inversamente solo perché mai l'organizzazione della
cultura avrebbe potuto pretendere di imporre in una lotta per la
vita e per la morte un proprio disegno di società razionale, se un
nuovo tipo di filosofi non avessero imposto se stessi come i più
eminenti uomini politici del paese. L'enormità delle esigenze
della dialettica e l'enormità delle esigenze dello stato sono andate
storicamente di pari passo, perché la dialettica ha basato la sua
effettualità sociale sul carattere razionale della società statale e
viceversa lo stato ha basato la sua razionalità sul carattere reale
del movimento dialettico.
Eppure nonostante l'assolutezza della dialettica e l'universalità
dello stato, il loro rapporto resta ambiguo non meno di quello che
garantiva la socialità della metafisica, dell'umanismo e della
scienza, la razionalità della chiesa, del partito, della professione.
Tanto la socialità della dialettica quanto la razionalità dello stato
sono inseparabili da un divenire, da un movimento, da una storia
che nessuno può pretendere di fermare con un giudizio senza
appello o con una effettualità ultima. Perciò, sebbene
separatamente presi sia la dialettica che lo stato segnino la
53
compiutezza rispettiva della filosofia e dell'organizzazione della
cultura, il loro rapporto resta incompiuto: esso non chiude affatto
la storia, ma anzi la spinge avanti all'infinito verso distinzioni
che non sono mai differenze, verso ritorni che non sono mai ripetizioni. Sebbene la dialettica sia il già ora della filosofia e lo stato
il già ora dell'organizzazione della cultura, il loro rapporto è un
non ancora da loro impensato e per loro impensabile. D'altra
parte tale limitazione resta la condizione imprescindibile della
loro socialità e razionalità rispettiva.
I tentativi compiuti dal pensiero contemporaneo di spezzare la
coappartenenza di dialettica e stato, dando rispettivamente luogo
ad una dialettica senza stato e ad uno stato senza dialettica
compromettono proprio la socialità del filosofare e la razionalità
dell'organizzazione della cultura. La dialettica senza stato è la
dialettica negativa: la sua pretesa di continuare il lavoro di
negazione del concetto per cogliere l'eterogeneo più irriducibile
ad ogni identità finisce col rendere di nuovo incompiuto ed
infinito il filosofare stesso; la socialità di tale dialettica negativa
è rimandata sempre a più tardi, all'avvento di una improbabile e
impensabile utopia. Tuttavia la dialettica negativa non ricade per
questo in una posizione meramente metafisica, umanistica o
scientifica, estranea al processo storico, ma paradossalmente
ritiene di stabilire un rapporto più profondo con la storicità della
storia proprio solo attraverso l'esercizio di una negazione
illimitata. In realtà essa spezza il legame occulto che teneva la
dialettica ancorata allo stato e spinge il filosofo in un isolamento
vertiginoso senza precedenti. Lo stato senza dialettica è lo stato
funzional-sistemico. In esso la razionalità intrinseca dello stato è
intesa come funzione, o meglio come riduzione della
complessità dell'ambiente mediante l'esercizio di una negatività
che non è più implicitamente dialettica come nello stato moderno, ma selettiva. Mentre cioè nello stato moderno la
razionalità è già data, nello stato funzional-sistemico essa è il
risultato di una selezione che riduce la complessità dell'ambiente
e individua un più limitato campo di alternative: il senso di
quest'ultimo consiste tuttavia proprio nel garantire la
conservazione di quelle possibilità che all'interno di tale campo
54
non sono momentaneamente attualizzate. Lo stato
funzional-sistemico è perciò di nuovo incompiuto, ma in un
modo completamente diverso dalle organizzazioni della cultura
precedenti, dalla chiesa, dal partito, dalla professione, che
escludevano la possibilità di mantenere, semplicemente
stralciandolo e neutralizzandolo, quanto non veniva immediatamente scelto. La stato funzional-sistemico ribadisce il
primato della negazione e il suo rapporto costitutivo col senso,
ma rifiuta di riconoscere alla negazione quell'effettualità che
invece era essenziale alla razionalità dello stato moderno. Ora,
un senso fondato sulla negazione, ma senza effettualità e
dimensione storica, può essere ancora considerato razionale? Più
chiaramente, una organizzazione culturale, in cui il passaggio da
una prima fase ad una seconda fase opposta e contradditoria
rispetto alla prima, è privo di quella giustificazione e razionalità
intrinseca che l'appello alla storia garantisce, può essere ancora
considerata come tale? In realtà il funzionalismo sistemico,
spezzando il legame occulto dello stato con la dialettica, lo getta
in un opportunismo di cui è impossibile rivendicare il carattere
razionale, almeno fintanto che si privilegia la negazione come
fonte di senso.
Il carattere ambiguo della coappartenenza di dialettica e stato è
del resto deducibile dalla considerazione dei due significati
fondamentali cui rimanda il prefisso verbale greco diá, la
divisione e la completezza. Il pieno sviluppo delle premesse
implicite nell'assolutezza della dialettica e nell'universalità dello
stato dovrebbe condurre ad una identificazione tra i due termini,
ma questa identificazione non può essere mai presa esplicitamente in considerazione, perché tanto la dialettica quanto lo stato
sono alternativamente mossi da un movimento di trascendenza
reciproca che si arroga in entrambi i casi l'identità tra razionalità
e realtà, ma la accentua diversamente: sicché nel primo caso il
razionale è reale, mentre nel secondo caso il razionale è reale. La
stessa proposizione non è mai univoca, ma è divisa in se stessa,
riproducendosi all'infinito in una specularità, per cui ciò che è
posto da un lato passa dall'altro e viceversa. Il compimento
dialettico-statale è una premessa che esige di essere prodotta e
55
riprodotta infinitamente, senza che questa duplicazione possa
mai esplicitamente essere presa in considerazione: esso non pone
termine alla storia, ma la sposta ininterrottamente dal lato della
filosofia a quello dell'organizzazione della cultura, e viceversa
dal lato dell'organizzazione della cultura a quello della filosofia.
Esso supera cosi, nel senso che insieme toglie e conserva
riproducendole ad un livello più alto, le ambiguità che
caratterizzano l'ordine metafisi- co-ecclesiastico, l'ordinamento
umanistico-partitico, il sistema scientifico-professionale. Il
duplice augurio di Platone, che i filosofi pervengano al potere
politico o che i capi politici diventino filosofi, è realizzato
proprio nella sua duplicità, nel senso che i filosofi insieme sono e
non sono i padroni della storia e i capi politici insieme sono e non
sono i padroni della storia. Il compimento dialettico-statale ha
perciò instaurato tra filosofi e organizzatori della cultura il
dialogo, nel senso appunto di discorso alternativo, in cui
l'opposto si raccoglie e si unifica, mantenendo tuttavia la
distinzione. L'effettualità attraversa la filosofia cosi come la
razionalità attraversa la realtà effettuale; con questo attraversamento la dialettica diventa transpolitica: essa attraversa e
insieme va oltre lo stato, cosi come lo stato diventa translogico,
nel senso che attraversa e va oltre la filosofia. Questi movimenti
e sviluppi tuttavia non risolvono ma riproducono l'ambiguità: nel
compimento dialettico-statale, estraniazione e riflessione,
traversalità e superamento, sono soltanto insieme infinite
dislocazioni dello stesso e rispecchiamenti dell'opposto, sicché
l'oltre dell'organizzazione statale si rivela poi essere sempre la
filosofia e l'oltre della filosofia si rivela poi essere sempre lo
stato.
L'insopportabilità di tale compimento non deriva tuttavia
soltanto dal suo paradossale rimando all'infinito, né dal fatto che
la concorrenza tra filosofi dialettici e uomini di stato è senza
esito definitivo, ma proprio dalla sua vuotezza speculare. Il
filosofo dialettico non appena si specchia nell'uomo di stato vede
immediatamente quanto poco di reale e quanto poco di razionale
attraverso lo stato si organizzi e viceversa non sfugge certo
all'uomo di stato quanto poco di reale e quanto poco di razionale
56
si compie nella dialettica. Da tale insopportabilità sono mossi sia
la dialettica negativa sia lo stato funzional-sistemico. La prima
sposta il compimento in nessun luogo, nel pensiero utopico; il
secondo trasforma il compimento in riduzione della complessità
mediante l'agire sistemico. In entrambi i casi viene infranta la
specularità dinamico-processuale di dialettica e stato e si
suppone di poter meglio garantire razionalità ed effettualità
mediante soluzioni asimmetriche che lasciano cadere lo stato
oppure la dialettica. In realtà tanto la dialettica negativa,
nonostante tutti i suoi sforzi verso un eterogeneo più reale del
concetto, quanto lo stato funzional-sistemico, nonostante tutti i
suoi sforzi verso un ordine più razionale della struttura normativa, restano frammenti del compimento dialettico- statale. In
entrambi va perduto ciò che più importa: la socializzazione
compiuta della filosofia che ha trasformato in realtà sociale il
pensiero, la culturalizzazione compiuta della società che ha
trasformato la realtà sociale in ragione.
5. Il compimento nichilistico-popuiistico
Nel compimento dialettico-statale il cammino iniziato dalla
filosofia con la metafisica e dall'organizzazione della cultura con
la chiesa non è ancora compiuto: solo l'appropriazione della
storia della filosofia consente alla dialettica di essere reale, solo
l'appropriazione della pre- senzialità storica consente allo stato di
essere razionale. Nichilismo e populismo cercano invece,
ciascuno per proprio conto ma secondo un medesimo processo,
una appropriazione più profonda e radicale rispettivamente della
realtà e della razionalità. Né la filosofia né l'organizzazione della
cultura possono accontentarsi di far dipendere l'assolutezza del
proprio carattere sociale o del proprio carattere razionale da un
gioco di specchi che riproduce ad un altro livello i caratteri
fondamentali delle forme filosofiche e organizzative superate:
57
l'inter- minabilità del processo, la coappartenenza reciproca occulta, la trascendenza del pensiero sociale e dell'organizzazione
razionale rispetto al mondo empirico sommerso che resta
attraverso i millenni ostinatamente sordo e inaccessibile ad ogni
socialità razionale o razionalità sociale. Affinché dunque il
compimento stesso non resti incompiuto, occorre che filosofia ed
organizzazione della cultura compino una parusia dell'assoluto
ciascuna per proprio conto, ponendo termine al rimando all'infinito, spezzando la loro coappartenenza, instaurando al posto
della verticalità della trascendenza l'orizzontalità
dell'immanenza.
Nella filosofia questo compimento finalmente compiuto avviene
col nichilismo, nell'organizzazione della cultura avviene col
populismo. Ciascuna delle due cerca di emanciparsi
completamente dall'altra ricreando al proprio interno ciò che
l'altra le garantiva occultamente: la filosofia non sarà perciò solo
l'ambito per eccellenza dell'essenza, della rappresentazione, della
ragione, della razionalità, ma anche nella stessa misura quello
dell'esistenza, della rappresentanza, del fondamento e della realtà
e viceversa l'organizzazione della cultura non sarà solo l'ambito
per eccellenza dell'esistenza, della rappresentanza, del
fondamento e della realtà, ma anche quello dell'essenza, della
rappresentazione, della ragione e della razionalità. Nel
nichilismo la volontà di potenza assume l'eredità della prima
serie di nozioni, l'eterno ritorno dell'uguale l'eredità della
seconda serie di nozioni. Ciò che però in ambedue i casi è
determinante non è la quieta appropriazione di un'eredità storica,
anche se essa va ben oltre i limiti tradizionalmente fissati alla
filosofia e all'organizzazione della cultura e perciò si presenta
sotto l'aspetto totalitario più che sotto l'aspetto totale. Ciò che
importa è l'inversione compiuta dal nichilismo e dal populismo,
grazie alla quale essi pongono fine alla filosofia e
all'organizzazione della cultura.
Il nichilismo non è semplicemente la filosofia della volontà di
potenza, ma è l'affermazione della volontà di potenza come
origine di tutte le filosofie e di tutte le organizzazioni della
cultura. Solo attraverso questa affermazione è possibile il salto
58
che sopraeleva la filosofia al di sopra di se stessa e autorizza il
nichilista a sciogliere ogni rapporto non solo con la chiesa, con il
partito, con la professione e con lo stato, con qualsiasi altra
forma sociale presente o futura, ma perfino con la metafisica, con
l'umanismo, con la scienza e con la dialettica: il nichilista non ha
bisogno di qualcosa che garantisca occultamente la propria
socialità o la propria razionalità perché egli stesso è già un
prodotto di quel fattore per definizione illimitatamente potente e
illimitatamente razionale, da cui proviene ogni socialità e ogni
cultura, che è la volontà di potenza. Ciò tuttavia non vuol dire
che il nichilista sia una marionetta i cui fili sono tirati da una
forza trascendente: egli appartiene compiutamente alla volontà
di potenza solo nella misura in cui approva incondizionatamente
ciò che esiste e vuole con la massima energia possibile la
ripetizione infinitamente reiterata di ciò che c'è. Tutto può essere
approvato dal nichilismo tranne ciò che non c'è, ciò che è mero
dover- essere.
Analogamente il populismo non è semplicemente l'organizzazione della cultura che attribuisce al popolo
un'importanza e un ruolo fondamentali, ma è l'affermazione del
popolo come origine di tutte le organizzazioni della cultura
passate e di tutte le filosofie. Il popolo non può sottostare a
nessuna dottrina, ideologia, programma o legge rigorosamente e
sicuramente fissate, perché è già da sempre per definizione il
luogo di ogni cultura e di ogni socialità: esso perciò può tollerare
la metafisica, l'ideologia, la scienza e la dialettica solo se restano
incondizionatamente subordinate a lui e può autorizzare la
chiesa, il partito, la professione e lo stato solo come sue
articolazioni. La volontà del popolo ha una manifestazione
visibile nella volontà del capo, che ha con lui un rapporto diretto
ed immediato. Ciò non vuol dire tuttavia che il popolo sia una
entità trascendente, con cui solo il capo sarebbe in relazione: al
contrario il popolo in tanto è popolo in quanto è tutto e tutti, in
quanto è massa. Il populismo perciò toglie a coloro che non sono
popolo ogni diritto di esistere: non combatte ma sopprime i suoi
nemici condannandoli alla pura e semplice sparizione fisica.
59
L'ordine metafisico-ecclesiastico, l'ordinamento umanistico-partitito, il sistema scientifico-professionale e il
compimento dialettico-statale erano unità che si reggevano su un
rapporto di coappartenenza reciproca occulta tra due termini, tra
filosofia ed organizzazione della cultura. Il compimento
nichilistico-populistico non è più una unità articolata, ma è
costituito da due unità, completamente indipendenti l'una
dall'altra, incondizionatamente sovrane, autonome, totali. Al
nichilismo non corrisponde nessuna organizzazione della
cultura: tutti i tentativi di considerare il nietzschenismo come la
filosofia del nazismo, che è stato il primo populismo compiuto,
misconoscono la frattura tra filosofia ed organizzazione della
cultura, che il loro compimento compiuto implica.
Analogamente perciò al populismo non corrisponde nessuna
filosofia: tutti i tentativi di trovare un nazismo filosofico
prescindono dal fatto che col nazismo l'organizzazione della
cultura si auto-oltrepassa e non ha più bisogno di nessuna
filosofia. Da ciò tuttavia non deriva che nichilismo e populismo
siano forme immobili e prive di tensioni. La contraddittorietà dei
termini su cui si reggono mostra proprio il contrario. Per quanto
concerne il nichilismo, il carattere di oltrepassamento, di
intensificazione, di sopraeleva- zione implicito nella volontà di
potenza sembra opposto alla mancanza di fini, di scopi, di mete,
connessa con l'eterno ritorno dell'uguale. Per quanto concerne il
populismo, la nozione di popolo inteso come aggregato sociale
omogeneo, dotato di una identità e depositario esclusivo di
caratteri specifici e permanenti sembra opposta a quella di
massa, intesa come raggruppamento amorfo ed eterogeneo,
privo di identità ed incapace di organizzarsi e di manifestarsi in
modo univoco. Eppure volontà di potenza ed eterno ritorno,
popolo e massa si coappartengono occultamente. Una volontà di
potenza che trovasse un limite nella mera rassegnazione ad un
destino sfavorevole non sarebbe una potenza incondizionata; la
volontà di potenza deve diventare volontà di eterno ritorno se
vuole rimanere tale: volontà di eterno ritorno significa essere
sempre i più forti anche e soprattutto nelle situazioni più ostili,
più nefaste, più orrende. E viceversa l'eterno ritorno dell'uguale
60
non è una legge del tempo cui la volontà deve sottostare, bensì
eterno ritorno della volontà: non solo tutto il presente e il futuro
appartiene alla volontà, ma anche tutto il passato. Analogamente
popolo e massa si coappartengono occultamente. Il popolo non è
la nazione, né tantomeno lo stato: la nozione di popolo sorge
quando le identità storico-dialettiche sono dissolte ed implica
un'affermazione esagerata, aggressiva, oltranzista dell'identità
sociale che riesce a mantenersi solo a patto di appellarsi al dato
meramente empirico e fattuale fornitole dalla massa. E viceversa
la massa, per rimanere tale, per non disperdersi in infiniti atomi
privi di ogni giustificazione d'esistenza, deve porsi come massa
di popolo, e non già come massa di diseredati, di orbati, di
disperati.
Il compimento nichilistico-populistico in tanto è compimento
compiuto in quanto i due termini che si sono resi autonomi l'uno
dall'altro, la filosofia divenuta nichilismo e l'organizzazione
della cultura divenuta populismo, riproducono ciascuno al
proprio interno, quel rapporto di coappartenenza reciproca che
caratterizzava la loro relazione. L'ambiguità si colloca perciò
interamente all'interno di ciascuno dei due: volontà di potenza ed
eterno ritorno sono e non sono la stessa cosa; cosi popolo e
massa sono e non sono la stessa cosa. Se da un lato questa
intensificazione ed autopromozione che porta ad una completa
sovranità dei due ambiti segna il pieno spiegamento di premesse
che erano già implicite nella metafisica e nella chiesa, dall'altro
introduce all'interno di ciascun ambito quell'ambiguità che nelle
forme precedenti di filosofia e di organizzazione della cultura
proveniva solo dal loro occulto rapporto reciproco. Invano si
cercherebbe perciò nel nichilismo quel rigore teorico che ha
qualificato la metafisica, l'umanismo, la scienza e la. dialettica o
nel populismo quella coerenza pratica che ha qualificato la
chiesa, il partito, la professione e lo stato. Le nozioni del
nichilismo, a confronto del patrimonio storico elaborato dalla
filosofia occidentale restano più affini ad immagini poetiche che
a veri e propri concetti: esse non sono contraddittorie nel senso
dialettico del termine, bensì aperte, equivoche, sempre pronte ad
assumere aspetti diversi; solo cosi esse possono contenere tutto.
61
Analogamente gli enunciati del populismo, a confronto della
programmatica elaborata dall'organizzazione della cultura nel
suo sviluppo storico, restano vaghi, confusi, più affini a
manifestazioni istintuali che a vere e proprie dichiarazioni
d'intenzione impegnative: essi non hanno più la generalità della
legge, bensì la genericità del banale, del luogo comune,
dell'ovvio espresso con un oltranzismo ed una intimidazione
degli avversari pari alla sua imprecisione. Perciò il nichilismo
sembra più prossimo alla poesia che alla filosofia, il populismo
più alla contestazione che all'organizzazione della cultura: in
realtà essi segnano la fine della tradizione poetica e
rivoluzionaria moderna non meno che della filosofia e
dell'organizzazione della cultura, perché svelano quanto questa
tradizione fosse, suo malgrado, strettamente connessa a ciò che
combatteva. Nichilismo e populismo si emancipano dalla
necessità di fornire giustificazioni o legittimazioni perché
presuppongono di possedere già tutto. In questo consiste la loro
giustizia, nel dare come già assegnata, acquisita e perfino
posseduta da loro stessi anche la parte che manca alla filosofia e
all'organizzazione della cultura tradizionali. Il compimento
compiuto implica il possesso di un vantaggio, di una parte
attribuita anticipatamente prima di ogni divisione: il nichilista si
è già accaparrata la socialità, il populista la teoricità, perché essi
si presentano come l'origine di ogni società e di ogni teoria.
Ciononostante sembra inadeguato definire come impostura
questa concezione della giustizia, perché essi si pongono oltre la
distinzione tra vero e falso ed oppongono alla concezione
meramente speculare della giustizia una loro maniera di pensare
costruttiva. Se giustizia non c'è mai stata, se cioè nulla ha mai
davvero garantito il filosofo dall'isolamento, dalla frustrazione,
dall'emarginazione, se nulla ha mai davvero garantito l'organizzatore di cultura dall'impotenza, dalla connivenza con i
violenti, dalla istituzionalizzazione di uno stato di fatto, allora
prendersi anticipatamente ciò a cui si ha avuto diritto da sempre
può anche essere l'unico modo per sottrarsi al risentimento, alla
sopportazione recriminante, al lamento sui torti subiti,
62
realizzando ed esaurendo cosi compiutamente il processo storico
iniziatosi con la metafisica e con la chiesa.
Il compimento compiuto è paradossale: esso compie non una, ma
due parusie, completamente indipendenti ed autonome l'una
dall'altra perché incondizionatamente sovrane; queste si reggono
su coppie di nozioni che sono diverse, ma riportabili ad una
problematica identica. Infatti tanto la coppia nichilistica volontà
di poten- za-eterno ritorno, quanto quella populistica popolomassa possono essere ricondotte ad un'altra più generale,
comune ad entrambe, la coppia valore-fatto. Infatti volontà di
potenza e popolo sono riconducibili alla nozione di valore,
eterno ritorno e massa a quella di fatto. Valore e fatto non
appartengono alla tradizione della filosofia pre-nichilistica e
dell'organizzazione della cultura pre-populistica: esse sono
nozioni ambigue che si coappartengono occultamente. Il valore
non è il do- ver-essere dell'imperativo categorico: quest'ultimo è
troppo incompiuto per il nichilismo e il populismo. Il valore
vale: la sua validità pesa come un fatto sulla bilancia del
nichilismo e del populismo; la volontà di potenza nel suo
svilupparsi e manifestarsi è strettamente congiunta con
l'instaurazione, col mantenimento, col rovesciamento dei valori e
il popolo è tale proprio nella misura in cui custodisce, potenzia,
trasforma i valori. Il valore importa non perché trascendente,
bensì proprio al contrario perché produce fatti, rende salde le
decisioni, muove le moltitudini. Il valore insomma conta perché
è un fatto. Reciprocamente il fatto non ha nulla a che fare con
l'effettualità dialettica: quest'ultima è troppo intrisa di negatività
per il nichilismo e il populismo. Il fatto non è l'estraniazione nel
processo storico, bensì proprio al contrario l'identificarsi
immediato con ciò che c'è, con l'identico che infinitamente
ritorna, con la massa che sta, nella sua opacità, informe ed
elastica. Si obbedisce dunque al fatto come se esso fosse un
valore, anzi esso è l'unico valore, il valore per eccellenza, ciò che
vale indipendentemente da altro, ciò che non ha bisogno d'altro
per valere, ciò che è finito, compiuto, perfetto.
Appartiene al compimento compiuto la riconsiderazione delle
filosofie e delle organizzazioni della cultura passate nella chiave
63
nichilistico-populistica: metafisica, umanismo, scienza e
dialettica appaiono come portatori di valori che sono riusciti a
diventare fatti in modo troppo incompleto e parziale, e che perciò
devono essere transvalutati, cosi come chiesa, partito,
professione e stato appaiono come portatori di fatti che
acquistano il loro pieno valore solo nella dimensione nuova e
dispiegata del fatto compiuto. La coappartenenza reciproca di
valore-fatto e di fatto-valore spiega perché né il nichilismo né il
populismo sopportino una demitizzazione e una derealizzazione
che sopprima tanto i valori quanto i fatti.
La sussistenza di una problematica identica, determinata dalle
comuni nozioni di valore-fatto e di fatto-valore rende inevitabile,
nonostante la totale e radicale separazione tra nichilismo e
populismo, l'emergenza del problema del loro rapporto. Questo
ovviamente non può mai diventare per definizione una
coappartenenza, né può essere mai concorrenziale, né speculare,
perché entrambi si danno come totali ed unici già in partenza. Il
loro rapporto non potrà essere che di coestraneità e destituzione
reciproca. Nel loro compimento compiuto filosofia ed
organizzazione della cultura si rivelano dunque cosi lontane 1'
una dall'altra da non riuscire nemmeno a scontrarsi, ma solo a
disprezzarsi reciprocamente, ignorandosi o utilizzandosi
opportunisticamente. Il compimento nichilistico-populistico non
è però il raggiungimento di uno stato definitivamente immobile.
Il movimento che ha prodotto la rottura del rapporto millenario
che filosofia ed organizzazione della cultura intrattenevano
segretamente tra loro, è anch'esso ambiguo e presenta un duplice
volto: se per un verso è stato orientato alla costituzione di totalità
orizzontali sempre più comprensive come nichilismo e
populismo, per un altro inaugura un processo di frammentazione
inarrestabile che spezza e dissolve queste stesse totalità. Tale
frammentazione si esercita innanzitutto sulle forme passate di
filosofia e di organizzazione della cultura. L'organicità verticale
ed
implicita
dell'ordine
metafisico-ecclesiastico,
dell'ordinamento umanistico-partitico, del sistema
scientifico-professionale appare sempre più insostenibile ed
estranea all'esperienza contemporanea: il rapporto di
64
coappartenenza implicita tra filosofia ed organizzazione della
cultura sembra meramente dottrinario, ideologico,
programmatico, autoritario. Correnti filosofiche contemporanee
come l'ontologia, l'ermeneutica, la nuova epistemologia e
perfino la dialettica negativa sono impensabili senza una
pregiudiziale intuizione nichilistica che condanna senza appello
ogni organizzazione della cultura esterna ad essa; analogamente
tendenze contemporanee come la nuova ecclesiologia, l'autonomia del politico, il movimento per l'educazione permanente
e perfino quello per lo stato funzional-sistemi- co sono
impensabili senza una pregiudiziale intuizione populistica che
nutre un insuperabile scetticismo nei confronti di ogni filosofia
esterna a se stessa. Il processo di frammentazione investe le
stesse forme compiute del nichilismo e del populismo. I termini
su cui si reggevano si rendono autonomi l'uno dall'altro. La
volontà di potenza senza eterno ritorno genera un decisionismo
che suppone di poter prescindere da ogni vincolo preesistente;
dall'eterno ritorno senza volontà di potenza prende origine la
teorizzazione di un pensiero debole, per il quale tutto sembra
risolversi in una rammemorazione pensante e poetante.
Analogamente la separazione della nozione di popolo da quella
di massa porta ad un partecipazionismo che si attende il formarsi
di una aggregazione sociale dalla mera mozione patetica degli
affetti; e all'inverso l'isolamento della nozione di massa da quella
di popolo conduce al dissolvimento della società stessa. Una
certa ristrutturazione di tutta la problematica di derivazione
nichilistico-populistica sembra possibile sulla distinzione tra un
orientamento attivo, in cui s'inscriverebbe il decisionismo e il
partecipazionismo, e un orientamento passivo, in cui si
collocherebbero le teorie del pensiero debole e dell'implosione
sociale. Ma questa distinzione è estrinseca, perché presuppone
che tali orientamenti costituiscano un effettivo oltrepassamento
del compimento nichilistico-populisti- co: in realtà essi lo
frammentano soltanto senza giungere ad una ipotesi alternativa.
Ciò che importa è il processo di equivalenza, circolazione e
confusione di questi frammenti. Esso instaura una situazione che
non è semplicemente riducibile al compimento
65
nichilistico-populistico nella sua forma classica, pur essendone
una conseguenza. Ciò che caratterizza questa fase estrema è la
riduzione di tutta la sedicente filosofia a spettacolo e di tutta la
sedicente organizzazione della cultura a macchinazione. Tutto si
confonde con tutto e tutto si capovolge in tutto: si afferma l'epoca
della compiuta mancanza di senso. Ogni residua pretesa ad
affermare la socialità intrinseca del pensare e la teoricità
intrinseca del potere, sulle quali è nata e si è costruita la civiltà
ellenico-cristiana viene spacciata per una velleità irrilevante,
oppure perseguita in modo aberrante come notorietà effimera e
complicità mafiosa. Lo spettacolo trova un campo di
applicazione più ampio trasformandosi in ornamento, la
macchinazione diventa accessibile a tutti nella forma della
banda. Si tratta certo ancora di sviluppi che non escono dal
compimento compiuto: l'ornamento è infatti ancor più
nichilistico della volontà di potenza e dell'eterno ritorno, la banda
ancor più populistica del popolo e della massa. Tutto il passato
viene reinterpretato sulla base di questi termini: la metafisica,
l'umanismo, la scienza e perfino la dialettica sembrano essere
state nient'altro che ornamento; la chiesa, il partito, la professione
e perfino lo stato nien- t'altro che banda. Il punto di arrivo
dell'epoca della compiuta mancanza di senso sembra essere
l'annullamento della stessa distinzione tra spettacolo e macchinazione, tra ornamento e banda: le due parusie si confondono
sempre più l'una con l'altra: forse qualcosa permette ancora di
distinguere la banda filosofica dall'organizzazione che si dà come
ornamento, ma che cosa più separa il sedicente filosofo-manager
dal sedicente manager-filosofo? Tuttavia proprio da questo
postremo esito proviene la certezza che si sta aprendo un nuovo
mondo in cui cultura e società, sapere e potere saranno congiunti
in modo molto più intimo di quanto non lo siano mai stati.
66
Conclusione
Per quanto l'ordine metafisico-ecclesiastico, l'ordinamento
umanistico-partitico, il sistema scientifico-profes- sionale, il
compimento dialettico-statale mostrino oggi, anche e soprattutto
a chi è sempre stato estraneo ad essi, a chi ne ha sempre visto i
limiti, a chi li ha combattuti, la loro grandezza per lo sforzo
immane perseguito nei secoli di tenere congiunta, sia pure in
modo occulto, la filosofia con l'organizzazione della cultura, il
sapere col potere, la socialità del pensare con la teoricità dell'istituzione, qualsiasi ritorno ad essi è impossibile. È impossibile
non per qualche pretesa legge della storia, né per un malinteso
attaccamento ad un supposto corso progressivo degli eventi, né
infine perché manchino le condizioni della loro restaurazione,
ma più essenzialmente perché il compimento
nichilistico-populistico con i suoi prodotti ultimi, l'ornamento e
la banda, è il punto di arrivo, la piena estrinsecazione, il
compimento compiuto di premesse che erano presenti fin
dall'inizio in quelle forme di filosofia e di organizzazione della
cultura e che sono state sviluppate in loro con ostinata ed
indefessa fedeltà.
Dal momento in cui tale continuità è apparsa nella sua evidenza,
è cominciata la ricerca di dimensioni radicalmente alternative ed
autonome più originarie e più aurorali, non soltanto storicamente
precedenti alla metafisica e alla chiesa, ma soprattutto
essenzialmente indipendenti da queste. Questo passo indietro
verso ciò che è più proprio e più prossimo all'origine, da cui si
attende il dono del presente e del futuro, ha assunto almeno tre
direzioni: verso la Grecia pre-classica della filosofia
pre-socratica e del mito tragico, verso la cristianità delle prime
comunità apostoliche e del movimento riformatore, verso le
radici dell'esperienza europea, colta soprattutto nel linguaggio
67
dei suoi poeti più autentici. Queste tre fonti hanno in comune il
fatto di essere completamente estranee alla metafisica,
all'umanismo, alla scienza e ai loro compimenti, non meno che
alla chiesa, al partito, alla professione e ai loro compimenti, e di
condurre ad una concezione dell'essere, dell'uomo e del sapere
alternativa rispetto alla tradizione filosofico-organizzativa che
sembra essere stata la via maestra dell'Occidente. Per quanto
questo orientamento non possa essere confuso né assimilato,
proprio per il suo carattere di proposta globale e risolutiva, ai
frammenti in cui si sono ridotte le forme della filosofia e
dell'organizzazione della cultura nel loro compimento compiuto,
tuttavia esso appare sempre più inadeguato ad effettuare quella
appropriazione-accettazione-approfondimento della storia
dell'Occidente che pur si propone, per la rinunzia a porre in
maniera finalmente esplicita il problema della socialità del
pensiero e della teoricità dell'istituzione. Il fatto che tale
problema abbia trovato un'impostazione insoddisfacente nella
filosofia metafisico-umanistico- scientifica e nella
organizzazione ecclesiastico-partitico- professionale e nei
rispettivi compimenti, non significa punto che esso cada con
queste. La proposta di soluzioni proto-logiche e
proto-istituzionali evita di prendere davvero in considerazione lo
stato di disperato isolamento e di irrimediabile frustrazione in cui
si sentono sprofondati il filosofo e l'organizzatore di cultura
contemporaneo, che è proprio al contrario essenzialmente
post-logico e post-istituzionale.
Non dunque verso ciò che è, ed è sempre stato, più originario, più
proprio, più autentico, deve volgersi l'attenzione, bensì verso ciò
che è, ed è sempre stato, più derivato, più ripetuto, più ibrido.
Non è guardando alla purezza proto-storica che si può vincere la
battaglia contro l'imbarbarimento e l'incanaglimento universale,
ma proprio al contrario scoprendo che la feccia di Romolo può
essere altra e differente da quanto è sempre parso ai seguaci della
repubblica di Platone. Non certo per farsi portavoce di una
qualche trascendenza che salva e redime, secondo il modello
elaborato dalla filosofia e dall'organizzazione della cultura, ma
proprio al contrario per trovare nello spurio e nel replicato,
68
finalmente considerati in quanto tali e non come semplici derivazioni degenerate e conseguenze accessorie del genuino e
dell'originale, la possibilità di un pensiero effettivo, di una
effettività pensante.
La filosofia e l'organizzazione della cultura, essendo state
dominate dalla preoccupazione di affermare, di preservare e di
imporre la loro identità socio-razionale, si sono rivelate troppo
estrinseche, artificiose e rigide nei confronti di una realtà storica
sempre mutevole, sempre differente, sempre pronta ad assumere
aspetti nuovi e inaspettati da cui esse a torto o a ragione ritenevano di dover essere preservate: la stessa netta distinzione tra
filosofia ed organizzazione della cultura nasce da una libidine
d'identità che le rende entrambe estremamente deboli e
vulnerabili. Certamente il compimento nichilistico-populistico si
è reso conto di tale fragilità, ma esso ha soltanto portato, senza
scrupoli e remore di sorta, alle estreme conseguenze la pretesa
che già animava l'ordine metafisico-ecclesiastico di affermare
incondizionatamente una identità totale, o una totalità identica.
Manca al compimento nichilistico-populistico ogni intuizione
della differenza della realtà storica, ogni capacità di discrezione
nei confronti di essa. Il passo indietro verso l'origine ha certo
inaugurato un pensiero della differenza, un pensiero differente
dalla presunta strada maestra della tradizione occidentale. Ma il
fatto di averlo cercato in sentieri che spariscono per poi
riemergere di tanto in tanto, in sorgenti che corrono sotterranee
per zampillare fortunosamente qua e là, ne ha estremamente
ridotto la forza innovativa. Per quanto esso si presenti come un
pensiero semplice, e in quanto pensiero dell'origine non possa
non esserlo, il carattere privilegiato che esso ha assegnato al
pensatore e al poeta lo ha ammantato di una solennità aurata, che
pur non essendo trascendenza, tuttavia non gli consente di
fornire risposte differenti alle domande tradizionali riguardanti il
rapporto tra sapere e potere, ma solo di porre domande differenti.
Ora il pensiero della differenza non può essere proseguito che
attraverso un passo indietro verso la ripetizione, il quale si
attende il dono del presente e del futuro dalla considerazione di
fonti simmetricamente opposte a quelle frequentate dal passo
69
indietro verso l'origine. Non la Grecia pre-classica, ma la Roma
pre-classica, che sul rito senza mito ha costruito l'effettività della
cerimonia, dell'ars, dello ius; non la Riforma protestante, ma il
cattolicesimo post-rinascimentale, che sulla elezione della
differenza storica ha edificato l'operatività della consolazione,
del principio della maggior gloria e della sovrana indifferenza
barocca; non l'Europa più genuina e segreta, ma l'Europa più
ibrida e più replicata, quell'Europa fuori di se stessa che ormai
occupa la maggior parte del mondo e che attraverso gli innesti
più illegittimi e le combinazioni più spurie, è artefice di una
quotidianità finalmente priva di appoggi, di giustificazioni, di
sostegni nella trascendenza del mito, dell'ideologia o della
scienza, e che proprio perciò è sorprendentemente pronta a
pensare la cosa che è e a far cosa di ciò che pensa.
Questo pensiero-cosa o questa cosa-pensiero, in cui l'esperienza
romana, l'esperienza cattolica post-rinascimentale e l'esperienza
dell'Europa fuori di se stessa convergono non è e non è mai stata
una filosofia, né un'organizzazione della cultura. Al pensiero
rituale della Roma arcaica, che estende la propria influenza a
tutta la romanità storica, è estranea la pretesa metafisica di determinare l'essenza dell'ente in modo univoco ed immutabile, non
meno di quella ecclesiastica di costituire un'istituzione religiosa
unica ed infallibile: esso procede attraverso una concessione
incondizionata di rilevanza ontica a tutto ciò che mostra una
qualche presenza effettiva per quanto larvale e intermittente, ed è
pronto ad incorporare mediante successivi sincretismi ed
assimilazioni qualsiasi elemento estraneo, senza mai creare una
classe sacerdotale separata dal resto della popolazione. Invece
dell'idea umanistica dell'identità dell'uomo e della sfida
prometeica che questa implica, esso pratica un'approvazione
piena ma non priva di impercettibili riserve e di duplicazioni
indiscernibili dell'effettività storica: una devozione accorta a
tutto quanto è positivo che rende fatali le alleanze e le
conflittualità non mediante l'appello a moti interiori, ma grazie
all'esecuzione di cerimonie collettive scrupolosamente compiute.
Infine esso non annulla il caso singolo nella legge, ma armonizza
la situazione specifica con la forma rituale, inaugura un
70
atteggiamento diretto allo studio del singolo fenomeno e con
l'importanza assegnata al calendario afferma una concezione del
tempo parimenti estranea al tempo cronologico unidirezionale e
irreversibile e al tempo ciclico metastorico e reversibile. L'erede
storico e il continuatore del pensiero rituale romano è stato il
cattolicesimo post-rinascimentale. Il pensiero-cosa ignaziano
non è una verità dogmatica sempre uguale che si possa
apprendere su un trattato, bensì il risultato di una serie di esercizi,
il cui direttore funge soltanto da catalizzatore di una ricerca di cui
ignora completamente il punto di arrivo. E nonostante
l'obbedienza speciale al papa, anzi proprio in virtù di essa, mira a
non confondersi con l'impotere ecclesiastico secolare, temporale
ed economico dei suoi tempi. Esso è sostanzialmente estraneo
all'umanismo, perché fa del dissolvimento del soggetto la
condizione indispensabile per essere disponibili al meglio
storico, il quale è per definizione altro e differente: la compagnia
inoltre si distingue nettamente agli altri ordini proprio per l'indeterminatezza del suo compito, per la disponibilità a
disseminarsi sotto i più vari aspetti in tutti i luoghi, per la sua
plasticità operativa. Per il pensiero-cosa ignazia- no infine conta
più il discernimento che la legge: saper cogliere in tutte le cose,
azioni, conversazioni, la differenza della storia è più importante
che applicare una norma astratta. Il pensiero-cosa ignaziano
inaugura nel cristianesimo un tipo di operatività pensante che è al
di là della filosofia e dell'organizzazione culturale, che è
irriducibile alla impostazione metafisico-ecclesiastica, ai suoi
sviluppi e ai suoi compimenti. Il pensiero-cosa contemporaneo si
presenta almeno sotto tre aspetti: come rete, come traffico, come
quotidianità. La nozione di rete è alternativa rispetto a quelle
tradizionali di ordine, ordinamento, sistema che hanno
caratterizzato il rapporto tra filosofia ed organizzazione della
cultura: ciò che importa oggi non è tanto il richiamo a una norma
razionale prestabilita che legittimi le determinazioni gerarchiche,
la regolamentazione delle coappartenenze, la correzione delle
deviazioni, quanto l'instaurazione e la persistenza di schemi
còmunicazio- nali che consentano la comprensione operatoria,
che siano indipendenti da ciò che viene veicolato attraverso di
71
loro, che permettano l'integrazione sociale senza la convergenza
su scopi comuni. Ora è evidente che tale orientamento non può
essere seguito da un pensiero che attribuisce un ruolo privilegiato
al prefisso tedesco ge e alla sua accentuazione enfatica del
raccogliere e del riunire intorno a ciò che è più segreto, più
proprio, più autentico. È al contrario il prefisso tedesco ver, che
evoca l'idea del passaggio, dell'operatività relazionale, del
traffico, dell'azione eseguita completamente, il più adatto a
determinare un'esperienza in cui l'esteriorità non vuole dire
ornamento e decorazione, bensì effettività pensante. Nel traffico,
nella trasmissione da un continente all'altro delle cose-pensiero,
nell'imitazione e nella ripetizione dei modi di vita in luoghi, in
tempi, in contesti socio-culturali completamente differenti da
quelli che li hanno generati, nella continua e inarrestabile
moltiplicazione, riproduzione, disseminazione dei gesti, dei
comportamenti, dei linguaggi, il primo a cadere, ad essere
dimenticato, trascurato, ignorato è il prototipo, il mito, il
significato originario. In questo universale trasporto, traslazione,
metaforismo che coinvolge, mescola e confonde tutto e tutti,
generando infinite congiunzioni, mescolanze, sincretismi, in cui
tutto e tutti vengono strappati alle loro matrici, alle loro patrie,
alle loro terre d'origine, per poi ritornare differenti e
irriconoscibili, anche se talora paradossalmente più perfetti di
quanto non lo siano mai stati, il reiterato, il ripetuto, il replicato
trova finalmente la sua dignità e autonomia ed è finalmente visto
come tale, indipendentemente dalla legittimazione,
dall'autorizzazione, dalla verificazione che deriva dal confronto
col modello. Non solo in Europa, ma ovunque, l'archetipico,
l'autoctono, l'indigeno scompare in una moltiplicazione
vertiginosa di se stesso che lo rende trasmissibile, comunicabile,
fruibile alle altre culture, a tal punto che bisogna farsi stranieri a
se stessi e perdere tutto ciò che si ritiene ancora di possedere,
bisogna farsi nulla e nessuno, se si vuole ancora vedere, sentire,
gustare qualcosa. Questo trionfo planetario del reiterato e dello
spurio, in cui la ripetizione e la contaminazione diventano
condizioni di comunicazione, non è affatto l'uniformizzazio- ne,
l'avvilimento, l'omogeneizzazione del mondo su un solo registro,
72
bensì proprio al contrario la disseminazione della differenza,
l'acquisizione del diritto di ogni singolarità per quanto
stereotipata ed illegittima ad essere considerata autonomamente.
La filosofia e l'organizzazione della cultura nel loro sviluppo
millenario dall'ordine metafisico-ecclesiastico fino all'estremo
compimento nichilistico-populistico, hanno sempre fatto coincidere la socializzazione della cultura e la teoricità della società
con la generalizzazione e universalizzazione di una identità
socio-razionale, supponendo che il possesso del modello
implicasse altresì il possesso di tutte le sue ripetizioni, che la
padronanza della matrice comportasse anche la padronanza di
tutti i suoi prodotti; si tratta ora di seguire la strada opposta, non
certo inseguendo ad una ad una tutte le singole copie, ma
trovando in una copia qualsiasi l'esser-copia della copia, la sua
socio- razionalità intrinseca, la quale non ha bisogno di essere
introdotta, programmata o progettata dall'alto perché c'è già. C'è
dunque una compiutezza che non è però il compimento della
metafisica e della chiesa, ma una pienezza di tempi e di luoghi,
un venir meno dell'attesa, dell'utopia, della profezia, cosi come
del catastrofismo escatologico, una scomparsa della distinzione
tra centro e periferia, tra prossimo e remoto, tra organicità e
marginalità.
Se da un lato non è errato considerare la pienezza dei
pensieri-cosa e delle cose-pensiero come una appropriazione-accettazione-approfondimento, nonché quindi come un
oltrepassamento, della filosofia e dell'organizzazione della
cultura tradizionali, perché compie in modo molto più profondo
e radicale quella connessione tra pensiero e società che quelle
avevano per due millenni tanto ostinatamente perseguito,
dall'altro è però difficile sottrarsi al dubbio che l'affermazione
d'identità tanto aspramente ribadita dall'ordine metafisico-ecclesiastico, dall'ordinamento umanistico-partitico, dal sistema
scientifico-professionale, dal compimento dialettico-statale e dal
compimento nichilistico-populistico sia stata, paradossalmente,
cedimento alla barbarie e complicità con questa, vuoi per
l'estrema fragilità che la sua mancanza di flessibilità e di
adattamento alle situazioni storiche concrete ha sempre
73
comportato, vuoi per la profonda ostilità che ha sempre
manifestato contro il pensiero rituale e per la lotta che gli ha
mosso.
Questa lotta non può essere taciuta. Il misconoscimento
dell'autonomia della ritualità, dell'esercizio, del quotidiano ha
assunto tanti aspetti e manifestazioni: ma sempre è ritornata la
stessa accusa di mancanza di senso, stereotipia, inutilità,
esteriorità idolatrica, disperazione patologica. La filosofia e
l'organizzazione della cultura hanno formulato e ribadito una
condanna inappellabile contro l'emancipazione del ripetuto e del
derivato nei confronti dell'archetipico e dell'originale. La causa
di un simile accanimento contro qualcosa che è poi stato, a ben
vedere, il fenomeno più esteso e più comune, è proprio da
ricercarsi nell'ambiguità essenziale del rapporto di
coappartenenza reciproca occulta che lega, nella tradizione
metafisico-ecclesiastica e nei suoi sviluppi, la socialità del
pensare e la teoricità della società: la pienezza dei pensieri-cosa e
delle cose-pensiero è per questa tradizione un fenomeno
incomprensibile e insopportabile.
Eppure questa pienezza dei riti, dei gesti e delle cose è la più
facile da cogliere. Il suo charme rende pronti ad una felicità
indipendente dalla fortuna.
Indice
Pag. 7
Premessa
9 Introduzione
23 1. L'ordine metafisico-ecclesiastico
33 2. L'ordine umanistico-ecclesiastico
74
44 3. Il sistema scientifico-professionale
55 4. Il compimento dialettico-statale
65 5. Il compimento nichilistico-populistico
76 Conclusione
75