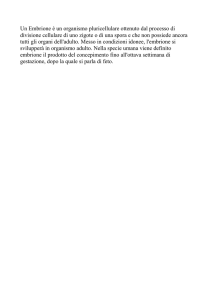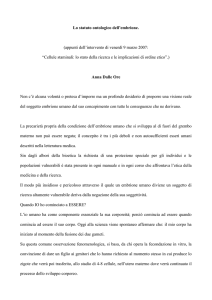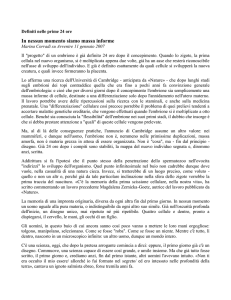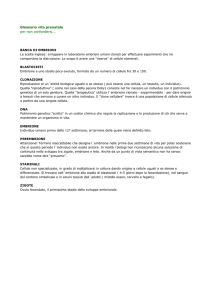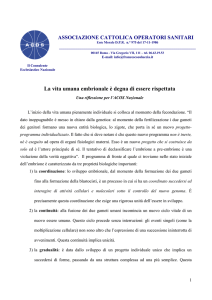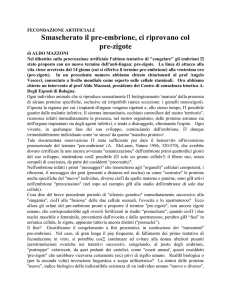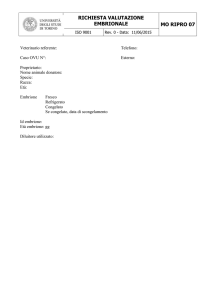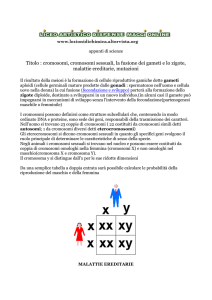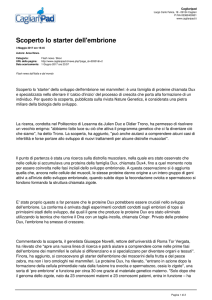LA DISCIPLINA DELLA PROCREAZIONE ASSISTITA:
ALCUNE QUESTIONI APERTE
di Carlo Flamigni
1. Una legge etica in un paese laico / 2. Esistono vie di fuga per
evitare le maggiori irrazionalità e crudeltà? / 3. L’«inizio della vita
personale»: a) le acquisizioni della biologia / 4. ...: b) la posizione
della Chiesa cattolica / 5. ...: c) cenni sulla legislazione tedesca e
svizzera / 6. La legge italiana e la questione della possibilità di
crioconservazione degli ootidi / 7. Altri profili di irrazionalità della
legge.
1. Una legge etica in un paese laico
Non ho mai dedicato tempo a ragionare su cose delle quali, pure,
riconosco la straordinaria importanza, un po’ perché chi spende gran
parte della sua vita facendo cose che gli piacciono finisce con l’essere
monotematico (questa è, naturalmente, autocritica), un po’ perché, per
carattere, tendo a non pensare alle cose che mi addolorano o mi
indignano. Così, non ho mai ragionato a lungo sulle norme che
regolano la nostra vita, su cosa le motiva e su come dovrebbero essere
fatte, e mi sono limitato a vivere come un cittadino un po’ spaventato
dalla Giustizia e a fingere di non vedere quanto spesso essa venga
manipolata fino a diventare uno strumento in difesa dei disonesti. In
ogni caso, un’idea su cosa dovrebbe fare il legislatore ce l’ho; è un
idea non originale, ma ce l’ho. Secondo questa idea il legislatore
dovrebbe rendersi conto di come la società si modifica, capire le
ragioni dei mutamenti, percepirne le conseguenze, intervenire infine,
con saggezza e buon senso, per costruire qualche argine, proteggere
chi potrebbe patire a causa di questi mutamenti, interpellando al
contempo le reazioni della morale di senso comune. Fare, dunque,
ordine.
Le modificazioni della società delle donne e degli uomini in
campo riproduttivo sono state molto importanti, soprattutto nei paesi
occidentali. Vita sessuale e riproduzione sono diventate cose diverse;
le coppie fanno meno figli, e i pochi che nascono hanno madri
1
generalmente non più tanto giovani; la ricerca scientifica ha
progredito in questo campo, consentendo un miglior controllo delle
nascite, diagnosi precoci delle malattie genetiche, cure efficaci per
molte forme di sterilità. Molte persone hanno affermato, con forza, il
proprio diritto a fare tutto il possibile per avere un figlio, di più, per
avere un figlio sano.
Poiché le offerte della scienza e le richieste dei cittadini venivano
presentate in un mercato privo di regole, ecco il bisogno di far
intervenire il legislatore, a regolare, prevenire, proteggere. E poiché
offerte della scienza e richieste dei cittadini si caratterizzano, in questo
specifico settore, per una pluralità di posizioni etiche, ecco dunque la
necessità di far intervenire un legislatore laico, rispettoso delle
posizioni, capace di mediare e di consentire convivenze altrimenti
faticose se non impossibili. Un legislatore, naturalmente, informato e
privo di pregiudizi, che capisca i diritti delle donne sole e dei bambini
non nati, che sappia mettere in fila le priorità e non si appiattisca su
una ideologia o una religione, per prevalente che sia, ricordando
sempre che questo è uno stato laico e che in questo stato tutte le
legittime espressioni del pensiero debbono essere considerate alla
stessa stregua e non possono essere né fermate né prevaricate, mai.
Mi pare che la legge sulla procreazione assistita non tenga conto
di nessuna delle cose che ho ricordato. Questo fa di lei il primo
esempio – a quanto ricordo – di una legge etica in un paese laico, un
esempio pericoloso e che, secondo me, deve essere cancellato.
Ho scritto recentemente su Bioetica un articolo nel quale definivo
questa legge «una legge cattolica» 1 . Sono stato molto criticato per
questa definizione, che riconosco essere apparentemente grossolana e
imprecisa, ma che ho scelto razionalmente perché, da vecchio ateo,
non riesco a fare differenza tra i cattolici e il loro magistero e non ho
voglia di perdere tempo in sottili distinguo. So, è vero, che esistono
cattolici laici, che in teoria meriterebbero di essere considerati a parte:
ma stanno sempre zitti, mi parlano solo nell’orecchio, e così li lascio
dove meritano di stare, nella grande famiglia cattolica.
Dunque, ribadisco quanto ho già scritto: questa è una legge
cattolica, perché è stata fortemente voluta dal mondo cattolico (dal
Pontefice, dai cardinali, dal Movimento per la vita) che hanno molto
insistito perché i parlamentari cattolici la votassero; contiene norme
C. Flamigni, Sulla “legge cattolica” per la fecondazione assistita in Italia, in
Bioetica, 2003, 11, 4, 733-751.
1
2
che fanno parte specifica dell’etica cattolica e la sua complessiva
visione del mondo è cattolica. Dire, a legge approvata, che si tratta di
una legge imperfetta mi sembra assai poco convincente e, soprattutto,
indegno della tradizione cattolica che i suoi principi li ha sempre
difesi con maggiore dignità.
C’è comunque, nella scelta di sostenere l’approvazione di questa
legge, qualcosa di poco comprensibile, che vale la pena discutere,
partendo da tempi piuttosto lontani.
Nel 1984 il Vaticano organizzò un convegno per discutere la
liceità morale di queste nuove tecniche, allora assai poco diffuse e del
cui possibile successo molti dubitavano. Erano stati invitati al
convegno, oltre a numerosi teologi, Howard e Georgeanna Jones,
Réné Frydmann e Carlos Chagas. Nel ricordo di Howard Jones (gli
atti di quel convegno non sono mai stati pubblicati) all’inizio della
discussione sembrava esistere una certa benevolenza nei confronti
delle tecniche, il cui fine ultimo (mettere un bambino nelle braccia di
sua madre) veniva giudicato fondamentalmente morale. L’opposizione
– scrive ancora Howard Jones - giunse da monsignor Caffarra che
ricordò a tutti come non fosse pensabile approvare tecniche che
offendevano uno dei principi ultimi della morale cattolica, quello che
riguarda la dignità della procreazione e che esige che vita sessuale e
vita riproduttiva non vengano mai disgiunte. La motivazione invocata
da Caffarra prevalse, e le tecniche di procreazione assistita furono
irrimediabilmente condannate.
Dove sia finita la dignità della procreazione, in una legge che
approva la fecondazione assistita e che è stata fortemente voluta dal
magistero cattolico, non è facile dirlo. Forse è stata congelata, al posto
degli embrioni, chissà.
2. Esistono vie di fuga per evitare le maggiori irrazionalità e
crudeltà?
È, dunque, prevalso il bisogno di proteggere la vita nascente
(l’embrione) e il «principio famiglia» (e se è così non è più assurdo
pensare che l’inserimento di quell’accenno al «concepito» come
portatore di diritti potrebbe rappresentare il grimaldello per aprire la
porta al processo/condanna della legge 194/1978 che consente
l’interruzione volontaria della gravidanza).
Il legislatore si è, conseguentemente, impegnato a costruire una
serie di norme che tenessero conto di alcuni fondamentali principi
3
della morale, e contemporaneamente ha dovuto cercare di tener conto
della buona pratica clinica, delle norme vigenti negli altri paesi, del
progresso scientifico in atto, dell’opportunità politica di mascherare la
propria dipendenza dal magistero cattolico, dell’esistenza di una
Costituzione da rispettare.
Ha certamente cercato di farlo, e la presenza di alcune passerelle,
vie di fuga per evitare di dover costringere i cittadini a ubbidire a
norme irrazionali o crudeli, lo dimostra. Alla fine, però, non c’è
riuscito, con i risultati che cercherò di illustrare.
La parola «concepito», inserita nell’articolo 1 della legge e
considerata da molti il machiavello per arrivare all’abolizione della
legge 194/1978, può essere considerata da due punti di vista.
Il primo riguarda i giuristi, che dovranno stabilire se questa
affermazione è sufficiente per considerare l’embrione come un
portatore di diritti e ai quali spetterà il compito di stabilire se esistano
contraddizioni con il nostro codice civile e quali problemi si
proporrebbero comunque nei confronti di altri portatori di diritti (la
madre, ad esempio). Questa parte del problema non mi può riguardare,
perché non ho competenza in merito.
Il secondo punto di vista ha invece a che fare con la biologia, cioè
con il mio mestiere, e qui debbo chiedere a chi legge un po’ di
pazienza e debbo fare una breve premessa. La legge n. 40/2004 vieta,
tra le altre cose, il congelamento degli embrioni e impone il cosiddetto
«caso semplice», la regola secondo la quale non possono essere
prodotti più embrioni di quelli che è lecito trasferire (nella fattispecie,
tre). È stato fatto osservare ai rappresentanti delle società scientifiche
da alcuni senatori favorevoli alla legge che non esistono norme in cui
si faccia menzione degli zigoti e degli ootidi: dunque, dovrebbe essere
consentito produrre zigoti o ootidi in sovrannumero e crioconservarli.
Questa interpretazione, peraltro, potrebbe essere ostacolata dal
fatto che, nell’articolo 1 della legge, è usata la parola «concepito» (per
assegnare a questo «soggetto» l’attributo di «portatore di diritti»); e
c’è poi la questione di stabilire con certezza che sia lo zigote che
l’ootide sono cosa diversa dall’embrione.
3. L’«inizio della vita personale»: a) le acquisizioni della biologia
Il problema dello statuto dell’embrione e dell’inizio della vita
personale è lungi dall’essere risolto, e persino all’interno della cultura
cattolica esistono differenti teorie (quali quella dell’ilomorfismo o
4
quella del cosiddetto pro-embrione). La legge n. 40/2004 sembra,
peraltro, aver scelto l’ipotesi tradizionale del magistero cattolico,
come confermato già dal primo comma del primo articolo («assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»). In realtà, se
si pensa a quanto complesso e dinamico sia il fenomeno del
concepimento (un processo che si verifica in un tempo relativamente
lungo), c’è bisogno di una definizione più precisa di quella, molto
generica e sconsigliata dai biologi, di «concepito». Scrive Adriano
Bompiani 2 (autore che mi sembra considerato al di sopra di ogni
sospetto anche dagli estensori della legge): «Circa l’inizio dello
sviluppo del nuovo essere (definito genericamente “concepito”)
l’opinione diffusa tra i biologi pone questo evento nella
“fertilizzazione dell’ovocita”, processo divisibile in vari stadi, ma che
si svolge in un lasso relativamente breve di tempo e che dà luogo
comunque ad un “evento”: il possesso, nella entità che si è formata, di
una informazione genetica unica e irripetibile. Volendo precisare il
momento culminante all’interno di questo processo, l’opinione
dominante identifica nello stadio detto di “anfimissi” (o singamia)
l’inizio della nuova “entità” o “essere” a questo stadio detto zigote».
Mi sembra dunque evidente che, per Adriano Bompiani, l’inizio della
vita si colloca nel momento finale della fecondazione (l’anfimissi), il
che, dal punto di vista di un cattolico, mi sembra ineccepibile:
anticipando una descrizione che troverà spazio più avanti, ricordo
infatti come il primo momento in cui esiste un genoma unico
contenuto in un nucleo si può indicare nella formazione di un
embrione a due cellule e che la stessa anfimissi (la ricostruzione di un
genoma diploide, cioè con quarantasei cromosomi) vede la presenza di
tutti i cromosomi assemblati ma non contenuti all’interno di un nucleo
e solo con molta buona volontà può essere considerata «formazione di
un unico genoma».
È bene precisare che anche sulla formazione dello zigote esiste
una certa confusione, tanto che persino in documenti ufficiali si
trovano definizioni e termini scorretti. Premetto quindi alcune
informazioni generali che traggo da un libro fondamentale di Frank
Longo3. Il risultato finale della migrazione dei due pronuclei, quello
A. Bompiani, Fecondazione assistita e statuto ontologico dell’embrione. I primi
sette giorni, in F.D. Busnelli, A.R. Genazzani, E. Ripepe (a cura di), Fecondazione
assistita.Una proposta di legge da discutere, CIC Edizioni Internazionali, Roma,
1997, pp.19-32.
3 F. Longo, Fertilization, second edition, Chapman e Hall Ed., Londra, 1997.
2
5
maschile (derivato dallo spermatozoo) e quello femminile (proprio
dell’ovocita) è la loro giustapposizione. I due pronuclei, ognuno con i
suoi ventitre cromosomi, si collocano in una posizione preordinata,
senza prendere contatto con l’altro. Sono in realtà necessarie molte ore
(quasi un giorno intero) perché i due genomi contenuti nei nuclei si
aggreghino per formare quel patrimonio genetico (quarantasei
cromosomi) che è caratteristico di tutte le cellule del nostro corpo,
gameti esclusi. Per arrivare a questa associazione finale, esistono due
vie: a) la prima, per la quale si fa riferimento alla fertilizzazione degli
ascaridi ma che riguarda anche l’uomo, consiste nella dissoluzione
della membrana esterna dei pronuclei e nella miscelazione dei
cromosomi materni e paterni; in questo tipo d’associazione i pronuclei
non si fondono, contrariamente a quanto sostengono le definizioni
contenute all’interno della legge svizzera, della legge tedesca e di
molti altri documenti; b) la seconda, per la quale ci si riferisce al
processo di fertilizzazione del riccio di mare, consiste in un vero e
proprio processo di fusione dei due pronuclei, cui consegue la
formazione di un singolo nucleo con quarantasei cromosomi: questo è
lo zigote, che più tardi andrà incontro alla mitosi (processo di
divisione cellulare da cui derivano due cellule che hanno lo stesso
numero di cromosomi della cellula da cui prendono origine).
Per coloro che non hanno mai studiato biologia, quanto ho scritto
può risultare poco comprensibile e provo a tradurlo in termini
ipersemplificati. La riproduzione dell’uomo si basa su due principi
fondamentali. È necessario anzitutto che l’uomo e la donna producano
cellule (i gameti) caratterizzate da un numero di cromosomi che deve
essere esattamente la metà di quello che caratterizza la nostra specie.
Ciò si verifica attraverso un meccanismo di divisione cellulare (la
meiosi) che ha finalità riduttive e che porta il numero di cromosomi da
quarantasei a ventitre. Per fare un esempio, lo spermatogone,
l’antenato dello spermatozoo, ha quarantasei cromosomi; il suo
pronipote, lo spermatozoo, ne ha ventitre. Il secondo meccanismo
consiste nella ricomposizione di una unica cellula, nella quale i due
patrimoni cromosomici debbono diventare uno solo, attraverso un
meccanismo che prende il nome di anfimissi. Questa nuova cellula, lo
zigote, può cominciare a dividersi per mitosi, formando prima due, poi
quattro cellule, e poi il feto, l’embrione, l’uomo. Sempre con gli stessi
meccanismi interni: la mitosi, per la formazione dei tessuti e degli
organi; la meiosi, per la formazione dei gameti, oociti e spermatozoi.
Esiste, a proposito del processo della fecondazione, una certa
confusione terminologica. È probabile che questa confusione sia
6
dovuta al fatto che la scelta dei termini risale ai tempi in cui si sapeva
poco o nulla dei meccanismi genetici che si accompagnano alla
fecondazione e di questi termini alcuni genetisti si sono riappropriati
quando le conoscenze sono state perfezionate. Così, singamia indica
la fusione dei gameti, ma la parola è stata anche utilizzata per fare
riferimento alla fusione dei pronuclei o alla anfimissi. Riporto, a
questo proposito, l’opinione di alcuni genetisti, pur consapevole che
possono esistere altre e differenti posizioni. Ad esempio, Kay Elder,
interpellata da Elisabetta Coccia, definisce «pre-zigote» o «ootide» il
periodo che va dall’ingresso dello spermatozoo nell’oocita a quello
che la stessa biologa definisce «singamia» cioè la presa di contatto tra
i cromosomi materni e paterni. In quello che è, con ogni probabilità, il
miglior testo di embriologia esistente4, il capitolo Fertilization afferma
che: il termine concepito è un termine generico per definire tutti i
prodotti del concepimento e sarebbe opportuno non utilizzarlo per
evitare confusione (si può comunque indicare come accettabile la
definizione del prof. Bompiani); in ogni caso questo termine – come
del resto afferma Bompiani – si riferisce alla fine del processo di
fecondazione; nel corso di questo processo si ha a che fare con altri
soggetti che confermano via via che la fecondazione procede; l’oocita
con due pronuclei (ootide, pre-zigote) è il più importante di questi
soggetti. Un elenco di questi soggetti, comunque, dovrebbe
comprendere: l’oocita, la cellula uovo con i suoi ventire cromosomi;
l’oocita attivato, cioè la cellula uovo che ha cominciato il processo di
fusione con lo spermatozoo: le membrane che avvolgono le due
cellule (oocita e spermatozoo) hanno cominciato a fondersi (solo
cominciato, il processo non è terminato) ma già l’oocita riceve segnali
di questo evento e si comporta di conseguenza (ad esempio
modificando la sua membrana più esterna in modo che altri
spermatozoi non possano più entrare): questo procedimento di fusione
si chiama «singamia»; l’oocita singamico, o «penetrato»: la fusione
tra le cellule è terminata e lo spermatozoo è ormai dentro la cellula
uovo; l’ootide, o oocita a due pronuclei, o prezigote: si sono ormai
formati i due pronuclei, quello maschile e quello femminile, che si
sono collocati vicini, in posizione programmata, ma che ancora si
ignorano; lo zigote: i due pronuclei si sono dissolti, i cromosomi si
sono mescolati tra loro ed è iniziata l’anfimissi, il processo di
ricostruzione del patrimonio genetico: da questo momento in poi è
R. O’Ratilly e F. Müller, Human Embriology and teratology, second edition, New
York, 1996
4
7
possibile definire questa entità come «il concepito», una definizione
che gli va un po’ larga (non si è ancora ricostituito un nucleo vero e
proprio con quarantasei cromosomi, lo vedremo solo nell’embrione a
due cellule), ma che può essere accettata; l’embrione a due cellule
(contenute nello stesso involucro dell’ovocita) prodotto al termine
della prima mitosi: finalmente ognuna di queste cellule ha un genoma
definitivo, quarantasei cromosomi che non cambieranno più (salvo
eccezioni che non cito per evitare confusione)
È chiaro che la definizione di «inizio della vita personale» può
non tener conto, o tener conto in modo molto personale, della
biologia. Si può persino dire che la vita personale ha inizio con
l’attivazione dell’oocita, quando addirittura la fusione con lo
spermatozoo non è completata, perché ormai «i giochi sono fatti», altri
spermatozoi non entreranno più, il genoma sarà quello o niente. Di
questo passo, si potrebbe arrivare a dire che l’inizio della vita
personale si può anticipare al momento in cui due persone che si
piacciono riescono a trovarsi sole nella stessa stanza da letto. Chi non
ha il senso del ridicolo può affermare, in realtà, qualsiasi cosa, e la
discussione sullo statuto ontologico dell’embrione lo prova. Resta il
fatto che, per la maggioranza dei biologi, è lo zigote a rappresentare il
“cambiamento” e che, come vedremo, anche la religione cattolica
sembra avallare questa posizione: ovviamente riconoscere il
significato biologico dell’anfimissi (e dunque della formazione dello
zigote) non significa affatto accettarne la sacralità, ma questo è un
problema diverso, del quale non parlerò.
4. ...: b) la posizione della Chiesa cattolica
Aggiungo, per completezza, alcune informazioni relative alla
posizione della Chiesa cattolica su questo argomento e sulla
legislazione della Germania e Svizzera, paesi che approvano il
congelamento degli zigoti.
Sul numero del 21 marzo 1987 di La Civiltà Cattolica, in un
documento intitolato Istruzione su il rispetto della vita umana
nascente e la dignità della procreazione. Risposte ad alcune questioni
di attualità - a cura della Congregazione per la dottrina della fede, ho
trovato a p. 565, una nota che dice: «I termini di zigote, pre-embrione,
embrione e feto possono indicare nel vocabolario della biologia stadi
successivi dello sviluppo di un essere umano. La presente Istruzione
usa liberamente di questi termini, attribuendo ad essi un’identica
8
rilevanza etica, per designare il frutto, visibile o non, della
generazione umana, dal primo momento della sua esistenza fino alla
nascita. La ragione di questo viene chiarita dal testo». Nello stesso
testo viene poi citata la carta dei diritti della famiglia pubblicata dalla
Santa Sede, nel punto in cui afferma: «La vita umana deve essere
rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento».
Viene poi richiamato l’insegnamento contenuto nella Dichiarazione
sull’aborto procurato: «Dal momento in cui l’ovulo è fecondato, si
inaugura una nuova vita che non è quella del padre o della madre, ma
di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto. Non sarà
mai reso umano se non lo è stato fin da allora. A questa evidenza di
sempre.... la scienza genetica moderna fornisce preziose conferme.
Essa ha mostrato come dal primo istante si trova fissato il programma
di ciò che sarà questo vivente: un uomo, quest’uomo-individuo con le
sue note caratteristiche già ben determinate. Fin dalla fecondazione è
iniziata l’avventura di una vita umana, di cui ciascuna delle grandi
capacità richiede tempo per impostarsi e per trovarsi pronta ad agire».
Questa dottrina rimane valida e viene peraltro confermata, se ve ne
fosse bisogno, dalle recenti acquisizioni della biologia umana la quale
riconosce che nello zigote derivante dalla fecondazione si è già
costituita l’identità biologica di un nuovo individuo umano.
Certamente nessun dato sperimentale può essere per sé sufficiente a
far riconoscere un’anima spirituale; tuttavia le conclusioni della
scienza sull’embrione umano forniscono un’indicazione preziosa per
discernere razionalmente una presenza personale fin da questo primo
comparire di una vita umana: come un individuo umano non sarebbe
una persona umana? Il Magistero non si è espressamente impegnato su
un’affermazione d’indole filosofica, ma ribadisce in maniera costante
la condanna morale di qualsiasi aborto procurato. Questo
insegnamento non è mutato ed è immutabile. Pertanto il frutto della
generazione umana dal primo momento della sua esistenza, e cioè a
partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato che è
moralmente dovuto all’essere umano nella sua totalità corporale e
spirituale. L’essere umano va rispettato e trattato come una persona fin
dal suo concepimento, e pertanto, da quello stesso momento gli si
devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto
inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita. Questo richiamo
dottrinale offre il criterio fondamentale per la soluzione di diversi
problemi posti dallo sviluppo delle scienze biomediche in questo
campo: poiché dev’essere trattato come persona, l’embrione dovrà
essere difeso nella sua integrità, curato e guarito, nella misura
9
possibile, come ogni altro essere umano nell’ambito dell’assistenza
medica.
Essenziale, per capire appieno il significato di queste
dichiarazioni, è la nota inserita al piede della pagina 568: «Lo zigote è
la cellula derivante dalla fusione dei nuclei dei due gameti». Dunque
traducendo questi insegnamenti del Magistero in termini comprensibili
per un biologo e chiarificatori per chiunque desideri discuterne e
capirne il significato, il rispetto per la vita nascente inizia da un
momento molto preciso, la formazione dello zigote; e lo zigote per gli
estensori del documento, è la cellula uovo fecondata dopo la “fusione”
dei due pronuclei5, cioè dopo l’anfimissi. Sembra dunque, per lo meno
a me, che l’ootide o oocita a 2PN o pre-zigote, faccia parte di un
momento precedente e che ad esso non vada riservata la stessa
rilevanza etica che spetta a zigoti, pre-embrioni e feti; lo stesso, mi
pare, dovrebbe potersi dire per gli ovociti fecondati.
Ho usato termini dubitativi non a caso, poiché nel documento
Istruzioni Donum Vitae 6 , che porta una data (22 febbraio 1987)
antecedente rispetto a quello appena richiamato ma che deve essere il
risultato di ulteriori discussioni essendo in realtà comparso più tardi,
la definizione è completamente diversa. La nota al piede della p. 33,
infatti, stabilisce che «Lo zigote è la cellula derivante dalla fusione di
due gameti»7. Chi avesse dubbi può andare alla nota scritta in latino
alla pagina precedente che parla della fusione «duorum gametum»8.
Non sta a me stabilire le ragioni del cambiamento della definizione,
ma il suo significato mi sembra molto evidente: l’inizio della vita
personale coincide con la fusione dello spermatozoo con l’oocita9. È
vero che anche qui un biologo vorrebbe chiarimenti e desidererebbe
forse fare qualche distinguo, ma si tratta, in tutta onestà, di
puntualizzazioni il cui significato pratico non è evidente, anche se
Come ho già spiegato, è più corretto parlare di “scomparsa” dei pronuclei.
Istruzioni Donum Vitae su il rispetto della vita umana nascente e la dignità della
procreazione, presentazione di S. Em. il Cardinale Joseph Razinger, Libreria Editrice
Vaticano, 1990.
7 Questa definizione è corretta anche secondo gli embriologi che ho potuto consultare.
Si tratta di definire la “fusione dei gameti” cioè se ci si riferisce al suo inizio o al suo
completamento.
8 Gli esperti mi hanno spiegato il significato delle due diverse versioni e mi hanno
assicurato che delle due fa testo la stesura in lingua latina.
9 Secondo una diversa interpretazione la “fusione dei gameti indica la fine del
processo e non l’ingresso dello spermatozoo nell’oocita: per una interpretazione
coerente con i principi successivamente applicati la definizione avrebbe dovuto
essere: zigote è la cellula derivante dall’inizio della fusione dei due gameti.
5
6
10
sarebbe importante capire se questa versione coincide con quella
offerta dal prof. Bompiani. Del resto non credo che la Chiesa
Cattolica, malgrado tutta la sua autorevolezza, possa concedersi il
lusso di cambiare i termini della biologia e il loro significato.
Recentemente ho chiesto, al prof. Maurizio Balistreri,
informazioni sulla posizione della Chiesa Evangelica Tedesca sulla
crioconservazione delle cellule uovo «impregnate» (questo è il
termine usato in Svizzera). Il prof. Balistreri mi ha inviato per
conoscenza un fax ricevuto dalla dottoressa Hire R. Knüppel che dice
che il Consiglio della Chiesa non si è ancora espresso in proposito.
5. ...: c) Cenni sulla legislazione tedesca e svizzera
La legge tedesca dà una definizione legale del termine embrione
(«ai sensi della presente legge con il termine embrione si intende
l’oocita umano fecondato e vitale fin da momento della cariogamia»).
Essa tutela l’embrione dal momento della cosiddetta
kernverschmelzung, o fusione dei pronuclei, consentendo di fatto la
crioconservazione degli «zigoti»10. Come ho già detto esistono molti
dubbi sulla correttezza di questa terminologia, soprattutto
considerando il fatto che, come ho già più volte ricordato, nella nostra
specie i pronuclei non si fondono.
Nella legge svizzera le definizioni vengono correttamente
riportate all’inizio del testo. Così, si parla di «ovule impregné» per
definire l’ovulo nel quale è penetrato uno spermatozoo, prima che si
fondano i pronuclei; l’embrione, a sua volta, è frutto della fusione dei
nuclei fino al termine dell’organogenesi. Anche nel caso della legge
svizzera, esiste un problema di definizioni: come ho già più volte
spiegato (ma non lo ripeterò mai abbastanza), in effetti nella nostra
specie (che segue il modello di fertilizzazione degli ascaridi) i due
pronuclei non si fondono (cosa che invece si verifica nelle specie che
seguono il modello di fertilizzazione del riccio di mare). In ogni caso
la legge svizzera consente che gli «ovuli impregnati» siano
crioconservati per cinque anni. È importante sottolineare che la stessa
proibirà questa conservazione se le conoscenze scientifiche
dimostreranno che è possibile conservare efficacemente ovuli non
impregnati.
10
Vedi Commentario alla legge, a cura di Keller, Günther, Kaiser, 1992.
11
6. La legge italiana e la questione della possibilità di
crioconservazione degli ootidi
Che in Italia venga consentita la crioconservazione di ootidi, è
molto difficile stabilirlo oggi.
Personalmente ho presentato un documento al Comitato
nazionale di bioetica, dove ho già trovato forte opposizione da parte
dei cattolici più dogmatici (anche da parte di Adriano Bompiani, che
non riconosce nella dichiarazione che ho citato da un suo articolo
l’espressione del suo personale convincimento). C’è stata
un’interpellanza presentata da tre senatori al ministro Sirchia perché
ponga un quesito specifico al Comitato nazionale di bioetica ma, al
momento in cui scrivo (fine maggio 2004) il Comitato non ha ricevuto
alcuna richiesta. La commissione che coadiuva il Ministro nella
preparazione delle linee guida ha però, sempre al momento in cui
scrivo, praticamente rifiutato di esaminare il problema.
È dunque possibile che la crioconservazione degli ootidi non
venga consentita; in questo caso diventerà necessario porre il
problema alla magistratura, che potrebbe vietare il congelamento o, in
alternativa, ammetterlo, sia per gli ootidi, sia (perché no?) per gli
zigoti. Potrebbe essere dunque persino saggio, per il Magistero
cattolico, che certamente verrà investito del problema anche se in
modo non ufficiale, accettare il congelamento degli ootidi (le basi
teoriche per farlo esistono) per non trovarsi di fronte alla possibilità
che vengano congelati anche zigoti (e qui la teoria non sembra più
d’accordo).
Cosa accadrà, se la crioconservazione di zigoti e/o ootidi verrà
accettata?
Riassumo le conseguenze: a) i risultati dei trattamenti saranno gli
stessi che si ottengono oggi congelando embrioni; b) si potranno
eseguire indagini genetiche sui due globuli polari in sequenza, in
modo da verificare tutta la patologia genetica di origine materna,
risolvendo anche i problemi relativi alle mutazioni genetiche
recessive; c) gli ootidi portatori di anomalie morfologiche (con tre o
più pronuclei) e di anomalie genetiche potranno essere eliminati.
Questa ultima possibilità mi sembra particolarmente importante
perché toglierebbe significato ad una delle norme più controverse,
quella che prevede che gli embrioni prodotti debbano essere
comunque trasferiti nel grembo della madre, anche qualora i biologi
avessero accertato l’esistenza di anomalie. Su questa norma,
12
certamente atipica, visto che non prevede sanzioni per la donna che
rifiutasse il trasferimento, ho sentito molte e differenti opinioni da
parte dei giuristi. Resta il fatto che si tratta di una norma non priva di
un certo tratto di crudeltà (si pensi che la legge assegna alle donne il
diritto di conoscere lo stato di salute dell’embione, non si capisce a
quale scopo, visto che non le consente poi di rifiutarne il
trasferimento) e che, per alcuni, dovrebbe contenere elementi di
anticostituzionalità.
Trovo molto difficile capire come una legge dello Stato possa
proibire a due cittadini, portatori di una grave malattia genetica, di
verificarne la presenza nei propri embrioni per evitare l’impianto in
utero di quelli malati, mentre non impedisce che la stessa coppia opti
per l’aborto, avendo fatto indagini specifiche in gravidanza.
Nello stesso modo, faccio molta fatica a comprendere come una
legge dello Stato possa consentire di aprire il cuore delle coppie sterili
alla speranza – riconoscendo che la sterilità è una malattia e che le
tecniche di procreazione assistita sono cure di quella malattia – per poi
preoccuparsi di distruggere le speranze appena nate inserendo una
serie di limitazioni e di impedimenti che rendono le tecniche assai
poco efficienti e creando ostacoli alla loro applicazione. Penso così
che, a meno che non venga accettato il principio del congelamento
degli ootidi, molte parti della legge dovrebbero essere considerate
incostituzionali, visto che la nostra costituzione ha parole assai nobili
nei confronti della salute dei cittadini e la legge dimostra la propria
volgarità proprio non tenendo in alcun cale quella stessa salute.
7. Altri profili di irrazionalità della legge
Faccio anche molta fatica a capire le ragioni che hanno convinto i
legislatori dell’opportunità di vietare la donazione di gameti,
riproducendo un’antica infamia, quella che consente il «turismo dei
diritti» solo a coloro che sono economicamente attrezzati a sostenerne
le spese. La mia sorpresa è ancora maggiore se penso alle mediazioni
proposte, che non sono state respinte, sono state completamente
ignorate, da una scelta parlamentare molto incivile, quella cioè di
blindare la legge. Io stesso avevo proposto di discutere la possibilità di
far fare alle coppie che desiderano una donazione di gameti un
percorso simile (certamente non identico, le condizioni sono del tutto
diverse) a quello cui sono tenute le coppie che hanno deciso di
adottare un bambino, in modo da consentire loro di dimostrare la
13
propria capacità di assumere una specifica responsabilità al riguardo;
così come avevo proposto di eliminare il segreto relativo al nome del
donatore e della donatrice, come molti paesi più evoluti di noi hanno
già fatto. È una norma, oltretutto, antistorica (i ragionamenti dei
parlamentari sulla «famiglia» erano un felice connubio tra De Amicis
e Dickens) e che non tiene conto del progresso della scienza che
potrebbe consentire, nel giro di qualche lustro, di ovviare a ogni forma
di sterilità mediante le nuove tecniche di «aploidizzazione» (cioè di
produzione di oociti a partire da cellule somatiche).
L’ultima cosa che mi sembra degna di menzione è l’ennesima
opposizione al progresso della scienza. Impedire ai ricercatori italiani
la possibilità di fare ricerca di base sulle cellule staminali prelevate da
embrioni umani, è per lo meno stolto, considerate le grandi speranze
che centinaia di milioni di persone ammalate ripongono nei risultati di
queste indagini. È noto che in Italia esiste un piccolo numero di
embrioni congelati che sono stati abbandonati dalle coppie che li
hanno prodotti e che non hanno altro destino che quello di attendere,
nell’azoto liquido, che la luce della loro vita biologica si spenga. Per
alcuni di noi, sarebbe stato più dignitoso, per quegli embrioni,
contribuire ad alleviare la sofferenza di molte persone sofferenti, ma
così non sarà. Quello che accadrà, invece, è che le ricerche
continueranno nella maggior parte degli stati europei e ai nostri
studiosi arriveranno, tra qualche tempo, colonie cellulari, costituite a
partire da cellule embrionali umane, sulle quali nessuno troverà più da
eccepire.
Ho preso in esame solo alcune delle anomalie e delle storture
delle quali questa legge è stata colmata, per evidenti ragioni di spazio.
Il mio parere conclusivo è che queste norme non possono essere
corrette ma debbono essere sostituite, e che questa sostituzione è
possibile perché esistono molte mediazioni accettabili, che non sono
state prese in esame.
Sono invece molto perplesso circa la richiesta di un referendum
abrogativo presentata da un partito politico. Penso che tutti ricordino
come gli ultimi referendum siano stati infruttuosi, non essendo stato
mai raggiunto il quorum, e sono particolarmente colpito dal fatto che
l’opinione pubblica sembra convinta della necessità di mantenere in
vita questa legge, perché «una cattiva legge è meglio che nessuna
legge» e perché, in caso di abrogazione, ritornerebbe il far west
procreativo e certamente gli scienziati folli comincerebbero a clonare
l’uomo. Senza poi parlare del fatto che, qualora il referendum fallisse,
nessuno riuscirebbe a trattenere il Movimento per la vita dal
14
presentare alla Corte costituzionale il quesito ultimo, quello che tutti si
aspettano: com’è possibile che coesistano una legge che riconosce al
concepito i diritti e la dignità della persona e una seconda legge che ne
consente la soppressione? In ogni caso, cercando di ignorare il mio
senso di impotenza, penso proprio che andrò a firmare per il
referendum, se non altro per protestare nei confronti della paralisi dei
sensi (compreso quello dell’onore) che sembra aver colpito le
segreterie dei partiti politici.
15