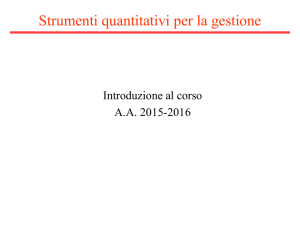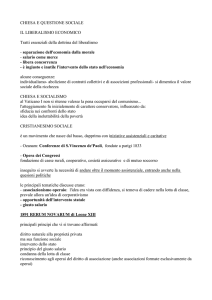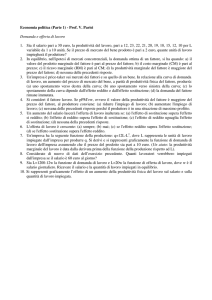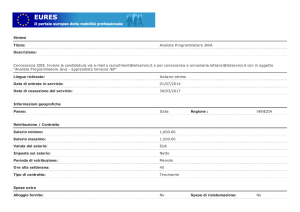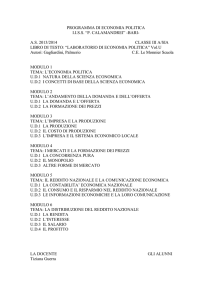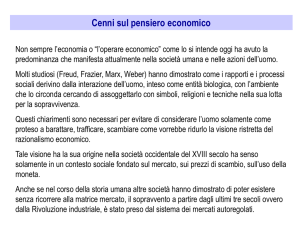gfp.83 – la Contraddizione, 25, Roma 1991
PREMIARE E PUNIRE
la riforma del lavoro e del salario
_______________________________
Apparirà chiaramente la massima: chi vuol vivere deve lavorare.
Obbligo del lavoro, ma anche retribuzione che permette
ai condannati di migliorare la loro sorte, e di preparare loro
qualche risorsa per il momento in cui la cattività dovrà cessare.
La pena trasforma, modifica,
stabilisce dei segni, predispone degli ostacoli.
Quale sarebbe la sua utilità se dovesse essere definitiva?
Una pena che non avesse termine sarebbe contraddittoria:
tutte le costrizioni che impone al condannato
e di cui, ridivenuto virtuoso, non potrebbe mai profittare,
non sarebbero più altro che supplizi; e lo sforzo fatto per riformarlo
sarebbero pena e costo perduti da parte della società.
La punizione non è che un elemento di un sistema duplice:
gratificazione-sanzione. Differenziare gli individui,
gli uni rispetto agli altri e in funzione di questa regola d’insieme.
Misurare in termini quantitativi e gerarchizzare in termini di valore
le capacità. Il potere che punisce si nasconde.
L’arte di punire deve dunque riposare
su tutta una tecnologia della rappresentazione.
[Michel Foucault, Sorvegliare e punire, La dolcezza delle pene]
Al tavolo triangolare della grande orgia neocorporativa si delinea con grande chiarezza una logica di
scambio tra flessibilità e salario. Il sindacato “ingiallito” propende esplicitamente per una gestione della
forza-lavoro che faccia leva sulla possibilità di “premiare e punire”. Esso arriva a ipotizzare, alla giapponese,
l’istituzione di “controllori”, scelti eventualmente dal sindacato, sia per esercitare pressioni e minacce sia per
erogare premi, con pubblicazione di nomi a risultato raggiunto. Gli stessi amministratori sarebbero caricati di
responsabilità diretta su guadagni e perdite.
“Il successo sta nel pieno controllo dell’impresa sul sindacato - il sindacato è gestito dai dipendenti di
fiducia dell’impresa”: rammentammo queste parole esemplari di Taiichi Ohno nelle considerazioni che
facemmo sull’imperialismo neocorporativo giapponese, pubblicate nel no. 18, maggio-giugno 1990, di la
Contraddizione. Ora queste parole, e il contesto sociale che le determina, ci soccorrono nel momento in cui
si apre l’ignobile farsa della trattativa sulla cosiddetta “riforma del salario”: quella trattativa che “assume una
vera e propria valenza istituzionale” - per riferire l’autentico concetto corporativo con uno tra gli innumeri
conati cossighiani di più recente “esternazione”.
Oggi si fa un gran parlare (come è anche giusto che sia) di costo del lavoro, oneri sociali, scala mobile,
cuneo fiscale, e via contabilizzando, fino alla sacra parola d’ordine della politica dei redditi. Ma non ci si
chiede a dovere da quale struttura economica siano determinate socialmente (non già computisticamente) le
cifre della busta paga e dei suoi annessi. Nello scambio tra flessibilità e salario, dunque, sulla prima si tace
facendo credere di poter parlare sensatamente solo del secondo. Al sindacato triangolare basta esternare,
senza costernazione, la propria unità d’intenti col presidente patriota della “civiltà del lavoro” nella lotta,
diremmo gladiatoria, contro l’inflazione.
Per converso, mancano allora quasi del tutto considerazioni dettagliate sulla nuova organizzazione
internazionale del lavoro caratterizzata da flessibilità, qualità, intensità [malamente integrate nell’ambigua
dizione di produttività, terminologia che non si finisce mai abbastanza di chiarire]. Pur se si parla di
profondo “intreccio” tra professionalità, responsabilità, qualità, salario, e se troppo spesso se ne mitizza il
processo di controllo (o il controllo di processo!) del lavoro nell’automazione informatica, sembra
riemergere sempre l’antico divieto di indagare sulla ristrutturazione e ridefinizione del processo lavorativo
sotto il rapporto di capitale: si potrebbe scoprire “nel segreto laboratorio della produzione, sulla cui soglia
sta scritto: Vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori, l’arcano della fattura del plusvalore”.
&%PAGINA
Con un padronato che abbia ripreso il pieno comando sul lavoro, le grame sorti del salario non possono
che essere irrimediabilmente segnate: il salario non è altro che la ricaduta - il fall out, si direbbe dell’organizzazione sociale del lavoro. Per non dimenticare mai la natura sociale del salario - irriducibile a
semplice prezzo-del-lavoro, “parimenti irrazionale come un logaritmo giallo” [se vogliamo ripetere l’ironia
di Marx], in quanto contraddice al concetto di valore della forza-lavoro - e la sua dipendenza dall’accumulazione e dall’organizzazione capitalistica del lavoro, conviene perciò richiamare alla mente i caratteri della
nuove forme internazionali del lavoro e del salario, a partire dall’esperienza giapponese. [Naturalmente, qui
non ripetiamo quanto già scritto su quell’esperienza, rimandando anche ad altri luoghi (il Manifesto, Marx
101) dove quelle medesime connessioni sono state riesposte].
Basterà ora riepilogarne il senso, con lo sguardo rivolto alla situazione italiana. Allo stesso tempo si invita
a riflettere sul fatto che in tutto il mondo del capitale imperialistico (Italia inclusa ovviamente, per chi lo
dimenticasse) c’è una rincorsa spasmodica al recupero dei “bei” vecchi tempi di incontrastato dominio di
classe; alla precarietà delle condizioni sociali di esistenza dei periodi di ripresa pionieristica
dell’accumulazione perduta; alla rivincita dell’economia privata sul contesto sociale (in senso proprio, al di
là di slogan semplicistici, quindi anche - o forse soprattutto - entro lo stato definitivamente curvato agli
interessi della classe borghese); insomma, al far girare all’indietro la ruota della storia.
L’eterno ritorno dell’uguale
San Pietroburgo invece di Leningrado. Berlino invece di Bonn. Serbia e Croazia. La borghesia vuole
tornare alle origini, sembra voler cancellare decenni di storia - in un esorcismo che pretenderebbe di togliere
senso al tempo - per farla sopravvivere più a lungo con quegli stessi decenni “recuperati”. Il capitale
ristabilisce il suo rapporto sociale in un clima di anteguerra invece che di dopoguerra - ma che è anche
effettivo dopoguerra, non tanto per la calda tempesta del golfo quanto per la vittoria fredda del 1989. Sul
piano del suo rapporto il capitale vuole ringiovanire, tornare ai cinquanta invece dei novanta: intesi come
decenni di questo secolo morente.
La perpetuazione (o la restaurazione) di condizioni e rapporti sociali tipici della ricostruzione postbellica
ha dimostrato essere l’elisir dell’eterna giovinezza per l’imperialismo giapponese, che ne ha fatto
abbondante uso da oltre trent’anni. Il ritorno indietro è oggi garantito dalla novità dell’elisir made in Japan,
poiché a disposizione del capitale mondiale c’è ormai anche quella macchina del tempo che è appunto
l’automazione flessibile.
La fluidità del lavoro, da rendere liquido, è sempre stata necessaria per i padroni, in qualsiasi forma del
modo di produzione capitalistico. D’altronde, l’ultima fase della prima grande rivoluzione industriale dell’automazione del moto, con la grande fabbrica giunta ai nostri giorni, si è strutturata intorno alla rigidità del
sistema di macchine della linea di montaggio taylorista. Questa, nel mondo intero, si è consumata negli
ultimi decenni - a causa proprio di quella contraddizione tra i limiti imposti dalla rigidità meccanica e
l’esigenza categorica della flessibilità lavorativa - allorché la classe operaia riuscì via via a bloccarne la
corrispondente forzosa flessibilità del lavoro.
Il compito operaio era, perciò stesso, relativamente facile sul piano tecnico, riversando tutte le difficoltà
sulla costruzione sociale di una rigidità di classe, antagonistica e di massa. In questo senso, va rammentato
come il capitalismo giapponese fosse antesignano della più tremenda sconfitta operaia contemporanea [nel
mezzo degli anni cinquanta]: a conferma che ogni ripresa dell’accumulazione capitalistica e della
trasformazione tecnologica ha a proprio fondamento il preventivo adeguamento del lavoro e del comando su
di esso.
Altrove, invece, nel resto del mondo imperialistico, una sorta di adattamento alla stagnazione della
crescita produttiva (il mitico sviluppo in stato stazionario degli economisti) si trascinò appesantendosi fino
al termine dell’ultimo ciclo di sviluppo postbellico [nella seconda metà degli anni sessanta]. Solo allora gli
esiti della lotta di classe evidenziarono le difficoltà di controllo capitalistico sulla crescente rigidità
operaia. Ai mandatari del potere borghese si prospettò la necessità di ricreare condizioni idonee al processo
di accumulazione.
Tali condizioni prevedono, in primo luogo, di ristabilire rapporti sociali che siano inequivocabilmente a
favore dei padroni: crisi, recessione e riproduzione dell’esercito industriale di riserva sono serviti allo scopo.
Ma, in secondo luogo, la rigenerata fluidità e flessibilità sociale della forza-lavoro ha potuto cominciare a
trasporsi stabilmente in flessibilità lavorativa solo per la mediazione della flessibilità del nuovo sistema di
macchine prodotto e messo in produzione con la seconda grande rivoluzione industriale dell’automazione
del controllo.
Sono apparsi superabili, così, i vincoli posti dalla rigidità della grande fabbrica in cui solo il moto era
assunto nell’automa centrale: taylorismo e fordismo, infatti, non avevano potuto aggiungervi nulla di
qualitativamente nuovo, se non le condizioni pratiche per il raggiungimento della soglia estrema consentita
&%PAGINA&
da quel particolare sistema di macchine [si vedano, a proposito della specificità delle macchine informatiche,
le considerazioni pubblicate su la Contraddizione, no. 24].
Su codeste basi - combinate tutte insieme e con tutti i necessari termini medi, sociali, organizzativi e
tecnici - la ripresa di comando sulla forza-lavoro da parte del capitale risulta totale. Solo su di esse dunque,
si vedrà, può realmente fondarsi - come loro ricaduta - la flessibilità del salario. Lo scopo ultimo
dell’accumulazione del capitale è proprio di mettere in grado il capitalista di rendere liquida, con il
medesimo esborso di capitale variabile, una maggiore quantità di lavoro. Attraverso l’uso gratuito dei
risultati della combinazione del lavoro e delle conoscenze, il capitale si mette nelle condizioni di sfruttare
maggiormente, in via intensiva ed estensiva, anche le forze-lavoro individuali, soppiantando
progressivamente forza-lavoro qualificata con forza-lavoro non qualificata.
Il problema antico e invariante del rapporto di produzione capitalistico è nella capacità di sottomissione
reale e massimamente efficiente del lavoro, e soprattutto della parte non pagata di esso. Gli obiettivi
strumentali sono sempre quelli delle “tre diverse circostanze” illustrate da Adam Smith per ottenere un
“grande aumento della quantità di lavoro”: richiedere maggiore abilità, destrezza e efficienza a ogni
lavoratore; mettere un solo uomo su diverse macchine per fare il lavoro di molti; risparmiare il tempo che si
perde tra le diverse operazioni lavorative. Dopo di lui, Marx spiegò le forme del plusvalore relativo appunto quelle dovute a maggiore abilità unilaterale del lavoratore e velocità dei ritmi di lavoro [intensità], e
alla riduzione dei tempi morti e della porosità della giornata lavorativa [condensazione] - che si affiancavano
a quelle del plusvalore assoluto - per il prolungamento di fatto (straordinari, cottimi,) del tempo di lavoro
[durata].
L’occultamento di entrambe le forme del plusvalore è facilitato dal rivoluzionamento delle forze
produttive, capace di comportare l’aumento della produzione reale a parità di lavoro [produttività, in senso
proprio]. Ma appunto tale “parità” nella pratica non si riscontra mai. Il risultato di maggior valore aggiunto e
profitto, prodotto dal processo di una maggiore quantità di lavoro liquidata con il medesimo esborso di
capitale variabile, è semplicemente ascritto all’aumento di “produttività” (che produttività non è). Il gioco è
fatto.
Chi vuol vivere deve lavorare, chi non lavora non mangerà: questo è il succo della questione del rapporto
di capitale e lavoro salariato celato al centro della “trattativa” in corso, e su cui andremo a riflettere. Chi
vuole guadagnare quanto basta per vivere deve partecipare al risultato dell’impresa. Morese della Cisl parla
apertamente di non meglio identificate, oscure e misteriose, “pratiche partecipative”. L’ineffabile Giugni
precisa, da par suo, che il “salario di partecipazione” è a due vie: ascendente sì [quando si lavora di più si
può anche guadagnare il necessario per vivere], ma anche discendente in caso di crisi [per restringere il
salario al minimo, largamente al di sotto della sopravvivenza]. Le “novità” sono chiuse nella vecchia pelle
borghese.
Flector, non frangor
L’esempio giapponese si impone, dunque, solo perché è la risposta contemporanea adeguata al tema
permanente della flessibilità del lavoro salariato, rivolta a spezzare l’antagonismo operaio. Lungi dal ritenere
che siano i robot a rivestire il ruolo di machina ex deo capace di miracolare il capitale in crisi di
plusvalore, occorre soppesare convenientemente la portata del rivoluzionamento rappresentato dall’assunzione del controllo nel corpo dell’automa centrale della fabbrica, decentrata operativamente ma
centralizzata gerarchicamente.
Non si comprenderebbe appieno la peculiarità del successo giapponese - non come modello, ma forma
prevalente su scala mondiale del sistema produttivo capitalistico contemporaneo - se ci si limitasse ai
presupposti teorici economici e ai fondamenti storici sociali. Se il ritorno a tali presupposti e fondamenti è
circostanza imprescindibile per la riaffermazione del dispotismo del capitale imperialistico multinazionale, la
loro incidenza odierna sul mercato mondiale si avvale di una condizione in più per fornire la risposta,
adeguata alla contemporaneità, alla questione permanente della flessibilità del lavoro salariato. Tale
condizione consiste nella tendenziale coincidenza della duplice flessibilità di lavoro e macchine, inedita nella
storia dell’industria, sicché la flessibilità del salario possa corrisponderle “naturalmente”.
Che il capitale cerchi costantemente di ottenere una maggiore quantità di pluslavoro non pagato è un fatto
incontestabile. Esso ha sempre perseguito siffatto obiettivo per due vie, cioè rendendo liquida una maggiore
quantità di lavoro e contenendo il livello di costo. Oggi la condizione in più, offerta dalla duplice flessibilità
di lavoro e macchine, facilita enormemente la ricerca di quella liquidità in quanto sintesi di quei due poli
della medesima unità dialettica, che sono appunto: l’aumento di lavoro e la diminuzione relativa di salario.
Al primo polo concorrono le varie tecniche di gestione e direzione del processo di lavoro (jit, kanban,
linea a U, scorte, subfornitori, shukkō, cicli continui), che aumentano intensità e condensazione del lavoro - e
non la produttività! - consentendo risparmi di tempo di lavoro dell’ordine del 40%. [Si ricordò altrove che in
&%PAGINA
tal modo quest’ultimo è spinto a coincidere col tempo di produzione]. Questa stessa organizzazione costringe
necessariamente i lavoratori ad accettare l’aumento della durata del lavoro (straordinari, turni, cottimi).
Dialetticamente, all’altro polo il salario sicuro scende al di sotto della metà della busta paga, in condizioni
normali di crescita economica. Tutto il resto del salario è condizionato alla partecipazione coatta ai risultati
della produzione, come ricaduta inesorabile di quella organizzazione. Oggi si dimentica sovente che anche
l’estrema individualizzazione del salario stesso rientra in questa forma di relazioni sociali (contro la cui
logica “premiale” la coscienza operaia può far leva solo sviluppando l’altro lato della contraddizione che
pone l’autocontrollo operaio).
La sintesi dell’intero processo dialettico può essere ben rappresentata dalla seguente circostanza: nelle
condizioni prevalenti del moderno processo complessivo di produzione, il posto di lavoro fisso tende a essere
garantito a una percentuale sempre minore (di cui soltanto una quota ulteriormente ridotta con effettive
prospettive di carriera) delle forze di lavoro. Codesta circostanza, unitamente all’elasticità dell’orario di
lavoro degli stessi occupati fissi, rende ulteriormente flessibile la maggior parte del lavoro totale, per
perfezionarne la forma liquida di pluslavoro, in termini di occupazione. Questa è la ragione sintetica per cui
la “disoccupazione” (nel lessico keynesiano) diviene categoria insignificante e inespressiva di una realtà in
cui solo fluidità, latenza e stagnazione della sovrapopolazione relativa (esercito industriale di riserva)
possono dare risposte adeguate.
“La sovrapopolazione relativa esiste in tutte le sfumature possibili” - avvertiva già Marx, senza essere mai
stato in Giappone. Proprio quelle sfumature fanno sì che l’occupazione regolare non segua il ciclo del
mercato, rimanendo sostanzialmente stabile, mentre le ore lavorate (dai non regolari, e anche dai regolari,
come straordinari) possono aggiustarsi alle esigenze della produzione. Un simile effetto di cuscinetto ha
facilità di ripercuotersi anche sulla cosiddetta “offerta” di lavoro non regolare, capace di sparire dal mercato
del lavoro quando non ci sia “domanda” di lavoratori (che proprio perciò tende a coincidere sempre meno, si
badi, come aveva intuito Marx, con quella di lavoro). Siccome anche i rapporti di lavoro dei subappalti sono
gestiti dall’impresa-madre, i subfornitori sono tenuti a ridurre l’attività dei propri lavoratori non regolari, che
funzionano così da cuscinetto finale. In ogni lavoratore, in misura percentualmente maggiore o minore, c’è
dunque una parte di disoccupato.
Il processo di produzione così riorganizzato si avvale completamente dei vantaggi di maggiore efficienza
arrecati dal lavoro di gruppo. Si tratta appunto di ciò che Marx indicava come appropriazione gratuita dei
risultati del lavoro combinato, collettivo, da parte del capitale. Nelle condizioni dell’esperienza giapponese si
è riusciti ad attuare questa determinazione economica al massimo grado. La superiorità dell’ohnismo sul
taylorismo è ascrivibile alla flessibilità del processo - dovuta innanzitutto alla flessibilità della forza-lavoro,
che ha reso possibile al capitale di avvalersi della flessibilità delle macchine.
Nella figura di multifunzionalità di lavoro e macchine si condensa gran parte delle caratteristiche dell’ohnismo. L’assenza di specializzazione dei lavoratori, con una cultura di base più duttile, è funzionale a questo
scopo. La tendenza nelle grandi imprese che adottano la moderna organizzazione scientifica del lavoro è che
la maggior parte della manodopera regolare sia multifunzionale. Ossia, questa è predisposta per un’alta
mobilità interna all’impresa, per una rotazione non solo nominale in quanto connessa alla capacità di
preparazione professionale molteplice [sia pure di livello elementare, tant’è vero che in Italia questo tipo di
lavoratori, detti “conduttori”!, è appena al quarto livello], e per interventi di sostegno al lavoro di colleghi
del gruppo in difficoltà [è del tutto abolito, a es., il sistema dei rimpiazzi].
La coesione del gruppo di lavoro, lungi dall’esser determinata dall’unità di classe, è sostenuta unicamente
dalla concorrenza tra i lavoratori stessi, costretti a ciò dai caratteri oggettivi della multifunzionalità e della
flessibilità della forza-lavoro (caratteri, si è detto, da cui soltanto può derivare la corrispondente flessibilità
del salario). Non a caso, allora, il rendimento medio del lavoro nell’ambito del cosiddetto controllo di
processo decentrato può essere superiore al normale di circa il 15% , il risparmio di tempo dovuto alla
combinazione ottimale di macchine diverse e lavoro multifunzionale può raggiungere punte del 40% , ecc.
Dunque tutto ciò - che va sotto il mistico nome di “produttività” (che produttività non è!) - implica solo una
maggiore quantità di lavoro estorta alla classe dei “conduttori” del processo di lavoro, costretta a flettersi per
non spezzarsi. Come esclamò un dirigente Kawasaki: “gli abbiamo messo proprio il fuoco al culo!”
Il cottimo corporativo
Tutte queste caratteristiche, perciò, non implicano affatto una reale delega delle decisioni strategiche da
parte della dirigenza aziendale. Ciò è anzi predisposto in vista di dare grande elasticità ed efficienza
all’esecuzione dei compiti di produzione. Gli studiosi del fenomeno avvertono, infatti, che tale sistema non
ha niente a che vedere con il concetto occidentale di “democrazia”: al contrario, la gerarchia e il rispetto dei
ruoli sono ancora più rigidi, come in un esercito o in un ordine religioso. Ecco perché non si può parlare di
consenso, se non in forma intrinsecamente coercitiva. Questa è la forma storica del neocorporativismo di cui
&%PAGINA&
il sindacalismo giallo è massimamente responsabile nella sua subalternità. E queste sono le ragioni per cui
Taiichi Ohno ha potuto coniare lo slogan, ricordato all’inizio, secondo cui “il successo sta nel pieno
controllo dell’impresa sul sindacato”.
Su queste basi si può tornare al confronto con la cosiddetta riforma del salario in Italia, in cui i sindacati
triangolari gialli di casa nostra vantano un principio guida che invoca, in barba alla rigidità operaia, l’abbattimento di ogni “rigidità per il sistema delle imprese” per dar loro “certezze nella determinazione della
crescita dei costi” [in ciò rientra anche il gran senso dell’ilarità sindacalese secondo cui, etimologia
permettendo, tutto può essere ricontrattato, anche gli “automatismi” (sic)]. Per dirla, alla rinfusa, con
esponenti confederali (Pesenti, Schettini, Morese, Inghilesi) “oggi siamo qui a parlare in maniera non
antagonistica, grazie all’impegno del sindacato, che non può caratterizzarsi né come opposizione né come
forza di governo, alla ricerca di un sistema di relazioni sindacali, con uno scambio equo e leale di certezze
nei reciproci comportamenti, oggi è possibile una convergenza tra l’interesse dei lavoratori e gli obiettivi
dell’impresa”.
Si può così capire meglio il significato mistificante di ciò che viene spacciato come economia
partecipativa (quella che gli esperti dell’economia corporativa amano chiamare share economy, in contrapposizione ideale all’economia capitalistica salariale, la wage economy). L’unico senso in cui i lavoratori
“partecipano” ai risultati dell’impresa è che essi sono sicuri solo di meno della metà della busta paga, e che
per ottenere il salario pieno devono sostenere lo sforzo produttivo massimo: altrimenti l’altra metà,
oscillante, si contrae. Qui sta l’imbroglio della “partecipazione agli utili” o peggio ai “profitti”. Molti studiosi - a es. nella stessa situazione giapponese in odore di privilegio consociativo - purtuttavia riconoscono
che l’interesse a non metter in difficoltà l’impresa è soltanto dovuto all’alta flessibilità salariale e
lavorativa cui sono sottomessi i lavoratori. Più che di partecipazione, si tratta di una economia del ricatto (si
può dire blackmail economy).
L’intera classe lavoratrice deve sottostare a una forma istituzionalizzata di ciò che si può allora definire
cottimo corporativo. La parvenza del coinvolgimento dei lavoratori si mostra nel conferire ai lavoratori
manuali - i conduttori - una serie di mansioni “intellettuali”, in cui appaia l’espressione della loro
“creatività” nel controllo del processo di lavoro e della qualità di prodotti e macchinari. Ma tale parvenza è
subito smentita. L’organizzazione e l’orario di lavoro sono già pianificati con una normale misurazione
tempi e metodi. Solo i tempi e i carichi di lavoro effettivi non sono predeterminati, ma affidati al gruppo. Si
noti bene che proprio su codeste basi si determinano poi le forti differenze di salario individuale. Cazzola
della Cgil evoca un sindacato che si dia un “disegno meritocratico” in cui non si “demonizzino i superminimi
individuali”, ma anzi si rendano “trasparenti e legittimi” per restituire la perduta “autorità salariale” al
sindacato.
Solo dopo un paio di secoli, dunque, la borghesia capitalistica - col sincero concorso sindacal-corporativo
- è riuscita a inverare praticamente, sul mercato mondiale, la propria felice profonda e falsa intuizione di
“pagare denaro in cambio di lavoro”. Il logaritmo giallo metafora del prezzo-del-lavoro, ancorché
irrazionale, è divenuto realtà operante. Il reale è irrazionale.
Il salario è già esso stesso una forma di relazione sociale che oblitera la divisione tra lavoro pagato e non
pagato, e che - giusta la critica di Marx - genera confusioni insolubili nell’economia politica. Non è certo un
caso che si favorisca così quell’inchinarsi all’apparenza in cui si adagiano tutti coloro che non ne vogliano
vedere il valore equivalente per la riproduzione sociale della forza-lavoro. Il nome di salario è occupato
abusivamente da coloro che vogliono occultare a ogni costo l’origine sociale del profitto nello sfruttamento
dovuto all’uso capitalistico, prolungato e intensificato oltre il valore di riproduzione, della forza-lavoro. [Tra
costoro albergano ormai stabilmente e felicemente anche i trisindacalisti]. Cosicché, parlando di salario essi
dànno l’impressione che si tratti realmente di una relazione tra uguali, essendo stata fatta cadere la
differenza specifica che sta oltre lo scambio, nell’uso del lavoro vivo altrui da parte del capitale. In simile
afflato ugualitario, appunto, i corporativi possono passare allegramente dall’economia wage a quella share,
tanto nulla cambia trattandosi solo di uso improprio di nomi doppiamente sbagliati. La determinazione teorica di salario è perciò ben altra da quella mistificata dagli economisti dominanti (tutti quanti, marginalisti,
keynesiani, neoricardiani, neo qualcos’altro e post-tutto) dove non appare mai esplicitamente in maniera
necessaria la dipendenza del lavoro salariato dal capitale.
Cionondimeno, questo stesso concetto rattrappito di salario è spazzato via dalla monetizzazione
quotidiana del tempo di lavoro, usato e spremuto dagli agenti pratici del capitale con intensità e condensazione crescenti. Al suo posto subentrano il salario orario (a tempo) e l’universalizzazione della forma di
cottimo. Anche qui, di nuovo, non importa quale sia il nome - partecipazione, qualità totale, professionalità,
produttività, e via post-modernamente mistificando - sotto cui la nuova forma corporativa del cottimo, eterna
“fonte fecondissima di detrazioni sul salario e di truffe capitalistiche”, venga occultato. Il cottimo offre al
capitalista una misura ben definita dell’intensità del lavoro e gli consente di prenderlo come forma di salario
che più corrisponde al modo di produzione specificamente capitalistico. In questa forma pare che il
&%PAGINA
capitalista compri “lavoro già oggettivato” e paghi direttamente la “capacità di rendimento” del lavoratore:
Marx si esprimeva così, i triangolari parlano di “salario di produttività”.
Tale forma di pagamento non muta nulla alla determinazione di salario, ma appunto è sicuramente la più
favorevole per lo sviluppo della produzione capitalistica. A essa, infatti, il capitalista associa la superfluità
della sorveglianza del lavoro, poiché qui la qualità e l’intensità del lavoro sono controllate dalla forma del
salario stesso. Non solo, ma così può proliferare quel sistema di sfruttamento e di oppressione
gerarchicamente articolato che consiste nel richiedere e ottenere la produzione del numero di pezzi
strettamente necessario, nel facilitare l’inserimento di attività di sub-fornitura e sub-appalto, e nel ricreare la
base del moderno lavoro a domicilio. Tutto ciò è messo in chiaro con le parole di Marx.
Il concertone della trinità
Il concerto della trinità corporativa, per un “patto per lo sviluppo, la competitività e l’occupazione”, ha
come punto di arrivo dichiarato il costo del lavoro, ma il passaggio obbligato è la nuova organizzazione del
lavoro, nel senso illustrato a proposito del caso giapponese. Del Turco ha dichiarato che “il contratto
collettivo nazionale di lavoro non funziona più”. Questo è il “via libera” per ricontrattare tutto contro gli
interessi proletari, azzerando le conquiste consolidate dai precedenti accordi: dopo la vittoria della borghesia
ciò è possibile.
Il quadro generale è quello in cui si riconosce che la produttività negli ultimi venti anni è andata ai
profitti. Ma il capitale italiano è riuscito in ciò, secondo solo al Giappone, con una politica “calda” in termini
di cambi, inflazione e tassi di interesse. In Giappone al contrario l’obiettivo è stato ottenuto direttamente in
termini produttivi reali: è questa ora la direzione della svolta, ritenuta necessaria dai padroni dopo l’entrata
dell’Italia nella “banda stretta” europea (cambi fissi). La chiusura dei margini monetari e valutari - “per
un’entrata in Europa dignitosa”, si preoccupano i confederali - determina la riduzione degli spazi di iniziativa
sindacale, comportando un’attacco ai lavoratori che gli stessi confederali sono ben disposti a gestire.
Alla luce dell’analisi generale svolta, il senso specifico della questione della “trattativa di giugno” si può
risolvere conclusivamente in poche battute [magari riservandosi di tornare in seguito sugli aspetti particolari,
col proseguire pratico dell’immondo concertone]. L’accordo vuole ridurre e razionalizzare i livelli di
contrattazione, evitando quelle sovrapposizioni che - a detta della Cgil! - costituiscono “oggi un vincolo
molto rigido per le parti padronali”. La finalità ultima è creare le condizioni organizzative della produzione
per ridurre al minimo la paga sicura, tornando alle origini della fase postbellica.
Infatti, se ancor oggi la paga base contrattuale nazionale copre meno di un terzo del salario, l’”anomalia”
italiana sta nel consolidamento di fatto delle voci, finora altrettanto sicure, relative a contingenza, anzianità e
superminimi collettivi e individuali di categoria, che portano la certezza retributiva per i lavoratori intorno al
90% della busta paga normale. Ecco: la consociazione triangolare ha convenuto di aggredire e togliere
certezza proprio a quel 60% scomodo.
Ciò diviene possibile - con una classe lavoratrice in balìa del sindacato giallo - appunto come ricaduta
salariale dell’organizzazione del lavoro analizzata. Se l’obiettivo “giapponese” di un terzo di salario
garantito è per ora difficile da porre, il padronato italiano si contenta dell’offerta che lo pone intorno alla
metà. L’accordo nazionale pilotato dai chimici fa da battistrada, dove precisamente in quella metà minima
sicura (circa ₤. 900.000) vengono via via riassorbite tutte le voci fin qui consolidate, a cominciare dalla
fatidica scala mobile, non appena il salario effettivo individuale superi quella soglia: con la conseguenza di
vanificare scala mobile (senza ufficialmente disdirla), anzianità, superminimi di categoria, ecc., su cui poi
riversare gran parte della forza contrattuale del proletariato semplicemente per la loro tenuta.
Una siffatta contrattazione nazionale, cogestita triangolarmente dall’apparato centrale della Grande
Corporazione del Lavoro, “definisce regole, procedure, competenze, diritti, poteri e gestione del mercato del
lavoro”, come afferma apertamente Veronese della Uil, ai cui detti ha sentito di dover aggiungere, non
richiesto, Caviglioli della Cisl che non si tratta però di “un governo superiore, una sopraffazione da parte
delle confederazioni”! Su queste basi la contrattazione decentrata (anche per il pubblico impiego, con criteri
omogenei per tutti) è mirata a un “governo tempestivo e flessibile” su innovazione, organizzazione,
flessibilità, condizioni di lavoro.
Si definisce proprio in questo decentramento il ricordato “salario di produttività” - cioè quella parte aleatoria del salario reale da conquistare giorno per giorno oltre i minimi nazionali, generali e di categoria.
Questa è appunto quella parte della remunerazione che andrebbe a sostituire le precedenti voci eccedenti i
minimi tabellari, finora consolidate in busta paga a seguito delle conquiste operaie. Essa perde così proprio la
sua rigidità e viene ricondotta entro i limiti della professionalità, produttività e redditività d’impresa. Questi
elementi sono ritenuti, dai vertici del triangolo, “parametri oggettivi e verificabili”! Pertanto sono da
privilegiare al punto tale da prenderli come riferimento retributivo il più possibile esente da oneri sociali.
Questi verrebbero limitati alla componente salariale minima nazionale.
&%PAGINA&
Alla luce della gran scoperta che “lo stato sociale [perché, quello privato e non sociale com’è? ndr] è
clientelare e particolaristico” - secondo lo slogan coniato da Massimo Paci, consulente di Occhetto - la nuova
corporazione lancia il progetto di riduzione e semplificazione degli oneri sociali. Il primo punto di attacco
riguarda i cosiddetti oneri impropri (“impropri” perché non riguardano il processo immediato di produzione
ma problemi sociali dei lavoratori: asili per i loro figli, assistenza ai loro orfani, tbc e malattie dei lavoratori
in pensione, altri progetti speciali). Questi oneri sono ormai visti dalla trinità come “tassa sul lavoro”. Si va
quindi verso la fiscalizzazione strutturale degli oneri impropri (18 mmrd), da estendere a una quota rilevante
del servizio sanitario nazionale (30 mmrd). Questo scippo di 50 mmrd, inclusa perciò la maggior parte del
Ssn, graverà sulla fiscalità generale (sui consumi - cioè sull’iva, in ultima analisi a carico dei lavoratori,
contribuenti fissi).
Qui c’è l’ultima impennata d’orgoglio e di vanto confederale. Secondo le nobili parole di Marisol
Brandolini, responsabile Cgil del settore fiscale, “l’attenuazione del grado di progressività del sistema è
anche frutto delle battaglie condotte dal sindacato per la riforma fiscale”: e brava Marisol! Negli anni ottanta
la tassazione progressiva (irpef su quote medio-alte) è cresciuta del 9% mentre quella proporzionale (iva su
consumi di massa) del 31% .
Il concertone della trinità corporativa vuole garantire maggiore stabilità al quadro macroeconomico. Il che
si traduce in “rallentamento della dinamica dei redditi nominali e anche dei redditi reali netti (maggiore
rigidità del salario monetario rispetto ai prezzi)”. La lotta padronale contro le troppe voci indicizzate trova
una così adeguata risposta che si prospetta anche una riforma [?!] dei cosiddetti ammortizzatori sociali
(pensionamento, indennità di disoccupazione, cig).
Questa è “la democrazia economica”: per concludere con l’adamantino Giugni, “che cos’è non si capisce,
il contenuto non è chiaro, ma nei programmi c’è, anche se non si è mai realizzato niente”.
&%PAGINA