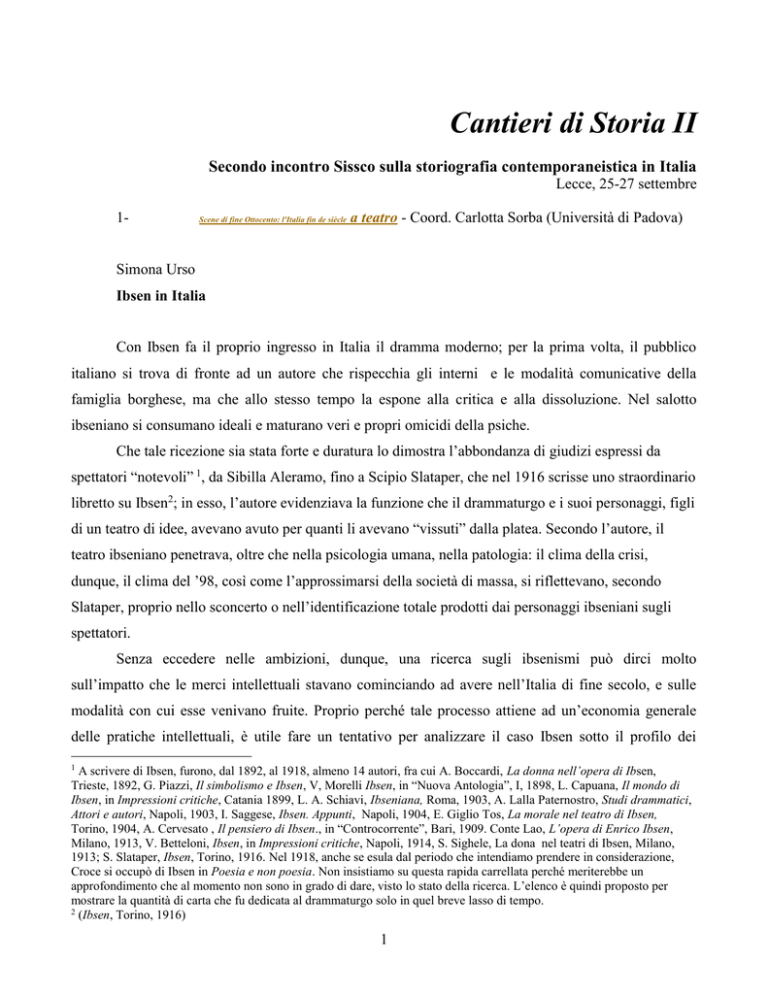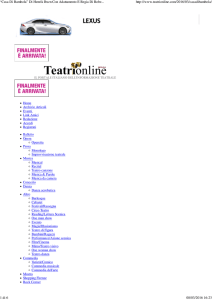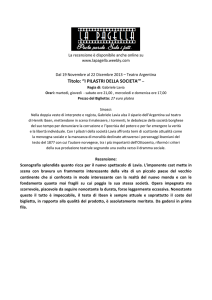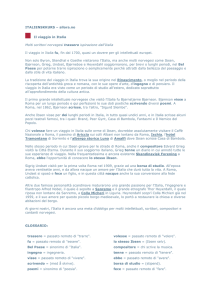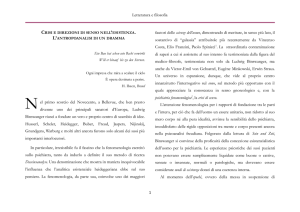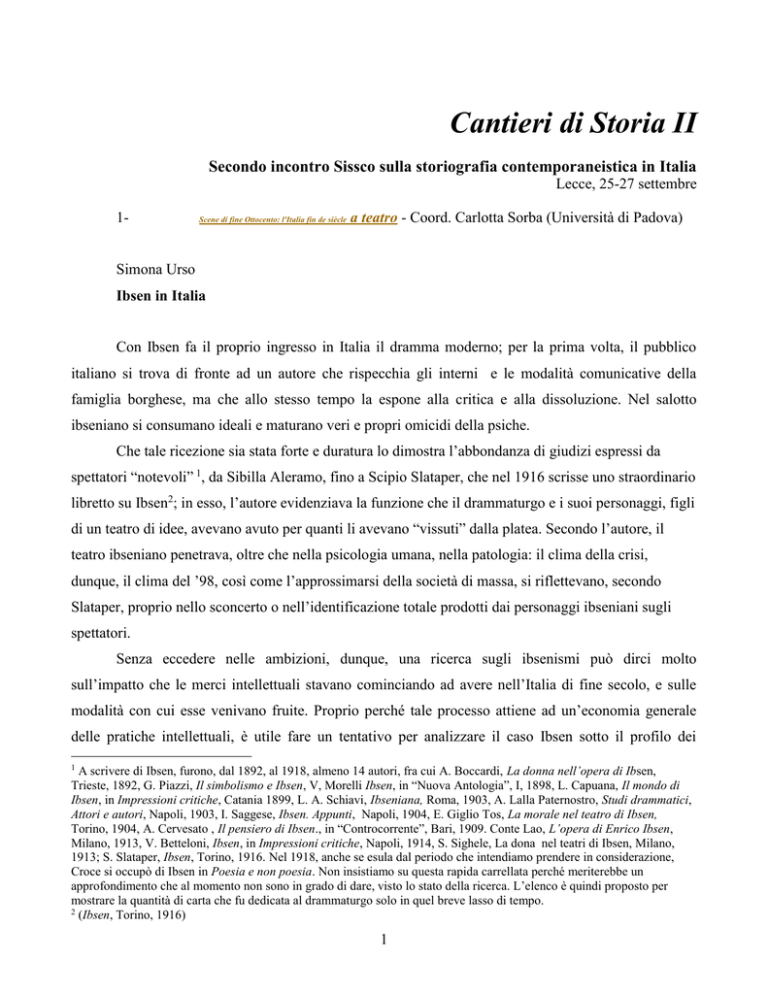
Cantieri di Storia II
Secondo incontro Sissco sulla storiografia contemporaneistica in Italia
Lecce, 25-27 settembre
1-
Scene di fine Ottocento: l'Italia fin de siècle
a teatro - Coord. Carlotta Sorba (Università di Padova)
Simona Urso
Ibsen in Italia
Con Ibsen fa il proprio ingresso in Italia il dramma moderno; per la prima volta, il pubblico
italiano si trova di fronte ad un autore che rispecchia gli interni e le modalità comunicative della
famiglia borghese, ma che allo stesso tempo la espone alla critica e alla dissoluzione. Nel salotto
ibseniano si consumano ideali e maturano veri e propri omicidi della psiche.
Che tale ricezione sia stata forte e duratura lo dimostra l’abbondanza di giudizi espressi da
spettatori “notevoli” 1, da Sibilla Aleramo, fino a Scipio Slataper, che nel 1916 scrisse uno straordinario
libretto su Ibsen2; in esso, l’autore evidenziava la funzione che il drammaturgo e i suoi personaggi, figli
di un teatro di idee, avevano avuto per quanti li avevano “vissuti” dalla platea. Secondo l’autore, il
teatro ibseniano penetrava, oltre che nella psicologia umana, nella patologia: il clima della crisi,
dunque, il clima del ’98, così come l’approssimarsi della società di massa, si riflettevano, secondo
Slataper, proprio nello sconcerto o nell’identificazione totale prodotti dai personaggi ibseniani sugli
spettatori.
Senza eccedere nelle ambizioni, dunque, una ricerca sugli ibsenismi può dirci molto
sull’impatto che le merci intellettuali stavano cominciando ad avere nell’Italia di fine secolo, e sulle
modalità con cui esse venivano fruite. Proprio perché tale processo attiene ad un’economia generale
delle pratiche intellettuali, è utile fare un tentativo per analizzare il caso Ibsen sotto il profilo dei
A scrivere di Ibsen, furono, dal 1892, al 1918, almeno 14 autori, fra cui A. Boccardi, La donna nell’opera di Ibsen,
Trieste, 1892, G. Piazzi, Il simbolismo e Ibsen, V, Morelli Ibsen, in “Nuova Antologia”, I, 1898, L. Capuana, Il mondo di
Ibsen, in Impressioni critiche, Catania 1899, L. A. Schiavi, Ibseniana, Roma, 1903, A. Lalla Paternostro, Studi drammatici,
Attori e autori, Napoli, 1903, I. Saggese, Ibsen. Appunti, Napoli, 1904, E. Giglio Tos, La morale nel teatro di Ibsen,
Torino, 1904, A. Cervesato , Il pensiero di Ibsen., in “Controcorrente”, Bari, 1909. Conte Lao, L’opera di Enrico Ibsen,
Milano, 1913, V. Betteloni, Ibsen, in Impressioni critiche, Napoli, 1914, S. Sighele, La dona nel teatri di Ibsen, Milano,
1913; S. Slataper, Ibsen, Torino, 1916. Nel 1918, anche se esula dal periodo che intendiamo prendere in considerazione,
Croce si occupò di Ibsen in Poesia e non poesia. Non insistiamo su questa rapida carrellata perché meriterebbe un
approfondimento che al momento non sono in grado di dare, visto lo stato della ricerca. L’elenco è quindi proposto per
mostrare la quantità di carta che fu dedicata al drammaturgo solo in quel breve lasso di tempo.
2
(Ibsen, Torino, 1916)
1
1
prodotti sociali e delle forme della loro diffusione.
L’indagine, una volta completata, coprirà l’arco cronologico 1891 – 1916, data, quest’ultima, in cui
escono contemporaneamente il libro di Slataper e finiscono le plurime traduzioni e le frequentissime
rappresentazioni (in seguito Ibsen verrà affiancato al un repertorio italiano e spesso sostituto dai più
rassicuranti Bracco o Giacosa). In questa sede ci limiteremo ad offrire alcuni spunti su un primo
periodo, che va dal 1891 alla svolta del secolo, quando Eleonora Duse deciderà di reinserire Ibsen nel
proprio repertorio. Come si vedrà alla fine della trattazione, tale scelta non è affatto arbitraria, ma
rappresenta un nuovo inizio: segnerà l’ingresso in Italia di un altro Ibsen, che con quello di cui ci
occupiamo in questa sede non ha quasi nulla a che fare.
Anticipo qui alcune delle conclusioni a cui sono approdata: “Ibsen in Italia”, prima di essere un
autore di successo, è un vero e proprio prodotto sociale, il frutto di una costruzione a priori, e il frutto
sia di un’oculata operazione commerciale, sia di una strenua lotta per la conservazione di un potere di
controllo sul mercato intellettuale.
L’era teatrale ibseniana in Italia comincia con Casa di bambola, tradotta dal tedesco
(Meininger) da Pietro Galletti, che, in omaggio alla tradizione “attoriale” del teatro italiano, lo
reinititola liberamente Nora ovvero la casa della bambola. L’allestimento, della compagnia di Emilia
Aliprandi e del marito Vittorio Pieri, nel 1889, al teatro Gerbino di Torino, riceve un’accoglienza
tiepida e scarsa visibilità sulla critica specializzata.
L’anonimo critico della “Gazzetta piemontese” così commenta l’evento ”il dramma venne
ascoltato con religiosa attenzione e giudicato un buon lavoro, non privo però di mende. (...) Alla
catastrofe finale, però, il pubblico ha fatto il viso arcigno” (16-17 febbraio 1899). Liborio, critico de
“L’Arte drammatica” (23 febbraio), è ben più severo: “Il lavoro si presterebbe alla più lunga ed
intricata discussione, tanto che non credo che la sua rappresentazione vorrà essere tentata da altre
attrici: certo è che la signora Aliprandi Pieri vi mise tutto il suo ingegno e ottenne un successo: ma
puramente d’attrice ed in grazia del quale la commedia si è replicata tre volte”. Giuseppe Cauda, nel
suo Chiaroscuri di palcoscenico (Ricordi, Savigliano Garimberti, 1910, p. 168), attribuì quel successo
solo alla capacità dell’attrice di interpretare il personaggio di Nora, ma non al copione, definito
“irrappresentabile in altra sede”.
La data è comunque significativa, così come la scarsa attenzione riservata alla pièce: il teatro
italiano guardava con accurata attenzione a quello francese, in particolare ad Antoine e al suo Théâtre
Libre; nato nel 1887; il Théâtre era orientato verso il naturalismo, visto come strada per imporre
2
finalmente una drammaturgia contemporanea, agganciata alla nuova corrente letteraria e alla sua
vocazione populista. Ma Antoine, rispetto alla Freie Bühne tedesca (impresa teatrale analoga alla sua,
sia per intenti che per organizzazione), che metteva in scena Ibsen almeno da quindici anni, allestì
Spettri, il suo primo Ibsen, solo nel 1890.
Per questo motivo lo spettacolo italiano del 1889 resta pressoché ignorato dagli altri critici: non
era stato messo in scena in Francia. L’autore, in Italia, non aveva quindi ancora la nomea di “autore di
successo”, nomea che gli veniva attribuita dal mercato teatrale solo dopo un passaggio in Francia
(questo benché Ibsen avesse ottenuto enorme successo già in Germania da più di un quindicennio: ma
lo stesso accadrà in Spagna, dove le prime rappresentazioni, contemporanee a quelle italiane,
attenderanno il passaggio francese prima di venire alla luce), e non disponeva ancora di una traduzione
francese a cui attingere (il canale consueto era infatti sempre la lingua francese, e quindi i copioni
solitamente erano ritraduzioni dal francese: la traduzione di casa di bambola, per la pièce successiva del
’91, era quindi possibile, esistendo già l’originale del conte Prozor).
Il ricordo di questa
rappresentazione ritorna alla memoria solo al recensore de “L’Italia del Popolo”, due anni dopo, che, a
proposito dell’interpretazione di Eleonora Duse, così commenta “a Torino rimase inosservata” (10 - 11
febbraio 1891). La Nora della Duse, al Teatro Filodrammatico di Milano, del 1891, pubblicizzata
ovunque come la prima messa in scena di Ibsen, rappresenta così un “secondo inizio”; seguiranno
l’Anatra Selvatica con Ermete Novelli, entrambi a Milano; Nel 1892 Spettri con Ermete Zacconi e
Hedda Gabler con la Mariani, sempre a Milano; nel 1894 La lega dei giovani a Napoli con Fiorella La
guardia e Un nemico del Popolo con Zacconi, a Verona.
La Casa di bambola del ’91 si appoggia su una nuova traduzione, di Capuana, che aveva
sposato invece la versione francese ultraortodossa (e già disponibile) del conte Prozor, traduttore
ufficiale riconosciuto da Ibsen (in Francia, invece, le traduzioni si sovrapporranno, e la versione di
Prozor cesserà di essere un canone solo alla fine del secolo). Si apre subito una querelle fra Galletti e
Capuana, su chi dei due sia il legittimo traduttore ufficiale. La vicenda si chiude con una lettera dello
steso Ibsen a Capuana, in cui lo consacra quale traduttore ufficiale del dramma (lettera immediatamente
pubblicata su “L’Arte drammatica”, 31 gennaio 1891). Il testo di Galletti viee comunque pubblicato
presso Treves, nel 1894, con il titolo Casa di bambola.
3
Il lieve sapore di scandalo che la diatriba provoca, precedente la rappresentazione del dramma,
diventa un’occasione di lancio per lo spettacolo in preparazione: i resoconti dei critici raccontano che il
prezzo del biglietto fu raddoppiato, e che il teatro si riempì ad ogni replica 3.
Questa volta, però, rispetto al caso torinese, non c’è alcun effetto di scandalo, a quanto pare, per
la materia trattata, cosa che invece era accaduta in altri paesi europei. Il critico della “Perseveranza”, un
certo Zampaldi, (10 febbraio 1891) commenta che nel dramma “c’è dell’ardimento”, ma fornisce, nel
proprio resoconto, una lettura del testo che non può non lasciare interdetti su cosa effettivamente fosse
stato rappresentato alla sera della prima: “Nora, quando non può più illudersi, e deve persuadersi che il
marito ha un carattere e un cervello diversi dai suoi; che egli ancora non l’ha compresa e che non l’ama
e non la stima come sente di dover essere amata e stimata, è costretta a lasciare la casa maritale. Questo
costringimento è l’arditezza del dramma”. Con un corsivo su costringimento.
La Nora della Duse, quindi, perde il suo più coraggioso gesto, quello definitivo: non se ne va,
cioè, di propria iniziativa, ma vi è costretta, perché non ama più il marito. Lo scandalo dell’abbandono
viene così mitigato nella resa di una moglie “semplicemente delusa” (ancora parole del Zampaldi).
Viene così ridimensionata l’accusa che Nora riversa sul marito, di averla costretta ad una finzione, cui
si è adattata: Ora, di fronte alla consapevolezza di “non aver vissuto”, e di essersi sempre adattata a ciò
che gli altri si attendevano da lei (il padre, il marito), si accorge di aver cessato di amare un marito
pronto a perdonarla per qualcosa che lei ha scelto di fare, un marito la cui sola obiezione è rivendicare
la proprietà. E l’allontanamento di Nora non è senza appello, quando dice al marito (uso parole mie,
parafrasando): se impareremo insieme ad essere una famiglia, allora, forse si potrà salvare qualcosa.
Ma dovrai accettare che io esista come Nora, come una donna che ha una propria identità da
ricomporre, dopo essere stata troppo a lungo il burattino dei desideri altrui.
In questa mitigazione della novità ibseniana, la critica è in prima fila: Ibsen entra infatti nel
teatro italiano come un nuovo autore alla moda, già consacrato come un grande in tutta Europa, e
quindi irrinunciabile (soprattutto perché importato dalla Francia). Ma si trova di fronte ad un pubblico
di consumatori abituati a ben altro teatro, quello di Giacosa, Praga, Bertolazzi, o al repertorio di Torelli,
in cui la famiglia borghese era già un topos, ma sempre un topos realista con ricomposizione finale. E il
modo per esorcizzare la novità dei contenuti ibseniani, da parte dei critici, è quello di non parlare di un
Ibsen artista, ma di un Ibsen filosofo, a giustificarne la modernità e la scabrosità dei temi. Così scrive
Giovanni Pozza sul “Corriere”, dopo la prima, a spiegazione del mancato scandalo: “Le teorie intorno
al matrimonio, alle donne incomprese, alle rivendicazioni dei diritti femminili, enunciate nella
3
Roberto Alonge, Ibsen, L’opera, la fortuna scenica, Firenze, le Lettere, 1995, p. 80.
4
commedia dell’Ibsen, non hanno trovato, neppure fra le nostre signore, seguaci ed oppositori
eccessivamente appassionati. Fino ad ora ci interessiamo poco a questioni di tale natura, ignari persino
della importanza che esse hanno acquistato in Germani, in Inghilterra, (...) ove si teorizza forse troppo,
ove si studia tutto.4” Se questo poteva servire a spiegare perché nessuno si era strappato i capelli di
fronte alla prima, in realtà aveva l’obiettivo prioritario di indurre un determinato orizzonte di attesa,
quasi a preparare e tranquillizzare il pubblico delle rappresentazioni successive.
Ma questa prima ricezione morbida di Ibsen non è solo frutto della capacità dei critici di
smussare le asperità dell’autore: è soprattutto figlia delle traduzioni, del filtro che esse hanno imposto
alle rappresentazioni teatrali; infine, è frutto delle relazioni di reciproca convenienza fra quanti,
traduttori, agenti, critici, primattori e impresari, stanno creando il “prodotto Ibsen”. Portato in Italia
dalla Francia, Ibsen era un possibile successo. Ma doveva essere reso appetibile, e per renderlo tale
occorreva controllarlo direttamente già al momento della traduzione.
La traduzione di Capuana, pubblicata poi da Kantorowicz nel 94, rispetto alla “originale”
francese del conte Prozor, del 1899, si differenzia infatti in alcuni punti nodali. Lo dimostreremo
attraverso una piccola opera di collazione:
1) Nel secondo atto, durante la scena di seduzione fra Nora e il dottor Rank, amico di famiglia da
sempre innamorato di lei, la donna gli mostra, indossandole, le calze di seta color carne che ha
intenzione di indossare con un costume per una festa in maschera. Il dottore (nella traduzione di
Prozor) commenta l’arditezza delle calze color carne di Nora, che gli sta mostrando il piedino
inguainato; e la risposta di Nora è inequivocabile: “Si, pourtant vous pouvez voir plus haut”, (la cui
traduzione letterale è “si, però può anche guardare più in alto”). La malizia del tentativo di seduzione è
palese.
2) La stessa frase, nella traduzione di Capuana, assume ben altra intonazione (gli appunti di scena
richiedono, per il traduttore, un tono sostenuto): “Se vedesse più in alto!”. La malizia sparisce e
compare la signora sdegnata.
3) E, davanti all’aria critica che Rank fa di fronte alle calze, Nora replica, nella traduzione di Prozor:
“Pourquoiu avez -vous cet air de doute? Vous ne croyez pas qu’ils m’iront? (“Perché quell’aria
dubbiosa? Pensa che non andranno bene?”).
Questo il commento di Rank nella traduzione di Prozor: “Sur quoi baser mon opinion?” (“Su che
dovrei basare la mia opinione?”)
4
G. Pozza, Cronache teatrali, Neri Pozza, 1971, p. 101.
5
Traduzione di Capuana (gli appunti di scena richiedono in questo caso una sommessa alzata di spalle):
“Per quale ragione non crederlo?”
Il che rende tutto sommato abbastanza ridicola la risposta di Nora: “maleducato”. (uguale in ambedue
le traduzioni).
Per comprendere meglio l’importanza del passaggio, occorre ricordare che Nora in quel
momento, per disperazione, tenta di sedurre Rank (amico di famiglia e da sempre innamorato di lei)
allo scopo di farsi aiutare per richiedere l’estinzione di un vecchio debito contratto poco dopo le nozze.
Per la propria felicità familiare avrebbe accettato anche questo.
Ed ecco che allora il critico de “Il Teatro Illustrato” (18 Febbraio 1891) può commentare: “La nota
dell’adulterio, che segna quasi tutte le sue produzioni drammatiche qui non c’entra per nulla, e ciò non
ostante qui vibrano tutte le corde dell’affetto e della passione”.
Al pubblico italiano è quindi meglio dare un po’ di sanità borghese. Se all’estero (ci torneremo se
avremo tempo) il pubblico riesce almeno a cogliere la carnalità di Nora, e nello stesso tempo la sua
disperazione, qui ciò diventa impossibile.
Anche la Duse, nella messa in scena (non dimentichiamo che allora il teatro italiano era
soprattutto u teatro di primattori, che avevano estrema libertà nell’adottare soluzioni sceniche a loro più
gradite), modifica, di propria iniziativa, una scena madre: quella della tarantella sfrontata che Nora (il
personaggio canta e balla spesso, nel dramma) fa davanti a tutti, con un abito (nell’edizione originale)
da pescivendola napoletana. La Duse indossa un costume da arlecchino, con il risultato di sottrarre
carnalità al personaggio e, forse, con lo scopo di intellettualizzare maggiormente la propria
interpretazione. Tale è lo snaturamento della Nora ibseniana, che neppure il cauto ma intelligente
Giovanni Pozza non può non commentare, dalle pagine del Corriere, che la rinuncia alla tarantella
richiedeva “almeno la sostituzione di un altro artificio scenico per rendere con maggiore evidenza
l’esaltazione febbrile della sua angoscia segreta.”
Va segnalato a questo punto un dato interessante e significativo, che tornerà utile quando
avremo terminato l’excursus di oggi: nonostante il successo della commedia, Eleonora Duse non
interpretò mai più un personaggio ibseniano fino al 1898, preferendo un repertorio
denso dei
tradizionalissimi Dumas, Sardou, e una lieve e cauta apertura alla nuova drammaturgia italiana (Praga,
Giacosa, Verga): la scelta di questi testi francesi, di cui ella stessa conosceva i limiti (come confidava
spesso ad Arrigo Boito nel noto epistolario), le permetteva figure di assoluto protagonismo femminile,
permettendole un margine di creazione personale e di riformulazione del personaggio, anche seguendo
il registro del fantastico (che ci spiega anche il costume da Arlecchino in Nora). Lo spettatore italiano,
6
tendenzialmente conservatore (figlio di una programmazione di repertorio da lungo tempo), aveva
bisogno di ritrovare ogni volta i personaggi tipici dell’attrice: Ibsen, pur depurato da Capuana, è ancora
un pericolo, per lei. Sarà una Duse di tipo nuovo, figlia di altre suggestioni culturali, quella che nel ’98
interpreterà Hedda Gabler.
La dittatura e i traduttori impresari
Ma nel caso Ibsen, più che in ogni altro caso di “importazione di un drammaturgo”, si inserisce
il legame diretto traduzione-critica-copione-impresario, il meccanismo di controllo e di potere che per
dieci anni si impose sulla scena teatrale italiana.
Protagonista di questa operazione è l’influente rivista “L’Arte drammatica”, dietro la quale si
nasconde in realtà uan formidabile macchina organizzativa e di controllo. Il 21 febbraio 1891 proprio
“l’Arte drammatica”, commentando la Nora della Duse così afferma, discutendo l’operazione Ibsen che
si sta per avviare in Italia: “Ibsen è un grande autore, ma è norvegese, è nordico, egli mette in scena
gente della sua razza, egli fa ragionare i suoi personaggi come in quei paesi si ragiona, non come tra
noi meridionali, ecco quello che il pubblico milanese non parve capire (...) La traduzione non mi parve
troppo felice, e troppo poi i tagli”. Se è di fatto vero che i drammi ibseniani sono lunghissimi, e che
spesso i personaggi sono caratterizzati in modo troppo localistico, non è solo questo che il recensore ci
dice: “L’Arte drammatica” intende legittimare, in questo articolo, l’ampia libertà del
traduttore
nell’adattare, tagliare, e rielaborare la scrittura originale. Lo stesso Giovanni Pozza, il critico per
eccellenza, non sembra sfavorevole: “Al Filodrammatico fu recitata nella sua interezza, e doveva
esserlo. Ibsen non è autore da meritare le sfregio di mutilazioni preventive. Ora però che la commedia
fu giudicata quale fu scritta, è lecito sfrondarla di tutto il superfluo che può riuscirle pericoloso.”
Obiettivo, quindi, era adattare la pièce al gusto e all’unità di tempo teatrale cui il pubblico era abituato.
Le parole de “L’Arte Drammatica”, per altro santificate da Pozza, miglior critico dell’epoca,
non sono in realtà casuali. A dirigerla è Icilio Polese Santarnecchi , affiancato e poi, alla morte, (1894)
sostituito dal figlio Enrico: e la rivista non è solo una potentissima rivista di teatro, è anche un’agenzia
teatrale. Ma, nel caso della drammaturgia ibseniana, è anche un’impresa di traduzioni: Lo stesso Enrico
Polese (con il germanista Paolo Rindler) è il traduttore delle prime sette opere di Ibsen messe in
commercio dall’editore Kantorowicz, che ne stampa ben 14 fra il 1892 e 1895. E quelle tradotti dalla
coppia Polese Rindler sono i più significativi, i più rappresentati e tuttora i più noti: Le colonne della
società (1892) Hedda Gabler (1893) Il costruttore Solness (1893), La donna del mare (1894)
7
Rosmersholm (1894), L’anitra selvatica (1894). Manca Casa di bambola, già pubblicata da Capuana
con Treves, come sappiamo. Il fatto che Polese traduca solo questi è indicativo: Polese è interessato
solo a tradurre le opere che si potrebbero definire funzionali alla battaglia per il realismo (non gli
interessa l’atmosfera romantica dei primi drammi), o che sono state maggiormente rappresentate
all’estero.
E’ da segnalare anche che cinque, fra le traduzioni edite di Polese (dal tedesco, che vantava un
corpus ibseniano già tradotto come quello francese), guarda caso, sono o contemporanee o subito
successive alle prime rappresentazioni di tali opere; opere, per altro, rappresentate su un copione
tradotto da Polese stesso, e poi edito. E’ facile pensare ad un accordo di Polese con le singole
compagnie che interpretavano tali opere, e ad una sua partecipazione diretta alla messa in scena.
Operazione, per altro, che avrebbe potuto garantire alle compagnie, critiche benevole sulle pagine de
“L’Arte drammatica”.
E’ certo comunque che di fronte a queste traduzioni, la critica reagisce in modo ambivalente:
esse vengono definite “malridotte dal tedesco” dal corrispondente milanese della “Gazzetta
piemontese”, che non manca però di commentare come esse fossero state gradite al pubblico, e quindi
frutto di un’opera tutto sommato riuscita; definite “soverchie le varianti fatte al testo” da Pozza (che
aveva comunque in mente “l’originale” francese di Prozor). Ma “L’Arte Drammatica”, (a nome di un
ignoto commentatore), così chiosa: “Alcuni critici milanesi fanno colpa ai traduttori di aver introdotto
alcune modificazioni: io non conosco il testo originale, come credo non lo conoscano neppure quei
signori, e alla polemica rimango estraneo solo riserbandomi dire che credo che il nostro pubblico non
possa sopportare per i suoi gusti, per i suoi sentimenti, una fedelissima riproduzione di queste potenti
opere degli ingegni nordici”. Dopo tale osservazione da parte di un colosso come “L’arte drammatica”,
scompaiono anche le lievi osservazioni degli altri critici.
Ma “L’arte drammatica” è la rivista di Polese. E la sua traduzione, a cui Rindler fornisce solo
l’ottimo apporto di un buon germanista (basta scorrere le traduzioni sue sia dal tedesco che dal russo
circolanti allora), è senza dubbio il lavoro di un’abile mestierante della drammaturgia, che conosce il
pubblico, che ha il controllo sul reclutamento degli attori e che spesso svolge, in modo indiretto, il
ruolo di impresario. E il lavoro di Polese, che, non dimentichiamolo finisce per influire sulla diffusione
di Ibsen per un intero decennio, significa: testi più snelli, nessuna allusione religiosa, livellamento degli
argomenti scottanti, ma soprattutto una capacità di ridisegnare i personaggi non solo secondo i gusti del
pubblico di fine ottocento, ma anche secondo le modalità abituali del teatro di allora. Le tipologie
devono avvicinarsi quindi a quelle già note al pubblico italiano e alle tipologie attoriali esistenti in quel
8
momento sulla scena teatrale italiana: una scena fatta esclusivamente dall’attore, dal grande attore,
contrariamente, per esempio, alla coralità delle commedie ibseniane, che attribuivano ad ogni
personaggio una funzione scenica insostituibile.
Occorrerebbe qui fare molti esempi concreti: Spettri, Hedda Gabler, Il costruttore Solness, La
fattoria Rosmer e La donna del mare: ci limitiamo a Spettri, che per la sua materia “scabrosa” si presta
bene alla nostra disamina.
Spettri va in scena a Milano, al teatro Manzoni, il 22 febbraio 1892, realizzato dalla compagnia
di Giovan Battista Marini, e dalla moglie, Virginia Marini. Ermete Zacconi, allora attor giovane,
interpreta Osvald. Il testo è immediatamente pubblicato.
Anche in questo caso Polese taglia e aggiusta, ma cerca anche di supplire all’oscurità e
allusività dei testi ibseniani; il termine “oscurità”, per altro, era ormai associato quasi automaticamente
a Ibsen e al suo teatro; e spesso, in virtù di tale “oscurità” quasi ovunque, in modalità differenti per
ciascun “campo letterario nazionale”, Ibsen veniva esplicitato, ma anche riletto e riadattato5.
La scena che offriamo come esempio è posta a confronto con un’altra traduzione di Spettri, una
traduzione fedele di Prozor, pubblicata anonima da Treves nel 1894, editore concorrente di
Kantorowicz nella pubblicazione dei testi ibseniani. Il cuore della scena è il legame che si crea fra
Osvald e la cameriera Regina, di cui il ragazzo si crede innamorato, e che desidera condurre con sé in
Francia. La ragazza è in realtà figlia illegittima del padre, e quindi sorellastra di Osvald. Come tale un
amore inconsapevolmente incestuoso. Ecco la scena madre secondo la traduzione Treves.
1 Traduzione Treves: Signora Alving: Eppoi ho riflettuto che Regina apparteneva a questa casa ...allo
stesso titolo di mio figlio.
Osvald: Regina!...
2 Traduzione di Polese:
Signora Alving: Non ho finito. Regina, in questa casa, ha gli stessi diritti di mio figlio...legittimo!
Osvald: Regina, mia sor....
Lo scopo di Polese è duplice. In primo luogo chiarire l’ambiguità della frase, spiegando
didascalicamente che i due sono fratellastri. Ma soprattutto sottolineare, in posizione enfatica, la parola
legittimo. Riduce quindi il ruolo di Regina a quello dei tanti bastardi che riempivano allora il teatro
5
MI ispiro evidentemente agli studi di Pierre Bourdieu , in particolare a P. Bourdieu, La distinzione, Bologna, Il Mulino, pp.
239 – 244 (ed. Or. La distinction, Paris, Les éditoins de minuit, 1979), ma anche al saggio di P. Casanova, La production de
L’universel littéraire: Le Grand Tour d’Ibsen en Europe, in Penser l’art et la culture avec les sciences socislers en
l’honneur de Pierre Bourdieu, Paris, Publications de La Sorbonne, 2002, pp. 63 – 79 (ringrazio per la segnalazione di
quest’ultimo saggio Carlotta Sorba).
9
contemporaneo, di Giacosa, di Praga, il repertorio di Torelli, ma anche il populismo napoletano di Di
Giacomo, che erano tutti nel consueto repertorio italiano. E se Helen, per Ibsen, aveva inteso anche
risarcire Regina di un segreto durato troppo a lungo, per Polese intende invece ribadire la distanza fra i
due figli, il legittimo e la bastarda.
Il testo, inoltre, viene notevolmente ristrutturato, anche nella funzione attribuita ai personaggi
nell’economia del dramma. Ed è bene seguire questa operazione perché è in grado di dirci cosa si
aspettasse il pubblico, e nel contempo che tipo di pubblico si cercasse come “cliente” fisso.
La forzatura maggiore sta nella trasformazione del dramma in un dramma incentrato sul figlio
sulla sua malattia, e non, come nelle intenzioni dell’autore, nel dramma personale di Helen Halving:
mentre sta per inaugurare un asilo in memoria del marito morto, uomo dissoluto, sposato senza amore,
e da lei spinto quasi verso l’abiezione definitiva, Helen si trova ad evocare gli spettri di un passato, in
cui il rispetto delle convenienze e l’odio per il marito l’hanno prosciugata di ogni altro sentimento. Ha
allontanato da casa il figlio Osvald per nascondergli la verità, e ora, con il ritorno del figlio, si trova di
fronte ad un essere che le ricorda, fiacco e confuso, il marito morto e odiato. E la malattia, forse,
venerea del figlio la fa ripiombare in un passato di menzogna e decoro borghese di cui ora, proprio
perché deve presenziare al ricordo pubblico del marito, prova disgusto.
Tutto il contrario nella traduzione di Polese, che incentra invece il dramma esclusivamente sulla
malattia di Osvald (forse sifilide), che lo porta alla pazzia. La protagonista non c’è più, sostituita dal
figlio e dal suo male, che diventa il nucleo portante dramma. La decadenza fisica di Osvald è il vero
oggetto di questo spettri riletto, in linea con le teorie sulla degenerazione e della malattia come sintomo
di anormalità.
Giovanni Pozza, lettore di Prozor, ma anche critico “comprensivo”, quando si tratta di
italianizzare l’autore, questa volta non ce la fa più. In una lettera aperta alla protagonista così scrive,
sempre dalle pagine del Corriere:
“Siamo in un teatro o all’ospedale? (...) Ella, non conservando al personaggio di Elena Alving quel
protagonismo drammatico che le fu dato dall’autore ha concorso involontariamente, ma con danno
irreparabile per l’armonia del lavoro a far si che la malattia di Osvaldo soverchiasse ogni altro elemento
drammatico del lavoro. Non è vero che gli Spettri siano il dramma della pazzia ereditaria (...) E’
presumibile che Ibsen (...) abbia scritto gli Spettri per presentare al pubblico il grande sconvolgimento
di uan malattia mentale? Ciò sarebbe puerile e imperdonabile6.”
6
G. Pozza, cit. p. 138 – 139.
10
Vero, ma questo è Gli Spettri di Polese. E non solo. E’ lo Spettri di Ermete Zacconi, abituato, nelle
proprie interpretazioni, a indulgere spesso e volentieri nella psicopatologia. Abbiamo però prima
ricordato che Polese era anche agente(ed era agente di Zacconi, in quel periodo). Come non pensare
che la traduzione fosse costruita ad arte per il suo attore?
Naturalmente, però, di fronte a questo attacco del critico più influente dell’epoca, proprio
Polese, questa volta in qualità di Direttore, sulle pagine de “l’Arte Drammatica”, smentisce l’ipotesi di
Pozza, citandolo indirettamente (27 febbraio 1892):
“Io non credo affatto che Ibsen abbia avuto intenzione di ricavare grande effetto dal carattere della
madre e soprattutto dal suo immenso dolore, dal dolore di lei che si vede distrutto in un momento il
sogno della sua vita, e riprodotto in un baleno, che durerà eterno, tutto il passato terribile. No, questo è
un effetto ormai troppo sfruttato in teatro, e non ha potuto tentare Ibsen. “
E pur non accettando l’accusa di aver trasformato Osvald nel protagonista così prosegue, con un banale
escamotage:
“Ed il personaggio principale di questi Spettri (...) non è la madre, non è Osvald, (..) è il padre di
Osvald che non comparisce in scena, perché morto da anni (...) E’ lo spirito di quest’uomo che domina
però tutto il lavoro, che lo modella, e si direbbe che muove a far parlare i suoi personaggi come più gli
talenta.“
Il controllo sul gusto ibseniano viene esercitato dunque da Polese non solo tramite la
traduzione, ma attraverso il ruolo di agente del coprotagonista, nonché dalle pagine della sua rivista. In
qualità di traduttore onnipresente, inoltre, si preoccupava di fornire agli attori indicazioni precise anche
sulla messa in scena (nell’ottocento il termine corrispondeva soprattutto alla scenografia, ai costumi),
fino a controllare le operazioni condotte dagli impresari nell’allestimento dello spettacolo. Il cerchio
così si chiude: controllo sul testo, sulla messa inscena, sull’interpretazione, sull’attività degli impresari,
sul pubblico attraverso la rivista.
D’altra parte, la “ricezione” italiana di Ibsen nell’ultimo decennio del secolo è condizionata
dallo stesso ambiente culturale e letterario che riempie di sé l’industria editoriale di fine secolo, dalle
sue scelte, dai suoi limiti. Appartengono all stesso “campo”, per usare un termine caro a Bourdieu, e
mettono in pratica le medesime strategie di fronte ad un pubblico di consumatori. E’ ancora Capuana7,
non casualmente, a fornirci il polso della situazione letteraria italiana: non ci sono nuovi autori italiani,
nuovi generi, nuovi codici, e il cuore della letteratura consumata è il romanzo francese, dumasiano. I
7
L. Capuana, Per l’arte, Giannotta, Catania, 1885, p. XI.
11
generi narrativi italiani, se si esclude il verismo8, risultano un fallimento: il romanzo di costume, che si
sarebbe potuto immaginare come il nuovo genere “cittadino”, di massa, è privo di codice e tecnica
narrativa; il romanzo storico è una vulgata del modello dumasiano, e alla fine il solo progetto valido
rimane, nonostante la modernità incipiente, un romanzo finalizzato al mercato letterario: quindi
naturalismo, o quella che Capuana chiama ”smania di positivismo, di studi , di osservazioni” (p.
XLIV), materia in cui l’editore principe è Treves. E’ insomma una produzione letteraria industriale, in
cui trionfano la marchesa Colombi, la Serao, De Amicis, nei casi migliori. In altri, di cui l’editore
Sommaruga a Roma era il modello dominante, tale letteratura industriale puntava al romanzo
eroticheggiante o peggio, ai romanzi – confessione.
E Il pubblico di Ibsen è lo stesso di questo mercato letterario, la cui l’attenzione all’aspetto
feuilletonistico, al malessere fisico, alla decadenza, alla degenerazione, spingono critica e traduttori a
trasformarlo in autore naturalistico e soprattutto non perturbante. L’Ibsen che stava passando per i teatri
italiani era l’Ibsen più rassicurante, quello che occorreva mettere in scena per un pubblico di
consumatori bisognosi di rassicurazioni, rassicurazioni che l’ordine restasse inalterato, e ogni
comportamento rientrava nei topoi drammaturgici che già essi conoscevano.
E’ indicativo di una stagione politica e culturale ormai agli sgoccioli, di un pubblico borghese
incapace di vedersi diverso, convinto anzi di poter rafforzare la propria autopercezione attraverso
esempi catartici: se si pensa per esempio ai temi dei drammi di Giacosa e Torelli si capisce che la
ricerca è sempre quella della ricomposizione di un ordine, o di una catarsi di un ordine, che era
speculare al disordine politico di quella fine di secolo. E’ un’Italia che ha appena vissuto la crisi
agraria, la prima espansione industriale, la genesi del partito socialista, la Triplice Alleanza, una
paradossale prosperità economica; è l’Italia che sta vivendo la crisi parlamentare e che sta per vivere la
crisi coloniale.
L’Ibsen di questi anni quindi, diventa in realtà un contenitore vuoto da utilizzare, proprio perché
modificabile grazie alla traduzione e all’industria culturale legata al teatro, per proporre in apparenza
un autore nuovo, già baciato dal successo, ma per riproporre in realtà i contenuti del repertorio teatrale
italiano di quegli anni. Questa scelta è legata ad un mercato culturale che in Italia era sicuramente il più
fiorente: fra il 1870 e il 1890 erano apeti in Italia 1,055 teatri ufficialmente censiti su 775 comuni, per
una popolazione complessiva che oscillava tra il 29 e i 31 milioni di abitanti; e a questi vanno aggiunti
tutti gli edifici che no erano ufficialmente adibiti a teatri, ma in cui si rappresentavano commedie. Il
giro d’affari del solo Teatro Lirico di Milano, in quel ventennio oscillava da 6.760.000 di lire a
8
Cfr. G. Ragone, Un secolo di libri, Torino, Einaudi, 1999, p. 50 – 51.
12
7.000.000, qualcosa fra i 15 e i 30 milioni di euro attuali9: una cifra forse non significativa, perché non
esaurisce in realtà il reale giro d’affari del mondo teatrale, spesso in perdita, ma significativa se
confrontata con i profitti dell’industria editoriale10. Non a caso l’editoria stessa faceva più affari con i
testi teatrali che con la narrativa.
Ma se la scelta di privilegiare una lettura “rassicurante” non poteva non dipendere in parte dalla
contingenza storica, la scelta di privilegiare una lettura “naturalista” dipendeva (lo steso Polese era un
radicale cavallottiano), ben di più dal bisogno di arginare una nuova generazione intellettuale e politica
(non è casuale che fra quanti hanno dedicato scritti a Ibsen ci sia, anche Scipio Sighele), che già
premeva per affermarsi.
Quando cambia quindi la percezione di Ibsen? Solo con la Duse, che, dopo aver interpretato
Nora nel 1891 non aveva più tentato di mettere in scena un personaggio ibseniano, a cui preferiva
invece il repertorio italiano, che poteva offrire figure di donne che le permettono un ruolo da mattatrice.
La Duse apre con cautela alla novità, consapevole di ciò che il suo pubblico desidera da lei. Ma quando
ritorna a Ibsen, lo fa nel nuovo secolo, e con un Ibsen ben diverso, figlio della scuola simbolista di
Lugnè Poe. Cosa era accaduto nel frattempo? Era cambiato il gusto? In parte si, e con la svolta del
secolo era ormai necessario decretare stantio il teatro naturalistico.
Con il secolo nuovo altre saranno le richieste del pubblico, ma soprattutto cambieranno le figure
dei mediatori culturali, di quanti sono “deputati a costruire il gusto”. Il passaggio del seoclo coincide
con la vittoria di una nuova classe di letterati che inevitabilmente passa attraverso D’Annunzio, il
primo a vedere anche nella letteratura “alta”, una fetta di mercato altrettanto appetibile. Lo scienziato,
che era il modello del secolo precedente, cede il passo all’eroe individualista di Carlyle, di Emerson,
subendo anche uno slittamento ideologico; ora anche la malattia sociale e individuale assurge al ruolo
di forma di conoscenza.
E ciò comporta, nel mercato letterario, una ristrutturazione sia sul piano della produzione che
della fruizione: se il modello letterario precedente era entrato in crisi, a sostituirlo non c’era ancora
nulla, se non la vulgata filosofica, il giornalismo filosofico, di nuovo tipo, le non fruibili avanguardie, e
guarda caso, proprio l’amplissima proliferazione dei testi teatrali, soprattutto stranieri: è una crisi
letteraria, specchio di una crisi complessiva, “Queste curve riflettono in pieno dinamiche profonde di
tipo sociale, oltre che culturale, che riguardano la sfiducia degli strati colti nell’innovazione, scientifica,
9
C. Molinari, L’attrice divina, Roma, Bulzoni, 1985, pp. 36 – 37.
G. Ragone, Un secolo di libri, Torino, Einaudi, 1999, pp. 58 – 65.
10
13
produttiva, sociale; significativa (..) è la spia data dall’aumento della produzione di testi filosofici, a
partire dal 1900”11.
In questa perdita e nuova ricerca di identità culturale, che è anche un’avvicendamento
generazionale, si insinua l’idealismo: non possono quindi non cambiare consumi, fruitori e generi. Il
simbolismo diventa allora un linguaggio adeguato al momento: l’individualismo ibseniano rappresenta
un ottimo esempio “carlyliano”, e nel contempo rappresenta la vittoria di una nuova generazione di
letterati; Ibsen riceve così anche una nuova collocazione all’interno dell’industria culturale, nella
circuitazione teatrale e in quella editoriale.
Per questo Eleonora Duse decide di cavalcare nuovamente il cavallo ibseniano, utilizzando
questa volta le traduzione francese di Lugnè Poe, garanzia assoluta di uan lettura simbolista e ieratica
dei personaggi ibseniani, che a Parigi aveva scalzato quella di Antoine e la sua battaglia per il
naturalismo.
Ciò che però non può non risultare chiaro è che anche questa volta Ibsen è servito non solo al
mercato delle arti, ma ad assicurare la vittoria di una nuova generazione intellettuale, all’interno di uno
scontro non solo intergenerazionale; è soprattutto uno scontro per la leadership del mercato
intellettuale, e, vorremmo aggiungere, di nuovi orizzonti ideologici.
La molteplicità dei mezzi usati per trasferire un teatro apparentemente inaccessibile dimostra
che l'autore è in realtà quasi sempre una costruzione collettiva, che lo storico deve descrivere e
comprendere: e, come direbbe Bourdieu, che la stessa opera, per ragioni differenti e categorie di
pensiero differenti, s'imponga in modo multiforme, è la prova della sua universalità. Ma questa
universalità ci interessa proprio perché vuota l’autore di contenuti reali, e lo riempie di contenuti che
riguardano soprattutto la mutazione di un orizzonte sociale e politico.
Ma sono contenuti che si impongono proprio attraverso variabili che con il testo e il suo autore
ben poco hanno a che fare: le traduzioni e gli adattamenti non sono solo traduzioni e adattamenti; le
divergenze di interpretazione provano che il riconoscimento di un capitale letterario si fa al prezzo di
una straordinaria annessione di un'opera eccentrica a interessi centrali: nella costruzione cioè di un
campo letterario nazionale, in cui potere e induzione di un orizzonte d’attesa ci permettono di
storicizzare la diffusione di un fenomeno ed attribuirgli la funzione di termometro per misurare la
trasformazione di un corpo sociale e politico.
Un orizzonte di attesa viene creato, non nasce mai spontaneamente: è l’insieme delle
conoscenze preliminari che precedono l’esperienza estetica e ne costituiscono la premessa volta a
11
G. Ragone, cit., p. 68.
14
orientare il giudizio critico, perché ogni testo è un atto storico, che si costruisce attraverso le norme
letterarie di un’epoca, nelle istituzioni sociali, nel mercato editoriale, nella stampa, nel divenire
storico12.
12
H R. Jauss, Eestetica della ricezione, Napoli, Guida, 1988.
15