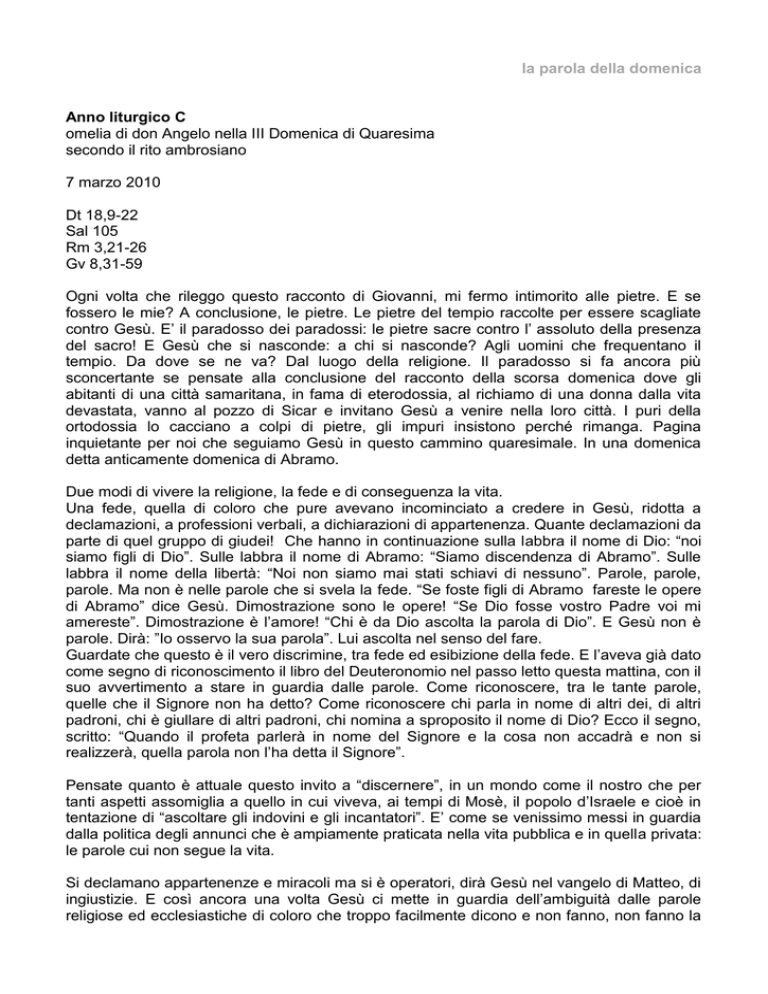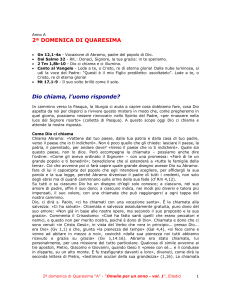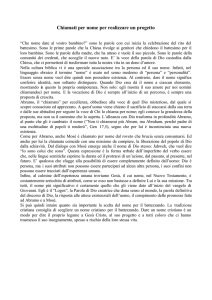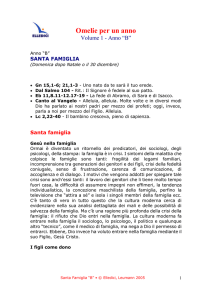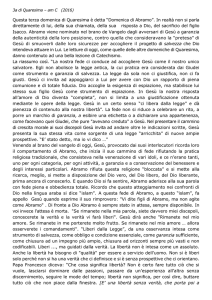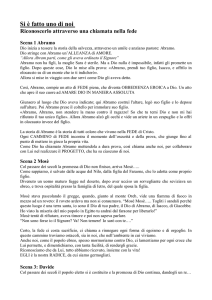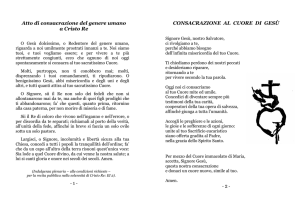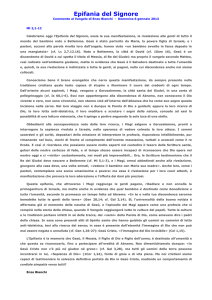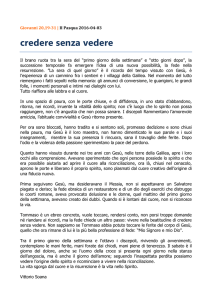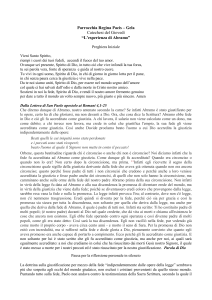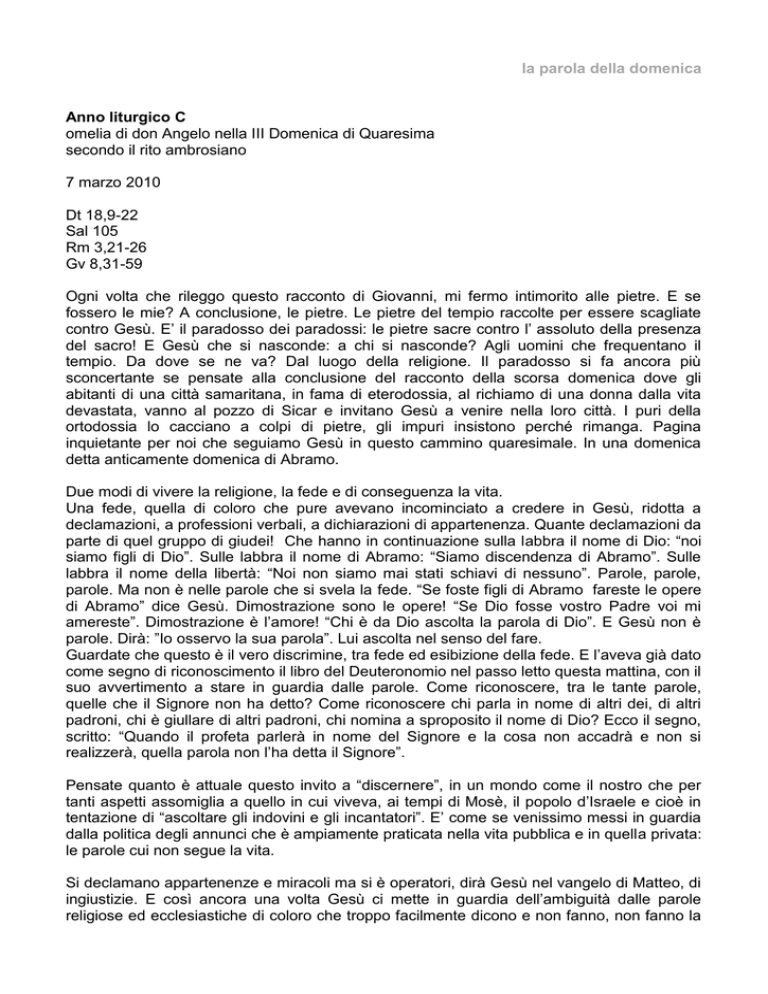
la parola della domenica
Anno liturgico C
omelia di don Angelo nella III Domenica di Quaresima
secondo il rito ambrosiano
7 marzo 2010
Dt 18,9-22
Sal 105
Rm 3,21-26
Gv 8,31-59
Ogni volta che rileggo questo racconto di Giovanni, mi fermo intimorito alle pietre. E se
fossero le mie? A conclusione, le pietre. Le pietre del tempio raccolte per essere scagliate
contro Gesù. E’ il paradosso dei paradossi: le pietre sacre contro l’ assoluto della presenza
del sacro! E Gesù che si nasconde: a chi si nasconde? Agli uomini che frequentano il
tempio. Da dove se ne va? Dal luogo della religione. Il paradosso si fa ancora più
sconcertante se pensate alla conclusione del racconto della scorsa domenica dove gli
abitanti di una città samaritana, in fama di eterodossia, al richiamo di una donna dalla vita
devastata, vanno al pozzo di Sicar e invitano Gesù a venire nella loro città. I puri della
ortodossia lo cacciano a colpi di pietre, gli impuri insistono perché rimanga. Pagina
inquietante per noi che seguiamo Gesù in questo cammino quaresimale. In una domenica
detta anticamente domenica di Abramo.
Due modi di vivere la religione, la fede e di conseguenza la vita.
Una fede, quella di coloro che pure avevano incominciato a credere in Gesù, ridotta a
declamazioni, a professioni verbali, a dichiarazioni di appartenenza. Quante declamazioni da
parte di quel gruppo di giudei! Che hanno in continuazione sulla labbra il nome di Dio: “noi
siamo figli di Dio”. Sulle labbra il nome di Abramo: “Siamo discendenza di Abramo”. Sulle
labbra il nome della libertà: “Noi non siamo mai stati schiavi di nessuno”. Parole, parole,
parole. Ma non è nelle parole che si svela la fede. “Se foste figli di Abramo fareste le opere
di Abramo” dice Gesù. Dimostrazione sono le opere! “Se Dio fosse vostro Padre voi mi
amereste”. Dimostrazione è l’amore! “Chi è da Dio ascolta la parola di Dio”. E Gesù non è
parole. Dirà: ”Io osservo la sua parola”. Lui ascolta nel senso del fare.
Guardate che questo è il vero discrimine, tra fede ed esibizione della fede. E l’aveva già dato
come segno di riconoscimento il libro del Deuteronomio nel passo letto questa mattina, con il
suo avvertimento a stare in guardia dalle parole. Come riconoscere, tra le tante parole,
quelle che il Signore non ha detto? Come riconoscere chi parla in nome di altri dei, di altri
padroni, chi è giullare di altri padroni, chi nomina a sproposito il nome di Dio? Ecco il segno,
scritto: “Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si
realizzerà, quella parola non l’ha detta il Signore”.
Pensate quanto è attuale questo invito a “discernere”, in un mondo come il nostro che per
tanti aspetti assomiglia a quello in cui viveva, ai tempi di Mosè, il popolo d’Israele e cioè in
tentazione di “ascoltare gli indovini e gli incantatori”. E’ come se venissimo messi in guardia
dalla politica degli annunci che è ampiamente praticata nella vita pubblica e in quella privata:
le parole cui non segue la vita.
Si declamano appartenenze e miracoli ma si è operatori, dirà Gesù nel vangelo di Matteo, di
ingiustizie. E così ancora una volta Gesù ci mette in guardia dell’ambiguità dalle parole
religiose ed ecclesiastiche di coloro che troppo facilmente dicono e non fanno, non fanno la
giustizia, di coloro che si autoincensano con le loro profezie e con i loro miracoli. Il brano è
nel vangelo di Matteo e sembra in perfetta consonanza con il racconto di Giovanni, nella
divaricazione tra parole e fatti. Ecco le parole di Gesù: “Non chiunque mi dice: ‘Signore,
Signore’ entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”.
Dicono ma non fanno. Noi diciamo, parliamo, ma facciamo? E aggiungeva: “In quel giorno
molti mi diranno: ‘Signore, Signore, non abbiamo forse scacciato demoni nel tuo nome. E
nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi. Ma allora io dichiarerò loro: Non vi
ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità” (Mt 7,21-23). Non basta
dichiarare, occorre praticare la giustizia.
E come ultima postilla vorrei aggiungere una breve riflessione sul nome di Abramo, cinque
volte sulle labbra dei giudei e cinque volte sulle labbra di Gesù in questo brano. Tutti
ricordiamo la chiamata di Abramo: “Il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla
tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò”. E’ l’uomo dell’andare,
Abramo! E quell’andare ce l’aveva scritto perfino nel nome. Secondo una etimologia,
Abramo, è l’uomo che “abar”, che “attraversa”. Scrive Paolo De Benedetti: “La chiamata di
Abramo, che è all’origine non solo delle religioni monoteistiche, ma del nostro modo stesso
di concepire la storia, il passato, il futuro, ha due caratteristiche fondamentali, che tutti in
qualche modo viviamo senza rendercene conto: la prima è, se posso esprimermi
paradossalmente, che non siamo alberi, cioè radicati in questa terra che tuttavia chiamiamo
patria; la seconda, che la vicenda dell’umanità e di ogni uomo è di andare, di un “uscire da”
e di un “andare verso”. Ma nel caso di Abramo c’è un elemento in più: Dio gli dice di andare,
ma non gli dice dove. E’ questo l’elemento della fede, un elemento che innerva tutta la storia
di Israele e anche, se ne siamo coscienti, del cristianesimo e che ha il suo culmine, nella
Pasqua che etimologicamente esprime un passaggio”.
Guardando quei Giudei sarei tentato di dire: “Ma come si fa a dirsi discendenza di Abramo
l’uomo che “esce”, che “attraversa”, che “va verso” ed essere così pesantemente immobili
nei pensieri nelle tradizioni nella vita?”
Starei per dirlo, ma poi immediatamente mi sorprendo a pensare: chi mi conosce, vede in
me uno che “esce”, uno che “attraversa”, uno che “va verso”?
Per la riflessione
Uscire da che cosa?
Attraversare che cosa?
Andare verso che cosa?