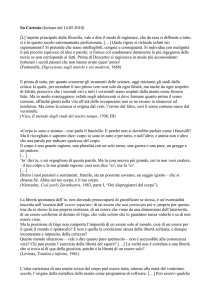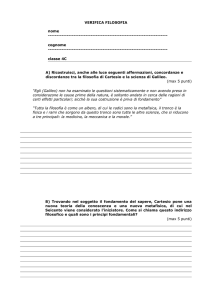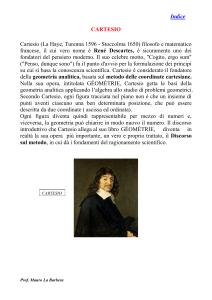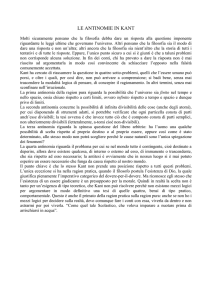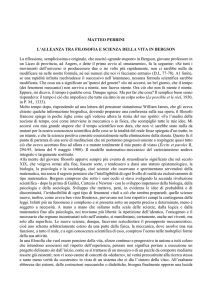LIBERTA’ E NECESSITA’ DAI GRECI AD OGGI
INTRODUZIONE
Nel corso della storia assistiamo al contrapporsi di due diversi modelli di libertà: da un lato, la libertà come
libero arbitrio, ossia come possibilità di decidere arbitrariamente tra due o più alternative (si tratta di quella
che gli scolastici definivano potestas ad utrumque): essa è la libertà di indifferenza, tale per cui quando ci si
trova a dover compiere una scelta è indifferente che si scelga A piuttosto che B, nel senso che non vi è
nessun condizionamento che implichi dall’esterno una differenza e che ci indirizzi a scegliere una cosa
anziché un’altra. In quest’accezione, questo modello può essere concepito come modello della "libertà di"
fare così oppure non così. Dall’altro lato, troviamo la libertà come assenza di costrizione, la libertas a
coactione degli scolastici: non è più l’indifferenza della scelta, tale per cui posso decidere liberamente di
scegliere o A o B, ma si tratta piuttosto di una libertà in virtù della quale sia che io scelga A sia che io scelga
B non sono condizionato da una costrizione, sia essa esterna (qualcuno che mi obbliga ad agire in un
determinato modo) sia essa interna (le mie passioni). Questo secondo modello implica non già una "libertà
di", bensì una "libertà da". Stando a quanto abbiamo finora detto, questi due tipi di libertà possono apparire
non troppo diversificate, cosicché è opportuno produrre altre distinzioni più incisive: innanzitutto, possiamo
notare come la "libertà di" sia sempre considerata come libertà positiva, in quanto si tratta di determinare
l’oggetto del volere e sono io stesso a deciderlo; sicchè la "libertà di" comporta la libertà di volere ciò che
ancora non si vuole, per cui siamo noi stessi a determinare la nostra volontà: l’uomo non sceglie perché
vuole, ma vuole perché sceglie. Sull’altro versante - quello della "libertà da" - ci troviamo dinanzi ad una
libertà di tipo negativo, giacchè ciò che si vuole è sempre già presupposto, cosicché io so già che cosa voglio
e non sono io a sceglierlo. Dunque, si può dire che nel caso della "libertà di" ciò che voglio non mi è imposto
(e per ciò sono realmente libero), mentre nel caso della "libertà da" mi è imposto (e perciò non sono libero).
Un’ulteriore distinzione può essere operata tenendo conto del rapporto che queste due forme di libertà
intrattengono con la contingenza o con la necessità: entrambe le due tipologie di libertà presuppongono una
razionalità dell’azione (voglio e scelgo qualcosa sulla base di un disegno razionale), ma diverso è il rapporto
sussistente tra la razionalità e il contesto in cui
essa si esprime. Nel caso del libero arbitrio (la
"libertà di"), il contesto in cui mi trovo ad
operare deve presupporre un certo livello di
contingenza, giacchè, affinchè io possa scegliere
A anziché B, occorre che l’ordine esterno delle
cose sia tale da consentire tanto la realizzazione
di A quanto quella di B: ciò significa che non
deve essere già predeterminato che si verifichi A
anziché B. Questa condizione di
indeterminatezza non è invece richiesta dal
modello della "libertà da", il che sembrerebbe a
dir poco assurdo: come si può, infatti, parlare di
libertà e, al contempo, ammettere che viga un
determinismo in forza del quale sia già decretato
che si verifichi A piuttosto che B? Tale assurdità
cessa di essere tale se teniamo presente che a
togliere la libertà non è la necessità in sé, ma
solamente quella esterna, ovvero quel che agisce sul soggetto essendo ad esso esterno. Anche le forze interne
(ad esempio le passioni o le abitudini) vengono considerate come esterne alla razionalità del soggetto agente,
sicché se mi trovo ad esser determinato dalle mie passioni nell’agire sono coatto da qualcosa a fare ciò che la
mia ragione mi indurrebbe a non fare: se ne evince che anche ciò che pare di primo acchito essere una forza
interna (le passioni), è in realtà esterna, in quanto opponentesi alla razionalità del soggetto. Se questi agisce
mosso da un principio di razionalità assoluta, allora agisce seguendo una necessità che rispecchia l’ordine
necessario del mondo: non è costretto da forze esterne, ma obbedisce ad un principio necessario dell’azione,
essendo in tal modo libero in quanto la forza che mi condiziona è identica alla mia stessa soggettività: in altri
termini, sono io stesso quella forza. In questo senso, la libertà risulta conciliabile con la necessità: il caso
paradigmatico di questa concezione è rappresentato da Spinoza, per il quale l’uomo che segue la necessità
imperante nel cosmo realizza la sua libertà, intesa ovviamente non come facoltà di scegliere A anziché B,
bensì come "libertà da" costrizioni. Sotto questo profilo, il livello della libertà intesa come negativa e come
positiva viene un po’ corretto e sfumato, giacchè la "libertà da" porta ad identificarsi con il principio causale
dell’agire, che così cessa di essere vincolante e negativo. Tuttavia, deve essere sottolineato come, se il
problema della libertà è così complesso e irrisolvibile, ciò sia dovuto precipuamente alla difficoltà e alla
polisemia dei termini impiegati nell’affrontarlo, tali da non afferrare mai del tutto che cosa realmente la
libertà sia: se almeno si sapesse con certezza che cosa essa sia, si potrebbe per lo meno univocamente capire
se l’uomo ne sia equipaggiato oppure no. Invece risulta assai arduo, ancor prima di decidere se l’uomo sia
libero o no, capire che cosa effettivamente la libertà sia, e ulteriori complicazioni sono introdotte dal fatto
che, accanto ai due modelli da noi proposti, se ne sono sviluppati molti altri da essi derivanti.
I GRECI
Dopo aver preso atto di quanto sia difficile la problematica, possiamo allora chiederci quando storicamente
ci si sia per la prima volta interrogati su di essa: la cultura greca, pur così acuta e ingegnosa, non si pose più
di tanto il problema della libertà, prova ne è il fatto che la lingua greca sia sprovvista di un termine che
designi propriamente la "libertà", tenendo conto che designa esclusivamente la libertà in sede
politica (libertà dalla tirannia, dai Persiani, ecc) e ha ben poco a che vedere con la possibilità di riconoscere
all’uomo una responsabilità dell’azione. Non è poi un caso che nelle tragedie, che dello spirito greco furono
il vertice, il coro, per spiegare le azioni dei protagonisti, faccia costante riferimento alla , alla
e alla , tutte forze che condizionano l’uomo impedendogli di esercitare qualsiasi forma di
libertà. Anche quando si fa più vivo il senso della responsabilità - e ciò avviene con le scuole fiorite in età
ellenistica - e spiccato diventa l’interesse etico, la giusta azione dell’uomo non è mai sottrazione alla forza
che regna nell’universo, ma anzi adeguamento ad essa, intesa come razionalità positiva (il degli
stoici) - permeante ogni cosa, ivi compreso l’uomo - a cui conformarsi o a cui opporre stupidamente
resistenza, come fa il cane che, legato al carro, anziché seguirlo sua sponte, gli si oppone, con il risultato che
è da esso ugualmente trascinato, ma con maggiori sofferenze. Questa concezione è sinteticamente
compendiata da Seneca: ducunt volentem fata, nolentem trahunt. Già Gorgia, nel comporre il suo Encomio di
Elena, di questa donna universalmente disprezzata come fedifraga, la giustifica spiegando che è stata
persuasa dalla parola - la quale può tutto - e che dunque non avrebbe potuto agire altrimenti. Si affaccia cioè
la prospettiva che anche il linguaggio sia un’altra di quelle forze estrinseche che necessitano gli uomini (e le
donne), e non è un caso che Nietzsche scorga l’esordio del crollo greco proprio in Socrate e in Euripide, che
per primi hanno cercato nell’uomo una responsabilità dell’agire. Anche in Platone e Aristotele il problema
della libertà umana è molto opaco e, per così dire, solo accennato: data l’incredibile statura di questi due
pensatori, ciò non fa altro che avvalorare la nostra tesi secondo cui la cultura greca era ancora troppo poco
matura per interrogarsi seriamente su tale problematica, alla quale forse solo Epicuro dedica degna
attenzione quando - nella Lettera a Meneceo - sente il bisogno di sconfessare il determinismo derivante dalla
. In Platone compare un accenno alla possibilità di scegliere liberamente, ma è una comparsa
cursoria e, per di più, all’interno di un mito: si tratta del famoso mito di Er (esposto nel libro decimo della
Repubblica), di questo glorioso quanto esotico guerriero morto e risorto che narra ciò che accade nell’aldilà;
egli racconta che le anime, prima di incarnarsi e di riprendere il loro ciclo vitale sulla terra, hanno
l’opportunità di scegliere il tipo di vita a cui andare incontro e - osserva Platone - la scelta non è assoluta,
poiché chi sceglie per primo non ha più possibilità rispetto a chi sceglie per ultimo con minor disponibilità di
scelta. A contare realmente nello scegliere liberamente è, invece, la saggezza, cosicché il primo a scegliere riferisce Er a riguardo di ciò che lui stesso ha visto - dà prova di stoltezza nel voler reincarnarsi in un tiranno,
mentre l’ultimo - Ulisse stesso - si rivela intelligente nell’optare per una vita comune, quieta e senza lodi o
accuse. Poi però Platone non tornerà più su queste idee, qui accennate in forma mitologica, ma si può notare
come la scelta descritta da Er sia comunque una scelta esclusivamente iniziale, tale per cui ciascuno di noi
sceglie all'inizio in quale vita calarsi ma, dopo di che, non ha più libertà di scelta, il che ben rispecchia
l’adesione platonica all’imperativo socratico - ostacolante a monte la possibilità di un’autentica scelta tra
bene e male - dell’impossibilità di scegliere deliberatamente il male: ad avviso di Socrate - qui risiede il suo
"intellettualismo etico" -, nessuno compie il male volontariamente, bensì lo fa solamente perché ignora la sua
reale entità, cosicché basta sapere che cosa sia il male per evitarlo. Contro questo principio socratico secondo
cui sarebbe impossibile scegliere scientemente il male si schiera Aristotele, il quale obietta che, se le cose
stessero davvero in quei termini, non si spiegherebbe perché vengano comminate pene a chi fa il male ed
elargiti premi a chi fa il bene, come se effettivamente sussistesse la responsabilità dell’agire negata da
Socrate. Si tratta allora - nota Aristotele - di rinvenire un principio di imputabilità per stabilire che - il
paragone è aristotelico - siamo padri delle nostre azioni non meno che dei nostri figli: per fare ciò, lo
Stagirita elabora un’attenta distinzione tra azioni volontarie () e azioni involontarie (): le
seconde sono compiute "per costrizione () e per ignoranza ()", mentre le prime sono quelle "il
cui principio risiede nel soggetto che conosce le condizioni in cui si svolge l’azione". In questo senso,
l’ dell’agire non è a me esterno, ma sono io stesso a sceglierlo spontaneamente, in quanto il soggetto
ha conoscenza della situazione (è questa una concessione all’intellettualismo etico di Socrate): se ne evince
che spontaneità e consapevolezza costituiscono il motore dell’agire volontario. Si affaccia per la prima volta
sullo scenario greco il principio di imputabilità, che garantisce la responsabilità dell’azione, anche se in
realtà Aristotele ritiene poi che alla base di tali azioni (volontarie o involontarie che siano) vi sia sempre una
, ossia un "desiderio": e allora in che cosa consisterà la volontarietà? Non si può certo scegliere il
desiderio di volere una cosa: lo troviamo anzi già in noi, cosicché la volontarietà non riguarda l’oggetto
desiderato, ma l’accondiscendere o meno a tale desiderio e, soprattutto, lo scegliere i mezzi grazie ai quali
appagare il desiderio stesso. L’elemento della libertà è quindi meramente funzionale, giacchè non posso
scegliere i miei desideri né la mia ("volontà"), che anzi mi son dati come ineludibili punti di partenza.
Sarò allora libero di scegliere i mezzi per realizzarli, ma non potrò scegliere se avere o no tal desiderio e tale
volontà: lo stesso momento decisionale - che Aristotele chiama , "preferenza" - altro non è se
non il preferire certe cose ad altre (ritenendo queste ultime meno utili ed efficaci rispetto alle prime), ma non
si tratta mai sensu stricto di una "libertà di", giacchè è sempre e comunque soggiogata alla e alla
. In questo senso, è lecito affermare che in Aristotele manchi tanto la "libertà di" quanto la "libertà
da".
I CRISTIANI
Col tramonto della cultura greca e il sorgere di quella cristiana si inverte rotta, in primis perché il
cristianesimo propugna una concezione personale di Dio, tale per cui sussiste un’analogia tra Dio e l’uomo
anche sul piano delle facoltà spirituali: Dio non è solo pensiero (come credeva invece Aristotele), ma è anche
- e soprattutto - volontà, e tale dualismo si riverbera sull’uomo, che è stato creato a Sua immagine e
somiglianza. Sicchè l’uomo, oltre a pensare, sa anche volere liberamente: la priorità in Dio della volontà
sull’intellettualità costituisce il cavallo di battaglia della tradizione cristiana non tomista (Duns Scoto e
Guglielmo da Ockham soprattutto), poiché al Dio come mero pensiero rispecchiante l’ordine del cosmo (a
cui Egli non può sottrarsi) si sostituisce un Dio onnipotente, tale da poter liberamente fare ciò che vuole, a tal
punto da determinare secondo la Sua volontà le leggi del pensiero: alcuni filosofi medioevali arriveranno a
dire che due più due fa quattro perché Dio ha deciso così, ma se Egli avesse deciso che facesse cinque, allora
due più due farebbe cinque. Da qui prende le mosse una lunga tradizione volontarista (tipicamente
francescana) che fa dell’uomo un ente pensante e - soprattutto - capace di scegliere liberamente se fare il
bene oppure il male. Nella cultura greca le azioni erano riflesso di una legge generale corrispondente ora al
, ora alla , ora alla , e ciò si trascina in parte fino ai cristiani, che molto ereditano dal
mondo greco: in particolare, questo strascico della cultura antica affiora in seno al cristianesimo nella
concezione ch’esso ha della Provvidenza come forza imperscrutabile che regge, trascendendolo, il mondo;
nel mondo musulmano, poi, ciò è ancora più forte, in quanto l’Islam è - letteralmente - una totale
sottomissione. Accanto a questa ripresa di modelli greci - seppur largamente modificati - compare anche
l’innovativo elemento del premio e del castigo, in virtù del quale, a seconda che si sian rispettate o meno le
prescrizioni divine su questa terra, si ricevono punizioni o compensi nella vita ultraterrena. Nell’ebraismo si
trattava soprattutto di punizioni collettive e terrene (specialmente cataclismi naturali, alluvioni, terremoti,
ecc), mentre nel cristianesimo sono di ordine individuale, cosicché ciascun individuo finisce per avere la sua
propria responsabilità, a cui è legata a filo doppio la libertà dell’arbitrio. E’ questa, al contempo, una "libertà
di" e una "libertà da", con la conseguente maturazione del diritto a un premio o a un castigo nell’aldilà.
Quest’insistenza sulla libertà è testimoniata da innumerevoli passi di autori cristiani: così Giustino dice che
"l’uomo compie o omette il giusto per libera scelta", Clemente Alesandrino parla addirittura di una
di scegliere il bene oppure il male, e Gregorio di Nissa riferisce di una
Siffatto atteggiamento è poi sollecitato, oltreché dalle dottrine cristiane, dal fatto
che l’imputabilità delle azioni fosse messa in forse dalla tradizione greca (specialmente nella sua veste
stoica) e, soprattutto, da alcune eresie che pullulavano ai confini della cultura cristiana, primi fra tutti i
Manichei, i quali, concependo il mondo come il teatro dello scontro tra il Bene e il Male e intendendo le
azioni umane come il manifestarsi di quei due stessi princìpi, finivano per spogliare l’uomo di ogni
responsabilità personale. E’ soprattutto Agostino a brandire la spada della critica contro i Manichei, lui che
in gioventù era stato uno di loro: sia nel De libero arbitrio sia nel De duabus animabus contra Manicheos,
egli insiste su come il male sia da noi accettato per libera scelta. "Nessuno è costretto a esser schiavo del
piacere", dice Agostino, e rincara la dose aggiungendo che "la volontà è un moto dell’anima senza nessuna
costrizione esterna o a non accettare qualche cosa o a ricercare qualche cosa". L’altra faccia della medaglia
del cristianesimo - accanto a quella della libertà dell’arbitrio - era quella data dal riconoscimento
dell’assoluto dominio della Provvidenza sulla natura e sul mondo umano (dominio espresso bene dal motto
popolare "non cade foglia senza che Dio lo voglia"): ora, è evidente che, almeno in apparenza, risulta
impossibile una convivenza tra la libertà dell’agire e la forza provvidenziale, in virtù della quale tutto è
decretato dai disegni divini. Uno dei grandi problemi contro cui si scontra la teologia cristiana sarà appunto
quello di ricercare una conciliazione tra questi due princìpi, ma raramente si riuscirà in questo intento, poiché
il più delle volte prevarrà il carattere necessitante o quello del libero arbitrio, e l’egemonia dell’uno o
dell’altro dipende anche dall’esigenza di difendere dogmi cristiani dai pericoli eretici che via via si
manifestano esaltando ora la libertà umana (e negando la Provvidenza) o, viceversa, celebrando la
Provvidenza a scapito della libertà. Accanto al manicheismo e al bipolarismo da esso propugnato, sorgono
altre eresie, altrettanto insidiose: e così, nell’ultima parte della sua vita, Agostino si trova indaffarato a
combattere contro in Pelagiani, i quali sostenevano l’assoluta libertà dell’uomo, svincolato da ogni principio
necessitante a tal punto che il peccato di Adamo non si sarebbe trasmesso agli altri uomini; ciò era
evidentemente inaccettabile in una ortodossa prospettiva cristiana, tanto più che i Pelagiani vedevano Cristo
semplicemente come un uomo dalla perfetta condizione morale. Contro di essi, Agostino fa ora leva sulla
Provvidenza, giungendo a propugnare la predeterminazione e, in tal modo, contraddicendo palesemente
quanto sostenuto contro i Mancichei, quando aveva parlato di una libertà assoluta nell’uomo: il libero
arbitrio - egli obietta ora contro i Pelagiani - si ha solo nella condizione in cui si è trovato Adamo, libero di
scegliere se peccare o no; ma dopo il suo peccato originale tale facoltà è svanita ed è rimasta un appannaggio
meramente teorico, cosicchè l’umanità è divenuta una massa dannata costretta a peccare e priva di libertà
d’arbitrio. Da questa condizione, tuttavia, l’uomo è risollevato dall’opera di redenzione di Cristo e
dall’intervento della Grazia divina, frutto di un gratuito dono di Dio in favore dell’uomo e tale per cui
quest’ultimo non può più peccare: anche in questo caso, dunque, non potendo più peccare (e cioè non
essendo libero di peccare) l’uomo non è dotato di libero arbitrio più di quanto lo fosse prima dell’intervento
della Grazia, quando non poteva non peccare. In realtà, questa posizione di Agostino non è radicalmente
nuova, ma è già presente nelle Scritture, in particolare nell’autore che più di tutti fu promotore della
concettualizzazione del cristianesimo: Paolo di Tarso, che in una delle sue tante epistole (la Lettera ai
Romani, 6) inviate alle comunità cristiane al fine di dare loro i quadri teorici entro cui orientarsi, sostiene che
l’uomo entra in stato di Grazia non per suo merito, ma in virtù della redenzione di Cristo: "il peccato infatti
non dominerà più su di voi poiché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque? Dobbiamo
commettere peccati perché non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia? È assurdo! Non sapete voi che,
se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi per obbedirgli, siete schiavi di colui al quale servite: sia
del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia? Rendiamo grazie a Dio,
perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato
trasmesso e così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia". Il presupposto filosofico che
soggiace a tal pensiero è che l’uomo sia necessariamente in schiavitù, cioè sottomesso e mai libero, cosicché
l’alternativa tra esser sottomessi al peccato o essere sottomessi alla Grazia non implica in alcun caso
l’esistenza della libertà di scelta. Più che di un’alternativa si tratta allora di una non-alternativa. L’unico vero
atto di libera scelta è stato quello compiuto da Adamo, attraverso il quale è stato scelto il male: la posizione
paolina è ben più radicale di quella platonica del mito di Er, secondo cui si sceglie sì solo una volta all’inizio
della propria vita, ma ciò vale per ogni singolo individuo e non per uno solo che sceglie per tutti. A sua volta
la posizione paolina godrà di grande fortuna (e sarà portata alle estreme conseguenze) presso i Riformati
luterani: fino a quel momento l’esigenza della libertà conviveva in certo modo (spesso contraddittoriamente)
con l’incontrastata egemonia della Provvidenza, cosicché queste due istanze antitetiche venivano
sapientemente coniugate in maniera tale che la libertà umana non si spegnesse mai del tutto di fronte
all’incontrastata Provvidenza; le soluzioni prospettate dagli autori cristiani erano spesso puerili e ricche di
contraddizioni - Calvino parlerà a tal proposito, con irrisione, di frivolum effugium: la meno credibile era
senz’altro quella imperniata sulla distinzione tra Provvidenza e prescienza, distinzione tale per cui Dio sa
tutto quel che avverrà, ma non lo determina, lasciando dunque che sian gli uomini stessi a decidere; in questi
termini, Dio si limita a sapere che cosa l'uomo sceglierà (perciò si parla di "prescienza") senza però intaccare
la sua libertà d’arbitrio. La Riforma rappresenta una svolta epocale nella cultura cristiana in primis perché
Lutero estirpa ogni ambivalenza e, conseguentemente, ripropone gli effetti della posizione di Paolo attraverso la mediazione di Agostino - portandoli all’ennesima potenza: nel De servo arbitrio (1525) Lutero
arriva a dire che "Dio non ha alcuna prescienza in forma contingente […]. Compie ogni cosa con
immutabile, eterna, infallibile volontà". La conseguenza logica di siffatta prospettiva è che "qualsiasi cosa
venga da noi compiuta non è opera del libero arbitrio, ma della pura necessità": il discorso sulla salvezza va
dunque rivisitato, giacché è assurdo illudersi di potersi guadagnare la salvezza con quelle che noi crediamo
essere opere compiute liberamente ma che in realtà sono frutto di un arbitrio "servo" e necessitato. Tale
posizione viene radicalizzata da Calvino nel 1536, nella sua Institutio Christianae religionis, in cui riprende
la scansione agostiniana che porta dall’originale scelta peccaminosa di Adamo alla conseguente servitù al
peccato dell’uomo, fino alla salvezza predestinata, una sorta di doppia predestinazione per cui Dio avrebbe
ab aeterno diviso l’umanità in un gruppo di pochi eletti che si salveranno e in un altro di dannati che
andranno in rovina. E pertanto - dice Calvino - le buone azioni non sono il frutto di una presunta libera
scelta, ma, viceversa, vengono compiute da chi è già stato prescelto dalla Grazia divina. In questa maniera il
libero arbitrio è del tutto azzerato: nel De libertate Christiana (1520), Lutero asserisce che l’unica libertà per
l’uomo consiste nell’esser libero dal peccato perché schiavo della Grazia. In tale ottica, la cultura cattolica,
che continua a farsi portavoce delle esigenze precedenti alla Riforma, si vede costretta a rivisitare le proprie
posizioni tenendo conto delle obiezioni sollevate da Lutero, con la conseguenza che - gradualmente verranno fatte sempre più concessioni al luteranesimo, soprattutto in sede tomistica. E tuttavia a difendere a
spada tratta il cristianesimo nella sua veste originaria, contro le folleggianti aberrazioni di Lutero, sono i
Gesuiti, le cui posizioni sono emblematicamente sintetizzate nella figura di Luis de Molina, professore in
Portogallo: egli, nel suo Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis (1588) tenta di coniugare ancora una
volta il libero arbitrio con la Grazia. Scrive Molina: "si dice libero quell’agente che, pur essendo posti tutti i
requisiti dell’agire, può agire o non agire"; egli riconosce, dunque, il fatto che per agire occorrano dei
moventi, cosicché la libertà non nasce da un punto zero, bensì devono esservi le cause che producono
l’azione ed esse, pur essendoci, non sono determinanti; sicchè l’uomo mantiene la sua facoltà (agostiniana)
di far sì che esse diventino attive e producano un effetto oppure di far sì che rimangano inattive. Ogni azione
pertanto ha sempre i suoi moventi, cosicché non sono mai io a causare le mie azioni (ed è questa una
concessione al determinismo di Lutero), ma ciononostante sono libero di lasciare che tale causa agisca, il che
significa fare una cosa oppure un’altra. Se ne evince che, in siffatta ottica, il libero arbitrio altro non è se non
il sospendere alla radice un meccanismo deterministicamente procedente. Per difendere la Provvidenza, poi,
senza perciò seppellire la libertà, Molina ricorre ad uno scaltro quanto brillante espediente: il "concorso
simultaneo", per cui ogni evento scaturisce dalla intima cooperazione di ben due cause. La prima corrisponde
all’intervento di Dio (che di tutte le cose è autore), la seconda riguarda invece l’azione di un agente creato:
sicchè da un lato Dio è il principio della causalità e, in questo senso, è autore di tutto ciò che avviene, ma,
dall’altro lato, quale sia la causa specifica che si attiva nel momento X, ciò dipende dall’intervento di una
creatura. Dunque, per i fatti fisici l’azione della creatura è sempre data da un corpo naturale che non può
agire altrimenti da come agisce: così il fuoco riesce a scaldare la pietra perché vi è la causalità generale
garantita da Dio e, in aggiunta, la specifica proprietà di bruciare peculiare del fuoco. Nel caso dei fatti
morali, poi, da una parte c’è sempre l’influsso di Dio come causa generale, ma, dall’altra, c’è la libera
volontà dell’uomo, che può applicare la causalità divina o lasciarla inoperante. Ad esempio, se siamo indotti
per passione a compiere un delitto, da un lato c’è la possibilità di essere causa di tal delitto (e ciò deriva da
Dio), dall’altro però come causa seconda io posso decidere se rendere operante tale causalità (e compiere il
delitto) o renderla inattiva (astenendomi dal compiere il delitto).
CARTESIO
La soluzione prospettata al problema della libertà dai Gesuiti - soluzione che andrà per la maggiore nel
Seicento, pur essendo facilmente attaccabile per via della sua eccessiva macchinosità - si oppone alla
necessità ammessa dai Luterani e dai Calvinisti e riconosce un irrinunciabile ambito di libertà all’agire
umano. Quando la filosofia moderna, che personifichiamo innanzitutto con Cartesio, viene a trattare del
problema della libertà, si trova immediatamente dinanzi ad un terreno ingombro da molto materiale: da un
lato, c’è la lineare e drastica soluzione dei Riformati - negatori di ogni libertà -, dall’altro vi è invece la
compromissoria posizione dei Gesuiti, in cui si cerca concordanza fra aspetti che difficilmente paiono poter
stare insieme. Queste due alternative rientrano nell’unica cornice della discussione teologica della libertà,
tale per cui la problematica della libertà si trova ad essere subordinata a quella inerente Dio. L’ulteriore
alternativa possibile consisteva allora nello smarcarsi dalla teologia e nel considerare finalmente il problema
della libertà esclusivamente in riferimento all’uomo e alle sue realizzazioni: ciò significava dare una
soluzione esplicitamente filosofica, ed è appunto questa la controversa strada imboccata da Cartesio, la quale
sarà via via condannata o rinforzata dai pensatori successivi, che da essa prenderanno le mosse. Il primo
tentativo di Cartesio di fronteggiare la problematica della libertà resta però ancora saldamente vincolato alla
prospettiva teologica e risulta essere autenticamente fallimentare: la prima prova a sostegno della debolezza
di Cartesio sta nel fatto che egli sia indeciso e continui a fluttuare tra posizioni opposte, a tal punto da
sostenere dapprima il libero arbitrio e, secondariamente, la necessità assoluta. Così, in Le passioni
dell’anima (articolo 146), egli asserisce che "dobbiamo renderci conto che tutto è guidato dalla
Provvidenza": tutto ciò che accade è necessario - dice Cartesio -, ma Dio ha limitato la sua stessa
Provvidenza per lasciare un margine di libertà all’agire umano; naturalmente quest’idea di una Provvidenza a
pelle di leopardo fa acqua da tutte le parti, ma non più di quella - sostenuta in una lettera a Elisabetta, datata
3 novembre 1645 - in cui Cartesio si fa foriero di posizioni diametralmente opposte: qui egli dice che, se
badiamo esclusivamente all’uomo, non possiamo accorgerci di come qui esista un libero arbitrio, ma tutto
cambia se guardiamo le cose in connessione alla Provvidenza: ci accorgiamo, in questo caso, di come anche
il nostro libero arbitrio dipenda da essa (in questo modo la zona franca di libertà riconosciuta nello scritto Le
passioni dell’anima è cancellata), poiché altrimenti ci si troverebbe costretti a dire che la Provvidenza è al
contempo infinita e finita (perché autolimitantesi). Qualcosa di analogo Cartesio sostiene in un’epistola del 6
ottobre 1645, in cui afferma a chiare lettere che sostenere un libero arbitrio indipendente da Dio
significherebbe negare la sovrana perfezione di Dio, il quale "non sarebbe sovranamente perfetto se nel
mondo potesse capitare qualcosa che non dipenda interamente da Lui". E la filosofia ci fa conoscere che
"nello spirito dell’uomo non potrebbe entrare il minimo pensiero senza che Dio lo voglia". Si prospettano
dunque due esigenze che cozzano fra loro e che Cartesio prova a conciliare: che sian conciliabili - egli nota lo attesta automaticamente l’esperienza del libero arbitrio che ciascuno fa, in questo mondo retto dalla
Provvidenza, guardando dentro se stesso; e, per argomentare tale conciliazione, Cartesio compie un passo
decisamente malriuscito e goffo, provando a chiarirsi con un esempio: immaginiamo un gran signore che
abbia proibito i duelli all’interno del suo regno e che però sia al corrente che due suoi vassalli si odiano a tal
punto che sicuramente si batteranno nel caso in cui si incontrino; immaginiamo ora che il sovrano decida che
essi si incontrino per strada e duellino fra loro, contravvenendo le prescrizioni stesse del sovrano, il quale
sapeva che si sarebbero scontrati e li ha fatti appositamente incontrare. Similmente, sussiste una volontà
assoluta per cui Dio prevede come avverranno le cose, ma ciò non toglie che sussista anche un’azione
relativa di Dio che comanda agli uomini di fare certe cose ed evitarne altre, cosicché non li costringe a far le
cose proibite, ancorchè li metta in condizione di farle. Bayle obietterà a Cartesio che in realtà il signore di cui
ha parlato fa di tutto affinchè i due vassalli si incontrino, mettendo così in luce l’inaccettabilità della
posizione cartesiana. E prosegue Bayle nella critica a Cartesio: immaginiamo un padre che voglia far morire
il primogenito: può farlo uccidere da un sicario oppure provocargli un dolore così grande che sia egli stesso a
suicidarsi: non vi è differenza, giacchè l’effetto sortito è il medesimo, con la sola differenza che nel secondo
caso si ha l’impressione che il figlio si uccida liberamente. La stessa cosa avviene nella prospettiva delineata
da Cartesio, dice Bayle. Ma Cartesio stesso era in certa misura consapevole della debolezza dei suoi
argomenti e, pertanto, nei Princìpi di filosofia, riprende lo stesso problema e ripete la tesi della conciliabilità
fra Provvidenza e libertà, ma dicendo - molto più modestamente - che di tale compatibilità siam certi come
credenti ma non possiamo renderne conto con la ragione. E’ questo l’abbandono del problema teologico del
rapporto tra libertà e Provvidenza all’ambito della fede; viene in questa maniera aperta la possibilità di
impostare la problematica della libertà non più in riferimento a Dio (giacchè in tale ambito solo la fede può
illuminarci), ma in riferimento all’uomo, in quell’ambito cioè in cui la ragione può procedere con sicurezza.
La soluzione prospettata da Cartesio per il problema della libertà si basa sul cardine della sua stessa
metafisica: quel dualismo in virtù del quale sussistono due sostanze separate ed autonome; da un lato, la
sostanza pensante (res cogitans) e, dall’altro, la sostanza estesa (res extensa). La separatezza tra le due
induce Cartesio a pronunciarsi circa la loro eterogeneità, in forza della quale si potrà imputare la libertà alla
sostanza pensante e relegare la successione causale deterministicamente intesa alla sostanza estesa. Per
dimostrare ciò, Cartesio si avvale di una definizione scolastica della sostanza, concepita come "ciò che non
ha bisogno che di se medesima per esistere" (Princìpi di filosofia, paragrafo 51): così intesa, la sostanza è ciò
che esiste autonomamente; successivamente, però, Cartesio torna sui propri passi e si accorge che tale
definizione si attaglia solo a Dio, perché Lui solo è causa sui, ossia Lui solo basta a se stesso per esistere; per
questo motivo, il pensatore francese corregge la definizione e arriva a dire che la sostanza è ciò che per
esistere non ha bisogno di nulla, fuorchè di Dio. Stando a questa precisazione - che sarà duramente criticata
da Spinoza -, il concetto di sostanza può essere applicato al creato nella sua totalità: in questa maniera, si
vengono ad avere due diversi tipi di sostanza, giacché solo due son le realtà che in effetti sussistono
indipendentemente: il pensiero e l’estensione, nel senso che l’estensione non dipende dal pensiero e
viceversa. Tra le due realtà manca dipendenza reciproca in quanto gli attributi - ovvero le qualità essenziali delle due sono radicalmente diverse e indipendenti tra loro: le une sono sostanze intelligenti, le altre son
sostanze corporee; alle prime competono il pensiero, la volontà, la spiritualità, ecc, alle seconde ineriscono
invece la profondità, la larghezza, ecc. L’unico aspetto comune che lega in certo modo la res extensa e la res
cogitans sta nell’essere dipendenti entrambe da Dio. Questo esasperato dualismo è il punto di partenza della
filosofia di Cartesio: e se consideriamo i corpi, subito ci accorgiamo di come essi siano caratterizzati
dall’inerzia meccanica, dal fatto che le loro relazioni reciproche sono date sotto forma di rapporti di causalità
necessaria tali per cui tutto è meccanicamente regolato (si noti che ciò vale tanto per la natura fisica esterna
quanto per l’organismo umano, concepito alla stregua di una macchina assolutamente assimilabile ad un
automa, per cui i muscoli sono come i tiranti, i nervi come i tubi, e così via). Questo rigoroso materialismo
concernente i corpi trova il suo contraltare nel pensiero o, se riferito agli uomini, nell’anima, la quale opposta al corpo - non ha ampiezza, lunghezza e inerzia, ma, viceversa, è spontanea, vivace ed irriducibile al
meccanismo causale necessario, cosicché il soggetto causa molte cose senza a sua volta essere causato.
Asserire che il pensiero è attività spontanea equivale a dire che esso è libero e incondizionato: ecco perché
Cartesio, in più luoghi della sua opera, sostiene che la libertà non ha bisogno di essere dimostrata, in quanto
la sentiamo immediatamente dentro di noi in tutta la sua evidenza. In questo modo, Cartesio è padre di due
correnti filosofiche antitetiche: grazie alla res extensa, egli è padre del materialismo settecentesco, che
giungerà all’apice con la concezione dell’uomo-macchina di La Mettrie, e, grazie alla res cogitans, è padre
dello spiritualismo, specialmente di quello francese. La sua è dunque una doppia paternità: l’anima diventa
un mondo a sé o, per dirla con Spinoza, un impero dentro l’impero. Ora, la forza della posizione di Cartesio
risiede tutta nella totale indipendenza dell’anima dal corpo, e ciò gli consente una fondazione assoluta della
libertà, tale per cui basta guardare in se stessi per accorgersi di essere liberi: si tratta però di una posizione
indimostrabile, di fronte alla quale ci si trova costretti "a prendere o a lasciare". Il dualismo ontologico e
metafisico che fonda la libertà finisce poi per creare seri problemi a Cartesio, giacchè finchè consideriamo il
rapporto tra le due res, possiamo pensare che esistano due mondi a sé stanti (quello spirituale e quello
materiale) senza interferenze reciproche, ma non appena rivolgiamo l’attenzione all’uomo, tale indipendenza
pare difficilmente giustificabile, in quanto l’uomo è anima e corpo, sintesi perfetta di quelle realtà che
abbiam detto essere separate. Come si spiegherà, ad esempio, il fatto che l’impressione del freddo generi
idee, con un evidente passaggio dalla materia al pensiero? O, al contrario, come renderemo ragione del fatto
che io voglia agire sul mondo esterno e il mio atto di volontà si traduca in movimenti corporei? Ciò vale
anche per le passioni (amore, odio, ira, gelosia, ecc), che sono da Cartesio considerate come movimenti degli
"spiriti animali", cosicchè mi adiro perché nel mio corpo si genera un turbinio di particelle che si scatenano e
il corpo muta; ma le passioni sono anche passioni dell’anima, cosicchè l’ira - oltre a modificarmi
fisiologicamente - mi fa sentire diversamente nella mia interiorità (ad esempio, avrò volizioni cattive verso
qualcuno); sempre le passioni indicano il passaggio dall’anima al corpo: se infatti la morale consiste nel
dominare stoicamente le passioni, allora l’anima deve agire sul corpo tenendolo a freno il più possibile. Tutti
questi esempi rivelano come nell’uomo anima e corpo entrino in conflitto tra loro, il che crea non pochi
problemi a Cartesio: come può l’anima - che è del tutto diversa dal corpo - agire su di esso? E, nel caso in cui
ciò sia possibile, non si crea forse un inquinamento tra la libertà dell’anima e la necessità del corpo? Cartesio
cerca di togliersi d’impiccio asserendo che anima e corpo sono strettamente congiunti pur restando tra loro
indipendenti: per spiegare tale congiunzione, occorre superare l’ostacolo rappresentato dal fatto che nel
corpo la comunicazione avviene causalmente e nell’anima no; per superare tale ostacolo, Cartesio ricorre alla
poco convincente soluzione della ghiandola pineale, ossia di una particolare ghiandola, ubicata nel cervello,
che, pur essendo un organo fisico, è così sensibile e sottile da poter apprezzare sia le sollecitazioni materiali
del corpo sia quelle incorporee dell’anima. La ghiandola pineale può cioè esser mossa sia dagli "spiriti
animali" che percorrono senza tregua il corpo sia dall’impalpabile azione della volontà: tuttavia su come ciò
avvenga, Cartesio tace. Sicchè egli fa del dualismo la struttura portante del suo pensiero e poi deve
continuamente correggerlo, ipotizzando una costante interazione tra le due sostanze indipendenti: è questa
una debolezza intrinseca del sistema cartesiano, che gli costerà le critiche più severe. Da un lato, grazie al
dualismo, egli può affermare vivamente la libertà dell’anima, dall’altro l’esigenza di limitare e correggere il
dualismo stesso con un modello enigmaticamente interattivo riduce e cancella al massimo questa fondazione
della libertà: consolidando il sistema interattivo, viene ad essere fiaccata la libertà. Le difficoltà teoriche
emergenti dalla soluzione cartesiana sono state brillantemente colte da Gilbert Ryle, che - nel suo The
concept of mind (1949) - ha parlato di un vero e proprio dogma dello spettro nella macchina: Cartesio - nota Ryle - descrive il corpo come una macchina e poi in essa situa uno spettro che, essendo altro dalla natura
fisica, non è ben chiaro come possa reggere la macchina. Sicchè l’anima finisce secondo Ryle per essere in
Cartesio un fantasma magicamente operante in un corpo non diverso da una macchina. Accanto alla testè
illustrata giustificazione metafisica della libertà, Cartesio ne escogita un’altra, tutta interna all’anima, senza
impantanarsi più con la res extensa: egli instaura un dualismo interno all’anima tra volontà ed intelletto.
Abbiam visto come nel cristianesimo l’intelletto e la volontà fossero le due prerogative fondamentali di Dio
(con un netto primato della volontà) e come di esse si trovasse un riflesso anche nell’uomo: anche Cartesio si
incammina lungo questa via, per dimostrare come nell’anima umana convivano l’intelletto e la volontà e
come la seconda sia prioritaria rispetto alla prima. Cartesio nota che se io considero il mio intelletto mi
accorgo subito di come esso sia infallibile, anche se limitato quantitativamente: conosce poche cose, sì, ma le
conosce in maniera perfetta. Sull’altro versante, se concentro l’attenzione sulla volontà, subito mi avvedo di
come essa, intesa come libertà di scelta, sia illimitata, giacchè posso volere tutto ciò che la mia mente forma:
sotto questo profilo, è dunque possibile dire che "latius patet voluntas quam intellectus". "Mi posso
lamentare di non aver ricevuto da Dio una volontà o libertà di arbitrio non sufficientemente ampia e
perfetta; vedo infatti che non è certamente circoscritta da alcun limite. E cosa che mi sembra molto degna di
nota in me non vi sono altre cose tanto perfette o tanto estese, che, a mio giudizio, non possano essere più
perfette o più grandi. Se, ad esempio, considero la facoltà di comprendere, subito riconosco che essa è assai
incompleta e molto limitata in me - e nello stesso tempo io mi formo l'idea di un'altra facoltà molto più
grande, ed anzi assoluta ed infinita - e per il solo fatto che posso concepire l'idea di lui, comprendo che essa
appartiene alla natura di Dio. Allo stesso modo, se esamino la facoltà di ricordare o di immaginare, o
qualunque altra, non ne trovo nessuna, che non comprenda essere in me tenue e circoscritta, in Dio
immensa" (Meditazioni metafisiche, IV). La maggiore estensione della volontà rispetto all’intelletto presenta
importanti conseguenze anche a livello gnoseologico: viene infatti impiegata da Cartesio per spiegare
l’errore; essendo infallibile l’intelletto, l’errore viene imputato alla volontà, la quale pretende - in quanto
infinita - di dare l’assenso o il rifiuto prima che vi siano gli elementi conoscitivi adeguati: anche in sede
morale, poi, posso per volontà dare l’assenso al male, travalicando pertanto le prescrizioni dettate
dall’intelletto. In questo modo, la volontà diventa centrale per quel che riguarda la libertà, poiché ovviamente
se la volontà fosse subordinata all’intelletto, allora non potrebbe volere qualsiasi cosa (vorrebbe solo il
giusto) e non vi sarebbe libertà assoluta, bensì l’uomo dovrebbe adeguarsi ad un ordine della realtà rivelato
dall’intelletto. Se, viceversa, la volontà può andare al di là dell’intelletto, l’uomo è assolutamente libero di
volere ciò che vuole. Tali premesse parrebbero garantire una libertà assoluta ed in effetti Cartesio se ne serve
in vista di questo scopo: il pericolo è però che la libertà così fondata - su una volontà sganciata dall’intelletto
- possa configurarsi come libertà di indifferenza, ossia come capacità di decidere arbitrariamente tra A e B
senza far riferimento ad alcun criterio normativo: se così fosse, come si potrebbe stabilire che cosa è bene e
che cosa è male? L’uomo arriverebbe a scegliere il male anziché il bene e ciò con pieno diritto; per ovviare a
questo problema, Cartesio precisa che la libertà di indifferenza non è per l’uomo la più alta forma di libertà:
essa è tipica di Dio, poiché Egli, essendo onnipotente, deve essere veramente libero di volere quel che vuole,
senza essere condizionato da regole che distinguano il giusto dall’ingiusto, il bene dal male, il vero dal falso,
ecc; Dio gode di una libertà così estesa - la sua è un’assoluta "libertà di" - da essere Lui stesso a decidere che
cosa sia il bene e che cosa il male, che cosa il giusto e che cosa l’ingiusto; perfino che 2+2 dia 4 o che il tutto
sia maggiore della parte dipende dall’incontrastata volontà divina. Per l’uomo, però, tale forma di libertà non
è quella suprema, giacchè l’uomo non è un essere infinito, ma è creato da Dio e, perciò, si innesta in un
contesto in cui è Dio ad aver stabilito che cosa sia vero e che cosa falso, che cosa giusto e che cosa ingiusto;
ne segue che per l’uomo la vera libertà non è volere ciò che vuole ("libertà di"), ma volere ciò che è giusto
("libertà da"), cosicché la libertà di indifferenza è la forma più bassa e più nociva di libertà, poiché consente
di scegliere il falso anziché il vero, l’ingiusto anziché il giusto: la vera libertà consiste allora nel decidere in
conformità all’ordine decretato da Dio, e ad illuminarci sull’ordine del mondo non può essere la volontà che per sua natura non opera distinzioni -, ma l’intelletto, che così diventa il vero principio della libertà, il
faro seguendo la cui luce si è liberi; la volontà deve quindi autosubordinarsi ad esso e decidere di volere ciò
che l’intelletto dice essere bene, giusto, vero, ecc. In questo modo, Cartesio sconfessa la tradizione cristiana
dell’egemonia della volontà sull’intelletto e si ricollega direttamente a Tommaso, per il quale è l’intelletto ad
individuare la ratio boni, il criterio del bene su cui la volontà deve modularsi. Sicchè, dopo aver definito la
volontà come assoluta e indifferente, Cartesio cambia repentinamente rotta e asserisce che la capacità di
scegliere tra A e B è subordinata all’avere gli strumenti adeguati (intellettuali) per scegliere B piuttosto che
A: "poiché essa [la libertà] consiste unicamente in ciò: che noi possiamo fare una cosa o non farla (cioè
affermare o negare, seguire o fuggire); o piuttosto solamente in questo: che, per affermare o negare, seguire
o fuggire le cose che l'intelletto ci propone, noi agiamo in modo che non ci sentiamo costretti da nessuna
forza esteriore. Infatti, affinché io sia libero, non è necessario che sia indifferente a scegliere l'uno o l'altro
dei due contrari; ma piuttosto, quanto piú inclino verso l'uno, sia che conosca evidentemente che il bene e il
vero vi si trovano, sia che Dio disponga cosí l'interno del mio pensiero, tanto piú liberamente ne faccio la
scelta e l'abbraccio. E, certo, la grazia divina e la conoscenza naturale, ben lungi dal diminuire la mia
libertà l'aumentano piuttosto, e la fortificano. Di modo che questa indifferenza che io sento, quando non
sono portato verso un lato piú che verso un altro dal peso di niuna ragione, è il piú basso grado della
libertà, e rende manifesto piuttosto un difetto nella conoscenza, che una perfezione nella volontà; perché se
conoscessi sempre chiaramente ciò che è vero e ciò che è buono, non sarei mai in difficoltà per deliberare
qual giudizio e quale scelta dovrei fare, e cosí sarei interamente libero, senza mai essere indifferente"
(Meditazioni metafisiche, IV). La libertà consiste dunque, ad avviso di Cartesio, nel fatto che, affermando o
negando ciò che suggerisce l’intelletto, non mi sento coartato da una forza esterna, e ciò in forza del fatto che
l’intelletto che detta legge sono io stesso, identificantemi con la mia ragione: ed è questa - come abbiamo
visto - la definizione della "libertà da", consistente nello scegliere A o B secondo un principio che sento
come mio e come non imposto dall’esterno; la "libertà di" resta una prerogativa squisitamente divina.
SPINOZA
Il modello compromissorio avanzato da Cartesio è messo alla berlina dal pensiero immediatamente
successivo, fatta eccezione per l’Occasionalismo, che del cartesianesimo fu la scolastica: in particolare non è
accettato il dualismo cartesiano per due ordini di ragioni. In primis, esso è respinto perché sostituito da un
rigoroso monismo che assorbe la sostanza estesa e quella pensante in un’unica sostanza (è il caso di
Spinoza), oppure lo rigetta privilegiando una componente sull’altra (spesso addirittura eliminandone una
delle due): o si elimina lo spirito riducendo tutto a corpo (è il caso di Hobbes), o si riconduce l’estensione a
epifenomeno dello spirito (come fa Leibniz). In tutte le soluzioni, perfino in quella spiritualistica di marca
leibniziana, venendo a mancare il dualismo, viene di conseguenza a mancare la distinzione tra un ambito in
cui vige la libertà e uno in cui regna la necessità. Partendo tutti dal presupposto che scire est scire per
causas, questi pensatori immediatamente successivi a Cartesio sostengono in ultima istanza il determinismo,
sopprimendo in tal modo la libertà nell’agire umano. Il crollo del modello dualistico prospettato da Cartesio
che separava libertà e necessità comporta allora l’entrata in crisi della libertà e il trionfo del determinismo,
pur secondo modalità diverse da filosofo a filosofo. Il primo modello che si pone come superamento di
quello cartesiano e dei problemi che esso lasciava irrisolti è quello di Spinoza: questi accetta la definizione di
sostanza fornita da Cartesio, tale per cui essa è ciò che esiste autonomamente, ma ne trae la rigorosa
conclusione - correggendo in ciò la modifica cartesiana secondo cui sostanza è ciò che per esistere non ha
bisogno di nulla fuorchè di Dio - che esiste un’unica sostanza infinita coincidente con Dio e con la natura
(Deus sive natura). Tale sostanza infinita ha infiniti attributi, dei quali noi conosciamo solo il pensiero e
l’estensione, giacché sono gli unici due di cui partecipiamo. Per Spinoza continua a valere quel determinismo
causale di cui parlava Cartesio, cosicché il rapporto tra i corpi è dato da una sfilza di connessioni causali
necessarie e immanenti alla sostanza stessa di Dio, poiché l’estensione non è che una qualità di Dio stesso.
Per Cartesio, tutt’altro discorso valeva per il pensiero, che era una sostanza distinta e opposta all’estensione:
per Spinoza, invece, il pensiero è attributo della sostanza infinita, sicché è - alla pari dei corpi - espressione
di un’unica sostanza. La sequenza delle idee nel pensiero non è che un modo diverso di considerare quel
processo causale che abbiam visto per i corpi materiali: ne segue che anche le idee sono relazionate tra loro
secondo rigidi rapporti rigorosamente causali, senza quella libertà spontanea riconosciuta da Cartesio.
Qualunque siano i modi con cui la sostanza si manifesta nei suoi diversi attributi, tale manifestazione avviene
sempre secondo quello che Spinoza definisce un "ordine geometrico", ovvero causale: il dualismo tra
estensione e pensiero è azzerato, proprio come la possibilità che uno dei due ambiti si sottragga al
determinismo. Cartesio aveva introdotto anche un secondo tipo di dualismo, quello interno al pensiero tra
intelletto e volontà, ritenendo che i due fossero in certo senso indipendenti, poiché la volontà si estende ben
di più rispetto al pensiero. Ora anche questo dualismo è accanitamente combattuto da Spinoza, il quale dice
che esiste un unico attributo del pensiero e al suo interno la volontà e l’intelletto non sono facoltà diverse
(altrimenti tale attributo si dividerebbe in sotto-attributi), bensì sono due modi diversi di indicare il pensiero
e, di conseguenza, le singole volizioni e le singole intellezioni sono la stessa cosa, ovvero sono gli stessi
modi del pensiero: sicché se per Cartesio con l’intelletto posso concepire una data azione (ad esempio
rubare) e la volontà può dare l’assenso o negarlo a tale concezione dell’intelletto, per Spinoza, al contrario,
volontà e intelletto, volizione e intellezione, sono lo stesso modo del pensiero, manca cioè la distinzione tra
volto pratico e volto teoretico del pensare, cosicché siamo noi a chiamare in due maniere diverse una singola
idea. Ne segue che quando mi rappresento l’idea del rubare, a tale idea è necessariamente connessa una
qualche volontà, nel senso che quando penso a rubare, sto già sempre e comunque volendo o non volendo
rubare; non esiste - come invece pretendeva Cartesio - un momento meramente intellettuale in cui penso al
rubare e un momento successivo in cui voglio o non voglio rubare: una siffatta argomentazione muove da
una falsa prospettiva, dovuta al fatto che talvolta abbiamo l’impressione di pensare al rubare e, dopo, di poter
volere o non volere rubare; in realtà, stiamo - secondo Spinoza - semplicemente oscillando tra il voler rubare
e il non voler rubare, senza che ci sia il momento neutro del pensare al rubare e a cui dare o no l’assenso con
la volontà. Da ciò si evince come il fatto che io poi rubi o meno non sia frutto dell’esercizio della libertà, ma
della sequenza causale in cui mi trovo inserito. Anche sotto questo profilo, non è possibile individuare alcun
dualismo, né è possibile riconoscere una libertà che si sottragga al determinismo: la volontà è sempre
vincolata alla necessità, a tal punto da essere da Spinoza definita come "causa necessaria" e non come
"causa libera", poiché il fatto che io voglia rubare piuttosto che non rubare è causalmente necessitato
dall’anello immediatamente precedente nella catena causale. Si deve allora concludere che per Spinoza non
esiste libertà? Se per libertà intendiamo che un singolo modo possa svincolarsi dalla catena causale che lo
lega agli altri, allora non esiste alcuna libertà (intesa qui come "libertà di"). Se tuttavia la intendiamo come
"libertà da" costrizioni esterne, allora possiamo a ragion veduta sostenere che per Spinoza la libertà esiste:
essa sarà, in particolare, non una libertà di agire in un modo anziché in un altro, ma di obbedire alla propria
natura, ancorchè quest’ultima sia necessaria. In questo senso, la libertà non si oppone alla necessità: perfino
Dio obbedisce alla propria natura e proprio per ciò non è determinato da altro; la libertà, così intesa, è
dunque opposta non alla necessità (che è ineliminabile), ma alla coazione, ovvero l’esser necessitati da altro.
A godere perfettamente della libertà come l’abbiamo poc’anzi delineata sarà solo Dio, mentre ogni altro ente
sarà sempre necessitato e per di più coartato. Nelle ultime parti dell’Ethica more geometrico demonstrata,
Spinoza ci parla significativamente della schiavitù degli uomini nei confronti delle passioni (De servitute
humana) e, in secondo luogo, della liberazione da esse (De libertate humana): ogni singolo modo della
sostanza (uomo compreso) è determinato dalla catena causale nella misura in cui è inteso, appunto, come
singolo modo; ma ciascuno può vedere se stesso non come un momento particolare della catena, bensì sotto
il profilo del tutto, eliminando per tale via la propria separatezza dal tutto stesso: in questo caso, il soggetto
considera se stesso come sub specie aeternitatis, ossia vede con l’occhio di Dio (e gode della Sua libertà) e
perde la propria individualità schiava: obbedisce cioè alla propria natura necessaria senza costrizioni esterne,
ed in ciò è libero ("libero da"). La libertà è dunque il frutto della conoscenza intellettuale, di quell’intelletto
che intuitivamente ci fa vedere le cose sotto l’aspetto dell’eternità e non dal nostro limitato punto di vista.
HOBBES
L’altra soluzione di fronte al dualismo lasciato in eredità da Cartesio consiste nell’eliminare lo spirito e nel
ridurre tutto a materia, consegnando ogni cosa nelle mani della più rigida necessità, dal momento che
nell’estensione regna la determinazione causale: è questa la soluzione prospettata da Hobbes, specialmente in
tre dei suoi numerosi scritti: Elementi di legge naturale e politica (1640), Leviatano (1651) e Della libertà e
della necessità (1646). Quest’ultima è un’opera particolarmente polemica, in cui Hobbes si contrappone con
veemenza alle tesi di un vescovo che propugnava la libertà dell’arbitrio. Secondo Hobbes l’azione
dell’uomo, infatti, è sempre necessitata: per capire il perché, occorre far riferimento alla gnoseologia
hobbesiana, che fa leva su un rigoroso sensismo per cui tutte le nostre conoscenze derivano dai sensi secondo
un modello necessario simile a quello cartesiano, con però l’aggiunta che, allorchè le impressioni arrivano
alla sede centrale del corpo umano, gli urti prodotti dalle impressioni esterne provocano una reazione che è
da Hobbes detta conatus (in inglese endeavour); il che implica la presenza nell’organismo umano di una
vitalità non meramente meccanica. Nello sforzo si autoproduce energia, e tale conatus può esser di due tipi
(positivo o negativo) a seconda che l’impressione ricevuta sia gradevole o sgradevole. Nel primo caso, si ha
un appetito verso la cosa desiderata (Hobbes nota con acutezza come la radice latina di adpetere indichi
sempre un movimento); nel secondo caso si ha invece l’avversione verso la cosa sgradita. Sulla base di
questi due conati fondamentali (in realtà Hobbes parla anche di un terzo: il timore come avversione proiettata
nel futuro), il filosofo inglese costruisce tutta la sua dinamica delle passioni, in maniera vicina a Cartesio
(che ne aveva individuate sei fondamentali combinantisi in vari modi). La nostra azione di desiderio o di
ripulsa non è qualcosa che venga deliberato da un atto di volontà, ma è la risposta condizionata ad una
determinata sollecitazione; ciò non esclude la volontà, tant’è che per Hobbes volontarie sono quelle azioni
che si compiono per appetito o per timore, mentre involontarie sono quelle compiute per coazione esterna: se
mi precipito in un fiume perché spinto da qualcuno, si tratta di un’azione involontaria; se invece lo faccio
perché preso da angoscia, è un’azione volontaria. Secondo Hobbes, esiste (come secondo Spinoza)
un’immediata coincidenza tra pensiero e volontà, e tuttavia egli ammette che noi abbiamo quotidianamente
esperienza della cosiddetta deliberazione, tale per cui ci si chiede se rubare o meno e poi si delibera di
rubare. La deliberazione - nota Hobbes - non è che un’alternanza di passioni contrarie, appetiti e timori
(desiderio di rubare e desiderio di non rubare), passioni che si confrontano nella nostra mente quasi come se
fosse in atto una lotta per cui ora sembra prevalere l’una, ora l’altra. Ciò si traduce nell’impressione di volere
e di non volere, e alla fine prevarrà una delle due: questa sarà quella che noi chiamiamo decisione o volontà.
Dunque, ciò che a noi orgogliosamente pare una nostra iniziativa, è in realtà il meccanico trionfo di una
passione, trionfo di fronte al quale siamo interamente passivi: "la deliberazione non è altro che
un’immaginazione alternata […] di appetito e timore. […] La deliberazione è successione alternata di
appetiti contrari nella quale l’ultimo è quello che chiamiamo decisione" (Della libertà e della necessità). Il
processo cade del tutto sotto il giogo della necessità: non solo c’è rigoroso determinismo nel processo
mentale, ma anche tra volontà ed azione. Tra il mondo psichico delle idee e quello fisico delle azioni non vi è
alcuna frattura, ma vi è continuità causale, cosicché noi non abbiamo libertà né di agire né di volere, se non
illusoriamente. Infatti la volontà è determinata dalla lotta delle passioni e l’azione è determinata dalla già
determinata volontà. Hobbes ci tiene però a precisare che la causalità qui in questione non è quella
"sufficiente", quella "a cui non manca nulla perché sia necessaria alla produzione dell’effetto", ossia quella
che ha tutti gli elementi necessari per poter produrre il suo effetto, ma non per questo necessita l’effetto: essa
è, insomma, tale da avere in sé gli elementi necessari per spiegar l’effetto, ma non lo necessita. Al contrario,
Hobbes, quando parla di causalità, intende la causalità "necessaria", quella cioè in cui ci sono gli elementi
per produrre effetti che non possono non essere prodotti. La distinzione tra queste due causalità è agli occhi
di Hobbes artificiosa, giacchè ogni causalità che sia davvero tale è sempre necessaria: se in me ho tutti gli
elementi per alzarmi, mi alzo. Se, viceversa, non mi alzo, ciò avviene perché non ne avevo gli elementi, e
non perché li avevo ma non erano necessitanti (causalità sufficiente). Perciò Hobbes insiste sul fatto che
parlare di volontà libera sia un’assurdità alla pari di quando si parla di cerchio quadrato: è ben più che un
semplice errore, quale può essere il sostenere che pioverà perché si son viste le nuvole quando poi in realtà
non piove. La volontà è sempre necessaria, e parlare di una volontà libera è un’aberrazione: non esiste,
allora, alcuna forma di libertà intesa come "libertà di"; semmai esiste la "libertà da" costrizioni esterne: sono
cioè libero quando non sono in catene, quando mi muovo liberamente senza che nessuno mi trattenga, anche
se la mia volontà di muovermi è necessitata. Per chiarirsi, Hobbes adduce l’esempio del fiume: esso è libero
di scendere a valle perché non c’è nessuna diga che lo ostacoli; ma non è libero di invadere i campi perché è
trattenuto dagli argini che lo limitano: tale è, appunto, la libertà umana, intesa meramente come libertà da
costrizioni.
LEIBNIZ
La soluzione di Leibniz consiste nella riduzione della res extensa a epifenomeno, ossia a manifestazione
secondaria dello spirito, con un’operazione opposta rispetto a quella compiuta da Hobbes. Leibniz si oppone
soprattutto a Spinoza, ad avviso del quale la sostanza era una e infinita; per Leibniz, al contrario, le sostanze
sono molteplici e indefinite nel loro numero perché coincidenti aristotelicamente con le sostanze individuali;
e il carattere dell’individualità è a tal punto spinto da individuare il singolo con l’elemento atomico, sicchè
non è né ulteriormente scomponibile né riconducibile ad altri individui. L’atomismo era stato in età
seicentesca recuperato nella sua veste epicurea da Gassendi: ora, Leibniz osserva che parlare di atomi
materiali significa automaticamente contraddirsi, giacchè, coincidendo la materia con l’estensione, se gli
atomi sono estesi, allora saranno divisibili. Alla materia è da Leibniz contrapposto l’elemento energetico
della forza, che è una delle strutture portanti del suo pensiero ed è il concetto che gli serve per opporsi al
cartesianesimo e alla sua filosofia della natura sfociante nel meccanicismo. Stando al meccanicismo di
Cartesio, nel mondo c’è una quantità definita di energia (o di movimento che dir si voglia) impressa da Dio all’atto della creazione - nella materia ed essa può esser redistribuita nella materia stessa passando per
traslazione da una parte all’altra, cosicchè per Cartesio il movimento sarebbe il prodotto della massa e della
velocità; Leibniz sostiene invece che in realtà il movimento non è esprimibile con tale formula, bensì deve
essere espresso come prodotto della massa per il quadrato della velocità, e il fatto che la massa possa
moltiplicarsi implica che il movimento sia una forza autogenerantesi, sicchè non è che un corpo sia
meccanicamente spostato da un altro corpo, bensì il corpo è dotato di un’energia spontanea non riconducibile
al meccanicismo. E a questa teoria fisica Leibniz fa corrispondere una teoria metafisica, nel senso che spiega
tale capacità della velocità di automoltiplicarsi sostenendo che tale forza non è solo elemento fisico, ma è
l’essenza stessa della realtà, la quale è dunque energia e slancio autoespansivo: le monadi sono dunque atomi
non di materia, ma di forza, di quest’energia metafisicamente intesa, cosicchè ciascuna monade ha in sé una
tendenza a svilupparsi e a diventare qualcosa d’altro da ciò che era: ogni monade è attività, è energia, non vi
è elemento statico e materiale, manca la substantia. L’attività della monade è semplicemente un’attività
percettiva, è una continua percezione che comporta il passaggio costante da una percezione all’altra, da
percezioni più basse e meno coscienti a percezioni più alte e coscienti: ma che cosa è ad esser percepito dalla
monade, essendo essa inestesa? Come punti geometrici, le monadi sono tra loro distinte ma definibili in base
alla loro relazione, cosicché la monade X sarà definita dai rapporti che essa intrattiene con le altre monadi. X
percepirà la sua posizione rispetto a tutte le altre monadi, con la conseguenza che la monade finisce per
essere un punto di forza che percepisce tutte le altre monadi, sicchè essa è un autentico punto di vista
sull’universo, in quanto è definita da tutte le altre monadi dell’universo, come un punto geometrico è definito
da tutti gli altri punti geometrici. La dimensione corporea scompare e permane quella metafisica, giacchè i
corpi non sono che aggregati di monadi che stanno insieme: gli individui e le anime, dal canto loro, sono
monadi che hanno determinate relazioni con tutte le altre, ma quando parlo della monade come individuo (ad
esempio Alessandro Magno) parlo di una monade che non ha estensione materiale, ma è pur sempre
un’entità che si trasforma, ovvero ha continuamente relazioni diverse con tutte le altre monadi: il punto di
vista di Alessandro Magno che guarda il suo cavallo sarà diverso da quello di Alessandro Magno che, un
attimo dopo, guarda a terra, cosicchè siamo di fronte ad un mutar continuo di prospettive e relazioni. Ma
come avviene tale successione di stati? Già sappiamo che il passaggio da uno stato all’altro è il risultato del
processo autoevolutivo dell’energia della monade che non viene dall’esterno, in quanto la monade non ha
finestre, ovvero interferenze causali con altre monadi, giacchè manca il nexus physicus (essendo immateriali
le monadi): Leibniz dirà che le monadi sono orologi caricati insieme, in maniera tale da segnare in accordo la
stessa ora, dall’orologiaio Dio secondo un’armonia prestabilita. Tale successione di stati è dunque tutta
interna alla monade e alla sua autocausalità: ma il rapporto di causazione che c’è tra uno stato e l’altro
all’interno della monade sarà libero, determinato o necessario? Ecco qui che affiora il problema della libertà,
che nasce dal tipo di sviluppo interno alla monade: Leibniz si rende ben conto del fatto che anche nella
cornice della cultura del Seicento - come nella tradizione aristotelica - l’unico modo per spiegar le cose è
mostrarne la causa e che una causa non è tale se non è determinata (una causa che non determini l’effetto non
è una causa): quindi, scire est scire per causas e, per di più, le cause in questione sono cause determinanti,
tali per cui A deve necessariamente determinare B. Ciò vuol dire che ciascuno dei nostri stati interni - e la
monade non è che la sequela di essi - può esser spiegata solo se vista come effetto determinato dallo stato
precedente, e tuttavia Leibniz sostiene che l’uomo è libero. Nella Teodicea, Leibniz afferma nella maniera
più drastica la natura determinata dell’azione dell’uomo, presentandoci dei passi sconcertanti per un filosofo
anti-materialista. Nel paragrafo 35 di tale opera, egli scrive: "quando si presta attenzione a sé, si noterà che
c’è stata sempre una causa che ci ha inclinati verso il partito che abbiamo preso, anche se non ci si accorge
che ciò ci muove". Anche quando facciamo cose che ci sembrano nuove e da noi inventate, in realtà notiamo
che c’erano impulsi (magari inconsapevoli) determinanti, posizione, questa, confortata anche dalla teoria
delle piccole percezioni, secondo la quale anche le percezioni consapevoli (appercezioni) sono il risultato
della chiarificazione di percezioni oscure e non consapevoli di sé. "Un’infinità di grandi e piccoli movimenti
interni ed esterni concorrono con noi e per lo più non ci si accorge di essi, e ho già detto che quando si esce
da una camera ci sono ragioni che ci portano a mettere davanti il piede destro senza pensarci": i piccoli
gesti sono automatici e tale determinismo induce anche a prendere le decisioni più importanti; ciò vuol dire
che l’uomo è un automa, e a dirlo è Leibniz, cosa atipica per uno spiritualista che aborre il materialismo.
L'uomo è sì un automa, ma un automa spirituale, e in una pagina della Teodicea Leibniz asserisce che è bene
prendere esempio da Hobbes, giacchè se fossimo liberi non si spiegherebbe il fatto che compiamo un’azione
anziché un’altra; tuttavia, Hobbes sbaglia nel dire che la volontà dell’uomo è necessitata. La determinazione
non equivale per Leibniz alla necessità: perciò egli ritiene di poter sostenere che la volontà umana è
determinata, ma che ciononostante l’uomo sia libero; il che emerge dalla contrapposizione che Leibniz fa tra
contingenza e necessità, da una parte, e tra determinazione e necessità dall’altra. Si ha la necessità quando
"di due proposizioni contraddittorie, l’una è vera e l’altra è falsa", cosicché la necessità si regge sul
principio di non contraddizione e si dice necessario ciò il cui opposto non è possibile (così intesa, la necessità
ha innanzitutto carattere logico). E’ invece contingente ciò che si basa sul principio di "ragion sufficiente",
ossia sul principio che stabilisce che nulla accade senza che vi sia una causa, o, meglio ancora, "senza che vi
sia qualcosa che possa render ragione a priori del perché (cur sit) questo esista anziché non esistere e del
perché esista così (quomodo sit) anziché esistere in altro modo". Il principio di ragion sufficiente ha in
comune con la necessità il riferimento alla causa, con però la differenza che - rispetto alla necessità - tale
causa non è necessaria, ma può ammettere anzi il suo contrario: così, dire che il tutto è maggiore della parte è
esprimere una verità necessaria, mentre dire che sono andato a scuola perché lo sentivo come mio dovere è
esprimere una verità contingente, incentrata appunto sul principio di ragion sufficiente (magari potrei essere
andato a scuola per paura di esser punito e non per mio dovere). In questo senso, Leibniz sta qui schierandosi
in linea antitetica a Hobbes, per il quale - come è noto - la causa necessaria e quella "sufficiente"
coincidevano, nel senso che non vi è causa che non sia necessaria. Per Leibniz, invece, si tratta di due cause
diverse e non riconducibili in toto l’una all’altra: "l’evento il cui opposto è possibile è contingente; quello il
cui opposto è impossibile, è necessario". Sull’altro versante - quello della distinzione tra necessità e
determinazione -, la tesi di Leibniz è che la causa determinante è sicuramente un principio di ragion
sufficiente, ossia basta a spiegare perché (cur) una cosa avvenga e perché avvenga a quel modo (quomodo),
ma non è una causa necessaria, poiché l’effetto potrebbe essere spiegato in altro modo: la determinazione è,
allora, compatibile con la contingenza, sicchè determinare non significa necessitare: così, io sono stato
determinato ad andare a scuola da certi impulsi, ma ciò non è necessario, giacché non è impossibile pensare
ch'io mi sia recato a scuola per tutt’altro ordine di ragioni (per paura, perché ne avevo voglia, ecc). In questa
maniera - tenendo lontana la necessità dall’agire umano -, Leibniz salva la libertà e fa dell’uomo un automa
libero e spirituale; la libertà così come egli la intende è sinonimo di contingenza: pertanto, A contiene
soltanto la ragion sufficiente di B, e non la sua necessità, sicchè si può affermare che l’uomo è determinato
ma libero, anche se la libertà in questione non è la "libertà di" fare ciò che si vuole, secondo il proprio
capriccio. A tal proposito, la tesi dell’asino di Buridano che, dinanzi a due mangiatoie ugualmente colme di
fieno, muore di fame non sapendo scegliere presso quale sfamarsi, è per Leibniz una finzione che non può
trovar spazio nell’universo, giacchè vi sono sempre differenze tra un’opzione e l’altra, differenze magari
impercettibili ma comunque esistenti (Leibniz rideva delle madame che cercavano nel parco due foglie
identiche), alle quali non possiamo sottrarci, ci determinano (ma non ci necessitano); ne segue che la "libertà
di" presupporrebbe che in noi non ci sia un elemento che ci predetermini a scegliere A anziché B, ma se la
monade è la storia dei suoi stati precedenti (e Bergson riprenderà tale concetto), anche scegliere il gelato alla
fragola piuttosto che quello al pistacchio implica sempre una determinazione nella scelta. Per Leibniz,
tuttavia, è solo un bene che non sia possibile la "libertà di", sennò l’uomo si troverebbe abbassato al livello
dei bruti, in quanto non potrebbe spiegare perché ha scelto una cosa anziché un’altra, sicchè la sua sarebbe
una scelta del tutto casuale, priva di motivazioni e alla connessione causale si sostituirebbe quella casuale. Il
che eliminerebbe l’imputabilità all’uomo (come incolparmi del fatto che ho scelto B se l’ho scelto per
caso?): per poter volere A anziché B, non a caso ci deve essere in me un movente determinante, che tuttavia
non è necessitante ma compatibile con la contingenza.
LOCKE e HUME
Locke e Hume sono i due pensatori che danno vita al filone empiristico anglo/scozzese e che si sottraggono
con decisione all’alternativa dell’accettazione o del rifiuto del dualismo cartesiano per il fatto che entrambi i
corni dell’alternativa sono espressione di una concezione metafisica che ritiene possibile definire il concetto
di sostanza (sia essa la sostanza infinita di Spinoza, o il corpo materiale di Hobbes o, ancora, le monadi
spirituali di Leibniz). La possibilità di un discorso sulla sostanza è dunque messa in crisi dall’empirismo di
Hume e di Locke: quest’ultimo nota come forse la sostanza esista, ma come in ogni caso essa resti per noi
inconoscibile; per Hume - su posizioni ben più radicali - essa è un concetto fasullo. Locke non se la sente di
arrivare a tanto, ma resta convinto del fatto che, sia nel senso della sostanza come sostrato che soggiace agli
accidenti sia nel senso della sostanza come ciò che è comune a più cose (l’oro come elemento di unione del
giallo, della lucentezza, ecc), si introducono concetti inconoscibili. Per esprimere questa sua posizione, egli
ricorda la storia di quell’indiano che sosteneva che il mondo è sorretto da un elefante, che a sua volta è
sorretto da una tartaruga, la quale però non si sa bene su cosa poggi: similmente, quando cerchiamo il
substrato metafisico, giungiamo ad una X sconosciuta, proprio in virtù del fatto che noi possiam conoscere
solo gli accidenti. La posizione di Hume è ben più radicale: tutte le nostre percezioni sono, a suo avviso, o
impressioni (percezioni nella loro vivida attualità) o idee (percezioni meno vivide e corrispondenti
all'immagine illanguidita che conserviamo nella memoria); tutte le nostre percezioni derivano dunque da
impressioni, cosicchè se ci chiediamo che cosa corrisponda all’idea di sostanza - ossia a quale impressione
corrisponda - non troviamo risposta, giacchè abbiamo sempre e solo impressioni del freddo, del caldo, del
pesante, ecc, e mai della sostanza. Quest’ultima altro non è, dunque, se non un’invenzione della mente
umana, alla pari del cavallo alato o dell’uomo volante. Ciò fa sì che il problema del dualismo sia un falso
problema, perché riferentesi ad una sostanza inconoscibile o inesistente; tuttavia, anche per questi pensatori,
resta vero il credo del determinismo della volontà, per cui non si può affermare che essa sia libera. C’è
tuttavia l’esigenza di riconoscere anche una dimensione di libertà all’uomo, che però non è riconducibile alla
libertà della volontà, cosicchè questi autori affermano una chiara distinzione tra la libertà dell’agire (che
viene ammessa) e quella del volere (che è negata). Si tratta, peraltro, di una distinzione già delineata da
Hobbes, il quale, pur negando recisamente la libertà del volere umano, ammette che l’uomo sia libero - in
quanto privo di impedimenti esterni - di fare ciò che la volontà determinata lo necessita a fare, cosicchè non
posso decidere se star qui o andarmene, ma ciononostante, se sono necessitato ad uscire, sarò libero di farlo,
a patto che la porta non sia sbarrata. Questa tesi è ripresa soprattutto da Locke - seppur raffinata - specie
nella definizione della libertà di agire, intesa come l’insieme di tutte quelle condizioni (anche quelle interne)
che possono promuovere la messa in atto di una volontà determinata. In particolare, Locke individua (nel
capitolo 21, paragrafo 35 del Saggio sull’intelletto umano), tra le varie forme di potere, anche la libertà e la
volontà, provando a darne una definizione: "noi troviamo in noi stessi un potere di cominciare o non
cominciare, continuare o interrompere varie azioni della nostra mente e vari moti del nostro corpo
semplicemente con un pensiero o con una preferenza della mente […]. Questo potere è ciò che noi
chiamiamo volontà". La volontà è qui definita come il potere di fare o non fare qualcosa sulla base di un
pensiero o di una preferenza della mente che decide se fare così o no; ma l’elemento della preferenza non è il
frutto di una libera scelta, ma è piuttosto il presupposto dato per determinare la scelta. "La libertà è l’idea del
potere che un agente ha di fare o di tralasciare qualunque azione particolare secondo la determinazione
della sua mente […] cioè secondo la sua volontà": la libertà di cui qui si parla è la libertà di fare ciò che è
deciso dalla volontà, testè definita come un qualcosa che troviamo già in noi stessi e che, quindi, non
possiamo liberamente determinare, con la conseguenza che dove io non sono in grado di mettere in atto
quella volontà che trovo in me, là io non sono libero. Preliminarmente è bene osservare come i concetti di
volontà e libertà non siano coestensivi, giacchè se la libertà comporta sempre la volontà, non vale l’inverso:
così posso volere uscire dalla stanza e non poterlo fare perché la porta è sbarrata. La questione ora più
generale è chiedersi se l’uomo sia libero oppure no: la risposta è che l’uomo è libero nella misura in cui - a
meno che non vi siano impedimenti esterni - può compiere quelle azioni che la volontà gli ordina: "che cosa
possiamo pensare di più, affinchè l’uomo sia libero, che egli possa fare ciò che vuole?". Per esser libero, non
vi è bisogno che sia libera la volontà, ma basta poter mandare liberamente ad effetto ciò che essa ci comanda
di fare: così se trovo in me la volontà di uscire (volontà che però non sono io a determinare), non v’è nulla in
me che impedisca di mettere in atto quella libertà, intesa naturalmente come "libertà da" impedimenti
intrinseci a fare ciò che la volontà prescrive. Ma, allora, dobbiamo chiarire se la volontà sia libera oppure no:
essa - dice Locke - non è affatto libera, giacchè consiste appunto in una preferenza, cosicchè non possiamo
non preferire ciò che preferiamo. Sarò allora libero di fare ciò che la volontà mi impone, ma non sarò in
alcun caso libero di voler diversamente da come voglio. "Chiedere se l’uomo sia libero di volere il
movimento o il riposo […], secondo che gli piaccia, significa chiedersi se vuole ciò che vuole": l’uomo non
può dunque preferire altro da ciò che preferisce, sicchè la libertà non potrà mai riguardare la volontà, ma
sempre e comunque l’agire, il rispondere o meno ai comandi di tale volontà. Ci si può allora chiedere - ed è
quel che fa Locke - che cosa determini la volontà: su questo punto, il filosofo inglese assume una posizione
oscillante o, meglio, differente nella prima e nella seconda edizione del Saggio sull’intelletto umano. Nella
prima edizione, egli fornisce una risposta assolutamente incongruente rispetto alla sua tesi sulla volontà
determinata, ragion per cui nella seconda edizione cambia posizione, conscio dell’incongruenza in cui era
incappato. Così, nella prima edizione, leggiamo che la volontà è determinata dalla felicità (e lo dice anche
nella seconda), la quale è un bene (questo compare solo nella prima), o, meglio è la ricerca del maggior bene:
e per sapere quale esso sia, l’analisi pratica trapassa necessariamente in quella teoretica, giacchè è l’intelletto
ad indicare quale sia il bene maggiore, intelletto che per Locke coincide con la ragione, la quale a sua volta è
la mia coscienza stessa, sicchè sono io a scegliere il bene maggiore e a scegliere che cosa sia la felicità: ne
segue allora che la volontà non può più essere una preferenza che trovo già determinata in me; viceversa
sono io a determinarla col mio intelletto, il che è in evidente contraddizione con la tesi di partenza. Locke si
avvede di questa contraddizione e, nella seconda edizione, corre ai ripari sostenendo che a determinare la
volontà è sì la felicità, però determinata dal piacere, cosicchè la massima felicità sarà data dal massimo
piacere; da qui prende spunto quell’eudemonismo settecentesco che riconduce la felicità al piacere sensibile.
Ma resta da chiarire da che cosa sia dato il piacere: esso è, ad avviso di Locke, dato dall’eliminazione della
condizione di disagio, sicchè a muover l’esigenza di felicità e la volontà è il disagio in cui mi trovo. Rispetto
alla prima edizione, la differenza fondamentale è che là interveniva inevitabilmente l’intelletto come
momento cognitivo dominante la situazione; ora, invece, l’intelletto non ha più voce in capitolo, e l’esempio
che Locke adduce per chiarire questo punto è quello dell’ubriaco, la cui felicità è data dal bere che gli
consente di uscire dal disagio in cui si trova; la ragione gli suggerisce di non bere perché ciò è nocivo, ma
egli continua a farlo pur di uscire dal disagio, contravvenendo le prescrizioni della ragione: così facendo,
Locke pone alla base della volontà un elemento che sfugge al controllo dell’uomo e ci determina. Locke
tenta anche di correggere un po’ questo determinismo, dicendo che quando l’uomo sente un disagio, egli può
qualche volta sospendere l’esecuzione (che prima appariva automatica) e valutare le conseguenze di queste
azioni, per vedere se esse portino all’eliminazione del disagio o se piuttosto non lo incrementino. E’ questo
un momento di ponderazione che tuttavia Locke ritiene possibile "soltanto qualche volta"; anche qui, però, si
agisce in vista di uscire da un disagio maggiore, sicchè sono sempre condizioni che sfuggono alla sovranità
razionale dell’uomo. A conclusioni pressoché analoghe perviene Hume, il quale, nel Trattato sulla natura
umana (III, 1), asserisce che "la volontà è quell’impressione interna che avvertiamo e di cui diventiamo
consapevoli quando diamo origine a qualche nuovo movimento del corpo o a qualche nuova percezione
della mente". Da ciò si ricava che le impressioni possono essere esterne o interne (di riflessione), ma tanto le
une quanto le altre sono passive, sono il frutto dell’azione di qualcosa che si imprime in noi, cosicchè esse
son sempre un dato di fatto, tant’è che son la pietra di paragone delle idee (le quali sono vere a fasulle a
seconda che rispecchino o meno l’impressione); sicchè se la volontà è l’impressione proveniente dalla mia
coscienza di iniziare qualche cosa, tale impressione è indiscutibile. La volontà e il suo contenuto sono un
qualche cosa di dato, il che ci rivela già come non possiamo controllare la nostra volontà né le nostre
impressioni: così come non possiamo non dire che il tavolo è giallo, ugualmente non posso dire di non voler
agire in quel dato modo. Tale controllabilità è meglio chiarita applicando alla volontà - come alle cose - quel
concetto di causalità che per Hume non è deducibile a priori né dimostrabile empiricamente, è una credenza
poggiante sull’abitudine. Sicchè la categoria della causalità è il concetto fondamentale con cui ci regoliamo
per tutte le "matters of fact" (i "dati di fatto"); ne segue che tal concetto diventa rilevante non solo per la
connessione dei dati di fatto del mondo esterno, ma anche per quelli inerenti al mondo interno, per cui la
causalità necessaria investe anche la volontà, così come qualsiasi altra impressione. Ora, per mostrare ciò,
Hume ricorda che il principio di causalità implica: 1) l’unione costante e necessaria della causa con l’effetto;
2) la possibilità da parte della mente di inferire un certo effetto data una certa causa. Hume si chiede allora se
questi due caratteri, validi per il mondo esterno, valgano anche per il regno delle impressioni interne e
risponde affermativamente: "le nostre azioni possiedono un’unione costante coi nostri motivi, coi nostri
caratteri e con le circostanze in cui ci troviamo"; ciò equivale a dire che le nostre azioni hanno una
connessione costante con la volontà, cosicchè quando i motivi, i caratteri e le circostanze saranno uguali,
allora si determineranno la stessa volontà e le stesse azioni: anche nella sfera delle azioni umane, cause simili
producono effetti simili. E Hume adduce l’esempio del carcerato che vorrebbe evadere ma che dispera di
farlo perché la porta e la finestra sono sbarrate e perché non è possibile corrompere il guardiano, inflessibile
e timoroso di esser punito dai suoi superiori: il prigioniero inferisce la conseguenza che in nessun caso il
guardiano lo lascerà evadere. Sono due cause diverse: una è fisica (la porta e la finestra chiuse), e l’altra è
morale (l’atteggiamento del guardiano), aventi tuttavia il medesimo effetto (l’impossibilità di evadere),
cosicchè la connessione è necessaria, non vi è in alcun modo più probabilità che il guardiano faccia uscire il
prigioniero di quanta ve ne sia che questi attraversi la porta o la finestra. Ciò avvalora la tesi secondo cui la
causalità vale nel mondo morale non meno che in quello fisico, sicchè l’uomo non ha "libertà di", è solo
libero - come per Locke - di fare ciò che la volontà gli impone. Ma Hume aggiunge alla posizione di Locke
alcune valenze positive, mettendo in luce la positività di tale concezione deterministica della volontà: egli
nota, in primis, come i motivi che determinano la volontà e che la rendono necessitata implichino che io la
possa considerare come espressione della mia personalità individuale, giacchè essa è determinata da motivi,
caratteri e situazioni che sono sempre miei (perfino le circostanze sono sempre il mio modo di considerarle);
la volontà dunque è determinata, ma non dipende che da noi, cosicchè essa esprime la nostra specifica
individualità e deve essere considerata non come una passività, ma come una spontaneità. E’ questa la libertà
psicologica, per cui non ho reale libertà di scelta, ma poiché la volontà coincide con me, non mi sento
coartato, ma psicologicamente libero. E poi Hume nota - sulle orme di Leibniz - come solo una volontà
determinata renda possibile il principio di imputazione, ossia la possibilità di attribuire la responsabilità
all’individuo.
KANT
Abbiamo visto, da un lato, il modello dualistico prospettato da Cartesio, che garantisce alla sostanza
pensante la libertà, e, dall’altro, il modello negante il dualismo e, perciò, rinunciante alla contrapposizione
tra una res libera e una necessaria, il tutto a svantaggio della libertà, che viene inequivocabilmente a trovarsi
schiacciata dall’imperare del determinismo più rigoroso. Ma la soluzione dualistica, tramontata
immediatamente dopo la formulazione datane da Cartesio, ritorna periodicamente nella storia della filosofia
successiva al Settecento, e il primo caso significativo in cui la ritroviamo sostenuta con energia - in difesa
della libertà - è costituito da Kant: il suo è però un dualismo diverso da quello cartesiano, giacché provvede
ad eliminare le difficoltà contro cui il filosofo francese s’era scontrato; questi aveva parlato di due sostanze
opposte ma appartenenti ad un medesimo livello di realtà, tant’è che nell’uomo finivano per interferire - sotto
forma di anima e di corpo -, implicando una seria difficoltà nello spiegare come due sostanze così eterogenee
possano compenetrarsi in maniera tale che l’anima si intrufoli enigmaticamente nel corpo a dirigerlo secondo
libertà, quasi come uno "spettro nella macchina" (Ryle). Il dualismo kantiano, invece, è molto più raffinato,
in quanto non implica il sussistere di due sostanze opposte ed interagenti nella stessa realtà, ma comporta
piuttosto l’esistenza di due diversi livelli di realtà, uno sovrastante l’altro: così, da un lato troviamo la realtà
sensibile ("fenomenica"), cui appartengono il corpo e tutte le sue determinazioni, e dall’altro una realtà
intelligibile non data dai sensi ma a cui si può pervenire tramite un’esperienza extra-sensibile. Così inteso,
l’uomo finisce per essere non una combinazione di due sostanze (quale invece era secondo Cartesio), ma
come un’entità appartenente a due diversi ordini di realtà, sicchè si tratterà di spiegare l’interazione tra questi
due ambiti, ossia si dovrà render conto di come le azioni originate dalla realtà intelligibile possano trovare
una loro precisa corrispondenza in quella sensibile. Prima di entrare in medias res, occorre tuttavia chiarire
come questo dualismo consenta a Kant di recuperare due giurisdizioni diverse, riconoscendo, per un verso,
un regno (il mondo fenomenico) in cui vige la causalità meccanica e, per un altro verso, un regno (quello
intelligibile) in cui impera invece una causazione non necessaria; pertanto il dualismo kantiano, nel cercare
un terreno per la libertà, assolve la stessa funzione di quello cartesiano, ma senza incappare in quelle grette
contraddizioni in cui Cartesio era scivolato. Con la sua soluzione, Kant, compiendo tale operazione di difesa
della libertà nel mondo noumenico, è rigoroso nell’escludere ogni forma di libertà in quello fenomenico,
cosa che pare ovvia ma che, se bene analizzata, non lo è affatto, giacché, nella misura in cui gli autori postcartesiani filo-deterministi si preoccupavano di salvare un margine di libertà anche all’interno del
determinismo, ricorrevano solitamente alla bislacca tesi per cui, nel caso della determinazione psicologica,
gli elementi che determinano il mio agire coincidono con la mia soggettività e quindi rappresentano una
forma di spontaneità tale per cui è impossibile dire che l’uomo non sia in certo modo libero. E’ questa la
soluzione propugnata soprattutto da Hume, ma anche da Leibniz: quest’ultimo aveva difeso la libertà
dell’agire in primis operando una decisa distinzione tra necessità e contingenza, mettendo in luce come il
determinismo fosse espressione di contingenza (e non di necessità), nel senso che implica la ragion
sufficiente delle cose ma non comporta che necessariamente quella sia la causa del dato effetto. In secondo
luogo, Leibniz difendeva la libertà dell’uomo, pur restando nell’alveo del determinismo, facendo leva sulla
spontaneità: è vero, sì, che nell’anima tutto è determinato da una consecuzione causale interna di stati, ma
tuttavia tali stati appartengono all’anima stessa (che anzi è essa stessa il suo sviluppo), cosicchè viene difesa
una sfera di libertà intrinseca al determinismo e incentrata sulla spontaneità dell’anima e Leibniz può
affermare: "per quel che riguarda la spontaneità, ci è propria perché abbiamo in noi il principio delle nostre
azioni […]. Infatti, in termini rigorosamente filosofici, le cose esterne non hanno influenza su di noi".
Escluso il nexus physicus, l’evoluzione della monade è tutta interna, con la conseguenza che sarei coatto se ci
fosse una determinazione dall’esterno, ma, non essendoci, sono sì determinato, ma da me stesso. Ora, Kant
dice chiaramente che questi discorsi "psicologici" sulla libertà sono privi di fondamento, sono dei raggiri che
rivelano subito la loro debolezza: è inutile che io cerchi di dire che il determinismo interno è meno forte di
quello esterno, poiché essi sono entrambi espressione del determinismo fenomenico, con l’unica differenza
che, per quel che concerne la mia interiorità, esso è dato nel tempo, mentre per l’esteriorità nello spazio. In
entrambi i casi, tuttavia, è e resta parimenti fenomeno, ossia un qualcosa di dato sensibilmente e, per ciò
stesso, solo in termini di causalità necessaria. L’errore che ha indotto fior di pensatori a fantasticare una
libertà psicologica trae secondo Kant origine dal fatto che chi lo commette riconduce la nozione di causalità
necessaria solamente con l’elemento dello spazio, come avviene quando la palla da biliardo A urta quella B e
ne causa il movimento sul tavolo da biliardo. Ma Kant ricorda come in realtà la categoria della causalità come tutte le altre undici - non è che una determinazione nel tempo, e, per spiegare ciò, egli ricorre ad un
duplice esempio: in primo luogo, egli ci rammenta di come tutti i nostri dati sensibili ci sian dati nello spazio
ma poi - nel momento in cui diventano miei - son ricondotti nell’interiorità, ove regna il tempo, cosicchè
vengono prontamente temporalizzati; ne segue che tutti i fenomeni - sia esterni sia interni - son connessi
secondo un determinato ordine di successione nel tempo. Si possono allora dare due diversi casi: tale
successione temporale non è il prodotto di una categoria, ma dell’immaginazione: a sostegno di ciò,
possiamo immaginare di guardare un palazzo facendo scorrere lo sguardo dal tetto alle fondamenta; in questo
caso, si ha una successione di immagini, di dati e di fenomeni, ma essa non è necessaria, giacchè posso far
scorrere lo sguardo dal tetto alle fondamenta o viceversa, sicchè, per quanto i fenomeni interni sian sempre
dati in successione, quest’ultima può non essere costitutiva dell’oggetto stesso proprio perché non interviene
la categoria della causalità. Passiamo ora ad esaminare il secondo caso, in cui l’ordine di siffatta successione
non è arbitrario, ma necessario in quanto costitutivo dell’oggetto stesso: così, il giocatore di biliardo sposta la
palla B urtandola con quella A; in questo caso, non si può che immaginare quella determinata sequenza per
cui la stecca colpisce A e questa urta e muove B, giacchè tale ordine è costitutivo dell’oggetto ed è tale
perché è subentrata quella causalità che mi fa concepire le cose così e non in un altro modo. Allora la
categoria della causalità non è se non una determinazione nel tempo: ciò che mi induce a dire che il
movimento delle palle da biliardo segue una certa sequenza non è lo spazio, ma il tempo e dunque è un grave
errore illudersi che la causalità abbia la sua radice nello spazio e che il tempo possa esentarsi da essa. Ciò
significa che in tutti i casi la successione causale è strettamente necessaria, giacchè è la stessa categoria della
causalità ad essere applicata ora nel fenomeno esterno, ora in quello interno: così, quando penso ad un
ricordo triste e mi intristisco, tra il ricordo e il nascere della mia tristezza applico la causalità, poiché non
posso dire che prima mi sono angosciato e poi ho pensato al ricordo triste. Dunque, è la causalità a legare
ciò, e non l’immaginazione, alla pari di quel che avviene con le palle da biliardo, senza far distinzioni tra
fenomeni esterni o interni. A contare davvero è che in entrambi i casi si tratta di fenomeni, di conoscenze
che, per costituirsi, necessitano di essere causalizzate, per cui posso capire la dinamica delle palle sul tavolo
da biliardo o del mio intristirmi solamente se applico la causalità. E allora - prosegue Kant - la libertà di cui
favoleggia Leibniz quando vagheggia una determinazione spontanea è in realtà la spontaneità di un
girarrosto che gira da solo, ma non già perché sia libero di girare, bensì perché necessitato a farlo,
esattamente come se subisse una determinazione esterna. Sicchè quando pensiamo alla nostra vita interiore
fenomenica dobbiamo pensare ad un mondo determinato necessariamente non di meno di quello fisico.
Allora la conclusione a cui Kant perviene è che o riesco ad uscire dal fenomenico (sia esterno sia interno) e
giungo ad attingere un livello di realtà extra-fenomenico oppure non c’è scampo e non vi è alcuna forma di
libertà. Si tratta dunque di esaminare se vi sia la possibilità di un livello di realtà che si sottragga alla
fenomenicità, distinguendo il fenomeno dalla cosa in sé e riconoscendo nel primo la necessità, nella seconda
la libertà: se non potessimo operare tale distinzione, "l’uomo sarebbe una marionetta […], costretto e
caricato dal sommo maestro di tutte le arti". L’uomo, così inteso, sarebbe un automa, magari anche un
automa illudentesi di essere libero, poiché non in grado di scorgere la causazione operata dal burattinaio
(Dio), le sue volizioni sarebbero determinate da altre sue volizioni, e queste da altre ancora, ma all’inizio
qualcuno deve aver messo in moto l’automa, che così viene a dipendere dall’azione esterna di un artefice. Se
tempo e spazio esprimessero la realtà ultima della cosa in sé (e non fossero solo forme a priori della
sensibilità), non vi sarebbe libertà alcuna e vigerebbe lo spinozismo, tale per cui tutto cadrebbe sotto il
dominio della fredda necessità. Il rimprovero mosso da Kant al post-cartesianesimo non è tanto di aver
rinunciato al dualismo, quanto piuttosto di essere stato incoerente, poiché, rinunciando al dualismo, si è poi
impossibilitati ad ammettere la libertà a livello fenomenico. Il passo verso il noumeno non può esser
compiuto con quegli strumenti conoscitivi che si servono delle forme a priori della sensibilità (spazio e
tempo) e dell’intelletto (le dodici categorie), poiché conoscere qualcosa significa fenomenizzarla, ovvero
riconnetterla ad una rete di connessioni causali neganti la libertà. Per giungere al noumeno, si dovrà allora
percorrere una strada alternativa, extra-gnoseologica, la strada dell’esperienza morale e pratica. Il problema è
risolto nella Critica della ragion pratica, ma è già lumeggiato nella Critica della ragion pura, seppur qui non
sia minimamente risolto: discutendo sulle modalità conoscitive, Kant ammette la possibilità della libertà, una
possibilità non verificabile in un’opera inerente alla conoscenza (quale è la Critica della ragion pura) ma
comunque non escludibile, aprendo in tal modo uno spiraglio al di là del determinismo fenomenico. Nella
Dialettica trascendentale - che è la parte della Critica della ragion pura in cui Kant prende in esame le
facoltà della ragione, contrapposta all’intelletto - si parla dell’idea del mondo come totalità incondizionata di
tutti i fenomeni e Kant sostiene che, proprio perché idea di un concetto incondizionato mai esperibile, su tale
idea del mondo si possono sostenere affermazioni contraddittorie senza poter provare l’errore teorico né
delle une né delle altre, cosicchè si può procedere ad un’antinomia della ragion pura in cui, da un lato, si
sostiene la tesi, dall’altro l’antitesi, senza che sia possibile trovare un errore formale nelle argomentazioni
addotte a favore della tesi o dell’antitesi (sarebbe possibile trovarle se si potesse fare esperienza dell’idea di
mondo). Delle quattro antinomie individuate da Kant, la terza consiste nella contrapposizione tra una tesi
secondo cui la libertà esiste e un’antitesi negante tale libertà. La tesi recita che "la causalità in base alle leggi
della natura non è l’unica da cui sia possibile far derivare tutti i fenomeni del mondo: per la loro
spiegazione, si rende necessaria l’ammissione di una causalità secondo libertà". Accanto alla causalità
necessaria, ne è dunque riconosciuta una libera, che concorre alla causazione dei fenomeni che, per altro
verso, sono già spiegabili con la causalità fenomenica: così, il moto della palla da biliardo B sarebbe causato
da una causa noumenica, inserendosi poi in una serie causale fenomenica per cui può esser ritenuto l’effetto
di un’altra causa fenomenica (l’urto della palla A). Ci verremmo dunque a trovare di fronte a due causalità
complementari. Di contro, l’antitesi recita l’esatto opposto, negando ogni forma di libertà: ora, queste due
affermazioni paiono elidersi mutuamente e Kant ritiene che invece esse possano essere entrambe vere,
appunto se, anzichè riferirle entrambe al regno fenomenico, riferiamo l’affermazione della necessità al
mondo fenomenico e quella della libertà ad un mondo non fenomenico, la cui esistenza sarà postulata nella
Critica della ragion pratica: nella Critica della ragion pura, invece, Kant non dispone di alcuno strumento
per ammetterlo e perciò si limita a dire che esiste la possibilità di una causalità libera e che tale possibilità è
solo problematica, ossia non può essere esclusa teoricamente poiché non si può teoricamente escludere
l’esistenza di una realtà noumenica. La Critica della ragion pura si affaccia al problema della causalità libera
come possibilità problematica che non può essere né esclusa né affermata; la Critica della ragion pratica
risolve tale problema, ma in sede pratica, senza risvolti teoretici. Che cosa si debba intendere per "causalità
libera" - affermata nella tesi della terza antinomia - viene da Kant spiegato in questi termini: essa è una
causalità in cui il soggetto è principio di una serie causale, ovvero in cui il soggetto causante non è a sua
volta effetto di una causa. La possibilità di un mondo intelligibile garantirebbe l’esistenza di siffatta causalità
libera, ma ciò nella Critica della ragion pura resta una problematica eventualità: è solo con l’ingresso nel
campo morale della Critica della ragion pratica e della Fondazione della metafisica dei costumi che il
problema trova una sua debita risoluzione. Il problema è nelle due opere posto in maniera
terminologicamente diversa: nella Fondazione della metafisica dei costumi, Kant si chiede se sia possibile
una volontà buona di per sé, tale per cui la sua bontà non sia funzionale ad un determinato obiettivo, ma sia
intrinseca alla volontà stessa. Invece, nella Critica della ragion pratica - che, tentando di seguire le orme
della Critica della ragion pura, si configura come un’opera più tecnica - Kant si domanda se la ragion pura
possa essere pratica, ossia se, accanto alle mansioni conoscitive e teoretiche esercitate a priori, essa possa
anche determinare la norma dell’agire umano. Ciò equivale a chiedersi se essa possa determinare una regola
pratica d’azione che sia universale, cioè per tutti valida. Quale sia questo elemento di universalità, lo
troviamo nella formulazione dell’imperativo categorico, così recitante: "agisci soltanto secondo quella
massima che , al tempo stesso , puoi volere che diventi una legge universale". Ora, questa soluzione del
problema morale comporta che la volontà intrinsecamente buona (ovvero la ragion pura immediatamente
pratica), oltre ad esprimere l’universalità, esprima un principio di autonomia, giacchè, per essere universale,
la volontà non può essere determinata da passioni o da interessi estranei alla ragione, in quanto questi sono
necessariamente particolari. L’unico elemento che possa determinare immediatamente la volontà stessa,
senza farla precipitare nella particolarità, è la ragione stessa nella sua universalità, cosicché la volontà sarà
universale nella misura in cui è determinata dalla ragione. Tra questa e il mio io intercorre un rapporto di
identità, nel senso che io sono la mia ragione e, nella misura in cui la volontà è da essa determinata, sono io
ad autodeterminarmi, senza che vi sia un principio esterno che mi coarti; se invece la volontà è determinata
da passioni o da interessi particolari generati dalla sensibilità, allora tutto cambia, poiché la sensibilità è
manifestazione della natura interna, che è un qualcosa che non esprime l’essenza dell’umanità (come invece
è la ragione), giacchè anche gli animali ne sono equipaggiati. La sensibilità è allora un qualcosa di altro
rispetto a noi, sicchè, quand’anche obbediamo alle passioni nostre, stiamo in realtà obbedendo a qualcosa
che non siamo noi. Pertanto se agisco in modo tale che solo la ragione determini la mia volontà, il mio agire
sarà autonomo, mentre se la volontà è determinata dalla sensibilità, allora la mia azione sarà eteronoma. A tal
proposito, nella Fondazione della metafisica dei costumi, Kant scrive che "l’autonomia della volontà è quel
carattere della volontà per cui essa è legge a se stessa, indipendentemente dai caratteri". L’autonomia è la
più alta espressione di libertà, in quanto esprime entrambi gli elementi componenti della libertà: da un lato, la
libertà negativa ("libertà dalla" natura, dalla sensibilità, dalle passioni e dai "moventi eteronomi"); dall’altro,
la libertà positiva come autodeterminazione, per cui non mi limito a rifiutare l’impulso sensibile, bensì lo
rimpiazzo con le prescrizioni della ragione, che detta una legge coincidente con me stesso, senza
determinazioni esterne. Comincia qui ad affiorare, seppur opacamente, il problema della causalità libera. "La
volontà è una specie di causalità degli esseri viventi in quanto ragionevoli […]. La libertà è […] quel
carattere per cui essa può agire senza dipendenze da enti esterni": anche la causalità libera ha le sue leggi
(altrimenti l’agire umano ricadrebbe nel caso), ma si tratta di leggi interne al soggetto, in quanto è la ragione
stessa a promulgarle. Ne deriva che autonomia (o libertà) e morale sono indisgiungibilmente connesse,
giacchè non può esserci moralità senza libertà e viceversa. Ma finora non abbiamo dimostrato che la libertà
esista o che la moralità sia principio obbligante per l’uomo: il legame tra le due - libertà e moralità - è stato
illustrato sul piano teoretico, senza tuttavia dimostrare che esse realmente esistano, sicchè quel passaggio
(richiesto nella Critica della ragion pura) ad un fondamento morale della libertà non è ancora stato
compiuto. A questo punto, Kant cambia improvvisamente idea dinanzi al bivio: si può dimostrare che l’uomo
è libero - egli sostiene - e che perciò ha in sé la legge morale (vista la stretta connessione fra le due); oppure
è possibile mostrare che nell’uomo vi è la legge morale e che, per ciò, egli è libero. Nella Fondazione della
metafisica dei costumi, Kant sceglie la prima via, dimostrando in primis la libertà e, sulla base di ciò, deduce
la moralità; per dimostrare l’esistenza della libertà, basta rivolgersi - con atto di introspezione - alla propria
coscienza e accorgersi che in quanto essere ragionevole faccio parte di due mondi: come animale, appartengo
al mondo fenomenico, ma in quanto detentore di ragione (facoltà intelligibile) sono parte integrante di un
mondo non fenomenico, per cui la libertà è indipendente da cause precedentesi; al contrario, essa è
autocausantesi e, perciò, è principio di una serie causale. In questo modo, l’uomo, anfibio tra due mondi,
verifica la libertà in quanto avverte la propria appartenenza anche ad un mondo non-fenomenico, cosicchè la
dimostrazione della libertà dell’uomo diventa anche fondamento della dimostrazione della sua moralità, data
l’indisgiungibile connessione fra le due cose: "gli imperativi categorici sono dunque possibili perché l’idea
della libertà mi rende membro di un mondo intelligibile"; posta la libertà, è necessariamente data anche la
moralità, a tal punto che se l’uomo fosse - per dirla con Schopenhauer - una "pura testa alata d’angelo",
ovvero un’entità meramente intellettuale e priva di corpo, sarebbe immediatamente un essere morale, senza il
contrasto prodotto da elementi esterni alla ragione. Ma, essendo l’uomo anche ente animalesco, la moralità si
dà sotto forma di imperativo implicante sofferenza e sforzo contro gli istinti sensibili che contro tale
imperativo confliggono, sicchè in noi la moralità non è automatica ma comandata e sofferta. Nella Critica
della ragion pratica il rapporto è ribaltato, giacchè qui Kant fonda la libertà sulla moralità: per tutta l’opera,
egli va ripetendo che condizione della libertà è la moralità. Perché mai egli avverte l’esigenza di stravolgere
la prospettiva? Nella Fondazione della metafisica dei costumi, la libertà era ricavata dalla coscienza data
dall’introspezione, senza venir conosciuta teoreticamente, cosa che non soddisfa pienamente un filosofo
rigoroso quale è Kant, che già in tale opera denuncia il limite noetico di questa coscienza, quasi come se
fosse un’intuizione spinozianamente intesa. In effetti, si trattava di una posizione alquanto debole e
difficilmente sostenibile, poggiante sulla coscienza di non appartenere solo al mondo fenomenico; era, come
Kant stesso nota con amarezza, un "punto di vista", una sorta di ipotesi. Come non posso avere un’autentica
conoscenza oggettiva di appartenere al mondo noumenico, così non posso avere un’autentica conoscenza di
essere libero. Nella Critica della ragion pratica, Kant sente l’esigenza di fondare la morale come conoscenza
di tipo costitutivo, in maniera non meno debole della conoscenza incentrata sulla sintesi a priori della Critica
della ragion pura, e non a caso la legge morale è una conoscenza sintetica a priori, data da una sintesi
differente da quella della Critica della ragion pura (dove si sintetizzavano intuizioni sensibili in un
concetto), in quanto vengono qui sintetizzate la volontà e la ragione, dimostrando che tra esse sussiste un
rapporto sintetico per cui la ragion pratica le pensa unite così come la ragion pura pensa unite in concetto le
intuizioni e le categorie. La moralità sarà allora un sapere con pari dignità noetica rispetto al sapere della
ragion pura. Per ribaltare la prospettiva, Kant asserisce che se la connessione tra volontà e ragione è identica
e costitutiva della ragion pratica, allora la legge morale è un fatto della ragione, e non un qualcosa di derivato
(come invece era nella Fondazione della metafisica dei costumi): la Deduzione trascendentale (che nella
Critica della ragion pura riguardava le dodici categorie) ha appunto per oggetto la giustificazione
("deduzione") della legge morale, sicchè la deduzione non riguarda un quid facti, ma un quid juris, cioè un
qualcosa che accampa un diritto da dimostrare. Se la legge morale è il fatto fondamentale della ragion
pratica, allora non necessita di esser giustificata; ma qui avviene qualcosa di paradossale, giacchè tale legge
morale giustifica a sua volta (senza dover essere giustificata essa stessa) la libertà, in quanto questa è
condizione essenziale per l’esercizio della moralità. Il rapporto rispetto alla Fondazione della metafisica dei
costumi è invertito: là la libertà era un concetto meramente negativo ed era una prospettiva debole e negativa,
cosicchè, se si vuol dare valore conoscitivo forte (ed è ciò che Kant vuole), occorre far derivare la libertà
dalla moralità, che so essere una conoscenza assolutamente oggettiva della ragion pura nella sua veste
pratica. Per superare quest’apparente incongruenza, Kant distingue - in una nota della Critica della ragion
pratica - tra due piani: da un lato, la libertà è la ratio essendi della moralità (ovvero la condizione per la sua
esistenza), dall’altro la moralità è la ratio cognoscendi della libertà (ossia la condizione per conoscerla).
Dunque l’ordine noumenico interferisce su quello fenomenico, per cui l’evento x è noumenicamente
determinato dalla mia ragione e nello stesso tempo tale azione si inserisce nella serie causale fenomenica; e il
fatto x è a sua volta spiegabile facendo riferimento ad una causa fenomenica, senza far riferimento
all’imperativo categorico. L’intero discorso è condotto in base ad una conoscenza morale e non teoretica,
sicchè sarà una conoscenza certa dell’esistenza della libertà e della moralità, ma non per questo è una
conoscenza teoretica.
IL NEOKANTISMO
Mantenendo due piani diversi di realtà, Kant salva il dualismo senza imbattersi nei problemi contro cui si era
scontrato Cartesio: il noumenico e il fenomenico restano due piani di realtà diversi, ma tuttavia vi è un punto
di contatto tra i due. In questa maniera, il problema dello spettro nella macchina è solo allontanato, ma non
debellato: queste difficoltà sparirebbero se si cancellasse il discorso metafisico sui diversi livelli di realtà e si
parlasse più semplicemente di punti di vista differenti, abbandonando il discorso ontologico e analizzando il
problema sotto forma prospettivistica. E’ esattamente ciò che fanno alcuni esponenti del neokantismo di
inizio Novecento. Uno dei caratteri portanti del movimento neokantiano è l’avversione ad ogni forma di
metafisica: l’idealismo, lo spiritualismo e anche il positivismo, che a suo modo, parlando di leggi della
realtà, finiva per essere una specie di metafisica. Secondo i Neokantiani, non è possibile fare un discorso
oggettivistico di questo stampo, puntando sul fatto che vi sia un oggetto che vada al di là del mio modo di
conoscerlo: questo è per loro il vero insegnamento kantiano, a cui il filosofo tedesco ha tenuto fede nella
Critica della ragion pura, ma che ha poi clamorosamente tradito nella Critica della ragion pratica, ove
postulava una sfera noumenica, ricorrendo in tal modo ad una scorciatoia di bassa lega. Essi negano
radicalmente che si possa parlare di un oggetto indipendente dalle modalità conoscitive aliene al soggetto:
per questa via, ogni metafisica è infallibilmente bandita. Wilhelm Windelband scrive nel 1904 un’opera
intitolata La libertà del volere, in cui parte dai seguenti presupposti: la conoscenza non può mai essere
assoluta, sicchè mai conosciamo la realtà quale essa è effettivamente; la nostra conoscenza, dunque, non
attinge altro che fenomeni. Ma Windelband - dopo questo incipit kantiano - estende quello che era
l’orizzonte di Kant: se per questi la conoscenza fenomenica è determinata da forme a priori (spazio e tempo
nel sensibile; le 12 categorie per l’intelletto), per Windelband, invece, essa è determinata dall’applicazione di
criteri diversi ("punti di vista") in forza dei quali si legge la realtà, con l’inevitabile conseguenza che la
connessione causale necessaria legante i fenomeni l’uno all’altro è solo un "punto di vista", un modo di
fenomenizzare (e di distorcere) che non può pretendere di conoscere la realtà nella sua noumenicità. Dunque,
se per Kant c’è una sola forma di fenomenizzazione, per Windelband, viceversa, ne esistono una pluralità,
tutto dipende dal punto di vista che si assume. Così, accanto alla causalità necessaria - usata nell’ambito delle
scienze -, esistono anche altri modi di fenomenizzare il reale, ad esempio considerando gli oggetti in una
sequenza non di cause ed effetti, ma di mezzi e fini in vista di valori: e il valore è, evidentemente, qualcosa
di nettamente diverso da quella causalità necessaria in cui a contare è solamente la connessione necessaria, a
prescindere dai valori; qui invece - cioè nell’ambito dei valori - vale l’esatto opposto, a contare sono i valori
e, conseguentemente, la possibilità di creare gerarchie assiologiche, senza che la causalità necessaria perda il
suo valore. Anzi, essa è affiancata dalla causalità libera, senza la quale non sarebbe in alcun modo possibile
parlare di valori: ne segue che ci troviamo dinanzi non già a realtà diverse, bensì a diverse modalità di
fenomenizzazione di una stessa realtà. In perfetta sintonia con Windelband, Cassirer - in Determinismo e
indeterminismo nella fisica moderna (1937) - sostiene che vi sono diversi modi di determinazione
dell’oggetto, diverse perché obbedienti a diverse forme di conoscenza, che Casirer chiama forme
"simboliche", a sottolineare che non c’è oggettività, ma soggettività che costituisce l’oggetto nella sua
simbolicità. Così la scienza determina l’oggetto in connessione causale, mentre la moralità lo determina coi
valori. Per meglio chiarire questo punto tipicamente neokantiano, Windelband ricorre ad un esempio
particolarmente chiarificante: immaginiamo di avere a portata di mano una statuetta antica; essa sarà
considerabile sotto diversi punti di vista, ossia come oggetto di più modi di determinazione. Ad esempio, sul
piano naturalistico del rapporto tra causa ed effetto, potrò considerarla come insieme di determinati elementi
chimici interagenti fra loro; sul piano estetico, invece, introdurrò forme simboliche e potrò dire che la
statuetta è bella; ancora, sul piano religioso la considererò sacra secondo modalità diverse da quelle per cui la
concepivo come bella o come aggregato di elementi. Ciò significa, allora, che queste modalità di
determinazione sono tra loro indipendenti, cosicchè potrò venerare la statuetta come sacra anche qualora non
sia bella. Ne segue che, in realtà, di fronte a me non ho una statuetta in assoluto, ma, al contrario, una
statuetta considerata ora dal punto di vista naturalistico, ora da quello estetico, ora da quello religioso: e i
criteri con cui la considero in questi modi sono assolutamente slegati l’un dall’altro e non riconducibili fra
loro (così, non posso valutare la bellezza della statua considerandone la composizione chimica). Anche qui ci
troviamo di fronte ad un dualismo, o, meglio, ad un pluralismo che però non è più di tipo metafisico (quale
invece era quello kantiano), ma è un pluralismo dei punti di vista e che, in forza di ciò, elimina il problema
cartesiano - allontanato ma non debellato da Kant - dello "spettro nella macchina" (G. Ryle): questo
problema, crassamente evidente in Cartesio e teoricamente allontanato (ma non del tutto) da Kant, è
completamente sconfitto da Windelband e da Cassirer che, in questa maniera, salvano la libertà dell’uomo:
sono libero perché il determinismo non è che un punto di vista, cosicchè, quando mi considero soggetto
morale, non sono un corpo entrante nella serie causa/effetto e ciò non perché la realtà ha due diversi ordini (il
fenomenico e il noumenico di cui parlava Kant); basta dire che non c’è oggettività assoluta e subito la
causalità non è che un a priori della mente umana (e per ciò presente in tutti gli uomini) che fenomenizza in
svariati modi, simbolizzando la realtà e riducendola (dunque ingabbiandola) a forme soggettive. Similmente,
certo esistenzialismo novecentesco arriva a negare la realtà nella sua datità - la presenzialità di cui parla
Heidegger -, sostenendo che essa è necessariamente sempre ridotta a significati legati all’esistenza, in virtù
del rapporto esistenziale determinato dal soggetto stesso (e non dalle forme a priori dei neokantiani); secondo
gli esistenzialisti, sento nella mia esistenza un certo rapporto nel vivere le cose, un modo determinato da me
stesso e dal mio modo di percepire la realtà.
L’IDEALISMO
Un’altra maniera di affrontare la problematica della libertà consiste nel fare riferimento ad una realtà assoluta
in cui vi è, sì, necessità, ma in cui - proprio perché si tratta della realtà assoluta - questa necessità viene a
coincidere spinozianamente con la libertà: con la conseguenza che l’uomo, per essere libero, deve
partecipare dell’Assoluto e della libertà che gli è propria. E’ questa la soluzione prospettata dall’idealismo
tedesco a cavallo tra Settecento e Ottocento, ma che torna ancora in pieno Novecento (basti ricordare il caso
italiano dello spirito di Croce e dell’atto assoluto di Gentile: la necessità si confonde con la libertà, e questo
avviene chiaramente in Gentile, in maniera più ambigua e sfumata in Croce). In maniera diversa e con
differente sensibilità, i tre protagonisti dell’idealismo tedesco - Fichte, Schelling e Hegel - confinano la
libertà nella libertà dell’Assoluto (inteso ora come "Io assoluto", ora come "Spirito assoluto", ecc), facendo
enigmaticamente coincidere la necessità e la libertà. Di questi tre pensatori, il più interessante per il modo in
cui risolve la questione è forse Fichte, la cui posizione è peraltro la più debole, giacchè in lui
l’assolutizzazione è conseguita solo ad un certo punto della riflessione (esattamente dopo il 1800): intorno al
1800 egli passa da una prospettiva trascendentale saldamente kantiana ad una metafisica, sollecitato e
suggestionato dai Romantici. Nel periodo trascendentale, egli si ritiene un seguace ortodosso di Kant, a tal
punto da credere di essere più kantiano di Kant stesso. Nella Dottrina della scienza, Fichte sostiene che
esiste un principio assoluto della conoscenza dato dall’Io assoluto; quel che per Kant era una mera funzione
(l’Io penso) avente il compito di unificare un molteplice empirico, diventa in Fichte un principio in sé avente
un proprio contenuto e ponente se stesso e la molteplicità che egli stesso unifica (è principio assoluto
contenente il principio di organizzazione e l’oggetto organizzato). Di conseguenza, Fichte concepisce tale Io
assoluto come un processo dinamico al cui interno l’Io pone se stesso e oppone a sé un non-Io (la natura) in
maniera inconsapevole, attraverso l’immaginazione produttiva (così detta perché non riproduce un oggetto
visto, ma produce ex nihilo). Qualcosa di simile avviene anche a livello pratico, giacchè Fichte distingue tra
due tipi di impulso: da un lato, abbiamo quello puro (coincidente con la ragione), dall’altro quello naturale
(coincidente con la sensibilità). Il primo è quello che nasce direttamente dall’Io ed è puro in quanto
spontaneo, è mera attività incondizionata dal non-Io, è cioè la pura creatività dell’Io stesso. L’impulso
naturale, invece, è dato dagli impulsi che il soggetto sente in sé come non-Io (impulsi corporei, psicologici,
empirici): è, in sostanza, tutto ciò che non è puro impulso razionale, ma frutto della sensibilità. Questo
discorso parrebbe, almeno in prima analisi, di sapore kantiano per via della netta contrapposizione tra
causalità libera razionale e causalità condizionata dalla sensibilità; e per Kant condizione della moralità e
della libertà era l’eliminazione dell’impulso naturale (si deve cioè recidere la parte animale presente in noi
per poter così diventare meri esseri razionali). Ciò vale perchè per Kant l’Io noumenico è radicalmente
distinto dal non-Io fenomenico (la sua morale poggia proprio su ciò); ma per Fichte tale separazione è
inaccettabile, giacchè l’Io comprende in sé anche il non-Io come sua produzione (di cui si serve per
svilupparsi), cosicchè l’impulso puro, senza un impulso naturale che lo contrasti e lo faccia sviluppare, non
può esistere; anzi, l’impulso puro si realizza sempre e comunque in una dialettica di opposizione alla
sensibilità, giacchè per Fiche la vera essenza dell’uomo non è la sola ragione - come invece credeva il Kant
della Critica della ragion pratica, quando diceva che se seguiamo le sensazioni siamo eteronomi -, ma
l’aggregazione di ragione e sensibilità, sicchè non si potrà mai sconfiggere l’impulso naturale, ma non per
questo si deve essere suoi schiavi; al contrario, esso deve essere soggiogato e fatto strumento per l’impulso
puro, senza negarlo ma piegandolo al servizio della ragione. Negare la sensibilità, infatti, equivarrebbe a
negare la natura umana, come obietta a Kant anche Schiller. Di conseguenza, Fichte può parlare di un terzo
impulso: l’impulso morale. La libertà non è - come era per Kant - un fare come se la sensibilità non ci fosse:
è, invece, dominare una sensibilità ineliminabile perché costitutiva dell’uomo, il che sembra lasciare ampio
spazio di manovra all’Io, che parrebbe dunque equipaggiato di una "libertà di" scelta tra le diverse strade che
possono sortire tale effetto. Ma in realtà non è così, giacchè - dice Fichte - a suggerirmi come superare di
volta in volta l’impulso naturale subordinandolo a quello puro è la ragione, cosicchè in ogni situazione,
dovendomi io servire di un impulso naturale finalizzandolo a quello puro, dovrò scegliere l’impulso naturale
più adatto. Così, quando faccio l’elemosina, agisco secondo Kant perché l’imperativo categorico mi
comanda di aiutare il prossimo; per Fichte, invece, mi trovo di fronte ad un ventaglio di impulsi sensibili (ad
esempio, l’impulso ad andar dritto per la mia strada senza aiutare il mendico, l’impulso ad aiutarlo per
compassione, l’impulso ad aiutarlo per fare bella figura con gli amici, ecc) che la ragione deve soggiogare; e
in ogni situazione esiste sempre un solo impulso naturale pienamente adatto ed è la ragione - nella sua
assoluta e divina purezza - a sapere quale esso sia, per cui, per agire in maniera veramente morale, devo
comunque sempre seguire ciò che la ragione stessa prescrive. Non esiste allora la pluralità delle strategie: in
ogni situazione c’è una sola cosa da fare, ma è vero che, pur essendo assoluto il comando, sono comunque
libero di disattenderlo o di ottemperarlo. Se Fichte si fermasse qui, eviterebbe le insidie derivanti dalla
metafisica dell’Assoluto: e invece egli - appena due anni dopo -, sotto pressione dei Romantici che gli
rimproveravano di non aver dato fondamento al suo sistema, compie il salto verso la metafisica, sul piano e
conoscitivo e etico. In particolare, i Romantici gli rimproveravano che, abolita la cosa in sé kantiana, l’Io
assoluto restasse una struttura trascendentale non meglio definita e poggiante sul vago, priva di un’idonea
veste ontologica. Allora egli viene a distinguere due diversi livelli: quello trascendentale e quello metafisico
dell’essere. Con la dinamica trascendentale non si arriva all’essere, ma saprò comunque che, sotto la
dinamicità trascendentale, vi è lo strato metafisico dell’essere. Questa divisione si riverbera anche sul piano
morale: la ragione che mi prescrive come agire, senza tuttavia potermi costringere, adesso - determinando in
modo assoluto il progresso morale - non è più solo normativa (come era in Kant), ma si fa metafisica in un
mondo ontologico che è il corrispettivo dell’essere sul piano metafisico. C’è quindi un livello morale
esistente in senso ontologico, per cui la realtà fenomenica è solo il piano su cui l’ordine morale metafisico si
manifesta necessariamente, senza accidentalità alcuna. La mia libertà di individuo, allora, è solamente quella
di adeguarmi a siffatto ordine, comprendendolo, oppure di fare ciò che necessariamente deve essere fatto,
senza però capirlo. E così Fichte - nei Tratti fondamentali dell'età presente (1806) - delinea una filosofia
della storia che egli identifica col processo di realizzazione della libertà, intesa come il necessario dispiegarsi
dell’ordine morale: se lo accetto con coscienza e con esso collaboro, allora sono libero; se invece mi
oppongo, lo subisco senza comprenderlo e non sono libero. La progressiva manifestazione della libertà è
allora la progressiva trasparenza dell’ordine morale metafisico, per cui - secondo Fichte - sempre più gli
uomini lo capiranno, fino ad accettarlo e ad adeguarvisi consapevolmente: in tal senso, la libertà viene a
combaciare con l’adeguazione all’Assoluto. Così, nei Tratti fondamentali dell’epoca presente, Fichte scrive:
"è la necessità a guidare noi e il nostro genere; in nessun modo però una necessità cieca, ma la necessità
interna, perfettamente chiara e trasparente a se stessa, dell’essere divino. E solo dopo che si è giunti a porsi
sotto questa delicata guida, si è divenuti veramente liberi e si è penetrati nell’essere, perché al di fuori di
essa non v’è altro che illusione e inganno".
SCHELLING e HEGEL
La posizione fichteana è in certa misura confermata da Hegel e da Schelling, forse per molti aspetti è
facilitata dal fatto che in loro manca il tortuoso percorso fichteano dall’Assoluto trascendentale a quello
metafisico. Essi partono anzi fin da principio con la convinzione che alla base del reale vi sia un essere
assoluto; inoltre, a facilitare l’assolutizzazione è il fatto che il non-Io è per Fichte solo un momento interno
all’Io - si tratta infatti di un Assoluto radicato nella soggettività -, mentre per Schelling e per Hegel
l’Assoluto è da subito inteso come unità di soggetto e di oggetto (di Io e di non-Io), di spirito e di natura,
cosicchè in esso è compreso non soltanto l’aspetto soggettivo dell’Io che pone, ma anche l’aspetto oggettivo
della realtà conoscitiva: la differenza tra Schelling e Hegel sarà poi data dal fatto che per il primo le due
componenti (Io e non-Io, nella terminologia fichteana) non sono distinguibili attraverso un’articolazione
concettuale (giacchè si tratta di un’assoluta identità indifferenziata di soggetto e di oggetto, di spirito e di
natura, di conscio e di inconscio), ma è l’intelletto a conoscere le cose distinguendole artificiosamente. Per
Hegel, invece, l’Assoluto è sempre un tutto (unità di soggetto e oggetto), ma gli elementi della soggettività e
dell’oggettività sono articolati concettualmente e distinti da un rapporto dialettico per cui è possibile
distinguere la totalità come insieme di momenti integrantisi a vicenda. Questa concezione dell’Assoluto ha
un immediato riflesso sul problema della libertà: per Schelling l’Assoluto è totale identità di spirito e di
natura, ma se lo spirito è di per sé espressione di libertà nella sua creatività spontanea, la natura, viceversa, è
di per sé espressione di determinazione. Per meglio chiarire questo punto, Schelling fa ricorso con certa
frequenza ai termini "conscio" e "inconscio", asserendo che lo spirito è conscio, ossia esprime l’elemento
della consapevolezza, mentre la natura è inconscia; stando le cose in questi termini, allora, se l’Assoluto è
unità di spirito e di natura, esso sarà anche unità indifferenziata di libertà e di necessità, ovvero la libertà e la
necessità saranno due aspetti indisgiungibili della stessa realtà. Non sono dunque due aspetti articolati
concettualmente, ma sono la stessa cosa che poi nella lettura dell’intelletto separante è letta ora come
elemento conscio (e dunque libero), ora come elemento inconscio (e dunque necessario). Ma nell’Assoluto
tale duplicità manca, e lo si evince facilmente da quelle due attività con cui l’uomo coglie intuitivamente
l’unità indifferenziata (che non è coglibile dall’intelletto separante): l’intuizione per eccellenza è - così crede
Schelling - quella estetico/artistica, cosicchè, per cogliere tale unità indifferenziata di soggetto e oggetto, di
libertà e di necessità, di conscio e inconscio, si deve far ricorso al momento artistico. Nel dipingere la
Gioconda, Leonardo ha dunque voluto raffigurare qualcosa di preciso, che egli aveva con chiarezza in mente:
ma la critica successiva ha poi dato migliaia di interpretazioni diverse dell’opera, e ciò potrebbe andare
avanti all’infinito, poiché la Gioconda racchiude entro sé infiniti significati, in quanto è il risultato
dell’attività di un singolo (Leonardo) che, in quanto genio, si è immedesimato nell’Assoluto: attraverso la
mano di Leonardo, allora, si è espresso l’Assoluto stesso, imprimendo sulla tela infiniti significati e non i due
o tre che pensava Leonardo. Sicchè da un lato c’è la libertà di Leonardo, che dà libera espressione ai
significati che desidera, ma, dall’altro, ci sono i mille altri significati individuati da noi che contempliamo
estasiati la sua opera, e sono significati posti in essa dall’Assoluto stesso, che agiva attraverso Leonardo:
questi era dunque al contempo libero e necessitato, conscio e inconscio. L’altro esempio che può chiarire le
idee sulla prospettiva schellinghiana è quello della storia: essa è fatta dagli uomini, ossia da individui aventi
una loro determinata volontà e imprimenti le loro azioni nella storia; da queste intenzioni individuali espresse
dai singoli non nasce però un caos, ma un tutto in cui - a distanza di secoli - possiamo rinvenire un ordine e
una volontà assoluta: nasce un tutto proprio perché in tale totalità di azioni esprimenti l’Assoluto non agisce
solo l’arbitrio individuale, ma anche una volontà assoluta, ossia agisce quello stesso Assoluto che agisce
nell’opera d’arte. Esso opera sempre laddove dalle azioni umane scaturisce qualcosa che travalica la volontà
degli uomini; ma ciò non toglie che l'individuo non sia coartato: lo sarebbe se, a livello dell’Assoluto, libertà
e necessità fossero due aspetti distinti, ma poiché a distinguerle è solo l’intelletto, libertà e necessità sono due
aspetti dello sviluppo storico che solamente a posteriori possiamo definire come tali, giacchè "nella libertà
stessa si trova la necessità". Così, Napoleone che cambia le sorti del mondo - al pari di Leonardo - è
consapevole solo di una piccola parte del significato del suo agire, sta in realtà realizzando un disegno che
non gli appartiene: accanto ad una ridottissima parte conscia, nel suo agire è presente un’immensa parte
inconscia, parte in cui egli non è affatto libero. Ciò significa che l’agire di Napoleone e di Leonardo è sì
libero, ma al contempo va contro il loro volere. Questa soluzione al problema della libertà non è la sola
prospettata da Schelling nell’arco della sua carriera filosofica: essa rispecchia anzi solo una prima fase del
suo pensiero, e presto verrà superata da una concezione religiosa dell’Assoluto implicante un mutamento
della valutazione del problema della libertà, pur restando invariato il rapporto intercorrente tra libertà e
necessità (intese come coincidenti nell’Assoluto). Diversa è invece la soluzione che propone Hegel: anche a
suo avviso l’Assoluto è dato dall’interezza, anche se le sue componenti non finiscono poi per fondersi in
un’unità indifferenziata di stampo romantico, ma restano anzi rigorosamente distinte fra loro attraverso una
scansione dialettica che governa le leggi del pensiero e della realtà. Anche per Hegel, allora, ci sarà
nell’uomo una forma di libertà coincidente con la necessità, proprio perché anche per Hegel il soggetto è la
controparte dell’oggetto nell’economia del tutto. Ma, mancando il rapporto di semplice unità indifferenziata
su cui poggiava il pensiero di Schelling, l’individuo dovrà passare per una fase preliminare in cui si abitua a
non considerarsi solamente come individuo e in cui si mortifica nelle pretese di essere una realtà a sé stante,
svincolata dal tutto: deve cioè smettere di illudersi di esser libero nella sua individualità. Sicchè vi sarà un
primo momento negativo di mortificazione dell’individuale e un secondo momento positivo in cui
l’individuo ritrova la propria libertà nell’essere inserito nel tutto: "una libertà per cui sussista qualcosa di
veramente esterno non è libertà", poiché non deve esserci nulla di estraneo. Per Schelling, era più facile che
l’individuo riuscisse a comprendere la sua partecipazione al tutto, poiché il tutto era un’identità
indifferenziata; per Hegel, invece, è più difficile, in quanto l’individuo è realmente differenziato dal tutto,
cosicchè la parte finisce per avere una giustificata coscienza della propria specificità che può generare
l’illusione di essere non una parte del tutto, ma una realtà autonoma. Ecco allora che in Hegel troviamo la
preoccupazione - sempre rinnovantesi - di mortificare la pretesa del particolare a valere disgiuntamente dal
suo rapporto col tutto. Tale mortificazione si può attuare attraverso quella meditazione filosofica che ci fa
cogliere la realtà come un tutto articolato in parti; ma poiché la filosofia è appannaggio di poche menti
eccelse, si dovrà intraprendere una via alternativa: in particolare, la strada proposta da Hegel è quella
delineata nel rapporto tra servo e signore, tratteggiato nella Fenomenologia dello Spirito (1807). Gli interessi
dell’individuo sono sempre legati ad una particolare situazione radicata in diverse cognizioni della vita, tali
per cui l'interesse dell'individuo è innanzitutto legato ad interessi materiali (sussistenza, felicità, ecc),
costituenti la sua vita fisica e facenti sì che l’individuo stesso cerchi di affermarsi egoisticamente come parte
autonoma: si tratta, pertanto, di abbattere questa falsa coscienza e, per fare ciò, Hegel ricorre alla figura del
rapporto tra signoria e servitù, rapporto realizzantesi quando la coscienza capisce di essere autocoscienza,
ovvero coscienza individuale contrapposta alle altre. Ora, Hegel asserisce che tale autocoscienza afferma la
propria realtà soprattutto nell’elemento della vita. Se l’individuo rimanesse a questo livello, lo spirito non
potrebbe progredire e non potrebbe essere momento di una totalità: occorre allora che si verifichi una
situazione drammatica in cui l’autocoscienza sia di fronte all’alternativa tra una vita condannata
all’individualità o una morte implicante l’universalità. Uno dei due combattenti preferirà gettar le armi e
salvare la vita, rimanendo chiuso nella propria particolarità, l’altro sceglierà di morire piuttosto di vivere
nella particolarità e, perciò, sarà il vero signore. Questa è la condizione preliminare per essere liberi, ma ciò
non è ancora essere liberi; per essere veramente tali, occorre partecipare a quell’istituzione che
concretamente nel mondo dello Spirito esprime la realtà del tutto: tale istituzione è lo Stato espressione
dell’Assoluto nell’ambito delle istituzioni. Esso non è che lo Spirito assoluto manifestantesi nell’esteriorità
delle istituzioni, cosicchè se l’individuo partecipa dello Stato non come mero "borghese" - individuo che
vuol sfruttare lo Stato per realizzare i propri egoistici interessi -, ma come "cittadino" - momento costitutivo
dello Stato -, allora egli realizza la sua appartenenza al tutto ed è momento della totalità. In questo caso, la
volontà dell’individuo diventa volontà dello Stato, e viceversa, cosicchè l’individuo stesso realizza la propria
libertà identificandosi nella legge dello Stato, inteso da Hegel come il tutto che perfeziona l’individualità
inserendola in una rete complessiva. In tal caso sarà per Hegel possibile parlare di "libertà sostanziale",
distinta dalla "libertà formale", che è quella che assegna all’individuo un certo ambito di giurisdizione
contrapposto a tutti gli altri individui, è quella che oggi chiamiamo "libertà civile"; la libertà sostanziale, dal
canto suo, è quella non già dell’individuo, bensì dello Stato come personificazione istituzionale
dell’Assoluto, e, nella misura in cui partecipa dello Stato, l’individuo partecipa anche di tale libertà politica,
consistente nel cogestire la cosa pubblica: non è più una libertà settoriale a porzioni, ma è una libertà sola da
tutti partecipata. E per Hegel lo Stato moderno ha il merito di conciliare le due libertà, a differenza dello
Stato antico - in primo luogo la greca - che privilegiava quella sostanziale, sacrificando quella
formale; nello Stato moderno, la libertà formale è invece assegnata e tutelata dallo Stato stesso. Resta però il
fatto che la libertà di cui finora abbiam parlato a proposito di Hegel è una libertà di tipo politico/giuridico e
non morale: questo perché, secondo Hegel, la libertà giuridico/politica è quella suprema, ricomprendente in
sé qualsiasi altra libertà, giacchè il momento dell’eticità è superiore a quello della moralità interiore di marca
kantiana, la quale è espressione di un puro dover essere, una mera idealità superata dall’eticità concreta: per
essere veramente libero, devo incarnare la mia libertà nell’istituzione dello Stato. Kant parla spesso di
dovere, ma mai lo concretizza, lasciandolo invece come mera formulazione formale e priva di contenuto: il
dovere è invece per Hegel fare ciò che mi prescrive lo Stato, e per capire il nostro dovere non dobbiamo far
altro che guardare la nostra posizione nella società, piuttosto che guardare dentro di noi. In questo modo, la
libertà è coincidente con la necessità, una necessità che, in quanto riconosciuta come mia, non soffoca la
libertà, ma anzi si identifica con essa. Dopo che Hegel ebbe elaborato queste dottrine, Schelling mutò
radicalmente la propria prospettiva: nel suo periodo della "Filosofia della libertà" - così detto per via dello
scritto del 1809 intitolato Ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana), Dio non può essere - dice
Schelling - inteso se non come Dio persona, e ciononostante ritiene che anche in questo caso non si possa
parlare di Dio se non come assoluta coincidenza di necessità e libertà, giacchè una libertà non coincidente
con la necessità sarebbe aperta all’indeterminatezza e ai condizionamenti esterni. Secondo questa nuova
prospettiva religiosa, anche l’uomo deve essere in tal senso libero, in quanto fatto ad immagine e
somiglianza di Dio: ma l’uomo non è Dio, è effetto di un processo da Lui derivante e per ciò la sua libertà
sarà necessariamente inferiore a quella divina. Tale inferiorità consisterà appunto nella non coincidenza con
la necessità. Sicchè la libertà non può consistere nel determinismo (in ciò Schelling si schiera contro la
tradizione deterministica del Seicento e del Settecento) né nell’indeterminatezza, ovvero nel libero arbitrio,
perché altrimenti non si dovrebbe parlare di libertà ma di caso. Per capire in che cosa realmente la libertà
consista, occorre tener conto del fatto che, pur volendo introdurre una prospettiva personalistica di Dio,
Schelling resta ancorato ad una concezione saldamente panteistica: ciò sembrerebbe contraddire la
concezione personalistica, ma Schelling - per non cadere in contraddizione - precisa che il panteismo a cui
egli fa riferimento non è quello da sempre erroneamente inteso spinoziasamente come meccanicismo
camuffato ed esteso ad una sostanza universale (chè infatti la Sostanza di Spinoza altro non era se non
un’infinita catena di cause); al contrario, il panteismo qui in questione consiste nel considerare Dio come
entità processuale e il mondo come derivazione di tale processo divino. A tal proposito, Schelling opera una
distinzione tra identità e medesimezza, dicendo che il mondo e Dio sono sì identici, ma non medesimi,
giacchè essi possono essere distinti: il mondo è in Dio, ma nello stesso tempo deriva da Dio, il quale resta un
qualcosa di diverso e superiore rispetto al mondo stesso. Così dicendo, Schelling si riallaccia direttamente al
panteismo vitalistico di Giordano Bruno e alla mistica tedesca, in particolare a Bohme e a Baader: da
quest’ultimo, recupera la dottrina secondo cui tutte le cose (ivi compreso Dio) hanno in sé un duplice
principio: un principio oscuro (il fondamento) e uno luminoso (l’intelletto); il primo esprime una brama
oscura di essere che non ha ancora ricevuto forma ed esistenza; il secondo è invece legato alla forma e
all’esistenza, e fa sì che la brama informata passi ad esistere. Da tale polarità - manifestantesi attraverso il
passaggio dall’oscuro alla luce - derivano sia Dio sia il mondo, con però la differenza che in Dio (che è realtà
assoluta) si tratta di un passaggio immediato ed inevitabile, tale per cui il momento della luce è
indisgiungibile da quello della libertà, cosicchè Dio riesce a superare pienamente l’oscurità stessa; nel
mondo, invece, questi due elementi sono necessariamente connessi e in gran parte del creato - la parte in cui
si giunge alla coscienza - il passaggio non è pienamente compiuto. Nell’uomo - che del mondo è il vertice - il
passaggio non è obbligato, e per ciò in lui la libertà non coincide con la necessità: in questo senso, l’uomo si
trova dinanzi ad un "punto di indifferenza", un momento in cui scegliere se restar legato alla bramosia oscura
del fondamento, rimanendo vittima del particolare, oppure sviluppare fino in fondo l’intelletto e realizzare lo
Spirito dell’amore, comprendendo l’unità col tutto e quindi realizzando perfettamente la propria
destinazione. La prima scelta è meramente negativa e coincide col male, la seconda è positiva e coincidente
col bene: la libertà è allora per Schelling scelta tra il bene e il male, scelta che manca in Dio, giacche
implicante una libertà di seconda qualità rispetto a quella divina. E qui tutto si complica, poiché Schelling,
dopo aver originariamente asserito che la libertà non è libertà di scelta, ora sembra ammetterla: del resto, la
creazione dell’uomo rientra in quel processo di manifestazione di Dio e quindi riveste un carattere
necessario, di contro alla libera scelta poc’anzi riconosciuta all’uomo. La soluzione prospettata da Schelling
resta assai ambigua: l’uomo compie l’atto di scelta tra il bene e il male, ma tal scelta non è compiuta
dall’uomo in ogni momento della sua vita né nel corso del tempo, bensì è dall’uomo compiuta in un
momento extratemporale, esattamente al momento della creazione. E’ dunque un atto di scelta compiuto al di
là della determinazione, poiché l’uomo è ancora puro essere spirituale non ancora entrato nel circolo del
tempo; dopo la scelta, tutto diventa necessario, giacchè l’uomo ha scelto la propria natura, che da quel
momento sempre lo condiziona necessariamente. Per meglio chiarire questo punto, Schelling ci ricorda
quante volte, accusati di aver agito in un dato modo, ci scusiamo dicendo "non è colpa mia, son fatto così!",
parole con cui non vogliamo sottrarci alla responsabilità quanto piuttosto mettere in luce come la nostra
natura sia determinata; il fatto stesso che un bambino si riveli malvagio implica che egli presumibilmente
sarà tale anche una volta diventato adulto. Schelling poi - che dopo esser stato luterano si convertì al
cattolicesimo - attacca i Luterani: essi hanno ragione a concepire l’uomo come determinato, ma sbagliano nel
credere che tale determinazione sia opera della volontà divina; al contrario, la predestinazione stessa è il
frutto della scelta operata dall’uomo.
L’OTTOCENTO
Nell’Ottocento non attecchiscono né la soluzione dualistica kantiana né quella idealistica, in nessuna delle
sue varianti, giacchè si assiste all’imperare incontrastato del determinismo - fatta qualche eccezione nata
peraltro soprattutto per reazione -, all’insegna di una legge regolante il comportamento tanto degli uomini
quanto delle società. Per i Positivisti, tale legge è al contempo della società e della storia; per
l’evoluzionismo è invece legge biologica, per l’utilitarismo si tratta di legge psicologica, per il materialismo
è invece legge dettata dalla natura o (nel caso di Marx e di Engels) dalla dialettica. In ogni caso, a prevalere è
l’elemento nomologico, cosicchè queste filosofie, pur diversissime fra loro, hanno tutte un carattere
fortemente descrittivo, limitandosi a descrivere la realtà più che a prescrivere come comportarsi e come agire
in essa. Nell’ambito del positivismo, Comte ritiene che la storia e le società siano regolate dalla cosiddetta
"legge dei tre stati" - valida e per la società e per l’individuo -, secondo cui dapprima gli individui e le società
passano attraverso uno stadio teologico (spiegano ogni cosa come effetto dell’intervento di un ente
soprannaturale), successivamente attraverso uno stadio metafisico (il principio di spiegazione è rinvenuto
nella natura stessa, ma non più come forza soprannaturale, bensì come forza metafisica che interviene nella
natura: è il caso della vis dormitiva per spiegare il sonno), infine giungono allo stadio positivo (capiscono
che i fatti debbono essere spiegati ricorrendo alle leggi), per cui tutto è riducibile a leggi costanti. Qualcosa
di analogo avviene per gli evoluzionisti, senonchè per essi la legge non è storica ma biologica, data o dal
progressivo adattamento degli organi all’ambiente (Lamarck) o dalle mutazioni spontanee a livello
individuale (Darwin). Simile è anche la concezione di quei materialisti che Marx definisce sprezzantemente
"volgari", i quali finiscono addirittura per parlare del pensiero come secrezione del cervello, così come la
bile è secrezione del fegato. Questo determinismo assoluto, azzerante la libertà umana, è rifiutato da Marx e
da Engels, ad avviso dei quali il materialismo è presente, più che nella natura, nella dialettica storica: essi
sono infatti convinti che vi sia una struttura economica tale da determinare qualsiasi altra manifestazione
sovrastrutturale (politica, storica, morale, ecc). Per gli utilitaristi, infine, i quali si riallacciano direttamente a
Hume, la volontà è determinata da associazioni mentali che seguono una catena causale necessaria e tale
causalità mentale ha la stessa necessità di quella fisica della natura. Sicchè è lecito affermare che l’Ottocento
è il secolo del determinismo, anche se tal determinismo, in realtà, non riesce mai ad essere coerente fino in
fondo, giacchè pressochè tutte le correnti deterministiche hanno anche esigenze normative e prescrittive: così
il positivismo invita l’intellettuale ad adoperarsi per accelerare la legge (e Comte stesso parla a più riprese di
"modificabilità della legge"), i materialisti cercano crepe nel determinismo per rinvenire margini di libertà, il
marxismo invita gli operai ad imbracciare i fucili e ad abbattere il regime capitalistico da cui sono
schiavizzati. Ora, tutto ciò presuppone, di fatto, che l’uomo sia almeno in parte libero e non del tutto
determinato: tutte queste correnti di pensiero, allora, finiscono con l’introdurre spazi di indeterminatezza,
quasi come se il determinismo si erodesse dal proprio interno. Così, le leggi dei Positivisti sono a tal punto
complicate quando son riferite all’intelletto umano da finire per sfuggire al rigido determinismo, e in questi
interstizi di indeterminatezza può inserirsi liberamente l’uomo. Lo stesso problema del rapporto fra struttura
e sovrastruttura - problema che sta al cuore del marxismo - resterà sempre aperto e mai efficacemente risolto
da nessun marxista: alcuni (in primis Gramsci) faran leva sulla sovrastruttura, altri (soprattutto Althusser)
sulla struttura, quasi come se tra le due intercorresse (e già Engels lo notava) un rapporto biunivoco per cui
gli intellettuali possono modificare col loro pensiero le strutture. A sostegno di questo margine di libertà
riconosciuto dai marxisti all’agire umano merita di esser ricordato come Marx, di fronte all’alternativa tra il
rigido e "cieco" determinismo di Democrito e quello di Epicuro, più tenue e da cui si intravedeva a sprazzi la
libertà umana, non avesse avuto alcuna esitazione a optare per il secondo.
LO SPIRITUALISMO
Nell’Ottocento vi è anche chi dichiara guerra al determinismo e lo fa puntando soprattutto sul fatto che esso
non può valere per ogni ambito del reale: era questa la soluzione prospettata già da Cartesio e che è ora
ripresa dallo spiritualismo francese, l’unica corrente filosofica dell’Ottocento - se si esclude certo idealismo a fronteggiare in modo decisamente combattivo e convincente il determinismo, schierandosi in difesa della
libertà dell’agire. Nella corrente spiritualistica troviamo per un verso una nuova versione del dualismo di
matrice cartesiana; ciò è intrinseco al fatto che lo spiritualismo ha come padre fondatore Cartesio stesso, il
quale - introducendo una res cogitans esulante da ogni necessità - aveva riconosciuto una sfera di libertà
all’uomo: separando, con una netta cesura, la sfera della materialità da quella della spiritualità, egli afferma
l’indipendenza assoluta tra le due e da qui prende appunto le mosse lo spiritualismo ottocentesco. Suo grande
punto di riferimento, oltre a Cartesio (in cui manca l’elemento dell’introspezione, centrale nello
spiritualismo), è Pascal, in virtù dell’egemonia da lui concordata allo spirito e alle ragioni del cuore (esprit
de finesse): comincia così a delinearsi il carattere portante dello spiritualimo: la coscienza come sede
originaria e primaria di ogni forma di conoscenza e, conseguentemente, di ogni moralità. Il vero sapere,
allora, non proviene dall’analisi della natura, ma dall’introspezione nel proprio sé, con un’evidente ripresa
del tema agostiniano del lumen naturale e del redi in te ipsum (il che era peraltro valido anche per Cartesio,
il quale - attraverso il cogito, ergo sum - faceva partire la conoscenza dall’evidenza di esistere in qualità di
soggetto pensante). Altro padre fondatore dello spiritualismo è Maine de Biran, il quale fonda una nuova
concezione della coscienza su base non metafisica, ma meramente psicologica, dandone una fondazione più
scientifica che non filosofica; egli si colloca come propaggine estrema della corrente dell’ideologie, dello
studio delle idee - intese come prodotto della mente - nella loro correlazione col corpo. Maine de Biran
asserisce che dobbiamo partire da un "fatto primitivo" - che può esser posto a fondamento della scienza - che
non sia un fantasioso principio astratto (quale era l’Io di Fichte), ma un fatto: ricollegandosi al "fatto", egli che pure del positivismo fu acerrimo nemico - si accosta alle tesi e alla terminologia positivistiche. Il fatto
originario in questione è il "senso interno" (detto anche "sentimento della mia esistenza"), con un fin troppo
evidente richiamo al cogito cartesiano (letto però in chiave scientifica). Tale originario sentimento della mia
esistenza è dato dal fatto che mi sento opporre una resistenza da qualcosa di a me esterno: è cioè dato dalla
coscienza di uno sforzo, il sentirmi come attività lottante contro la passività dell’esterno che mi si oppone e
mi fa resistenza (e tra questi oggetti esterni a me opponentisi c’è il mio stesso corpo, che lotta contro il mio
sforzo interno). Riconoscere al soggetto l’attività (ovvero la spontaneità) come sua essenza equivale a
riconoscere che egli è libero, sottratto da una catena causale i cui singoli anelli sono insieme attività
(causano) e passività (sono effetti di altre cause): la causalità necessaria, allora, si deve arrestare un attimo
prima che si entri nell'interiorità del soggetto. "Porre in discussione la libertà significa mettere in dubbio il
sentimento dell’esistenza dell’io, che da essa non si differenzia […] La libertà, o l’idea della libertà,
considerata nella sua fonte reale, non è altro che il sentimento della nostra attività e del nostro potere di
agire e di produrre lo sforzo costitutivo dell’io": nel soggetto impera un’energia prorompente all’esterno e
scontrantesi con esso; libertà è, appunto, sentire la nostra attività interna, lo sforzo costitutivo dell'io.
Sebbene nel mondo esterno regni il determinismo, sussiste un ambito che da esso non è minimamente
sfiorato: tale è l’ambito della coscienza, regno della spontaneità. Questo modello è ripreso e corretto dallo
spiritualismo: caratteristica precipua è la distinzione e la separazione dei piani, per cui coscienza e realtà
materiale sono due sfere eterogenee e quindi incompatibili, senza che una sia la versione nobilitata dell’altra.
Nello spiritualismo, tuttavia, il discorso si fa più complesso: la coscienza è caratterizzata da spontaneità e,
per ciò, è libera e sottratta alla causalità; ma poi lo spiritualismo tende a fare della coscienza la realtà
fondamentale, rispetto a cui la non-coscienza (ossia la natura) è realtà subordinata e derivata, quasi come se
fosse una coscienza addormentata e oggettivata, che ha perso lo smalto delle sue prerogative. Si giunge per
tal via ad un monismo camuffato, per cui l’unica realtà è la coscienza, e la natura - eccanicisticamente intesa
da Cartesio, da Kant e da Maine de Biran - è coscienza sviluppatasi in maniera più grossolana. Ciò significa
che, in qualche modo, l’intera realtà è spontanea, anche se non manifestantesi nella forma umana della
libertà: sicchè lo spiritualismo può affermare la libertà in forma generalizzata, tale per cui essa è estendibile
all’intera realtà, poiché anche la natura è spontanea e attiva, capace di produrre il nuovo: in tal senso,
l’effetto non può mai essere inteso come mero risultato meccanico della causa.
EMILE BOUTROUX
Uno dei più insigni esponenti dello spiritualismo, Boutroux, si propone di partire da un’impostazione
categoriale di tipo positivistico: nel suo saggio Della contingenza delle leggi della natura (1874), egli
riprende apertamente il modello della realtà organizzata gerarchicamente in diversi "mondi" (necessità
logica, essere astratto, generi, materia, corpi, esseri viventi, uomo). In primis, egli osserva che questi generi
sono qualità diverse fra loro, non si tratta di pura crescita quantitativa, ma di vero e proprio salto qualitativo,
automaticamente escludente la causalità necessaria. Se ciò che viene dopo è superiore (e quindi nuovo) a ciò
che sta prima, non può infatti esserci causalità necessaria: è invece Dio che ha creato i diversi livelli di realtà
e Boutroux connota questa differenza qualitativa dicendo che la necessità della legge va vieppiù
decrescendo. Nel primo "mondo" (quello della necessità logica) la causalità necessaria è fortissima; nel
secondo (l’essere astratto) già si fa più debole, fino al mondo vivente, dove è ancora più debole, giacchè lì
non sempre le cose sono calcolabili con la necessità causale; il livello massimo è dato dall’uomo, che è anche
realtà spirituale e non solo corporea. E’ un’autentica gerarchia di realtà che vanno dalla più bassa alla più
alta, dalla più astratta alla più concreta, cosicchè, salendo nei livelli di realtà, ci imbattiamo in realtà più
piene (l’uomo è più "reale" della materia inorganica, e così via). Ciò significa che la contingenza va di pari
passo con tale scala e, dunque, più la realtà è piena e tanto più in essa trovo contingenza. L’idea sotterranea è
qui che la necessità sia un mio modo di vedere le cose legato alla rappresentazione di un certo tipo di realtà:
così leggerò i livelli bassi del reale avvalendomi della necessità, legata al modo di rappresentarmi quella
struttura della realtà. Tutto questo appare ancora più evidente nello scritto di Boutroux intitolato L'idea della
legge naturale nella scienza e nella filosofia contemporanee (1895): anche qui egli propone una gerarchia,
ma si tratta, più che di una gerarchia ontologica, di una epistemica, in cui vengono gerarchizzate le varie
scienze (logica, matematica, meccanica, fisica, biologia, psicologia, sociologia); anche qui si sale
dall’astratto (la logica) al concreto (la sociologia), e ciò era già valido per un positivista come Comte, ma
Boutroux aggiunge che, quanto più la scienza è astratta, tanto più i rapporti sono necessari; viceversa, quanto
più essa è concreta, tanto più si deve fare a meno del rapporto necessitante. Il passaggio dalla gerarchia della
realtà a quella della scienza rivela come il criterio della necessità sia tutt’altro che assoluto, nel senso che non
appare neppure essere intrinseco al reale, ma meramente metodologico, frutto della nostra mente. Ben
emerge la tendenza spiritualistica a considerare la realtà come un tutto unitario in cui i livelli bassi sono letti
secondo il criterio della necessità, senza che però tali livelli siano strutturalmente diversi dai più alti: è,
questo, un monismo abilmente camuffato dietro la maschera della gerarchia; l’essenza della realtà,
rivelantesi ai livelli più alti, è assolutamente spontanea e libera.
HENRI BERGSON
Una posizione altrettanto radicale rispetto a quella di Boutroux è quella sostenuta da Henri Bergson, espressa
inizialmente nel suo Saggio sui dati immediati della coscienza (1889): i "dati immediati" in questione sono i
primi contenuti della coscienza, ossia quelli che essa ritrova immediatamente in sé prima di ogni
elaborazione del pensiero. Lo scritto bergsoniano parte dalla premessa con cui si avvisa il lettore che tali dati
hanno carattere qualitativo e non quantitativo, di contro al positivismo che riduceva tutto a quantità
misurabili. Il discorso di Bergson è dunque incentrato innanzitutto sulla difesa della qualità: egli comincia
col sostenere che i dati immediati della coscienza - dai quali parte ogni nostra elaborazione concettuale hanno carattere qualitativo e, per chiarire questo punto, Bergson costella il suo periodare elegante di più
esempi. Pensiamo alla gioia o al dolore, egli dice: essi possono accrescere o diminuire in seguito a
determinate riflessioni; ma la gioia crescente implica non solo differenze quantitative, ma anche qualitative:
una gioia minore, infatti, non è solo quantitativamente più ridotta rispetto ad una maggiore, ma è anche una
gioia qualitativamente diversa, di altro tipo. Ciò vale anche per i dati della coscienza derivanti dall’esterno:
così avviene alla carta allontanata o avvicinata alla fonte luminosa; per i Positivisti, quanto più la allontano,
tanto meno essa è illuminata, e viceversa, il tutto in termini rigorosamente quantitativi. Per Bergson, invece,
se la allontano, la carta diventa sempre più grigia; se essa invece è rossiccia, si fa più violetta, cambiando
colore: non è più o meno luminosa, semplicemente cambia qualitativamente colore. Ciò si spiega con la
natura della coscienza, implicante l’introduzione del concetto chiave nella filosofia bergsoniana di "durata
reale". Bergson dice che la nostra comune rappresentazione del tempo è quella di un tempo spazializzato (o
omogeneo), cioè ridotto a segmenti temporali che si aggiungono gli uni agli altri: e ognuno dei segmenti è
omogeneo agli altri, e pertanto essi sono interscambiabili fra loro, poiché non qualitativamente diversificati
(come se cinque minuti trascorsi piacevolmente fossero del tutto identici a cinque minuti spesi soffrendo). E
allora, in una siffatta concezione del tempo, l’elemento del fluire è un’illusione, frutto del considerare in
fretta la successione dei segmenti: come al cinema il rapido succedersi delle immagini fisse dà la sensazione
del movimento e del fluire, quando in realtà vi è solo la giustapposizione di un’immagine all’altra, così è per
il tempo spazializzato, mera successione statica e giustappositiva di istanti che si succedono. Ma per
Bergson, in realtà, le cose non sono così e quello del tempo spazializzato è un inganno ottico: se ricorro
all’introspezione e guardo dentro di me, all’interno della mia coscienza, mi accorgo subito che il tempo è una
"corrente" che fluisce (la distensio animi di cui parlava Agostino) ininterrottamente, una corrente in cui
manca la distinzione tra segmenti. Ci troviamo cioè dinanzi ad un unico fluire in cui ciò che c’era prima si
espande in ciò che viene dopo, senza elementi spaziali di mezzo: come in una sinfonia abbiamo una serie di
note che si sviluppano ma, quando la sentiamo, non possiamo scomporla in singole note, giacchè essa è
fluire di note in un tutt’uno, così è per la "durata reale", che è un flusso scorrente nella nostra coscienza. E se
allora il tempo è un’unica corrente in cui non si possono distinguere segmenti, non è possibile parlare di
segmenti interscambiabili e a sé stanti: se immagino di scomporre la "durata reale", otterrò un segmento che
porta in sé tutte le influenze dei presunti segmenti precedenti; il secondo segmento avrà qualità diverse
rispetto al primo, e, per quanto spazializzati siano uguali (cinque minuti son sempre cinque minuti), nella mia
coscienza sono del tutto diversi a livello qualitativo: così, cinque minuti spesi piacevolmente saranno
completamente differenti da cinque minuti trascorsi nella sofferenza. Si tratta, allora, di segmenti interni ad
una sola corrente. Nel caso del tempo spazializzato, ciascun segmento è indipendente e distinto dagli altri,
che possono relazionarsi secondo un rapporto di causa/effetto (solo dove vi son cose distinte ciò può
avvenire); nel caso della durata reale, invece, c’è un solo movimento, differenziantesi all’intero a livello
qualitativo, ma si tratta di differenziazioni di una sola realtà: essendo una sola la realtà semovente, non sarà
possibile ricorrere al rapporto di causa/effetto. Sicchè nella durata reale non vi sono momenti che sono causa
e altri che sono effetto, ma vi è un unico flusso di sviluppo costituente la nostra coscienza. Il rapporto di
causa/effetto è sostituito dalla spontaneità. I dati immediati della coscienza hanno carattere qualitativo
proprio perché si collocano in unico flusso, tale per cui ora percepisco la mia interiorità diversamente da
come la percepivo un’ora prima; in siffatta prospettiva, non v’è modo di introdurre la causalità. E Bergson
ritiene che si possa sviluppare una critica sia a quel "determinismo psicologico" (cioè interiore) che pretende
di intendere meccanicisticamente l’interiorità dell’uomo, sia a quello esteriore, che legge la realtà come
determinata causalmente, secondo il modello seicentesco del meccanicismo: a tale critica è dedicato il terzo e
ultimo capitolo del Saggio sui dati immediati della coscienza. Bergson ritiene che tale determinismo
meccanicistico assuma nella scienza contemporanea una configurazione nuova, spostandosi dal piano
macrofisico a quello microfisico della fisica atomica: muovendosi all'interno delle molecole, gli atomi
eserciterebbero azioni causali reciproche e tal movimento sarebbe il corrispettivo di ciò che avviene nella
macrofisica nel movimento dei corpi, col presupposto del principio della conservazione dell’energia. Il
determinismo infatti si regge - nota Bergson - sul principio della conservazione dell’energia, cosicchè
l’energia disponibile in natura non può né crescere né diminuire. E l’ipotesi di una determinazione necessaria
viene immediatamente meno sia nel caso in cui l’energia diminuisca sia in quello in cui essa aumenti, poiché
si viene ad avere un effetto che soverchia la causa; infatti, per il principio di conservazione dell’energia, la
somma degli effetti deve essere sempre uguale a quella delle cause, sennò non è possibile rendere
deterministicamente conto del surplus di energia. Ma Bergson ritiene appunto che in più casi si verifichi tale
surplus di energia, ad esempio nella coscienza, intesa come un flusso autoalimentantesi senza stimoli
dall’esterno, una sorta di forza interiore che cresce su se stessa. Per questa via, Bergson sconfessa a livello
coscienziale il determinismo: il surplus di energia riconosciuto nella coscienza non può essere spiegato nei
termini di un rapporto di causa/effetto. Tuttavia, questa tesi bergsoniana può convincere solo chi già accetta
spiritualisticamente la concezione della coscienza come corrente autoespansiva, e dunque Bergson prova a
mostrare come eccezioni al principio di conservazione dell’energia sussistano anche nel mondo naturale. Tal
principio è ottimo finchè consideriamo il mondo dal punto di vista della fisica meccanica, ma già entra in
crisi in quei fenomeni naturali in cui invece si entra nell’ambito della vita (la chimica organica e, ancor di
più, la biologia), perché qui si assiste ad un fenomeno che assolutamente manca nel mondo inorganico: la
crescita dei viventi, ovvero il loro aumento di energia, tale per cui l’energia si aggiunge a quella già presente,
senza esser riconducibile a fattori causali esterni; già Kant notava - nella Critica del Giudizio l’impossibilità di spiegare causalmente perfino una realtà semplice quale può essere un filo d’erba o un
verme, riconoscendo la necessità di introdurre il finalismo. Bergson, dal canto suo, non parla di finalità (è
anzi contrario ad ogni forma di finalismo), e ritiene che la forza non vada cercata in un fine futuro, ma alle
spalle, senza tuttavia inserirla nella determinazione causale: si tratta cioè di una spinta non riconducibile a
singoli momenti giustapposti causalmente. Dopo aver sbaragliato quello fisico, Bergson attacca anche il
determinismo psicologico, quello propugnato dall'associazionismo, secondo cui tutti i nostri processi mentali
sono determinati da associazioni meccaniche e necessarie tra immagini precedenti e immagini successive
(l’immagine precedente causa cioè quella successiva, inducendo ad associazioni: dopo che mi son scottato,
non appena vedo la fiamma, subito a tale immagine si associa quella del dolore derivante dalla scottatura).
Secondo Bergson, l’errore imputabile all’associazionismo è il seguente: le singole idee avrebbero una loro
individualità atomica e l’atto di volizione consisterebbe in un rapporto associativo per cui A produrrebbe
meccanicamente B; Hume - che dell’associazionismo è il padre fondatore - diceva significativamente che
nella mente avviene ciò che si verifica sul tavolo da biliardo quando le palle si scontrano e producono effetti
totalmente determinati dalla causalità. Bergson obietta che la coscienza non è tale aggregato di stati atomici
tra loro distinti: è, piuttosto, un flusso unico, in cui A trascolora lentamente in B (che molto conserva di A),
che a sua volta trascolora in C, e così via, con una crescita implicante un’energia autogenerantesi e, dunque,
non necessitata, quasi come una valanga che frana a valle. "Questi sentimenti - premesso che essi
raggiungano una sufficiente profondità - rappresentano ciascuno l’anima intera, nel senso che il suo
contenuto si riflette in ciascuno di essi": non c’è un A o un B con contenuto e significato autonomo, c’è solo
un’unica corrente esplicantesi in singoli sentimenti indisgiungibili dallo sviluppo dell’intera corrente e "dire
che l’anima si determina sotto l’influenza di essi, equivale a dire che l’anima si autodetermina"; la
rappresentazione non è qualcosa di esterno all’anima, è anzi l’anima stessa che, in quel momento, si presenta
in quel dato modo e "l’associazionismo riduce l’io ad un aggregato di fatti di coscienza, sensazioni,
sentimenti e idee, ma non vede in essi niente di più che ciò che il loro nome esprime". Ovvero li considera
come contenuti mentali autonomi, sicchè l’associazionismo "potrà giustapporre questi momenti
indefinitivamente, senza ottenere che un io fantasma, l’ombra dell’io che si proietta nello spazio". In tal
maniera si viene cioè ad ottenere non il vero io, ma un io superficiale, coincidente con la successione
giustappositiva di immagini esterne dell’io, come se, anziché conoscere una città vivendola dall’interno, si
prendessero tante sue immagini e le si osservassero. L’errore risiede dunque anche nel perdere l’essenza
reale dell’io, frantumandolo in un pulviscolo di immagini a sé stanti e causalmente regolate. Per meglio
chiarirsi, Bergson ricorre a più esempi: immaginiamo che io mi alzi per aprire la finestra, ma che poi, una
volta alzato, mi dimentichi quel che volevo fare e, dunque, non apro la finestra. Stando all’associazionismo,
tale sequenza si spiega dicendo che si interrompe la connessione e vien meno l’associazione: ma Bergson
osserva come ciò sia del tutto contraddittorio, poiché, se partiamo dall’assunto deterministico per cui una
data immagine A già contiene in sé la causa per produrre B, allora non potrà interrompersi la sequenza
causale; dire ch’essa si interrompe equivale a dire che A poteva non dare B, ma magari A1 o A2, cosicchè si
sgretola la connessione necessaria. Per Bergson dunque la questione deve essere diversamente interpretata,
dicendo che il mio alzarmi per aprire la finestra è il punto estremo del flusso che è la durata reale: nulla
impedisce che esso non abbia sempre la stessa velocità e che possa momentaneamente interrompersi per poi
ripartire; in questo caso, senza sforzi di memoria, accade che improvvisamente mi torna in mente che devo
aprire la finestra, poiché il flusso è ripartito dopo una pausa. Similmente, sento il profumo della rosa e ciò
suscita in me un determinato ricordo: per gli associazionisti, vi è un’associazione tra quella determinata
immagine (la rosa) e il ricordo; ma se davvero fosse così - obietta Bergson -, allora tutte le volte che sento il
profumo della rosa dovrei sempre avere quel ricordo, cosa che evidentemente non avviene. Ciò perché mi
trovo in un particolare momento in cui il flusso della durata reale mi sfugge in maniera tale che riaffiora il
ricordo di quella situazione vissuta in concomitanza con la percezione del profumo della rosa. Ma Bergson,
nel suo argomentare, dà per scontato che per gli associazionisti le rappresentazioni abbiano carattere
meramente quantitativo, quando invece un associazionista convinto come John Stuart Mill aveva insistito su
come esse avessero anche prerogative qualitative e fossero meno meccaniche del previsto. L’ambito
corporeo, tuttavia, resta sotto la tutela delle leggi meccaniche: occorre allora chiarire quale sia il rapporto tra
durata reale e corpo, e, per far ciò, bisogna primariamente affrontare il problema inerente a che cosa sia per
Bergson la materia. Egli ha, in merito, una posizione del tutto particolare, mediana fra il realismo e
l’idealismo (pur rifiutandoli entrambi): per il realismo, i corpi esterni esistono autonomamente, in maniera
indipendente dalle nostre rappresentazioni; per l’idealismo, invece, non vi è esistenza che non si identifichi
con la percezione stessa (l’esse est percipi di Berkeley). Dal canto suo, Bergson asserisce che i corpi non
sono che le immagini da noi indipendenti (e in ciò dà ragione al realismo), ma identificantisi con la nostra
percezione (e in ciò dà ragione all'idealismo): sicchè, quando pensiamo alle cose esterne, pensiamo alle
nostre immagini come da noi indipendenti, come se le cose fossero le nostre immagini. Tra di esse ve n’è una
particolare - il nostro corpo - che di peculiare ha l’essere l’immagine con cui selezioniamo tutte le altre,
scegliendone alcune e scartandone la maggior parte, cosicchè, quando parliamo del mondo, abbiamo
presente non tutte le immagini possibili, ma solo quelle che ci interessano in quel dato momento (tale
atteggiamento sarà ripreso e portato all’ennesima potenza dal pragmatismo). Tra il corpo e la "memoria"
(termine per Bergson equivalente a "coscienza" e a "durata reale") vi è un preciso rapporto: il corpo
interagisce con varie immagini e, per far ciò, deve far riferimento al mio io, giacchè il modo in cui reagisco
al mondo è legato indissolubilmente al mio io. Sicchè sussiste una fortissima correlazione tra corpo e
coscienza: ci deve essere un elemento che sia omogeneo coi due e che li renda dunque compatibili; a tal
proposito, Bergson distingue due livelli di memoria che generano due tipi di ricordi: il primo è la "memoria
pura" (coincidente con la durata reale), è l’io profondo, in cui è racchiusa tutta la mia storia e da cui
scaturiscono i "ricordi puri"; il secondo è uno strato di memoria più superficiale, in cui i ricordi non sono
puri - cioè scaturenti dal flusso coscienziale - ma sono immagini, ricordi di sensazioni e dunque appartenenti
sì alla coscienza (poiché frutto della memoria), ma, in quanto immagini, legati al corpo: e così, se mi dicono
che per aprire la porta devo premere il pulsante rosso, avrò un’immagine di ciò, giacchè è sì un ricordo, ma
non un qualcosa di profondo a tal punto da appartenere solo alla mia storia; è anzi un qualcosa di molto
vicino all’azione che il corpo compie per aprire la porta. Esisteranno allora delle immagini anfibie tra il
corporeo e il coscienziale: in questo caso, si dovrà parlare non di memoria pura ma di "memoria-abitudine";
tale è il caso in cui premo, senza pensarci, il tasto rosso per aprire la porta o il caso in cui mi alzo quando
sento la sveglia suonare: ciò è il frutto dell’io superficiale, che produce deterministicamente azioni secondo
associazioni, e la quasi totalità delle nostre azioni sono tali. Pertanto i momenti di vera libertà sono
pochissimi e coincidono con quei momenti in cui guardo ai miei ricordi per produrre qualcosa di veramente
nuovo, tale da far cambiar rotta alla mia vita con un’energia autoproducentesi. E i ricordi/immagini possono
(raramente) diventare ricordi profondi, come nel caso della rosa che evoca in me ricordi indimenticabili: il
guaio è - nota Bergson - che c’è chi agisce coi ricordi/immagini per tutta la vita, rinunciando alla propria
libertà. La nostra libertà, d‘altro canto, non si manifesta come libera scelta tra A e B (secondo il modello
dell’asino di Buridano), poiché se l’azione libera è davvero tale investe le radici profonde della coscienza e,
di conseguenza, non è scelta tra A e B, ma è una scelta già contenuta (ma non determinata) nella mia storia: i
sostenitori del libero arbitrio commettono lo stesso errore commesso dai deterministi. Infatti, di fronte
all’alternativa tra A e B, il determinista dirà che io sceglierò A perché son determinato a sceglierlo; il
difensore del libero arbitrio, invece, dirà che io sono assolutamente libero di scegliere, commettendo però
l’errore di intendere la memoria come suddivisa in tanti segmenti e di prefigurare un punto A e uno B,
ovvero una sequenza che deve ancora venire; ma non si può dire che si vada verso A anziché verso B fino a
che il flusso effettivamente non ci sia andato. Esso non è né determinato né dotato di libero arbitrio,
altrimenti sarebbe costretto a scegliere una cosa che non ha nulla a che vedere con la mia storia e che sta lì,
estranea, ad aspettare di esser scelta. I deterministi - conclude Bergson - sono ancora più coerenti dei
propugnatori del libero arbitrio, poiché questi ultimi hanno l’aggravante di affidare la scelta al caso. Sicchè
per Bergson non sussiste la libertà di scelta intesa come opzione per un’alternativa anziché per un’altra:
scegliamo liberamente quando ci affidiamo a noi stessi e alla nostra storia personale per continuare ad
esprimerci secondo la nostra personalità. Anche in Bergson, dunque, come in Cartesio e in Kant, sussiste una
duplicità di livelli: da un lato, la coscienza, svincolata da ogni determinismo; dall’altro, il corpo, soggiogato
alla necessità. Ma il pensiero bergsoniano conosce un’evoluzione che lo porta gradualmente a trasferire la
nozione di durata reale dalla realtà psichica alla realtà in generale, con la conclusione (esposta in
L’evoluzione creatrice) che vi è uno "slancio vitale" che percorre l’intera realtà e ne spiega il movimento
evolutivo; tale slancio può essere pensato come una sorta di fontana che si spinge verso l’alto e si ramifica in
tanti zampilli, alcuni più alti, altri più bassi, a seconda della forza impressa. Ciò permette a Bergson di
recuperare una concezione non deterministica dell’evoluzionismo, legandolo ad una spinta vitale libera e
spontanea, valida sia per la coscienza sia per la realtà esterna. Sicchè il concetto di libertà è esteso all’intera
realtà, sotto forma di spontaneità dell’essere, capace di produrre sempre qualcosa di nuovo. La materia
diventa allora leibnizianamente un sottoprodotto dello spirito, non è anzi altro che la stessa coscienza
irrigiditasi e privata della propria spontaneità, proprio come gli zampilli della fontana che, dopo essersi
innalzati, ricadono verso il basso: in questa maniera, il dualismo prospettato nel Saggio sui dati immediati
della coscienza e ammesso anche, seppur più timidamente, in Materia e memoria, nell’Evoluzione creatrice
cede il passo ad un monismo spiritualistico per cui ad esistere è la sola coscienza, a cui la materia stessa si
riduce.
LA SCUOLA DEL SOSPETTO
Paul Ricoeur usa l’espressione "scuola del sospetto" in riferimento a Marx, Nietzsche e Freud, poiché ritiene
che questi tre autori siano accomunati dal ritenere la realtà quale ci appare come una specie di vernice che
nasconde un livello più profondo di realtà, sicchè essi sospettano che al di là della realtà apparente vi sia
qualcosa di diverso e di più "reale" da esplicitare per meglio capire i meccanismi regolanti la realtà visibile.
Secondo Marx, tale realtà profonda coincide con la sostanza economica: il mondo che vediamo e in cui
siamo immersi presenta molti altri rapporti, ma sono tutti sovrastrutturali, ovvero secondari rispetto ad una
realtà superiore in virtù della quale possono essere spiegati: tale realtà è appunto l’economia. Similmente, per
Nietzsche, il mondo quale ci si presenta è una "favola" al di là della quale vi è la "volontà di potenza", una
forza assoluta e irrazionale che non è in alcun modo possibile coartare. Dal canto suo, Freud, con la
psicoanalisi, fa ben emergere come le azioni che abitualmente compiamo non siano spiegabili se non
riconducendole a pulsioni nascoste e rimosse dalla coscienza. Sebbene Ricoeur non lo faccia, possiamo
annoverare tra i "maestri del sospetto" anche Schopenhauer, che fa costante riferimento ad una duplicità del
reale, rivisitando e correggendo l’opposizione kantiana tra il fenomeno e il noumeno, quest’ultimo
coincidente con una volontà unica e irrazionale. Anch’egli è dunque un maestro del sospetto, nella misura in
cui riconosce uno strato superficiale di realtà in cui ci si può illudere di avere una volontà libera e, al di là di
esso, uno strato profondo, in cui ci si rivela la reale radice della nostra condizione, in cui è soppressa tale
forma di libertà che ci illudevamo di possedere. Da Kant, Schopenhauer desume innanzitutto la distinzione
tra fenomeno e noumeno e, tuttavia, riprendendola, la stravolge: per Kant, tale contrapposizione aveva una
valenza marcatamente antimetafisica, giacchè si riconduceva l’oggetto alla sintesi operata dal tempo, dallo
spazio e dalle dodici categorie e, inoltre, si faceva del noumeno un mero concetto limite, pensabile ma non
conoscibile (perché metaempirico). Ora, Schopenhauer si dirige invece in direzione metafisica: se per Kant il
fenomeno è l’unica realtà conoscibile, per Schopenhauer esso diventa l’apparenza e l’illusione, non è più la
realtà prodotta dal pensiero, ma è la parvenza della realtà; lo stesso noumeno diventa una vera e propria
realtà soggiacente al fenomeno. Quest’ultimo, dal canto suo, si costituisce anche per Schopenhauer in forza
dell’applicazione delle forme a priori della sensibilità (spazio e tempo) e dell’intelletto, sebbene quest’ultimo
operi con una sola categoria (e non con le dodici kantiane): la causalità. Tale intelletto, inoltre, non è più una
facoltà mediata (quale era in Kant), procedente per via discorsiva, ma è uno strumento di tipo intuitivo e,
dunque, assimilabile alla sensibilità: sicchè se per Kant prima c’è la sensibilità e poi l’intelletto unificante,
per Schopenhauer si tratta di un processo unitario, in cui v’è un unico momento intuitivo in cui spazio e
tempo individuano gli oggetti e, al contempo, la categoria della causalità li relaziona in una connessione
causale facendone un "mondo" completo e organico, in cui tutto è legato con tutto il resto da una serie
causale ineludibile. Da tale impostazione segue ineluttabilmente la negazione della libertà nel mondo
fenomenico, giacchè l’elemento della causalità necessaria si estende a qualsiasi fenomeno, proprio come
diceva Kant stesso, con però l’aggiunta che nel processo di causazione intervengono per Schopenhauer due
aspetti: i motivi esterni e il carattere dell’individuo. Così compio una certa azione perché su di me agiscono
motivi determinati dalla situazione esterna: in questo senso la causazione è meccanica; però, nel mio stesso
caso, un’altra persona avrebbe agito diversamente, il che testimonia che la causazione non può essere del
tutto determinata da motivi esterni, ma anche da quell’elemento assolutamente individuale che è il carattere
che esprime una componente energetica esulante dalla necessità. Per questa via, Schopenhauer esclude il
puro e semplice meccanicismo e ritiene invece che, affinchè la causazione avvenga, debba esserci un
elemento energetico (qui Schopenhauer è suggestionato dalla lettura di Leibniz) che faccia passare dalla
causa all’effetto. Ciò non significa che siamo liberi: non siamo infatti noi a sceglierci i motivi, ma sono
situazioni oggettive in cui ci troviamo e che ci condizionano; ma il carattere stesso, in quanto fenomeno, è
elemento necessario, determinato da una data serie causale (che mi determinano il carattere), cosicchè
l’incontro di questi due elementi di causazione (necessità esterna e necessità coincidente col mio io) fa sì che
io non possa in alcun caso esser libero e l’impressione che ho della libertà non è che un’illusione originata
dal fatto che spesso l’azione che compio risponde contemporaneamente anche agli elementi passionali che io
voglio soddisfare e che ritengo espressione della mia singola individualità. Sicchè nasce in me l’illusione di
non essere costretto, in virtù del fatto che i motivi son filtrati col carattere coincidente col mio essere. Se
sono in catene e non sento l’esigenza di muovermi, penso di essere libero di star fermo perché non sento le
catene: tale è la nostra condizione, siamo incatenati da vincoli sia esterni sia interni. Ciò vale per il mondo
fenomenico, che è solo l’aspetto apparente della realtà: dal canto suo, il noumeno non può esser raggiunto
cognitivamente, perché quanto più provo a conoscerlo tanto più ricorro alla causalità, al tempo e allo spazio
e, dunque, sempre più mi impantano nel fenomenico. Lo strumento alternativo per entrare in contatto diretto
col mondo noumenico è secondo Schopenhauer dato dal mio corpo stesso: esso è, sì, fenomeno tra i
fenomeni, ma è anche un modo di sentirsi vivere precategoriale. Col corpo mi sento parte della realtà ancor
prima di conoscerla, cosicchè essa - di cui mi sento parte scavalcando le barriere del fenomenico - sarà del
tutto diversa da quella fenomenica (caratterizzata dal principio di individuazione e dalla causalità). E dunque
la realtà noumenica sarà sganciata dal principio di individuazione e dalla causalità (e quindi dalla
razionalità): ma essere svincolati dal principio di individuazione vuol dire non essere articolati in tanti
individui, sicchè la realtà noumenica sarà un tutto compatto e unitario; d’altro canto, essere slegati dalla
causalità equivale a non avere un ordine razionale: per ciò il noumeno, oltre ad essere un tutto unitario, è
irrazionale, una forza cieca e inconscia che non obbedisce ad alcun disegno razionale. Ma che cosa è, in
definitiva, tale realtà noumenica? Grazie al mio corpo, sento che il mio vivere è un voler vivere, è un
qualcosa che trovo in me e che non posso giustificare con le categorie: appunto tal volontà di vivere è il
noumeno, che si configura dunque come mera volontà noumenica o "volontà trascendentale", dove il
"trascendentale" non è qui l’a priori delle categorie kantiane, ma ciò che è al di là di tale a priori, è un
noumenico che trascende il processo gnoseologico, con la conseguenza che la realtà ultima è un’unica
volontà irrazionale stante alla base di ogni rappresentazione fenomenica del mondo quale a noi appare; il
mondo, infatti, ci appare come un’oggettivazione di una volontà noumenica realizzantesi in queste forme e,
per ciò, disperdentesi nelle individualità e disciplinantesi (grazie alla causalità) in un mondo ordinato. La
volontà, da una che era, viene ad essere coartata nel tempo e nello spazio, cosicchè ciascuna forma di
individualizzazione è una costrizione generante sofferenza e gli stessi fenomeni in cui si oggettiva si
contendono lo spazio e il tempo, con la conseguenza che si realizza una perpetua lotta fra i fenomeni stessi,
in ciascuno dei quali la volontà spinge per espandersi senza limiti, battagliando contro ogni restrizione. Da
ciò la costante sofferenza che connota l’esistenza nel mondo fenomenico: e da qui trae le mosse il noto
pessimismo di Schopenhauer, il quale prova a fornire una morale per sottrarsi a questa miseranda
condizione: non ci si può, certo, sottrarre al fenomenico e regredire al noumenico; ma tuttavia è possibile
impedire l’oggettivazione della volontà nei fenomeni e ciò equivale a negare la volontà stessa,
capovolgendola in "nolontà": finchè c’è volontà, c’è oggettivazione e, con essa, sofferenza. E qui
Schopenhauer propone un vero e proprio processo di annullamento della volontà articolantesi in quattro
gradini: la prima cosa che si può fare per vincere la volontà è dedicarsi all’esperienza estetica, contemplando
le idee (gli universali platonici), prime oggettivazioni della volontà a metà strada tra noumeno e fenomeno;
come secondo passo v’è il rispetto del diritto, che riconosce le diverse giurisdizioni spettanti agli individui e
non permette travalicazioni, contenendo la lotta tra gli individui. Come terzo gradino v’è la compassione,
con la quale esco dalla mia individualità ed entro in quella altrui, comprendo che propriamente non vi sono
individui. Infine, come ultimo momento, c’è l’ascesi mistica, con cui colgo l’unità della volontà e riesco con un atto di libertà - a negare la volontà stessa, trasformando i motivi della mia azione in "quietivi",
mortificando e dicendo "no" alla volontà. Se ciò fosse pienamente realizzato anche da un solo individuo,
ecco che l’unica volontà sparirebbe; ma ciò è solo un ideale verso cui orientarsi, non una realtà attuabile.
Negando la volontà, l’individuo evade dalla propria individualità, pur restando se stesso: questo è l’unico
atto veramente libero dell’uomo, giacchè è un atto compiuto sì da me come individuo, ma andando contro la
volontà, e per ciò al di là e della legge del fenomeno e di quella della volontà. A differenza del determinismo
tradizionale (che è sempre di tipo razionale), Schopenhauer esclude nettamente la libertà ma in favore di un
determinismo di tipo oscuro, retto da forze esulanti dalla razionalità e, per di più, negative: tali forze possono
però essere debellate (a livello ideale).
NIETZSCHE
Anche Nietzsche - che di Schopenhauer fu grande lettore, oltrechè aspro critico - resta saldamente convinto
che l’uomo sia libero solo illusoriamente, in quanto determinato da una forza che non è nelle sue mani e che
non è di tipo razionale, ma ha radice vitalistica. A differenza di Schopenhauer - che riteneva mutabile in
nolontà la volontà -, per Nietzsche tale elemento vitalistico che sta alla base della nostra determinazione non
può in alcun modo essere negato, ma deve anzi essere affermato e accettato, dicendo "sì" alla vita. Anche
Freud seguirà questa corrente, negando la libertà dell’individuo e riconoscendolo determinato da una forza
oscura (le pulsioni): tali forze possono essere, se non negate, controllate esplicitandole; sicchè la psicoanalisi,
portandole all’evidenza, le trasforma in elementi conosciuti e controllabili. In questo senso, nel tentativo di
conoscere le oscure radici della volontà umana, Freud rivela una certa tendenza illuministica: è qui in bilico
tra la "scuola del sospetto" e il positivismo. Dal canto suo, Nietzsche arriva a fissare chiaramente la propria
posizione intorno al problema della libertà con Umano, troppo umano, Genealogia della morale e - come
antidoto - con Così parlò Zarathustra, dove propone la libertà della vita e dell’accettazione della volontà di
potenza. Nella sua prima opera di rilievo - L’origine della tragedia -, egli opera (in veste di filologo) la
celebre distinzione tra spirito apollineo e spirito dionisiaco, tale per cui le prime forme di tragedia greca
(espresse da Eschilo e da Sofocle) meglio rispondevano allo spirito greco e alla realtà stessa, poiché davano
la preminenza alla forma che domina il mondo naturale esprimendo un puro impulso di vivere: lo spirito
dionisiaco. Tant’è che in tali prime forme di tragedia i personaggi singoli rivestivano scarso rilievo e i veri
sviluppi si avevano nei momenti corali, ove il coro esprimeva la forza del destino e della vita irrompente nel
mondo umano, quella vita che travolge gli uomini senza lasciar loro alcuna libertà. Questo modo di
concepire la vita e la realtà (e di far tragedia) muta radicalmente con Euripide, il quale smorza l’elemento
corale della forza vitale e dello spirito dionisiaco, facendo invece assurgere in posizione egemonica
l’apollineo, l’individuo con la sua responsabilità morale e con la sua libertà: ciò avviene - secondo Nietzsche
- come effetto di un’evoluzione del pensiero greco realizzatasi grazie alla figura di Socrate, che al centro
della filosofia pone non già la natura, bensì l’uomo, inteso come essere razionale responsabile delle proprie
azioni, non più imputabili all’imperscrutabile volere del fato: per questa via, al dionisismo subentra
l’apollineo e la ragione, l’armonia, la sobria ed equilibrata compostezza scalzano l’orgiastica volontà di
vivere del mondo greco pre-euripideo; siffatta componente apollinea sarà poi trasmessa al mondo cristiano e,
a sua volta, costituirà la struttura portante dell’anti-dionisiaco mondo occidentale, introducendo l’illusione
che l’uomo sia un essere libero. A tal proposito, così si esprime Nietzsche: "la storia dei sentimenti umani è
la storia di un errore: l’errore della responsabilità, che riposa sull’errore della libertà". A partire da
Umano, troppo umano Nietzsche delinea con maggior chiarezza la propria posizione, illustrando la natura
dell’illusione in forza della quale ci crediamo liberi e ci diamo una morale. In tal senso, egli fa una vera e
propria "genealogia della morale" (come recita il titolo di un suo scritto), descrivendo l’origine di quegli
atteggiamenti che abitualmente riteniamo morali, poiché guidati da ideali e norme che sarebbero razionali e
si sottrarrebbero alla dinamica degli impulsi materiali. Ciò equivale a fare chimica, ossia a scomporre le
azioni umane nelle loro componenti essenziali per vedere quali siano gli elementi ultimi: così facendo, si
scopre che gli elementi ultimi non sono che impulsi (in primis l’autoconservazione, poi la ricerca del piacere
e la fuga dal dolore). La soluzione qui prospettata al problema della libertà è di stampo
fisiologico/materialistico: l’uomo non è se non un coacervo di impulsi combinantisi meccanicamente, senza
che vi sia un reale spazio per il libero agire. E tuttavia Umano, troppo umano è dedicato agli "spiriti liberi"
(nella fattispecie a Voltaire), sicchè Nietzsche vuole parlare della libertà intesa non come libertà della
volontà, ma piuttosto come libertà dal falso concetto di libertà quale si è tramandato dalla tradizione. La vera
libertà starà allora nel liberarsi dall’illusione della libertà. Il testo che meglio esprime questo programma
ambizioso è Così parlò Zarathustra, il cui protagonista (Zarathustra appunto) è il profeta che annuncia la
nuova verità, indispensabile per liberarsi da quella congerie di credenze che paralizzano la potenza e la
natura umana. La prima credenza da smascherare è la credenza in Dio, cioè in una realtà sovraterrena
condizionante quella terrena (e l’agire umano, configurantesi come funzionale a Dio). Zarathustra annuncia
allora la morte di Dio: ora che Dio è morto - egli dice -, devono vivere molti dei, ovvero nuovi valori che
promuovano la vita (anziché mortificarla). E la liberazione dalla credenza in Dio è la prima condizione per la
nascita del Superuomo (o - come preferisce chiamarlo Vattimo - Oltreuomo), quell’uomo non più
imprigionato in false credenze e tale da prender coscienza delle proprie possibilità, dopo aver congedato tutti
i valori e aver detto "sì" alla vita terrena. L’idea dell’Oltreuomo non è una novità assoluta introdotta da
Nietzsche: già presente in qualche modo nel pensiero di Dostoevskij, affiorava in maniera esplicita nel Faust
di Goethe, quando Faust invoca lo spirito della terra e questi, dopo essergli apparso, lo spaventa e lo dileggia
appellandolo "superuomo", a sottolineare che vuol dominare la terra ma che non appena scorge il suo spirito
si lascia terrorizzare. Per Nietzsche sbarazzarsi di Dio equivale a sgombrare il campo dalla trascendenza
(tanto cristiana quanto platonica), tant’è che la negazione di Dio si traduce automaticamente in negazione
della spiritualità concepita come un qualcosa di opposto e superiore al corpo. L’Oltreuomo deve poi liberarsi
del senso del dovere, quella morale imposta da Socrate e ribadita dal cristianesimo e da Kant: a tal proposito,
in una famosissima pagina di Così parlò Zarathustra, Nietzsche asserisce che l’uomo deve diventare
cammello, leone e, infine, fanciullo; cammello, cioè tollerante e paziente di fronte alle avversità; fanciullo
nel senso che deve acquistare la capacità di vedere il mondo con occhi nuovi e ingenui; leone nel senso che
deve diventare forte e combattivo contro il drago dalle mille scaglie lucenti (metafora del senso del dovere).
In questo senso, il leone è la volontà e ciascuna delle scaglie del drago è uno dei mille doveri che incombono
sull’uomo, lucenti perché si presentano come valori che brillano: all’io deve imporsi il principio dell’ "io
voglio". Altrove Nietzsche identifica il dovere col volere, asserendo che "io posso perché io voglio",
cosicchè il volere trionfa su ogni norma e si impone come volontà assoluta. Qui ben emerge l’aspetto
propositivo (ed emancipatorio, secondo Vattimo) del discorso nietzscheano: dopo aver detto che occorre
negare la tradizione dei valori e della trascendenza, il filosofo tedesco asserisce che l’Oltreuomo deve
affermare la propria volontà in maniera assoluta e incondizionata, sostituendo il mondo trasmessoci dalla
tradizione con un mondo nuovo, dove i vecchi valori siano trasmutati in nuovi; un mondo in cui la realtà sia
"volontà di potenza". "Tutti gli scopi, le mete e i significati sono solo modi d’espressione […] della volontà
di potenza": come già per Schopenhauer, anche per Nietzsche tutto è manifestazione di un’unica volontà, che
però non è "noumenica" (come credeva Schopenhauer), ma anzi percorre la realtà. Addirittura, possiam
notare come in Nietzsche manchi completamente l’impianto metafisico schopenhaueriano (incentrato sulla
distinzione kantiana tra noumeno e fenomeno), sebbene anche Nietzsche distingua tra una dimensione
apparente (il mondo come favola) e una profonda (al di sotto del mondo vi è un’unica volontà di potenza
permeante l’intera realtà). Essere liberi significa allora volere e volere ciò che la vita vuole, dicendole di sì in
ogni suo aspetto (e l’eccellenza dell’individuo consiste appunto nel saper dire di sì alla vita con maggiore
forza); ma c’è, nella coincidenza di volontà e potenza, un limite, dato dal passato: quest’ultimo, infatti, non
può essere in alcun caso cambiato, anche se voluto diversamente da come è stato; ciononostante posso volere
il mio passato, così come voglio ciò che avviene e ciò che avverrà. In tal prospettiva Nietzsche formula la
sua teoria dell’eterno ritorno, da intendersi non già nel senso storico di un reale ritorno delle cose in eterno,
bensì - in senso antimetafisico - nel senso che se tutte le cose tornano, allora la storia non ha senso (proprio
per ovviare a questo i cristiani optano per la linearità del tempo, in modo tale da poter conferire un senso
compiuto alla storia: non a caso si dice di Cristo che "semel mortus est"). Se la vita è la vera essenza della
realtà, allora non importa che cosa eternamente ritorni, a contare è il fatto che ciò avvenga in eterno. L’unica
libertà di cui godiamo è allora quella di accettare la volontà di potenza riconoscendoci in essa e partecipando
della sua libertà, che però non è una libertà costruttiva, ma è anzi una libertà avente come alveo di sviluppo
la prospettiva nichilistica per cui non è possibile considerare oggettivamente le cose. In La gaia scienza,
Nietzsche asserisce che chi si abbandona a questa condizione è un’anima che si lascia andare in un oceano
infinito, senza coordinate costrittive e limitanti: "guai se ti coglie la nostalgia della terra!", ammonisce
Nietzsche, dove la nostalgia della terra è la nostalgia di una prospettiva che abbia coordinate e punti di
riferimento fissi, cioè parametri gnoseologici e morali. L’unica vera libertà è allora essere in mare aperto,
senza terre e punti fermi a cui far riferimento durante la navigazione.
L'ESISTENZIALISMO
Sebbene ricorrere a termini così generici implichi sempre l'identificazione di posizioni variegate e, spesso,
inaccostabili, ciononostante possiamo dire che l'esistenzialismo è una corrente filosofica e letteraria divenuta poi una vera moda - che si sviluppa soprattutto a cavallo tra i due conflitti che hanno scosso il
Novecento, spazzando via l'ottimismo, tutte le certezze e i punti fermi su cui esso riposava: l'improvvisa
tragedia divampata con lo scoppio delle guerre mondiali travolse infatti tanto la positivistica fiducia in una
scienza capace di produrre progresso, quanto l'utilitaristica convinzione del costante miglioramento dell'agire
umano e la spiritualistica certezza della coscienza come incrollabile sede di verità inconfutabili e
irrefrangibili. Se c'è un elemento comune a tutte le molteplici manifestazioni a cui l'esistenzialismo dà vita,
quello è l'insistenza sulla finitudine dell'uomo e sull'esistenza come radicalmente opposta all'essere in quanto
tale. Certo, di per sè, queste due nozioni non sono innovative, in quanto già ampiamente presenti nella
tradizione filosofica precedente; ma sicuramente originale e nuovo è il modo in cui dall'esistenzialismo
vengono intese: fino ad allora, infatti, l'uomo era stato concepito come realtà oggettiva fra le tante, magari
come parte integrante di un'unica realtà (è il caso del Positivismo) oppure come vertice di una realtà
stratificata (è il caso dello Spiritualismo). Dal canto suo, l'esistenzialismo si diversifica radicalmente da tutte
queste posizioni, uscendo dai sentieri dell'oggettivismo e sostenendo che può sì esistere un livello di realtà
oggettiva, ma precisando che tale livello non coincide minimamente con l'esistenza dell'uomo, dotato di una
soggettività irriducibile alla realtà freddamente oggettiva. In questo senso, per gli esistenzialisti l'uomo non è
mai un mero oggetto fra i tanti. Viceversa, egli è sempre soggetto radicato in una realtà da lui inseparabile,
con la quale viene a creare una fitta rete di rapporti intenzionali costituenti la sua situazione, in cui egli si
trova irrimediabilmente calato e a cui non può sottrarsi. Ciò comporta, naturalmente, che l'uomo sia
costituzionalmente finito, giacchè la sua esistenza è sempre e comunque definita dagli inoggettivabili
rapporti intrattenuti con la realtà esterna. Ben si capisce, allora, perchè l'autore a cui fanno costante
riferimento gli esistenzialisti novecenteschi sia Søren Kierkegaard, il quale aveva posto al cuore della propria
riflessione le nozioni di soggettività, di possibilità, di progettualità, di angoscia e di esistenza, in netta
opposizione alla categoria hegeliana dell'essenza (del tutto inadeguata a cogliere l'individualità esistenziale
del soggetto). L'esistenza non può mai essere ridotta ad un mero essere oggettivo, ma, piuttosto, dev'essere
qualificata come un ex-sistere, ovvero come un tirarsi fuori da una situazione oggettiva venendo ad essere
qualcos'altro rispetto al mondo: in questo senso, l'esistente non è mai interamente racchiuso in se stesso, ma
sporge sempre in avanti, affacciato sul proprio futuro, di cui è artefice (proprio qui risiede la progettualità).
Ne segue, allora, che l'esistenza è costantemente contraddistinta dalla trascendenza rispetto ad una realtà data
nella sua bruta, massiccia e opaca oggettività, quale la concepiva Hegel (che di Kierkegaard è l'idolo
polemico); di contro all'essenza universale hegeliana e alla sua logica della contraddizione - in cui gli opposti
trovano una loro conciliazione nel superiore momento della sintesi -, Kierkegaard rivendica la singolarità
dell'esistenza, tale per cui ogni scelta implica automaticamente l'esclusione di altre possibili scelte, proprio
come, giunti ad un bivio, si imbocca una strada tralasciando l'altra. In quest'accezione, l'esistenza si
configura non già come un et et (come la logica hegeliana, in cui son possibili e A e non-A), bensì come un
aut aut (come recita il titolo di un celebre scritto kierkegaardiano). La mia esistenza di soggetto non è mai
qualcosa di ritagliabile e scientificamente definibile: è, piuttosto, un flusso magmatico sfuggente a qualsiasi
costrizione e a qualsiasi pensiero oggettivante che si proponga di ingabbiarlo, in opposizione al reale nella
sua bruta datità oggettivabile. A tal proposito, Heidegger (che con l'esistenzialismo intrattenne rapporti
piuttosto ambigui) - in Essere e Tempo - opera una netta distinzione tra la "presenzialità" (ovvero l'essere
come pura presenza oggettiva) e l'esistenza (Dasein), rimproverando alla metafisica di aver sempre
trascurato l'esistere, quello che lui chiama l'essere-qui in una fitta e inestricabile rete di relazioni col mondo
(è la nozione husserliana di intenzionalità che, uscita dall'ambito coscienziale, si trasferisce a quello della
realtà esistente). Ancora Sartre contrappone radicalmente l'in sè al per sè: il primo denota l'essere come mera
presenza, l'oggettività grezza e impenetrabile dal soggetto esistente; il secondo si identifica invece con la
coscienza umana, è mera soggettività opponentesi all'opaca e massiccia oggettività esterna: su questa base
poggia la distinzione operata dal filosofo francese tra l’essere (la realtà esterna, nella sua datità) e il “nulla”,
ovvero la coscienza del soggetto che si oppone alla datità dell’essere e la nullifica. Presso gli esistenzialisti il
problema della libertà non può che essere cardinale: essendo l'uomo consustanzialmente finito e radicato
nella sua situazionalità identificantesi con la sua esistenza, che cosa può egli esser libero di fare, in un tal
contesto in cui è accentuato il rapporto e, con esso, la dipendenza del soggetto dal mondo? E' ammissibile
una libertà? E, in caso di risposta affermativa, di che tipo di libertà si tratta? Gli esistenzialisti sostengono
che, al pari della questione dell'esistenza, nemmeno quella inerente la libertà può essere oggettivata: non ha
dunque senso disquisire astrattamente e oggettivamente di libertà; tanto più che, nella misura in cui oggettivo
la realtà, la libertà pare azzerata. Già Kierkegaard notava che se ci limitiamo a considerare l'essere e non
l'esistenza, allora l'unica soluzione plausibile è quella spinoziana, riducente il mondo a mera macchina in cui
ogni evento è causato ed è a sua volta causa di altri eventi. Ma se facciamo slittare la prospettiva dalla sfera
della realtà oggettiva a quella dell'esistenza, ecco che tutto cambia: significativamente, Karl Jaspers asserisce
che "là dove io sono, in quel senso originario che non si può oggettivare, là è anche il regno della libertà".
Ben si capisce allora che, per poter parlare di libertà, occorre addentrarsi nel regno della soggettività,
lasciandomi alle spalle quello in cui ad imperare è l'oggettività, poichè la libertà appartiene all'esistenza e
non già all'essere oggettivato, essa non è - semplicemente - una cosa fra le cose; non ha pertanto alcun senso
domandarsi se oggettivamente esista o meno la libertà, come ci si potrebbe chiedere se esista o no la casa.
Poichè la libertà dipende in tutto e per tutto dall'ambito esistenziale e soggettivo, si evince facilmente come
la sua esistenza o inesistenza sia strettamente connessa al modo in cui si intende l'esistenza stessa e, a tal
proposito, le soluzioni prospettate sono molteplici e mai riconducibili a schemi fissi. Già le posizioni di
Pascal e di Lutero - antesignani dell'esistenzialismo - sono emblematiche da questo punto di vista: per il
primo, l'uomo è libero nella propria decisionalità, può scegliere se credere o non credere in Dio, se vivere
autenticamente o abbandonarsi al divertissement; al contrario, per il secondo l'arbitrio dell'uomo è servo,
incatenato alla più rigida necessità. Per trattare della libertà, la categoria più mobile e più in voga - da
Kierkegaard in poi - era stata quella della possibilità (ripresa soprattutto da Heidegger e da Jaspers),
opponentesi alla necessità: in particolare, l'uomo coglie la propria esistenza in quanto prende atto del fatto
che è equipaggiato della possibilità di sviluppare il proprio esistere in diverse direzioni, a seconda di come si
muove nella propria situazione. Strettamente legata alla possibilità è la nozione di progetto: trovandosi
proiettato in una situazione, il soggetto deve sviluppare un progetto rispetto ad essa, in maniera tale da
orientarla verso una determinata direzione, operando scelte sempre configurantisi come aut - aut, cioè
elidentisi mutuamente. Secondo Kierkegaard, tali grandi scelte erano fondamentalmente tre: in primis la vita
estetica (quella condotta dal Don Giovanni di Mozart), consistente nel non preoccuparsi del futuro e nel
vivere l'attimo come se non vi fosse storia; in secundis la vita etica, quella dell'uomo sposato che ogni giorno
riconferma la propria scelta; infine quella religiosa, scelta da quell'Abramo che si rivela disposto a sacrificare
il figlio Isacco in nome di Dio, compiendo un atto inteso come delitto dalla società: egli è il "cavaliere della
fede" che, nell'ascoltare Dio, si isola dalla società e conduce un'esistenza solitaria. Spetta dunque al soggetto
l'individuazione delle diverse possibilità su cui costruire progettualmente la propria esistenza in maniera
vincente, anche se poi di fatto per quasi tutti gli esistenzialisti ciò viene a configurarsi come un progetto
fallimentare e destinato - per usare le parole di Jaspers - al “naufragio” e allo “scacco”: la possibilità si rivela
allora come una non-possibilità, e campione di questa veduta è Heidegger, ad avviso del quale l'esito ultimo
a cui approda il fallimento dell'uomo è l'esistenza inautentica, caratterizzata dal vivere in maniera omologata
e conformata alla massa, prestando ascolto al Si impersonale, per cui non c'è più un "io faccio, io dico, io
sono", ma un inautentico "Si fa, Si dice, Si è", tale per cui l'originarietà muore e l'uomo viene ad essere
determinato nei propri comportamenti da modelli impersonali e conformistici; in questa maniera, egli è
sottoposto ad un vero e proprio processo di deiezione, per cui cessa di esistere autenticamente e, da mero
soggetto, diventa una cosa fra le cose, incapace di scegliere progettualmente la propria vita e di cavalcare
l'onda della possibilità. Per l'uomo portato alla deiezione ogni forma di libertà è azzerata. L'unica via per
poter vivere autenticamente è per Heidegger data dall'anticipazione della morte, concepita come la nostra più
autentica possibilità, in quanto capace di generare quell'angoscia a cui già Kierkegaard aveva dato grande
importanza: nell’angoscia viviamo in maniera autentica ed esperiamo quella libertà azzeratasi con la
deiezione. Nell'itinerario heideggeriano, tuttavia, la posizione esistenzialistica è meramente funzionale ad
un'altra e superiore esigenza: quella di indagare l'essere. E dopo la "svolta" all'interno del suo pensiero,
Heidegger cambia rotta, riconoscendo che l'esistente può ricongiungersi con l'essere nella sua assolutezza:
tale ricongiunzione, però, non può avvenire in virtù dell'esistente stesso, giacchè esso è condannato ad
un'esistenza inautentica, in cui non gli è più dato di scegliere liberamente; è invece l'essere l'attore della
ricongiunzione, in quanto esso si rivela nel linguaggio (che è "la casa dell'essere"): l'uomo diventa
finalmente "pastore dell'essere", a lui solo è affidato il compito di custodirlo. In questa mutata prospettiva,
però, l'essere - e non l'uomo - è dotato di libertà, ma si tratta di una libertà che può dall'uomo essere
partecipata nella misura in cui egli riesce a saltare dall'esistenza all'essere servendosi del linguaggio come
trampolino di lancio. Anche per Jaspers l'uomo, fin tanto che resta radicato nella situazionalità, resta "sotto
scacco", nel senso che, per quanto egli si impegni nella scelta, si ritrova sempre e comunque in una
situazionalità obbligata, dove pare non esservi alcuno spazio per la libertà: la situazione dello "scacco", sotto
cui ciascuno di noi costantemente si trova, appare particolarmente lampante in quelle che Jaspers definisce
"situazioni-limite" (la morte, il dolore, ecc), cosicchè, pur essendo vero che la nostra vita trascorre tutta sotto
scacco, è anche vero che di ciò prendiamo atto solo in quelle particolari circostanze in cui lo scacco risulta
più evidente, come ad esempio quando ci si accorge di essere malati mortalmente. La vera salvezza (e, con
essa, la vera libertà) proviene per Jaspers - come per Heidegger - dal salto verso la trascendenza, esulando
dall'esistenza, anche se tale salto è per Jaspers in riferimento a Dio e non all'essere. Particolarmente
significativo è poi l'esistenzialismo ateo di Jean-Paul Sartre: soprattutto nel romanzo filosofico La nausea,
egli fa leva sull'assurdità dell'esistenza in quanto tale, un'assurdità che, non appena venga avvertita, genera
immediatamente un insopprimibile senso di nausea:
"[...] eravamo un mucchio di esistenti impacciati, imbarazzati da noi stessi, non avevamo la minima ragione
d'esser lì, né gli uni né gli altri, ciascun esistente, confuso, vagamente inquieto si sentiva di troppo in
rapporto agli altri. Di troppo: era il solo rapporto ch'io potessi stabilire tra quegli alberi, quelle cancellate,
quei ciottoli. Invano cercavo di contare i castagni, di situarli in rapporto alla Velleda, di confrontare la loro
altezza con quella dei platani: ciascuno di essi sfuggiva dalle relazioni nelle quali io cercavo di rinchiuderli,
s'isolava, traboccava. Di queste relazioni (che m'ostinavo a mantenere per ritardare il crollo del mondo
umano, il mondo delle misure, delle quantità, delle direzioni) sentivo l'arbitrarietà; non avevano più
mordente sulle cose. Di troppo, il castagno, lì davanti a me, un po' a sinistra. Di troppo la Velleda… Ed io fiacco, illanguidito, osceno, digerente, pieno di cupi pensieri - anch'io ero di troppo. Fortunatamente non lo
sentivo, più che altro lo comprendevo, ma ero a disagio perché avevo paura di sentirlo (anche adesso ho
paura - ho paura che questo mi prenda dietro la testa e mi sollevi come un'onda). Pensavo vagamente di
sopprimermi, per annientare almeno una di queste esistenze superflue. Ma la mia stessa morte sarebbe stata
di troppo. Di troppo il mio cadavere, il mio sangue su quei ciottoli, tra quelle piante, in fondo a quel
giardino sorridente. E la carne corrosa sarebbe stata di troppo nella terra che l'avrebbe ricevuta, e le mie
ossa, infine, ripulite, scorticate, nette e pulite come denti, sarebbero state anch'esse di troppo: io ero di
troppo per l'eternità".
Sull'assurdità dell'esistenza insiste anche Albert Camus, il cui pensiero filosofico trova espressione
soprattutto in opere teatrali (che, meglio del trattato filosofico, pongono al centro della scena il singolo e la
situazione particolare in cui egli è radicato): in Lo straniero, il protagonista commette un omicidio e assiste
impassibile, in maniera del tutto assurda, alla propria condanna, a sottolineare che l'uomo, con il suo
pensiero, si trova ad essere straniero nel mondo in cui vive; in Il mito di Sisifo l'esistenza è accostata alla
fatica di Sisifo, il mitico personaggio condannato dal destino a sospingere in cima ad un monte un macigno,
che poi ogni volta ricade giù, obbligando Sisifo a ripetere inutilmente il suo sforzo. L’unico atto in grado di
riscattare l’uomo e di conferire un senso al suo esistere è la rivolta contro le ingiustizie e l’intolleranza
perpetrate sull’uomo dall’uomo stesso: in tal senso, il nuovo motto dell’esistenzialismo camusiano contenuto nello scritto L’uomo in rivolta - diventa “io mi rivolto, dunque noi siamo”.
Appunti del corso tenuto dal prof. MASSIMO MORI presso l'università di Torino nella primavera
2003.
INDIETRO