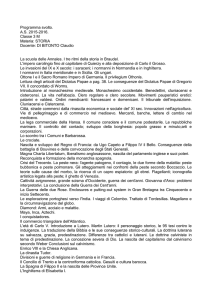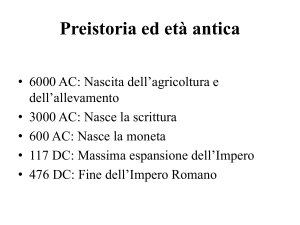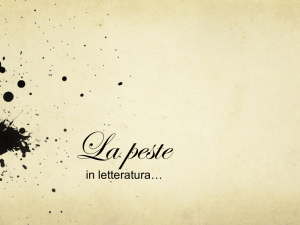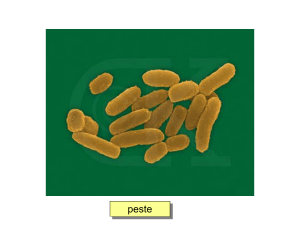PESTE E LETTERATURA
TUCIDIDE E LA PESTE DI ATENE
Racconta la Guerra del Peloponneso (431- 404 a.C.),
durante la quale Atene visse la catastrofe della peste, cominciata
dal porto del Pireo.
"Non ne conosco le cause, descriverò solo gli effetti“, scrive.
Persone sane avvertivano improvvisi calori al capo, occhi
infiammati, sangue e fetore in bocca, piaghe esterne e interne,
sete, dolori, insonnia, diarrea, morte tra il settimo e il nono
giorno. I sopravvissuti avevano perso estremità, parte dei
genitali, occhi e memoria. Gli animali ghiotti di carne umana
la evitavano oppure ne morivano: scomparvero cani e animali
domestici. Inevitabile la fine: isolati si moriva senza soccorso,
soccorrere significava contagiarsi. Veniva dal contado gente che
girava per le vie, occupava i luoghi dei morti, entrava nei templi,
espandeva il contagio.
Sofferenza e paura distruggevano rispetto
per luoghi e tradizioni. I morti erano più dei
vivi e, mancando ai vivi tempo, forza e mezzi per
il rito funebre, molti mettevano il proprio morto
su una pira altrui e vi davano fuoco, o lo
gettavano sulla pira dove già bruciava un
cadavere e se ne andavano. I pochi scampati
erano presi da un’illusione di immortalità,
ma il senso generale era l’abbandono,
l’assenza di leggi e di religione, in cui pareva
lecito e impune ogni delitto e sacrilegio. C’era chi,
impadronitosi di sostanze dei morti, cercava di
cavare il massimo piacere dalla vita, poiché il
futuro era la morte. Questi effetti saranno il
tragico denominatore comune di tutte le
cronache.
LUCREZIO E LA PESTE DI ATENE
Più di tre secoli dopo, nel poema
De rerum natura Lucrezio analizza
con la luce della ragione le angosce
di morte, malattia, guerra, la paura degli dei.
Descrive movimenti e combinazioni degli elementi nei
fenomeni della natura: nell’aria ci sono i semi di ogni cosa,
quindi anche delle malattie; il clima e le condizioni della
terra favoriscono o causano il diffondersi dei mali.
De rerum natura vuol dire “L’origine di ciò che esiste”:
chi degli eventi conosce l’origine ne controlla
anche il percorso e col sapere raggiunge,
l’imperturbabilità del saggio (atarassia). Descrive
anche lui la desolata rievocazione della peste di
Atene, sottolineando che bisogna usare la ragione
per comprendere la realtà.
BOCCACIO E LA PESTE DI FIRENZE
Il Decameron si apre sulla peste a Firenze del
1348:
il grandioso affresco di orrori e guasti nel
dissolvimento delle regole civili fa da
introduzione alle cento novelle raccontate
da dieci giovani che hanno deciso di vivere in
campagna per "fuggire i disonesti esempi degli
altri". Alla violenza fisica e morale del morbo
essi contrappongono il diritto a vivere, ma la
spensieratezza sarà regolata, ogni giornata sarà
scandita da orari e compiti: un tempo per pregare, un
tempo per nutrirsi, per danzare, per riposare, un
tempo per narrare. E nel narrare è libertà
dell’immaginazione, ma la parola rimane decorosa, la
malizia elegante, i doppi sensi sottili e intelligenti.
A Firenze Boccaccio deve fare i conti con
l’immenso Dante della Commedia, che tra
l’altro egli ammira e venera: e dunque, quale
inferno migliore della peste da
contrapporre al paradiso di gioventù e
natura? Peccato che l’introduzione sia letta
sempre meno: ma a chi la legge essa trasmette
l’ideale dell’autore: raccontare vivendo e vivere
narrando. Con eleganza.
MANZONI E LA PESTE DI MILANO
Manzoni descrive nei Promessi sposi la peste
del 1629-30 a Milano.
"La peste, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto,
entra nel milanese e nel resto dell’Italia con le bande alemanne".
Il medico Settala, che aveva conosciuto quella del 1576, diede
l’allarme, ma non fu ascoltato; il 18 di novembre il governatore
Ambrogio Spinola ordinò pubbliche feste per la nascita del
primogenito di Filippo IV. Non sembrò grave nemmeno che un
soldato italiano, che aveva portato in casa vestiti e masserizie di
soldati tedeschi, il giorno dopo si trovò un bubbone e al quarto
giorno morì. Quando il lazzaretto affollatissimo non garantiva più
isolamento né cure né cibo, solo allora tra il popolo e l’autorità si
diffuse la parola ‘peste’; dunque in principio la parola viene
censurata, poi la si introduce di sbieco (‘febbri pestilenziali’),
infine peste ma non proprio, e infine peste-peste ma già si
aggiunge l’idea di "malefizio e venefizio": un’altra fuga dalla
parola. E l’autore commenta "molte parole fanno lo stesso corso
costosissimo e lento, mentre sarebbe meglio osservare ascoltare
paragonare pensare prima di parlare, ma quest’ultima è più
facile".
L’ignoranza della dinamica
del contagio, e insieme il bisogno
di spiegarselo, portarono a
credere che fossero gli untori
a propagare il male.
Certo a pensare non aiutò
il governatore quando, con la peste palese e
manifesta, per festeggiare la pace su un
fronte della guerra, ordinò una processione
di ringraziamento. Il cardinale Federigo
Borromeo si oppose energicamente, ma poi
dovette cedere, anzi acconsentì a che
rimanessero esposte per otto giorni le
reliquie di san Carlo. Ne seguì una
vertiginosa crescita del numero dei morti,
che finalmente indusse a credere al
contagio. Dei 250.000 abitanti di Milano
sopravvissero 64.000.
http://www.storia.rai.it/articoli/la-pestenera/23859/default.aspx