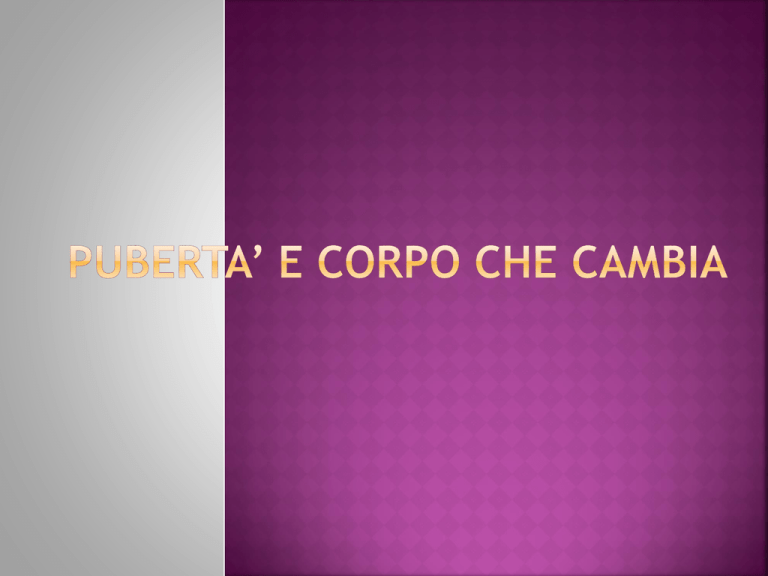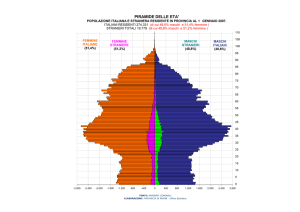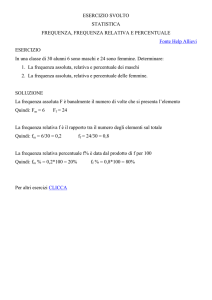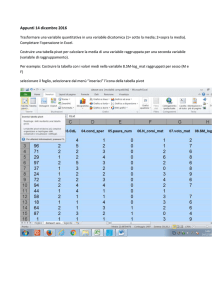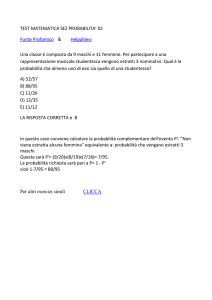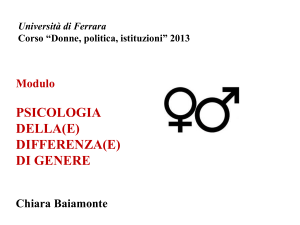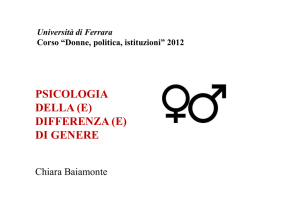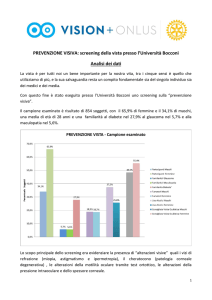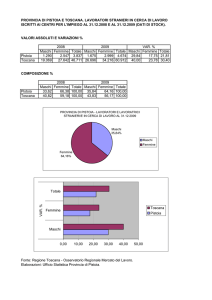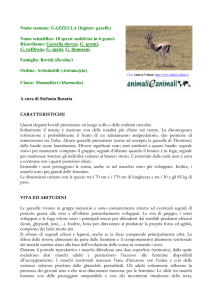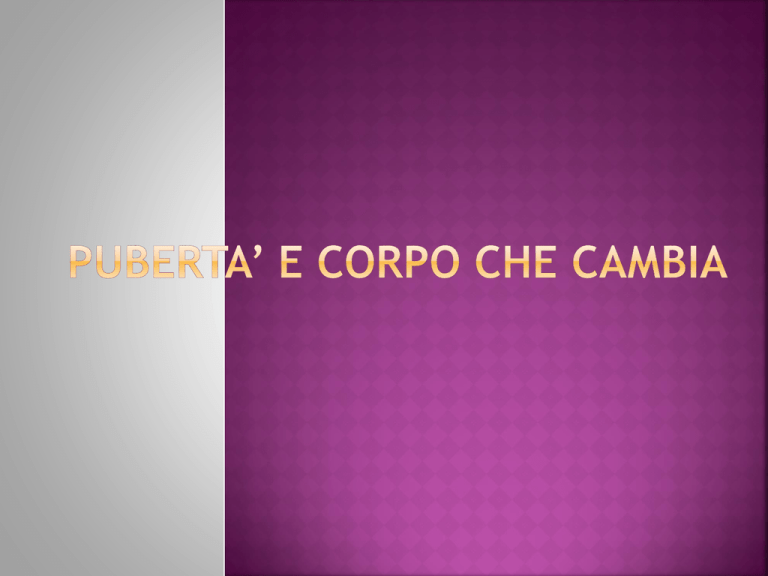
Il
cambiamento corporeo è la prima grande
sfida con cui l’adolescente si confronta
Comporta un cambiamento della propria
identità
Comporta un cambiamento del modo di
rapportarsi con l’ambiente
Aumenta la motivazione ad osservarsi e
riflettere su di sé
Differenze individuali
Differenze di genere
Essendo il cambiamento più precoce è quello che può
creare più problemi
I clinici imputano ai cambiamenti biologici le difficoltà
psicologiche tipiche dell’adolescenza
PUBERTA’: periodo di passaggio dalla condizione biologica
di bambino a quella di adulto. Segna l’inizio
dell’adolescenza come passaggio sociale
Tendenza secolare: abbassamento dell’età della pubertà
Scatto di crescita: aumento del ritmo di sviluppo di peso ed
altezza.
Altezza: prima gambe mani e piedi poi tronco e braccia
(disarmonie di crescita e difficoltà di movimenti)
Aumento della massa adiposa, aumento dei tessuti muscolari ed
ossei in particolare
Sviluppo degli organi genitali. Comparsa di prime eiaculazioni
nei maschi e menarca nelle femmine (mediamente a 13-14 anni
maschi e 11-12 anni femmine)
Sviluppo dei caratteri sessuali secondari. Maschi: Aumento della
peluria; allargamento della laringe ed allungamento delle corde
vocali. Femmine: aumento del seno, allargamento bacino.
Sviluppo del sistema circolatorio e respiratorio
Cambiamenti del sistema endocrino
Ridistribuzione del grasso corporeo e dei tessuti muscolari
Sviluppo del sistema nervoso
Sviluppo del sistema linfatico
I
ragazzi percepiscono grande inquietudine
perché non conoscono l’esito del
cambiamento
L’immagine del proprio corpo deriva
dall’interpretazione personale che si ha di
esso essendo investito di desideri, sogni
aspettative per ciò che si vorrebbe essere
Mentalizzazione del corpo: sentimenti
ambivalenti amore e odio
Problema: l’adolescente non ha ancora le
competenze cognitive e sociali necessarie
per costruire ed accettare pienamente la
nuova identità corporea
Il
corpo del bambino era ritenuto stabile e
sede delle competenze percettive e motorie
ora crolla un punto di riferimento
Finché il corpo non è pienamente
mentalizzato c’è una forte distanza mentecorpo: difficoltà di percezione dei segnali e
risposte inappropriate
Mentalizzare il corpo significa passare da un
momento di corpo come prigione ad una
buona rappresentazione che può
comprendere e controllare
Fattore
intrapersonale (paure, fobie,
relazioni)
Differenze interindividuali (anticipi e ritardi)
Fattore culturale
Hall:
i turbamenti psicologici
dell’adolescenza hanno come causa diretta i
cambiamenti fisici
Anticipi o ritardi puberali (vantaggio e
svantaggio psicologico)
Rapporto tra maturazione puberale e
condotta sociale: la troppa precocità appare
correlata a condotte devianti
Forte dispendio di energia per il
cambiamento fisico correlato a scarse
energie mentali (calo a scuola)
Ridefinizione
del proprio ruolo di maschio e
di femmina per i caratteri secondari
Identità sessuale: percezione sessuata di sé e
del proprio comportamento
Intensificazione delle condotte di genere.
Oggi situazione più paritaria
Approccio psicosociale: La pubertà si
configura come compito di sviluppo e la sua
risoluzione dipende dalle risorse interne ed
esterne
I pari diventano occasioni per mostrare la
propria identità di adulti e per sedurre
Anticipazione
della pubertà e posticipazione
dell’autonomia economica
Maggiore libertà sessuale e rapporti al di
fuori del matrimonio
Anticipo dell’esordio sessuale (15-16 anni
media, maschi più precoci). Il 30% dei ragazzi
sotto i 30 anni ha avuto più di tre partner
Sessualità vissuta nelle coppie stabili
soprattutto senza rapporti completi
Importanza della scelta consapevole
(omosessualità)
Si
costruisce in base alle modificazioni puberali
Si costruisce in base alle interazioni con il
contesto di socializzazione (come il contesto
risponde al cambiamento fisico)
Anoressia
e bulimia come ipermentalizzazione
del corpo e come difficoltà di integrazione delle
propria identità (sè diviso)
Pubertà:
comparsa del desiderio e di forti
ambivalenze nei confronti del proprio corpo
Conflitto fra nostalgia del corpo bambino
investito dall’affetto genitoriale e bisogno di
rivendicare autonomia sul proprio corpo
Prevale la necessità di mostrarsi come
soggetti autonomi: forte investimento sul
nuovo corpo
Dedizione per il corpo in quanto base per la
costruzione dell’identità sociale ed oggetto
di giudizio dei pari
Mentalizzazione
del corpo: saper costruire
un’immagine mentale che dia significato
etico ed affettivo alle trasformazioni
puberali ponendo le basi per l’identificazione
di genere e per quella sessuale
Manipolazione attiva del corpo per ricerca di
unicità e di presentabilità sociale
Difficoltà di mentalizzazione di oggi non
dovuta alla restrizione educativa ma alla
difficoltà di accettare la ferita narcisistica e
il nuovo corpo
L’adolescente
ha molti corpi che devono
essere integrati (sociale, sessuale,
alimentare, maschile o femminile…).
L’immagine corporea è un’integrazione
coerente di tutte queste rappresentazioni
Distanza tra corpo da abitare e mente e
sopraggiungere del piacere e desiderio che
possono essere rifiutati
Anoressia: rifiuto del corpo sessuato o altre
forme di aggressione. Controllo del corpo
come controllo sull’ambiente per ircerca
dell’identità
dismorfofobia
Genere:
differenze psicologiche tra maschi e
femmine
Sesso: differenze fisiche
I
bambini acquisiscono presto il senso
dell’identità di genere perché la
socializzazione è largamente influenzata dal
sesso
Identità di genere (18-30 mesi): il bambino
diventa consapevole dell’esistenza di due
categorie. A tre anni iniziano a riconoscere il
sesso degli altri bambini in base ad indizi
percettivi.
Stabilità del genere (dai 3-4 anni): il sesso è una
caratteristica costante per tutta la vita. Ma
conoscenza ancora limitata fino allo stadio
operatorio: tendono a credere che il sesso
cambia se cambiano gli indizi percettivi.
Coerenza del genere (dai 5-6 anni):la
caratteristica è costante e non varia in relazione
al contesto o agli indici. Comprensione del
genere completata.
Comprensione del ruolo di genere (dai 2-3 anni):
i bambini capiscono che alcune cose sono
adeguate per i M altre per le F (stereotipo)
Stereotipi:
M:attivo, dominante, sicuro,
aggressivo; F. passiva, premurosa,
accondiscendente, dedita alla cura degli altri
Gli stereotipi culturali non sono così presenti
effettivamente nel comportamento dei
bambini. Rassegna del 1974: nessuno dei
tratti considerati differenzia effettivamente
bambini e bambine. Studio del 1998:
differenza nei compiti percettivi o verbali,
differenze minime, no di personalità, ruolo
del contesto.
Differenze nella scelta dei giocattoli e nelle attività di
gioco molto precoce. Fattori innati o pressioni sociali?
Molte pressioni dai 2 anni in particolare sui maschi.
Gli adulti incoraggiano in particolare i maschi a giocare
con giochi tipizzati per sesso
Gli adulti incoraggiano i M a scegliere giochi vigorosi e
attivi
Ai M sia assegnano compiti domestica da M
Si presta più attenzione al comportamento aggressivo e
assertivo dei M
Le proibizioni verbali e fisiche sono indirizzate più ai M
I genitori incoraggiano maggiormente i M all’autonomia
I genitori discutono di più di sentimenti con i M
I M sono più incoraggiati a controllare la manifestazione
delle emozioni
Il
M è percepito come più forte, autonomo,
meglio coordinati e più vigili; la F è
percepita come più piccola, delicata, più
bella e tranquilla
Esperimento con filmati di Baby X
Separazione
tra i sessi come fenomeno
spontaneo universale.
M: gioco più coercitivo, violento, competitivo
F: gioco più cooperativo
Percezione
di sé unitaria come maschio o
come femmina
Processo multifattoriale che si articola
attraverso dimensioni biologiche,
psicologiche,relazionali e socioculturali
Ruolo di genere: tutto ciò che viene
comunicato agli altri per manifestare questa
appartenenza. Molti modi di esprimere il
genere non solo atipici
Studi recenti: 4 dimensioni: consapevolezza,
compatibilità psicologica, pressione
percepita, convinzione (pregiudizio)
La
popolarità ed accettazione da parte del
gruppo dei pari è correlato alla percezione di
compatibilità con il proprio genere. La bassa
compatibilità è negativa laddove è forte la
pressione percepita. L’androginia psicologica è
secondo alcuni possibilità di adattamento
superiore.
Maschi più compatibilità ma anche più pressione.
Il pregiudizio intergruppo può essere causa di
difficoltà relazionali con i pari.
Chi riceve più pressione è meno esplorativo, più
accettato dai pari ma poco soddisfatto.
DIG:
disturbo dell’identità di genere. Non
conformità con il proprio genere.
Gender identity interview fo children (Zucker et
al., 1993): rivela sentimenti di disforia di
genere, desiderio di appartenenza al sesso
opposto, ambivalenza nei confronti del proprio
sesso.
Studio
dell’identità di genere in
preadolescenza
Studio delle differenze per genere ed età
Studio di possibili atipicità
246
soggetti di età compresa tra 9 e 13
anni bilanciati per sesso
Gender identity interview for children (GII)
Big Five questionnaire (Barbaranelli et al., 1998)
Questionario sull’identità di genere per gli
insegnanti (Johnson et al., 2004)
Child Behaviour Checklist (CBCL di Achenbach,
1991)
Rara presenza di atipicità
Chi ha bassa consistenza con il prorpio genere ha
alta instabilità emotiva, bassa coscienziosità,
tendono a manifestare condotte
aggressive/trasgressive