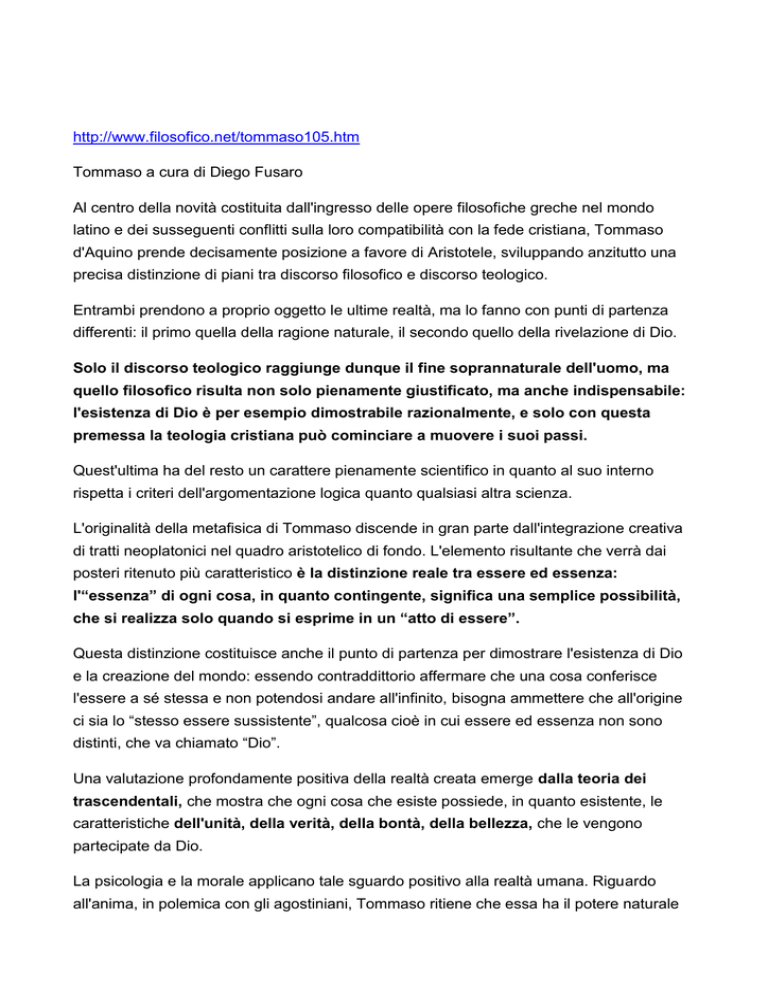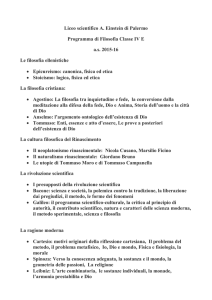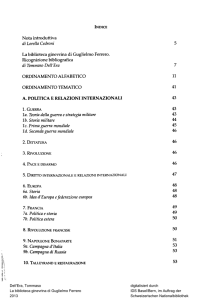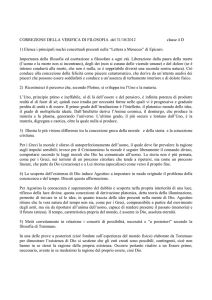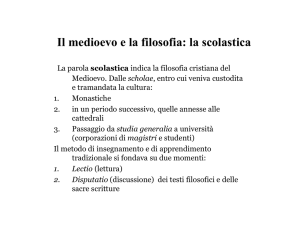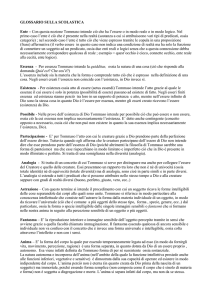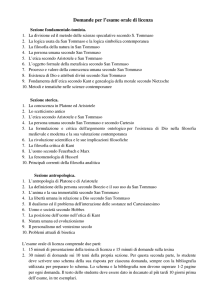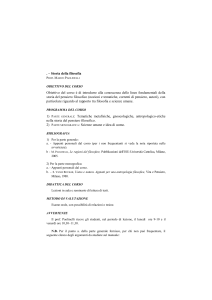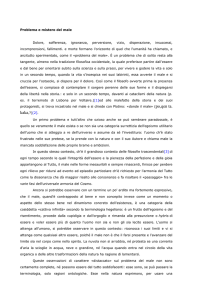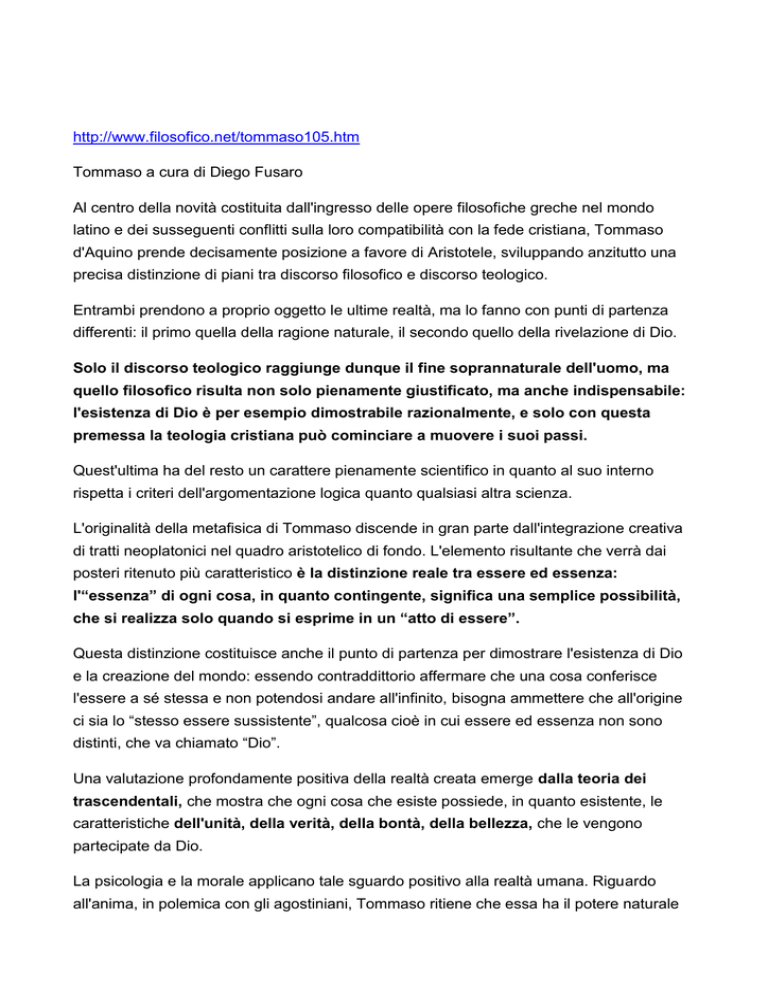
http://www.filosofico.net/tommaso105.htm
Tommaso a cura di Diego Fusaro
Al centro della novità costituita dall'ingresso delle opere filosofiche greche nel mondo
latino e dei susseguenti conflitti sulla loro compatibilità con la fede cristiana, Tommaso
d'Aquino prende decisamente posizione a favore di Aristotele, sviluppando anzitutto una
precisa distinzione di piani tra discorso filosofico e discorso teologico.
Entrambi prendono a proprio oggetto le ultime realtà, ma lo fanno con punti di partenza
differenti: il primo quella della ragione naturale, il secondo quello della rivelazione di Dio.
Solo il discorso teologico raggiunge dunque il fine soprannaturale dell'uomo, ma
quello filosofico risulta non solo pienamente giustificato, ma anche indispensabile:
l'esistenza di Dio è per esempio dimostrabile razionalmente, e solo con questa
premessa la teologia cristiana può cominciare a muovere i suoi passi.
Quest'ultima ha del resto un carattere pienamente scientifico in quanto al suo interno
rispetta i criteri dell'argomentazione logica quanto qualsiasi altra scienza.
L'originalità della metafisica di Tommaso discende in gran parte dall'integrazione creativa
di tratti neoplatonici nel quadro aristotelico di fondo. L'elemento risultante che verrà dai
posteri ritenuto più caratteristico è la distinzione reale tra essere ed essenza:
l'“essenza” di ogni cosa, in quanto contingente, significa una semplice possibilità,
che si realizza solo quando si esprime in un “atto di essere”.
Questa distinzione costituisce anche il punto di partenza per dimostrare l'esistenza di Dio
e la creazione del mondo: essendo contraddittorio affermare che una cosa conferisce
l'essere a sé stessa e non potendosi andare all'infinito, bisogna ammettere che all'origine
ci sia lo “stesso essere sussistente”, qualcosa cioè in cui essere ed essenza non sono
distinti, che va chiamato “Dio”.
Una valutazione profondamente positiva della realtà creata emerge dalla teoria dei
trascendentali, che mostra che ogni cosa che esiste possiede, in quanto esistente, le
caratteristiche dell'unità, della verità, della bontà, della bellezza, che le vengono
partecipate da Dio.
La psicologia e la morale applicano tale sguardo positivo alla realtà umana. Riguardo
all'anima, in polemica con gli agostiniani, Tommaso ritiene che essa ha il potere naturale
di conoscere la realtà e non ha dunque bisogno di una continua illuminazione da parte di
Dio.
Riguardo alla morale viene rivendicato il valore di un'etica naturale, che non è annullata
dalla constatazione che il fine della perfetta beatitudine a cui aspira l'uomo non può essere
raggiunto con le sole forze naturali.
Nella valutazione dell'atto umano Tommaso accoglie fin dove gli era possibile le
coraggiose proposte di Abelardo, che assegnavano un ruolo determinante all'intenzione
con la quale si agisce: per questo l'uomo ha sempre il dovere di agire seguendo la propria
coscienza, e contemporaneamente il dovere di conoscere sempre meglio che cosa è
veramente bene.
Armonia tra ragione e fede
Uno dei tratti più caratteristici del pensiero di Tommaso d'Aquino è senza dubbio il
tentativo di armonizzare, nella loro reciproca autonomia, filosofia e teologia.
Per Tommaso il problema si poneva in maniera molto forte: la sostanziale accettazione
della filosofia aristotelica, che pareva a prima vista conciliabile con molta difficoltà con il
pensiero cristiano, poteva suscitare l'impressione di una subordinazione della rivelazione
al pensiero razionale (come sembrava essere avvenuto nella filosofia araba di Averroè
[1126-1198].
Bisogna quindi anzitutto mostrare che oltre le scienze filosofiche è necessaria all'uomo
un'altra dottrina, superiore per valore alle scienze filosofiche e certa quanto esse.
La necessità della teologia è fondata da Tommaso sulla necessità della rivelazione
stessa: dato che l'uomo è diretto per la sua natura ad un fine che eccede le sue capacità
naturali (un tema che diverrà più chiaro parlando della morale), per la salvezza dell'uomo
è necessaria una rivelazione divina.
La dottrina basata sulla rivelazione non va però confusa con la teologia razionale:
quest'ultima prende a proprio oggetto Dio così come egli può essere conosciuto alla sola
luce della ragione (come per esempio aveva fatto Aristotele), la teologia rivelata così come
egli ha voluto rivelare sé stesso.
In questo modo è assicurata anche l'autonomia della speculazione puramente razionale:
tutt'altro che essere esautorata, essa diviene invece la premessa (il preambulum) della
teologia, presentando le verità cui l'uomo può giungere con le sue sole forze, che
attendono poi completamento dalla rivelazione.
Esistenza di Dio
“Un caso tipico è costituito dall'esistenza di Dio: Il fatto che dio esista, e altre cose di
questo tipo che tramite la ragione naturale possono essere note su dio, come viene detto
in Rom. 1,19, non sono articoli [= princìpi] di fede, ma premesse agli articoli: infatti la fede
presuppone la conoscenza, così come la grazia presuppone la natura, e come la
perfezione presuppone ciò che può essere reso perfetto. Tuttavia nulla proibisce che ciò
che di per sé è dimostrabile e conoscibile venga accettato come credibile da qualcuno che
non capisce la dimostrazione” (Somma teologica 1, q2a2ad1).
L'ultima annotazione significa questo: l'esistenza di Dio è per esempio una verità
razionale, e quindi può essere “conosciuta”; ma chi non ne capisce la dimostrazione potrà
semplicemente “credervi”, per esempio fidandosi di chi gli assicura che essa è corretta (se
così non fosse la fede cristiana sarebbe accessibile solo al filosofo!).
Ma la teologia in sé (o “sacra dottrina”, come preferisce chiamarla Tommaso) può essere
definita “scienza”? Ecco per intero la discussione del problema:
“Per il secondo articolo si procede così: sembra che la sacra dottrina non sia una scienza.
Infatti ogni scienza procede da princìpi noti per sé. Ma la sacra dottrina procede dagli
articoli di fede, che non sono noti per sé, non essendo ammessi da tutti: la fede infatti non
è di tutti, come si dice in 2Tess. 3,2. Dunque la sacra dottrina non è una scienza. Inoltre, la
scienza non riguarda le cose singolari. Ma la sacra dottrina tratta di cose singolari, per
esempio delle gesta di Abramo, Isacco e Giacobbe, e simili. Dunque la sacra dottrina non
è una scienza. Ma contro c'è ciò che dice Agostino in De Trinitate 14,7: “A questa scienza
si attribuisce solo ciò tramite cui la fede che dà la salvezza viene generata, nutrita, difesa,
rafforzata”. Ma ciò non appartiene a nessuna scienza se non alla sacra dottrina. Dunque
la sacra dottrina è una scienza.
Rispondo dicendo che la sacra dottrina è una scienza. Ma bisogna sapere che ci sono due
generi di scienze. Infatti alcune sono quelle che procedono da princìpi noti alla luce
naturale dell'intelletto, come l'aritmetica, la geometria e le scienze di questo tipo. Altre
invece sono quelle che procedono da princìpi noti alla luce di una scienza superiore: come
la prospettiva procede da princìpi resi noti dalla geometria, e la musica da princìpi noti
tramite la matematica. E in questo modo la sacra dottrina è una scienza, perché procede
da princìpi noti alla luce di una scienza superiore, vale a dire la scienza che posseggono
dio e i beati. Quindi, come la musica crede ai princìpi trasmessile dal matematico, così la
sacra dottrina crede ai princìpi rivelatile da dio. Alla prima obiezione dunque bisogna dire
che i princìpi di qualsiasi scienza o sono noti per sé, o si riconducono alla notizia di una
scienza superiore. E tali sono i princìpi della sacra dottrina, come è stato detto. Alla
seconda bisogna dire che le cose singolari vengono trasmesse nella sacra dottrina non
perché si tratti principalmente di essi: ma vengono introdotti sia come esempio di vita,
come nelle scienze morali; sia anche per rendere chiara l'autorità degli uomini tramite cui
giunse a noi la rivelazione divina, sulla quale si fonda la sacra Scrittura ovvero la sacra
dottrina” (Somma teologica 1, q1a2).“
In sintesi: la teologia trae i suoi princìpi da una “scienza” superiore, che è la conoscenza
che Dio ha di sé stesso (e che posseggono per quanto possibile anche coloro che sono
giunti alla beatitudine eterna); e come il musicista si fida delle informazioni che il
matematico gli dà riguardo alla sua scienza, così il teologo (come ogni altro credente) si
fida delle notizie che Dio ha dato di sé stesso rivelandosi.
Ma il carattere scientifico della teologia è assicurato dal suo metodo razionale e
argomentato, che permette di ricavare conclusioni logiche da premesse di fede e anche di
ragione. Ciò non significa per Tommaso (come s'intenderà più tardi) che la teologia sia
esclusivamente una scientia conclusionum, una scienza cioè che non fa altro che tirare
conseguenze da princìpi indiscutibili: anche nei confronti dei princìpi di fede la ragione ha
infatti il compito di mostrare che essi sono credibili.
Ciò può essere fatto in due modi: o evidenziando l'autorità del rivelante, o dimostrando
che i princìpi rivelati non solo non sono contrari alla ragione, ma anzi si trovano
intimamente d'accordo con essa.
La fede non è infatti concepita come qualcosa di irrazionale e privato, ma l'atto
tramite cui accettiamo come vero sulla base di buoni motivi qualcosa rivelato da
qualcuno.
Questo è il senso anche delle molte dimostrazioni di “convenienza”: delle opere di Dio non
è possibile mostrare la necessità (ciò significherebbe negare la libertà di Dio); si può però,
a posteriori, comprendere che sono coerenti con la sua natura.
“Un esempio tipico tra i molti possibili è la discussione sull'incarnazione di Dio: La stessa
natura di dio è la bontà. ... Quindi qualsiasi cosa appartenga al carattere del bene è
conveniente a dio. Ma appartiene al carattere del bene che si comunichi ad altri. ... Quindi
al carattere del sommo bene appartiene che si comunichi alla creatura nel modo più alto.
Ciò in verità avviene per il fatto che “congiunge a sé la natura creata di modo che venga
una sola persona da tre elementi, verbo, anima e carne”, come dice Agostino in De
Trinitate 13,17. Dunque è chiaro che fu conveniente che dio si sia incarnato” (Somma
teologica 3, q1a1c).
Bisogna inoltre notare che Tommaso, nonostante affermi che l'unico scopo dei fatti
“singolari” è servire o da esempio morale o da prova dell'autorità, non può rimanere fedele
a quest'assunto di origine aristotelica. Una parte importante della Somma Teologica è
infatti dedicata a Cristo: alla sua persona, alla sua vita, alla sua passione, morte e
resurrezione, tutti aspetti o fatti singolari per eccellenza. È evidente allora che, malgrado le
affermazioni di principio contrarie, la teologia di Tommaso non può rinunciare a quel fatto
del tutto unico e particolare che è costituito dal compimento della salvezza nella storia. In
questo modo la fede cristiana, eminentemente storica, rivendica i suoi diritti, costringendo
Tommaso a trasgredire tacitamente le regole della scientificità della cultura del suo tempo.
Filosofia e teologia
Riassumendo, in Tommaso la ragione svolge un triplice compito a servizio della teologia:
1) dimostra le premesse che permettono l'accoglienza dei princìpi di fede;
2) mostra la “credibilità”, cioè in ultima analisi la coerenza, dei princìpi di fede;
3) offre il metodo argomentativo tramite cui dedurre dalle premesse razionali e dai princìpi
di fede ulteriori verità.
Nel seguito toccheremo quasi esclusivamente gli aspetti più originali della filosofia di
Tommaso che, proprio per le ragioni dette, è facilmente separabile dalle discussioni
teologiche.
Si noterà tuttavia che si tratta di una separazione che ha un carattere provvisorio: la
filosofia è infatti secondo Tommaso capace di comprendere i propri stessi limiti, e dunque
di attendere un completamento da una scienza guidata da una luce superiore alla ragione
naturale. Inoltre, il ruolo chiarificatore che la ragione assume nei confronti degli articoli di
fede fa sì che molte delle discussioni filosoficamente più interessanti si trovino in un
contesto propriamente teologico.
La metafisica
Nelle sue linee generali, la metafisica di Tommaso si presenta come un'intenzionale
ripresa di Aristotele, le cui opere proprio in quell'epoca cominciavano a circolare nella loro
interezza nel mondo culturale di lingua latina. L'aristotelismo di Tommaso d'Aquino è
tuttavia fortemente impregnato di elementi neoplatonici, desunti da varie fonti (Porfirio
[232-304], Proclo [410-485], Dionigi l'Areopagita [5º secolo], ibn Sînâ ovvero Avicenna
[980-1037]).
L'influenza neoplatonica si può rilevare anzitutto nella maggiore sottolineatura della
distinzione tra gli enti sensibili e quelli puramente intellegibili, distinzione che in Aristotele
veniva attenuata dall'identificazione dell'ousía con la “forma”.
Secondo Tommaso ciò è pienamente vero solo nel caso degli enti privi di materia (detti
“sostanze separate” e identificati con gli angeli), la cui natura o essentia (questa è
l'originaria traduzione latina di ousía) è solo forma; ma nel caso degli enti
necessariamente possedenti materia (le “sostanze composte”, per esempio l'uomo),
l'essentia è il composto di forma e materia.
Tale precisazione di sapore neoplatonico in Tommaso sembra però ottenere un risultato
contrario a quello originario: non una svalutazione delle sostanze composte, ma piuttosto
una maggiore stima della corporeità. Affermare che la materia fa parte dell'essenza
significa infatti sostenere per esempio che la perfezione dell'uomo include
necessariamente anche la corporeità (donde la giustificazione razionale dell'articolo di
fede sulla resurrezione della carne).
Parimenti influenzata dal neoplatonismo è la diversa concezione dell'essenza. Mentre in
Aristotele l'ousía e il tí én éinai (l'“essere-per-ciascuna-cosa”) erano anzitutto singolari, in
Tommaso l'essentia (o quidditas) è universale, e viene così ad avvicinarsi alla nozione
logica di éidos, cioè di specie. Da qui nasce un problema che in Aristotele non poteva
porsi: vale a dire il problema dell'individuazione.
Se l'essentia è universale, ma la realtà è del resto solo singolare (in questo Tommaso
accetta integralmente la critica d'Aristotele a Platone), che cosa conferisce l'individualità
alla singola cosa?
Sfruttando un'osservazione marginale di Aristotele e seguendo Avicenna, Tommaso
risponde che si tratta della materia:
“Il principio di individuazione è la materia. Da ciò sembrerebbe seguire che l'essenza, che
comprende in sé la materia e assieme la forma, sia soltanto particolare e non universale.
... E dunque bisogna sapere che non la materia comunque intesa è principio
d'individuazione, ma solo la materia determinata (materia signata). E dico materia
determinata quella che viene considerata sotto certe dimensioni. ... Nella definizione
dell'uomo viene posta la materia non determinata: infatti nella definizione dell'uomo non si
pone questa carne e queste ossa, ma carne e ossa in assoluto, che sono la materia non
determinata dell'uomo (Sull'ente 2,6). Nel caso dell'uomo dunque, non è l'anima in quanto
tale che conferisce individualità (l'anima è forma), ma solo in quanto fatta per unirsi ad un
corpo (“la moltiplicazione delle anime è secondo la moltiplicazione dei corpi”), Somma
teologica 1, q72a2ad2).
Diverso è il caso degli angeli: non avendo essi materia, l'individualità sarà
necessariamente data dalla forma, che dunque sarà diversa per ogni angelo e si
identificherà con lui. È comunque solo l'ente pienamente individuato che può ricevere il
nome di “sostanza” (traduzione del greco hypóstasis), indicante ciò che sussiste realmente
e autonomamente. In questo mutamento di prospettiva c'è anche una importante
conseguenza di carattere gnoseologico.
Con l'affermazione dell'universalità dell'essenza Tommaso riesce infatti ad aggirare una
difficoltà della filosofia aristotelica, nascente dalla giustapposizione tra l'individualità della
realtà e l'universalità della scienza: in quale modo la scienza può allora avere una sua
verità?
In Tommaso il problema è risolto perché l'universale non è solo un prodotto dell'astrazione
dell'intelletto (universale post rem), ma è anche realmente presente nella singola cosa
(universale in re), anzi la precede pure (neoplatonicamente) nella mente di Dio, che
possiede i modelli esemplari di tutte le cose create (universale ante rem, ovvero ideae).
Questa era già la soluzione che aveva dato al problema degli universali Pietro Abelardo.
La scienza dunque è valida anzitutto perché non si basa solo su generalizzazioni (in
quanto tali fallibili), ma sulla capacità che l'intelletto possiede di riconoscere l'universale
incarnato nelle singole cose. La totale assenza di materia negli angeli (sostenuta in
polemica con il contemporaneo Bonaventura [1221-1274], che vedeva in essi la presenza
di una “materia spirituale”) pone di fronte ad un ulteriore problema. Affermare che essi
sono forme pure non equivale forse a designarli come “atti puri”, eguali quindi a Dio
stesso?
Tommaso evita questa conseguenza con la dottrina della distinzione reale tra esse ed
essentia:
“Qualsiasi cosa non faccia parte della comprensione dell'essenza o quiddità, le viene
dall'esterno ed entra in composizione con l'essenza, perché nessuna essenza potrebbe
essere compresa senza ciò che fa parte dell'essenza. Ma ogni essenza o quiddità può
essere compresa senza che si comprenda alcunché del suo essere di fatto (de esse suo
facto). Posso infatti comprendere che cos'è l'uomo o la fenice, e tuttavia ignorare se
abbiano essere nella natura reale (an esse habeant in rerum natura). Dunque è evidente
che l'essere è altro dall'essenza o quiddità” (Sull'ente 5,3).
Ciò significa che le cose di cui abbiamo esperienza sono contingenti, non posseggono
cioè in sé stesse nulla che richieda necessariamente la loro esistenza. Anche nell'angelo,
liberamente creato da Dio, c'è dunque una tale composizione tra essere ed essenza, che
impedisce di considerarlo un essere assolutamente “semplice”.
Fin qui, Tommaso segue sostanzialmente l'opinione che era già stata di Guglielmo di
Alvernia (1190-1249).
Il passo ulteriore è invece più originale. Come più chiaramente viene detto in testi
successivi al Sull'ente e l'essenza, la relazione tra essenza ed essere va chiarita con
l'aiuto dei concetti aristotelici di potenza e atto:
“Nelle cose materiali si trova una duplice composizione. La prima è quella di forma e
materia, dalle quali viene costituita una certa natura [ovvero essenza]. Ma la natura così
composta non è il suo essere, ma piuttosto l'essere è il suo atto. Dunque la stessa natura
è in rapporto con il suo essere come una potenza con un atto. Dunque, eliminata la
materia, e posto che la stessa forma sussista senza materia, rimane ancora il rapporto
della forma con lo stesso essere, come della potenza con l'atto. E questa composizione
bisogna intenderla negli angeli” (Somma teologica 1, q50a2ad3).
Quindi, i termini potenza e atto possono indicare due cose distinte: o la materia in rapporto
alla forma (questo è il significato aristotelico), o l'essenza (materia più forma o forma pura)
in rapporto all'essere.
Quest'ultimo andrà quindi definito “l'attualità di tutti gli atti” -- per questo viene spesso
chiamato anche actus essendi -- e costituisce l'autentico vertice della conoscenza
metafisica. In questo modo Tommaso integra all'interno della metafisica aristotelica la
tendenza neoplatonica a considerare l'“essere” come un qualcosa dotato di una sua
autonomia (non solo concettuale, ma reale) rispetto a tutte le possibili determinazioni degli
enti.
La distinzione di Tommaso tra essere ed essenza, per quanto non venga presentata
con molta enfasi da lui stesso, venne presto ritenuta il tratto più caratteristico del suo
pensiero, e come tale vivacemente contestata o difesa, per lo più sotto la forma della
coppia concettuale essentia / existentia (un termine quest'ultimo poco amato da
Tommaso). Tale distinzione ha così costituito un punto di riferimento fondamentale per
pressoché tutte le filosofie posteriori, fino all'esistenzialismo contemporaneo.
I trascendentali
Un'importanza particolare ha nella metafisica di Tommaso d'Aquino la teoria dei
“trascendentali” (come saranno in realtà solo più tardi chiamati), sostanzialmente originale
rispetto ad Aristotele (ma in parte ripresa da Alessandro di Hales [1185-1245]).
I trascendentali sono gli attributi generalissimi che riguardano l'ente in quanto tale.
Essi quindi oltrepassano, “trascendono” le categorie (o “predicamenti”), che
dividono invece l'ente in differenti generi (altro è la sostanza, altro la quantità, e così
via).
La distinzione tra i trascendentali non è quindi reale, ma solo di ragione (e infatti
“convertuntur”, dice Tommaso); proprio per questo però essi aiutano a comprendere la
ricchezza di un termine -- “ente” -- che altrimenti rischierebbe di rimanere vago e
indeterminato. Il passo più completo sui trascendentali si trova nella prima questione Sulla
verità, che opera una precisa deduzione dei caratteri dell'ente:
“Alcune cose vengono dette aggiunte all'ente per il fatto che esprimono un modo dell'ente
stesso che non viene espresso dal nome “ente”.
Ciò accade in due maniere: nella prima cosicché il modo espresso è un qualche modo
speciale dell'ente [= categorie]. ... Nella seconda cosicché il modo espresso sia un modo
generale che consegue ad ogni ente; e questo modo può essere inteso in due maniere:
nella prima in quanto consegue a qualsiasi ente in sé; nella seconda in quanto consegue
ad un ente in rapporto ad un altro. Se è nella prima maniera, ciò avviene in due maniere,
perché esprime nell'ente qualcosa o affermativamente o negativamente. E non si trova
nulla che sia detto affermativamente in modo assoluto, che possa essere inteso in ogni
ente, se non la sua essenza, secondo la quale si dice che esso è; e così viene assegnato
il nome “cosa”, che differisce da “ente”, secondo ciò che dice Avicenna all'inizio della
Metafisica, perché “ente” viene tratto dall'atto di essere, ma il nome “cosa” esprime la
quiddità o essenza dell'ente. E la negazione che consegue ad ogni ente in maniera
assoluta è la non divisione, che viene espressa dal nome “uno”: infatti l'uno non è
nient'altro che l'ente indiviso. E se il modo dell'ente viene inteso nel secondo modo, cioè
secondo il rapporto di una cosa all'altra, ciò può avvenire in due maniere. Nella prima
secondo la divisione di un ente dall'altro, che viene espressa dal nome “qualcosa”: infatti si
dice “qualcosa” come se si dicesse “un'altra cosa”; dunque come l'ente viene detto “uno”
in quanto è in sé non diviso, così viene detto “qualcosa” in quanto è diviso dagli altri.
Nella seconda maniera secondo l'accordo di un ente con un altro; e ciò però non può
avvenire se non si prende qualcosa che possa per natura accordarsi con ogni ente: e ciò è
l'anima, che è in un certo senso tutte le cose, come viene detto nel terzo libro Sull'anima.
Ma nell'anima c'è una facoltà conoscitiva e desiderativa. Dunque l'accordo dell'ente con il
desiderio viene espresso dal nome “buono”, così come all'inizio dell'Etica [Nicomachea] si
dice che il buono è ciò che tutti desiderano. E l'accordo dell'ente con l'intelletto viene
espresso dal nome “vero” (Sulla verità q1a1c).
I sei trascendentali dell’essere
In conclusione, sei sono (contando anche ens) le nozioni trascendentali: ens, res, unum,
aliquid, verum, bonum. Ciò significa che ogni ente (cioè ogni cosa che ha essere) è una
cosa in quanto determinato (cioè in quanto ha un'essenza), è un'unità in quanto identico a
sé (come già esplicitamente rilevava Aristotele), è un qualcosa in quanto distinto dagli altri
enti, è vero in quanto conoscibile, è buono in quanto desiderabile. Questo in sintesi lo
schema del ragionamento di Tommaso: attributi speciali (praedicamenta) attributi
generali (trascendentia) conseguono all'ente in sé affermativamente (res) negativamente
(unum [indivisio]) conseguono all'ente in rapporto ad altro secondo la divisione di un ente
da un altro (aliquid [aliud quid]) secondo l'accordo di un ente con un altro con l'intelletto
(verum) con il desiderio (bonum)
Qualche osservazione aggiuntiva.
La prima riguarda il verum. Il fatto che esso sia un trascendentale dell'ente non significa
che la verità sia una proprietà più delle cose che dell'intelletto: Tommaso tiene infatti ferma
la nozione aristotelica di verità come corrispondenza soggettiva tra la mente umana e
la realtà. Piuttosto, ogni cosa ha già, in quanto possiede essere ed essenza, una naturale
predisposizione ad essere conosciuta. La definizione di verità come adaequatio rei et
intellectus, che rimarrà classica nei secoli, intende tener conto sia dell'aspetto soggettivo,
che è primario, sia di quello oggettivo, che è derivato.
La seconda notazione riguarda il trascendentale bonum. Esso suppone la tesi della
“irrealtà” del male, che viene ripresa dal neoplatonismo: il male è soltanto la mancanza di
bene, cioè di essere, e più precisamente di un essere dovuto: la cecità è un male per
l'uomo, ma non per l'albero.
L'ultima osservazione riguarda il pulchrum, “bello”.
Esso riceve discreta attenzione, ma non viene incluso nella lista dei trascendentali in
quanto sostanzialmente omologato al verum.
Tommaso interpreta infatti l'esperienza estetica come il piacere che si accompagna
spontaneamente alla percezione della verità: Il bello e il buono in un soggetto sono
lo stesso, perché si fondano sulla stessa cosa, cioè sulla forma: e per questo il buono
viene lodato come bello. Ma differiscono per il carattere. Infatti il buono propriamente
riguarda il desiderio: infatti il buono è ciò che tutti desiderano. E perciò ha il carattere di
fine: infatti il desiderio è quasi un certo movimento verso una cosa.
“Il bello invece riguarda la facoltà conoscitiva: vengono dette infatti belle quelle cose che
piacciono quando sono viste. Dunque il bello consiste in una debita proporzione, perché il
senso prova diletto nelle cose debitamente proporzionate, come in cose simili a sé; infatti
anche il senso è una certa ragione, come ogni virtù conoscitiva. E giacché la conoscenza
avviene per assimilazione, e la somiglianza riguarda la forma, il bello propriamente
riguarda il carattere della causa formale” (Somma teologica 1, q5a4ad1).
La dottrina dei trascendentali acquista anche un immediato rilievo dal punto di vista
conoscitivo. Seguendo Avicenna, Tommaso afferma ripetutamente che l'ens è il primo
oggetto dell'intelletto. Quest'affermazione non è contrapposta all'altra (di origine
aristotelica) secondo cui l'oggetto proprio dell'intelletto umano è costituito dalla quidditas
rei materialis, ma ne costituisce piuttosto la base: ogni essenza può essere conosciuta
infatti solo in quanto esistente, e ogni concetto si formerà dunque “per addizione” rispetto
alla nozione trascendentale di ente.
In questo modo viene affermata l'originaria e immediata consonanza della mente umana
con la totalità della realtà, quantunque originariamente colta solo nella sua assoluta
generalità (a questo proposito egli parla di esse commune). In questo modo è possibile
fondare anche, in modo più rigoroso di quanto aveva fatto Aristotele, la supremazia del
primo principio dell'intelletto, il principio di non contraddizione.
Esso infatti è la diretta traduzione in un giudizio del trascendentale unum, così come in
campo morale è il trascendentale bonum a costituire la premessa per il primo principio
pratico:
“Nelle cose che cadono sotto l'apprensione di tutti, si trova un certo ordine. Infatti ciò che
cade per primo sotto l'apprensione è l'ente, la cui comprensione è inclusa in tutte le cose
che uno conosce.
E dunque il primo principio indimostrabile è che è impossibile contemporaneamente
affermare e negare, che si fonda sul carattere dell'ente e del non ente; e su questo
principio si fondano tutti gli altri. Ma come l'ente è la prima cosa che cade sotto
l'apprensione in assoluto, così il bene è la prima cosa che cade sotto l'apprensione della
ragione pratica, che è ordinata all'azione: tutto ciò che agisce infatti agisce per un fine, che
ha il carattere di bene.
E dunque il primo principio nella ragione pratica è quello che si fonda sul carattere del
bene, che è: il bene è ciò che tutti desiderano. Questo è dunque il primo precetto della
legge: il bene dev'essere fatto e cercato, il male evitato.
E su di esso si fondano tutti gli altri precetti della legge di natura: in modo che cioè
facciano parte dei precetti della legge di natura tutte le cose da fare o da evitare che la
ragione pratica conosce essere beni umani” (Somma teologica 2/1, q94a2c).
È difficile sopravvalutare l'importanza di questa dottrina. Con essa infatti sembra giungere
alla propria meta l'originaria intenzione di Aristotele, quella di costruire una scienza
dell'“ente in quanto ente”. La successiva storia della filosofia in gran parte seguirà questa
intuizione di Tommaso, e già Giovanni Duns Scoto (1266-1308) definirà la metafisica
scientia transcendens (una definizione questa che, seppure in una prospettiva diversa,
giungerà fino a Kant).
In maniera simile a quanto avveniva in Aristotele, lo studio dell'ente in quanto tale
culmina per Tommaso nella teoria dell'ente sommo, ovvero nella teologia: Tutto ciò
che compete a qualcosa o è causato dai princìpi della sua natura, come la capacità di
ridere nell'uomo, o viene da qualche principio esterno, come la luce nell'aria per influenza
del sole. Ma non può essere che lo stesso essere sia causato dalla stessa forma o
quiddità della cosa (intendo come causa efficiente): perché così una qualche cosa
sarebbe causa di sé stessa, il che è impossibile. Dunque è necessario che ogni cosa, tale
che il suo essere è diverso dalla sua natura, abbia l'essere da un altro. E poiché tutto ciò
che è tramite un altro si riconduce a ciò che è per sé come alla causa prima, dunque è
necessario che ci sia qualcosa che sia causa dell'essere per tutte le cose per il fatto che
essa è soltanto essere. Altrimenti si andrebbe all'infinito nella cause, giacché ogni cosa
che non è soltanto essere ha una causa del suo essere, come s'è detto. È chiaro quindi
che l'intelligenza [l'angelo] è forma ed essere, e che ha l'essere dal primo essere che è
soltanto essere (et quod esse habeat a primo esse quod est esse tantum); e questo è la
causa prima, che è dio (Sull'ente 5,4). Perciò, Dio dev'essere indicato come ipsum
esse subsistens, come cioè l'unico ente che è l'essere, a differenza di tutti gli altri che
hanno l'essere.
Non soltanto egli s'identifica con la sua essenza (come gli angeli), ma anche con il suo
stesso essere. In questo modo viene confermato razionalmente il nome che Dio rivela sul
roveto ardente: “Così dirai a loro: "Io Sono mi ha mandato a voi"” (Es. 3,14): questo è
infatti il nome che può indicare meglio di qualsiasi altro “il mare infinito dell'essere” (che
però va tenuto chiaramente distinto dall'esse commune, l'essere che possiedono tutte le
cose create considerate astraendo dalle loro determinazioni).
Il brano che abbiamo riportato presenta anche la struttura fondamentale della prova
dell'esistenza di Dio secondo Tommaso: la stessa esistenza di cose che
posseggono un essere soltanto partecipato mostra la necessità di qualcosa che sia
originariamente l'essere e dunque causa prima di tutto il resto -- ciò che appunto si
indica con la parola “Dio”.
Si noti che questo ragionamento ha una forma induttiva di tipo aristotelico (si parte da ciò
che è sott'occhio per giungere al principio primo), ma un punto di partenza niente affatto
aristotelico, e cioè la distinzione reale di essenza ed essere nelle cose diverse da Dio.
Breve sintesi
Un articolo celeberrimo della Somma Teologica (I, q2a3) elenca cinque diverse “vie” per
dimostrare l'esistenza di Dio, alcune di ispirazione più aristotelica (la prima, la seconda, la
quinta), altre di sapore più neoplatonico (la terza e la quarta).
La struttura delle cinque vie è però simile: in tutte infatti si tratta di mostrare come ciò di cui
si ha esperienza sarebbe inspiegabile se non si ammettesse un Dio che sta al di fuori del
campo dell'esperienza stessa.
Ecco in sintesi i ragionamenti seguiti:
1) il movimento è impossibile se non si ammette un primo motore che non è mosso da
nulla;
2) il divenire è impossibile se non si ammette una prima causa efficiente;
3) il contingente o possibile non può essere se non c'è qualcosa che è di per sé
necessario (questa via si identifica con la dimostrazione prima considerata);
4) i vari gradi di essere (e anche di verità, di bontà ecc.) sono impossibili se non c'è un
ente supremo in riferimento al quale giudicarli;
5) il finalismo della natura, anche inanimata, è impossibile se non c'è un intelletto che la
ordina.
Sulle stesse basi Tommaso dimostra razionalmente la creazione, cioè la produzione di
tutte le cose “dal nulla” (cioè “non da qualcosa di preesistente”):
“È necessario dire che tutto ciò che è in qualsiasi modo, sia da dio (omne quod
quocumque modo est, a deo esse). Se infatti qualcosa si trova in un'altra cosa per
partecipazione, è necessario che sia causato in essa da ciò a cui conviene
essenzialmente (così come il ferro diventa infuocato per opera del fuoco). Ma è stato
mostrato ... che dio è lo stesso essere sussistente per sé. E poi è stato mostrato che
l'essere sussistente non può essere che uno. ... Resta dunque che tutte le cose altre da
dio non siano il loro essere, ma partecipino dell'essere (non sint suum esse, sed
participant esse)” (Somma teologica 1, q44a1c).
E ricevere l'essere per partecipazione è proprio ciò che si indica con il termine “creazione”
(ciò tuttavia non equivale a negare l'eternità del mondo, una tesi questa che viene
confutata solo dalla rivelazione: è il tema dell'opuscolo Sull'eternità del mondo contro i
mormoratori).
La nozione platonica di “partecipazione”, assente dalla metafisica di Aristotele, diventa
allora centrale in Tommaso: essa indica appunto la condivisione di qualche cosa da parte
di chi la possiede originariamente e dunque definisce il rapporto originario tra Dio e le
creature. Altrettanto importante è la nozione di “analogia”, che significa non più, come in
Aristotele, solo l'uguaglianza di rapporti tra cose diverse (analogia proportionalitatis), ma
anche la diversità di rapporti rispetto ad una stessa cosa (analogia attributionis).
In questo secondo senso, l'analogia è una qualifica primaria della nozione di “ente”:
l'essere infatti si trova in tutte le cose, ma non nello stesso modo, soprattutto nelle
creature e in Dio: le prime “hanno” essere, il secondo “è” essere.
È perciò possibile formulare su Dio affermazioni che, pur limitate, non sono tuttavia false.
La stessa cosa si dovrà anzi dire a proposito di tutti gli attributi che si possono dire di lui:
“Alcune cose vengono dette di dio in maniera analoga, e non puramente equivoca, né
univoca. Infatti non possiamo nominare dio se non a partire dalle creature. ... E così
qualsiasi cosa venga detta di dio e delle creature si dice per il fatto che c'è un qualche
ordine della creatura rispetto a dio, come al principio e alla causa in cui preesistono in
modo eminente tutte le perfezioni delle cose. E questo modo di comunanza si trova tra la
pura equivocità e la semplice univocità. Infatti nelle cose che vengono dette per analogia
non c'è una sola relazione (ratio), come in quelle univoche, né una relazione totalmente
diversa, come nelle equivoche: ma il nome che così viene detto in molti modi significa
diverse proporzioni nei confronti di qualcosa di unico” (Somma teologica 1, q13a5c).
Uno dei più importanti fili conduttori per parlare analogicamente di Dio è costituito per
Tommaso dalla teoria dei trascendentali. Se infatti Dio è “ente” nel significato più alto, i
trascendentali gli competono per eccellenza: “qualsiasi cosa conviene all'ente in quanto
ente è necessario che si trovi soprattutto nel primo ente” (Commento a Boezio, Sulla
trinità, q1a4ob1).
Si potrà dunque dire che Dio è assolutamente unico (in quanto unum), che racchiude in sé
ogni possibile verità (in quanto verum), che è massimamente desiderabile da qualsiasi
ente intelligente (in quanto bonum). Cose simili si potrebbero senza dubbio dire per gli altri
trascendentali (anche se Tommaso non lo fa esplicitamente): Dio possiede l'essenza più
ricca e anzi infinita (in quanto res), è massimamente individuato perché il suo essere
coincide con la sua essenza (in quanto aliquid).
Anche in questo modo Tommaso si pone sulla scia di Aristotele, considerando la teologia
(razionale) come il coronamento della scienza dell'ente in quanto tale: ma
contemporaneamente l'immagine di Dio -- già ad un livello puramente razionale -- muta
profondamente: se da una parte c'è un Dio “pensiero di sé stesso” che non può amare il
mondo pena la perdita della propria perfetta attualità, dall'altra c'è un Dio che proprio in
quanto atto puro partecipa il proprio essere a tutte le creature, come dono dalla propria
ricchezza.
Infatti, il fatto stesso che le cose di cui abbiamo esperienza ci sono pur non godendo della
coincidenza di essere ed essenza dimostra che il loro essere è ricevuto in dono.
Ciò che si deve dire dell'essere va allora ripetuto per tutti gli altri trascendentali:
Dio partecipa l'essenza, l'individualità, l'unità, la verità, la bontà a tutto il creato, che
così porta la traccia della sua perfezione.
Per la sua importanza storica, conviene inoltre toccare il problema della potenza di Dio
(affrontato con dettaglio nelle questioni Sulla potenza e riassunto nella Somma).
In Dio c'è potenza? Certamente essa non c'è nel senso in cui si oppone all'atto: Dio è
infatti atto puro. Tommaso sfrutta però un secondo significato di potenza, che era stato già
evidenziato (ma meno usato) da Aristotele: la potenza cioè non come possibilità di essere
modificato, ovvero imperfezione (potentia passiva), ma come possesso di un principio di
movimento o mutamento, ovvero perfezione (potentia activa). In questo secondo senso
Dio non solo è potente, ma anzi onnipotente, essendo perfettissimo. Ma che cosa significa
che egli può tutto?
“Dio viene detto onnipotente perché può tutte le cose possibili in assoluto. ... Ma l'essere
divino, sul quale si fonda il carattere della potenza divina, è l'essere infinito, non limitato a
qualche genere dell'ente, ma recante in sé la perfezione di tutto l'essere. Dunque qualsiasi
cosa possa avere il carattere di ente fa parte delle cose possibili in assoluto, rispetto alle
quali dio viene detto onnipotente. Ma nulla si oppone al carattere di ente, se non il non
ente. Esso dunque ripugna al carattere del possibile in assoluto, che è sottomesso alla
potenza divina, perché implica in sé l'essere e contemporaneamente il non essere. ...
Tutte le cose dunque che non implicano contraddizione fanno parte di quelle cose possibili
rispetto alle quali dio viene detto onnipotente” (Somma teologica 1, q25a3c).
Tale precisazione consente a Tommaso d'Aquino di respingere l'opinione secondo cui il
mondo creato da Dio sarebbe “il migliore possibile”:
“Quando si dice che Dio può fare qualcosa meglio rispetto a ciò che fa, se “meglio” è un
nome, è vero: infatti di qualsiasi cosa può farne un'altra migliore. ... Ma se “meglio” è un
avverbio e riguarda il modo da parte di colui che fa, allora Dio non può fare meglio di come
fa: perché non può fare con maggiore sapienza e bontà” (Somma teologica, 1, q25a6ad1).
Insomma, lo stesso concetto di “mondo migliore possibile” è contraddittorio, perché di
qualsiasi cosa finita è sempre possibile una più perfetta (allo stesso modo, per esempio, è
contraddittorio il concetto di “numero maggiore possibile”).
Tuttavia anche in Tommaso, soprattutto nelle opere giovanili, si trovano dichiarazioni di
ispirazione neoplatonica (analoghe a quelle che molto più saranno caratteristiche di
Leibniz), in cui viene riconosciuto anche al male un ruolo nella bontà complessiva del
mondo:
Un universo in cui non ci fosse nulla di male non avrebbe tanta bontà quanta ne ha
quest'universo, perché non ci sarebbero in quello tante buone nature quante in questo, in
cui ci sono alcune nature buone alle quali non si aggiunge del male, e alcune alle quali si
aggiunge: ed è meglio che ci siano entrambi i tipi di nature piuttosto che le prime soltanto
(Commento al Libro delle sentenze, 1, d44q1a2ad5).
La facoltà di parlare analogicamente di Dio non toglie che la sua essenza sia
assolutamente impossibile da conoscere tramite le facoltà naturali dell'anima umana:
questa, che essendo unita al corpo è la forma di una materia, può infatti conoscere solo
ciò che le è connaturale: cioè le cose individuate nella materia (tramite i sensi) e le forme
universali astratte dalle cose (tramite l'intelletto).
Ma conoscere lo stesso essere sussistente che è Dio è al di sopra delle possibilità naturali
di qualsiasi intelletto creato, che possiede l'essere solo per partecipazione.
Dimostrare che Dio c'è (an est) è infatti ben diverso dal sapere che cosa egli sia
(quid est). In questo modo Tommaso interpreta l'affermazione del prologo del vangelo di
Giovanni: “Dio nessuno lo ha mai visto” (1,18), e contemporaneamente valorizza la
tradizione della teologia “negativa” o “apofantica” (soprattutto Dionigi l'Areopagita),
secondo la quale di Dio si può dire propriamente solo ciò che egli non è.
D'altra parte, l'ignoranza dell'essenza di Dio è l'unico motivo per cui Tommaso contesta
Anselmo d'Aosta (1033-1109), che riteneva che l'affermazione dell'esistenza di Dio sia
“per sé nota”, cioè immediatamente evidente.
Il difetto di questa opinione non consiste per Tommaso (come spesso poi affermato) in un
indebito passaggio dal piano mentale a quello reale (per quanto riguarda Dio è
perfettamente lecito dedurre dall'essenza l'esistenza), ma nella supposizione che l'uomo
conosca l'essenza di Dio, il che equivale sostanzialmente ad una petitio principii.
Ma dato che così non è, il concetto di Dio come essere sussistente viene formato
dall'uomo solo a partire dalle cose contingenti che sono a lui più vicine:
“Questa proposizione: dio esiste, in quanto è in sé, è nota per sé, perché il predicato è
identico al soggetto: dio infatti è il suo essere. ... Ma poiché noi non sappiamo di dio che
cosa egli sia, per noi non è nota per sé, ma ha bisogno di essere dimostrata tramite le
cose che sono più note dal nostro punto di vista e meno note dal punto di vista della
natura, vale a dire tramite gli effetti” (Somma teologica 1, q2a1c).
Il risultato finale della metafisica di Tommaso è dunque differente da quello di Aristotele: la
domanda sull'essere, che muove la meraviglia dell'uomo, può giungere alla fine solo ad
una indicazione, ma non ad una risposta intellettualmente completa. Si potrebbe dire che
anche davanti ad una pietra risulta impossibile chiarire fino in fondo che cosa significhi per
essa esistere: si potrà sì dire che ciò vuol dire avere l'atto di essere partecipato da colui
che è l'essere, ma quale sia l'essenza dello stesso essere rimane ignoto.
La metafisica culmina così in un grande interrogativo, dietro al quale però è già
assicurato che non si trova il nulla, ma al contrario la sovrabbondanza di tutte le
perfezioni che conosciamo solo imperfettamente e limitatamente e tuttavia
desideriamo spontaneamente nella loro totalità.
L’etica
Il problema dell'essere si sposta così dal campo speculativo al campo morale. Come la
fisica nel suo complesso, anche la dottrina dell'anima è in Tommaso pressoché
interamente ripresa da Aristotele. Alcune correzioni dovevano però essere introdotte per
renderla compatibile con la rivelazione cristiana.
I due punti più delicati erano costituiti dalla dottrina dell'intelletto agente (o “produttivo”) e
dall'immortalità.
Riguardo al primo, Tommaso, prendendo posizione in una celebre questione che
Aristotele aveva lasciato poco definita, ritiene che vada necessariamente ammesso che
l'intelletto agente sia qualcosa appartenente alla singola anima:
“Alcuni hanno affermato che quest'intelletto separato secondo la sostanza sia l'intelletto
agente, che, quasi illuminando le immagini sensibili, le rende attualmente intellegibili. Ma,
concesso che ci sia un tale intelletto agente separato, purtuttavia bisogna affermare che
nella stessa anima ci sia una qualche facoltà partecipata da quell'intelletto superiore,
tramite la quale l'anima umana le rende attualmente intellegibili. ... E questo lo
conosciamo sperimentalmente, quando percepiamo di astrarre forme universali da
condizioni particolari, il che significa renderle attualmente intellegibili. Infatti nessuna
azione conviene a qualche cosa se non tramite un qualche principio che gli inerisca
formalmente. ... Ma l'intelletto separato, secondo i documenti della nostra fede, è dio
stesso, che è creatore dell'anima. ... Dunque da lui l'anima umana partecipa la luce
dell'intelletto” (Somma teologica 1, q79a4c).
In questo modo Tommaso modifica drasticamente anche la dottrina agostiniana
dell'illuminazione: l'uomo conosce non perché attualmente lo illumini Dio (che alcuni
identificavano con l'intelletto agente unico di cui parlava Avicenna), ma perché il suo
proprio intelletto ha ricevuto -- una volta per tutte -- una luce naturale sufficiente a
garantire l'autonomia e la correttezza della sua conoscenza.
A maggior ragione risulta confutata la teoria di Averroè e dei suoi seguaci, che
teorizzavano l'unicità anche dell'intelletto possibile, affermando così un'unica anima per
tutta la specie umana (questo è l'argomento affrontato nell'opuscolo polemico Sull'unità
dell'intelletto contro gli averroisti).
La posizione di Agostino e dei contemporanei maestri francescani viene rifiutata anche da
un altro punto di vista: in quanto cioè essa sosteneva che nell'uomo esistano più “forme”,
che cioè le anime intellettiva, sensitiva e vegetativa siano realmente distinte. Seguendo
Aristotele, Tommaso afferma invece che nell'uomo c'è un'unica anima intellettiva, che
assume anche le funzioni delle anime inferiori e dev'essere dunque definita ancora “forma
corporis”.
Infatti, è lo stesso uomo che percepisce di sentire (tramite il corpo) e di pensare (tramite il
solo intelletto). Ciò è un ulteriore segno che solo l'unione di anima e corpo può essere
indicata come “uomo”.
Ma non viene in questo modo negata l'immortalità? Tommaso ritiene di no. La chiave
dell'argomentazione è costituita dal mostrare che l'anima intellettuale, quantunque sia
forma del corpo, è tuttavia un principio incorporeo e sussistente, cioè autonomo. Gli atti
intellettuali infatti manifestano un carattere di universalità che non può essere attribuito ai
sensi corporei, neanche come semplici strumenti: la corporeità impedirebbe infatti,
essendo legata al qui e all'ora, lo svolgimento di una conoscenza universale.
Ora, qualcosa di sussistente può corrompersi solo perdendo la propria forma. Ma l'anima
è forma, ed è impossibile che una cosa si separi da sé. Dunque l'anima è incorruttibile. Ma
c'è anche un argomento più immediato, di sapore agostiniano, tramite il quale si può
indurre l'immortalità dell'anima:
“Un segno di questa cosa può essere preso anche dal fatto che ciascuna cosa
naturalmente desidera essere a suo modo. Ma nelle cose conoscenti il desiderio segue la
conoscenza. Il senso non conosce l'essere se non sotto il qui e l'ora: ma l'intelletto
apprende l'essere assolutamente e secondo ogni tempo. Dunque chiunque ha intelletto
desidera naturalmente essere sempre. Il desiderio naturale non può del resto essere
vano. Dunque ogni sostanza intellettuale è incorruttibile” (Somma teologica I q75a6c).
Il presupposto è ovviamente costituito dalla coerenza e dalla bontà dell'intera natura, che,
in quanto esistente grazie alla partecipazione dell'essere divino e ad esso orientata, non
può mai ispirare un desiderio irrealizzabile.
Sul piano teologico, con un argomento simile si può sostenere la convenienza della
resurrezione finale dei corpi: quantunque infatti -- come si vedrà -- l'anima può giungere di
per sé alla beatitudine, la riunione con il corpo la renderà più perfetta. La dottrina
dell'anima di Tommaso suscitò numerose discussioni presso i contemporanei. In essa
infatti sembravano essere presenti troppe concessioni alla filosofia pagana, che
rendevano problematici perfino elementi essenziali della fede cristiana. Dietro alle
discussioni speculative c'era tuttavia una questione fondamentale di atteggiamento
culturale: in Tommaso la rivendicazione della verità della psicologia aristotelica supponeva
implicitamente una piena valutazione dell'autonomia e della globale bontà dell'essere
umano -- anima e corpo -- che poteva apparire pericolosa per la religione cristiana.
Il tempo avrebbe in realtà dato ragione a Tommaso, e la sua psicologia divenne addirittura
parte dell'insegnamento ufficiale della Chiesa: nel 1312 il Concilio di Vienna addirittura
anatematizzerà chi affermi che “anima rationalis seu intellectiva non sit forma corporis
humani per se et essentialiter” (DS 902). Anche nella morale Tommaso d'Aquino si ispira
da vicino ad Aristotele, tanto che la sua esposizione sembra spesso obbedire solo alla
preoccupazione di mettere maggiore ordine e precisione nella teoria aristotelica.
In realtà, la stessa assunzione dell'etica aristotelica è molto significativa: essa sottolinea,
una volta di più, che il piano puramente naturale -- quello che era stato raggiunto dalla
filosofia pagana -- mantiene una sua autonomia e validità anche all'interno della
prospettiva cristiana.
L'aspetto più interessante della morale di Tommaso consiste allora proprio nel modo in cui
quest'ultima viene integrata all'interno della struttura classica. Il punto di partenza, così
come per Aristotele, consiste nel precisare che l'uomo agisce sempre -- in maniera più
o meno consapevole -- in vista di un fine, e nel cercare quale mai possa essere
questo fine.
Anzitutto bisogna mostrare come tutti i beni naturali, che sono alla portata delle sole forze
dell'uomo, non riescono a soddisfare la sua sete di felicità: né le ricchezza, né gli onori, né
la fama, né il potere, né la perfezione corporale, né il piacere, né la perfezione dell'anima,
né in generale alcun bene creato può costituire la sua felicità ovvero beatitudine:
“La beatitudine infatti è un bene perfetto, che sazia totalmente il desiderio: altrimenti non
sarebbe il fine ultimo, se restasse ancora qualcosa da desiderare. Ma l'oggetto della
volontà, che è il desiderio umano, è il bene universale (così come l'oggetto dell'intelletto è
il vero universale). Da ciò è evidente che nulla può soddisfare la volontà dell'uomo
all'infuori del bene universale. Ed esso non si trova in nulla di creato, ma solo in dio,
perché ogni creatura ha solo una bontà partecipata. Dunque solo dio può soddisfare la
volontà dell'uomo, secondo le parole del Salmo 102,5: “Colui che ricolma di beni il tuo
desiderio”. Dunque, solo in dio consiste la beatitudine dell'uomo” (Somma teologica 2/1,
q2a8c).
Dire che Dio è la beatitudine dell'uomo però non basta. Bisogna precisare più da vicino in
quale modo l'uomo possa conquistare questa felicità ultima:
“La beatitudine ultima e perfetta non può consistere in altro che nella visione dell'essenza
divina. Affinché ciò sia evidente bisogna considerare due cose. In primo luogo, che l'uomo
non è perfettamente beato finché gli resta qualcosa da cercare e desiderare. In secondo
luogo, la perfezione di qualsiasi facoltà è in rapporto al genere del suo oggetto. Ma
l'oggetto dell'intelletto è il che cos'è, cioè l'essenza della cosa. ... Dunque la perfezione
dell'intelletto procede in tanto in quanto esso conosce l'essenza di qualche cosa. Se
dunque un intelletto conosce l'essenza di qualche effetto, tramite la quale non possa
essere conosciuta l'essenza della causa (non si possa cioè sapere che cosa sia la causa),
non si deve dire che l'intelletto abbia raggiunto in senso assoluto la causa, sebbene
tramite l'effetto possa conoscere della causa che essa c'è. E dunque all'uomo rimane
naturalmente il desiderio, quando conosce l'effetto e sa che esso ha una causa, di sapere
anche che cosa sia quella causa. E questo desiderio è la meraviglia, che causa la ricerca,
come viene detto all'inizio della Metafisica. ... Se dunque l'intelletto umano, conoscendo
l'essenza di qualche effetto creato, di dio sa soltanto che c'è, la sua perfezione non
raggiunge ancora in senso assoluto la causa prima, ma gli rimane ancora un desiderio
naturale di cercare la causa. Dunque non è ancora perfettamente beato. Dunque per la
perfezione della beatitudine si richiede che l'intelletto giunga alla stessa essenza della
prima causa” (Somma teologica 2/1, q3a8c).
In questo modo morale e metafisica vengono legate in modo ancora più stretto di
quanto già avveniva in Aristotele.
Se in lui la felicità maggiore veniva individuata -- al termine dell'analisi del comportamento
umano -- nella vita teoretica, che però era realizzabile solo in maniera parziale (è
impossibile per l'uomo passare la vita a contemplare soltanto), in Tommaso la stessa
morale è fin dall'inizio mossa da quella meraviglia che costituisce il primo movente della
ricerca, e dunque orientata ad un fine ultimo di sua natura assoluto e perfetto.
Si realizza allora un curioso contrasto: il fatto stesso che l'uomo possa desiderare il bene
perfetto mostra che egli di fatto lo può raggiungere (altrimenti esisterebbe un desiderio
naturale smentito dalla natura stessa, il che è contraddittorio); ma tuttavia le sue forze
naturali sono palesemente insufficienti a raggiungerlo: ciascuna creatura infatti conosce
“secundum modum substantiae eius”, cioè adattando l'oggetto conosciuto alla propria
natura: ma l'essenza divina eccede infinitamente qualsiasi essenza creata.
Ciò mostra la necessità di ammettere razionalmente la possibilità di altre virtù oltre quelle
intellettuali (dianoetiche) e morali (etiche): quelle teologiche (o teologali), la cui realtà è
testimoniata dalla rivelazione cristiana:
“C'è una duplice beatitudine ovvero felicità dell'uomo. Una proporzionata alla natura
umana, cioè alla quale l'uomo può giungere tramite i princìpi della sua natura. Un'altra è la
beatitudine che eccede la natura dell'uomo, alla quale l'uomo può giungere solo per virtù
divina, secondo una certa partecipazione da parte della divinità, secondo ciò che viene
detto in 2Pt. 1,4, che tramite Cristo siamo diventati partecipi della natura divina. E poiché
una tale beatitudine eccede la proporzione della natura umana, i princìpi naturali
dell'uomo, in base ai quali procede per agire bene secondo la sua proporzione, non
bastano per ordinare l'uomo verso la suddetta beatitudine. Dunque è necessario che
all'uomo vengano aggiunti da parte di dio alcuni princìpi per mezzo dei quali egli venga
ordinato alla beatitudine soprannaturale. ... E tali princìpi vengono detti virtù teologiche: sia
perché hanno dio come oggetto, in quanto tramite esse veniamo rettamente ordinati verso
dio; sia perché solo da dio vengono infuse in noi; sia perché solo tramite la rivelazione
divina, nella Sacra Scrittura, simili virtù vengono tramandate” (Somma teologica 2/1,
q62a1c).
Le virtù teologiche -- così come enumerate da Paolo in 1Cor. 13,13 -- sono fede,
speranza e amore (caritas).
Ciascuna di esse porta a perfezione un aspetto dell'anima razionale in relazione al suo
fine ultimo: la fede perfeziona l'intelletto, la speranza il tendere della volontà al sommo
bene, l'amore il suo conformarsi al fine ultimo.
La loro trattazione è compito della teologia e non più della filosofia, ma ciò non toglie che
anche su di esse è possibile e necessario riflettere in maniera razionale. Notiamo solo due
aspetti interessanti. Il primo consiste nel fatto che le virtù teologiche, a differenza di tutte le
altre (secondo Tommaso anche di quelle intellettuali), non consistono nel “giusto
mezzo”: nei confronti di Dio non possono infatti esistere eccessi, ma anzi vi sono sempre
difetti: nessun uomo -- in quanto creatura finita -- potrà infatti mai amare Dio o credere o
sperare in lui quanto sarebbe giusto.
Il secondo consiste nella preminenza che viene accordata all'amore. Esso è da
giudicare la più grande delle virtù, anzi la loro stessa “forma” (in quanto indirizza tutte le
altre al fine ultimo che è Dio), ed è l'unica ad avere un carattere definitivo: la fede riguarda
infatti ciò che non si vede (dunque scomparirà quando si vedrà l'essenza divina), la
speranza ciò che non si ha (e dunque non avrà più motivo quando si possederà Dio): solo
l'amore conduce in assoluto all'unione con colui che si ama.
Questo mostra anche che solo in un certo senso la meraviglia che motiva la vita morale è
destinata ad essere spenta: nella visione dell'essenza divina infatti la cosa più importante
non è comprendere Dio tramite l'intelletto, ma piuttosto amarlo:
“Le virtù teologiche hanno un oggetto che è al di sopra dell'anima umana. ... Ma in ciò che
è sopra l'uomo l'amore è più nobile della conoscenza. Infatti la conoscenza si realizza nel
fatto che le cose conosciute sono nel conoscente; ma l'amore, nel fatto che l'amante viene
attratto verso la cosa amata” (Somma teologica 2/1, q66a6ad1).
In questo modo il tipico intellettualismo greco, che Tommaso dapprima sembra
condividere, viene corretto sulla base della creaturalità dell'uomo e degli insuperabili limiti
del suo intelletto.
Il primo oggetto del pensiero dell'uomo è l'essere: ma questo nella sua forma più perfetta,
dunque come beatitudine, è destinato a rimanere sempre incomprensibile, chiedendo solo
l'adesione dell'amore.
Il principio della destinazione soprannaturale dell'uomo conferisce importanza centrale ad
un tema che non poteva interessare molto un'etica puramente naturale: il problema cioè
dei criteri di valutazione degli atti umani. Laddove in Aristotele il loro valore veniva
immediatamente attribuito dalla capacità di contribuire ad una felicità naturale, in
Tommaso essi sono tanto buoni quanto rendono l'uomo meritevole di ricevere in dono -dopo il corso della vita terrena -- la visione dell'essenza divina.
In questo modo la felicità naturale non viene però negata, ma piuttosto ordinata alla felicità
completa e infinita cui l'uomo aspira.
È per questo che il criterio fondamentale della moralità delle azioni resta ancora la recta
ratio (corrispondente all'orthós lógos aristotelico): se la ragione è in grado di dirigersi verso
un fine soprannaturale, essa sarà capace anche di ordinare le azioni dell'uomo verso di
esso.
Il problema: il male della volontà
È insomma alla ragione che spetta l'insostituibile compito di dare senso e valore all'intero
campo dei comportamenti autenticamente umani. In questa prospettiva però si crea un
grande problema, che costituirà nelle sue implicazioni tema di interminabili discussioni
nella morale cristiana. Nella sua forma più semplice può essere espresso così: se tutto ciò
che viene fatto volontariamente dall'uomo è scelto sub specie boni, cioè perché in esso
viene visto qualcosa di buono, su quale base si potrà parlare dal punto di vista della
volontà -- l'unica che rende un'azione realmente umana -- di un'azione cattiva?
Ancora più semplicemente: come può esistere un peccato realmente imputabile all'uomo?
Il problema nasce appunto perché viene presupposta l'esistenza di un giudice delle azioni
umane che non guarda solo al loro aspetto materiale, ma piuttosto all'intenzione con la
quale esse vengono compiute.
La risposta di Tommaso (in buona parte ispirata a Pietro Abelardo) è piuttosto articolata.
Anzitutto bisogna distinguere più cause che possono rendere cattiva un'azione umana:
“L'uomo, come anche qualsiasi altra cosa, ha naturalmente desiderio di bene (appetitum
boni). Dunque il fatto che il suo desiderio devii al male accade a causa di una qualche
corruzione o disordine in qualcuno dei princìpi dell'uomo: così infatti si trova l'errore
nell'azione delle cose naturali. Ma i princìpi degli atti umani sono l'intelletto e il desiderio,
sia razionale (che viene chiamato volontà), sia sensitivo. Dunque il peccato negli atti
umani accade sia per difetto d'intelletto, per esempio quando uno pecca per ignoranza; e
per difetto del desiderio sensitivo, come quando uno pecca per passione; così anche per
difetto di volontà, che è un suo disordine” (Somma teologica 2/1, q78a1).
Esaminiamo brevemente i tre casi.
Il primo si verifica quando l'uomo agisce in sèguito ad un'ignoranza volontaria o a cui egli
avrebbe potuto rimediare. Per esempio, nessuno potrà scusarsi dell'adulterio adducendo
la sua ignoranza della legge di natura che proibisce di andare con la moglie di un altro:
perché proprio questa ignoranza è colpevole.
L'unica ignoranza che scusa un'azione in sé cattiva è infatti quella che non è causata da
negligenza né tanto meno intenzionale. Ma che cosa accade se la ragione, senza alcuna
colpa, presenta ad un uomo come buona un'azione che invece in sé è cattiva?
L'uomo ha il dovere di seguirla; se viceversa agisse contro la propria ragione,
commetterebbe peccato, perché sceglierebbe un'azione in quanto cattiva.
Un esempio estremo e paradossale:
“Credere in Cristo per sé è cosa buona e necessaria alla salvezza: ma la volontà non vi si
dirige se non secondo ciò che la ragione propone. Dunque, se dalla ragione ciò fosse
proposto come un male, la volontà vi si dirigerebbe come ad un male: non perché sia in sé
male, ma perché è male per accidente, in seguito all'apprensione della ragione” (Somma
teologica 2/1, q19a5).
In conclusione: l'uomo ha sempre il dovere di agire secondo ragione (o, come anche si
esprime Tommaso, “secondo coscienza”).
Ma, parimenti, ha il dovere di rendere il più corretto possibile il giudizio della ragione.
Il secondo caso succede quando l'uomo, pur conoscendo la legge universale (che è
dettata dalla ragione), si lascia tuttavia sopraffare dalla passione sensibile, che gli
suggerisce un bene che per quanto abbia una sua validità (per esempio il puro piacere), è
tuttavia disordinato per l'uomo, in cui la forma essenziale è costituita dall'intelletto: si tratta
quindi di un bene apparente, e non di un bene reale.
Il terzo caso avviene quando l'uomo coscientemente preferisce un bene subordinato ad
uno sovraordinato: quando per esempio preferisce la ricchezza (che in sé è un bene) alla
vita di un altro uomo (che è un bene immensamente più grande): in questo caso si può
quasi dire che l'uomo scelga coscientemente il male, sebbene sarebbe più corretto dire
che sceglie consapevolmente un bene palesemente minore.
Sostanzialmente originale rispetto ad Aristotele è anche la dettagliata trattazione che
Tommaso offre del concetto di legge, definita come “ordinamento razionale diretto al bene
comune, promulgato da colui che ha la cura della comunità” (“quaedam rationis ordinatio
ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata”, Somma teologica
2/1, q90a4c).
È lo strettissimo nesso con la ragione umana che permette di assumere la legge come
criterio della bontà dei comportamenti. Ma non è certamente la legge umana quella che
interessa di più Tommaso, ma piuttosto quella che, promulgata dal Dio onniprovvidente (o
meglio coincidente con il suo intelletto), tende al massimo bene comune dell'intero
universo: questo è il concetto di lex aeterna.
Nella misura in cui essa viene partecipata all'uomo tramite la ragione, essa va poi
chiamata lex naturalis. Questa tuttavia sarebbe sufficiente solo se l'uomo fosse ordinato
ad un fine puramente naturale: ma dato che la sua destinazione è soprannaturale, è
necessario che egli riceva anche una lex divina positiva, tramite le quale anche la legge
naturale acquisti maggiore certezza ed efficacia.
La legge divina -- la cui trattazione è compito non più della filosofia ma della teologia -- è
quella che la rivelazione ci trasmette nella duplice forma di legge antica e legge nuova
(cioè evangelica), la seconda delle quali perfeziona e adempie pienamente la prima. Ma in
che cosa consiste la legge divina nella sua forma definitiva assunta nel Vangelo? Qui la
risposta di Tommaso è molto originale: la legge nuova non è una legge scritta, non
contiene quindi precetti, ma piuttosto è “la stessa grazia dello Spirito Santo, che viene
data ai credenti in Cristo” (Somma teologica 2/1, q106a1c), che quindi è scritta nel cuore
stesso dell'uomo.
La legge nuova non è così un insieme di norme da rispettare, ma piuttosto la stessa
capacità, donata da Dio all'uomo, di portare a realizzazione l'obiettivo della sua perfetta
umanità e perfetta felicità, nella comunione con lui.
Infatti, “come l'intenzione principale della legge umana è di fare amicizia reciproca tra gli
uomini, così l'intenzione della legge divina è di costituire principalmente l'amicizia
dell'uomo verso Dio” (Somma teologica 2/1, q99a1).
Per questo la legge nuova non è una legge che condanna, ma piuttosto una legge che
iustificat, cioè perdona:
“Alla legge del Vangelo appartengono due aspetti. Uno in maniera principale: cioè la
stessa grazia dello Spirito santo data interiormente. Quanto a ciò, la legge nuova
giustifica. Per questo Agostino dice in De Spiritu et littera, 17: “Là -- cioè nell'Antico
Testamento -- la legge era posta dall'esterno, per spaventare gli ingiusti; qua -- cioè nel
Nuovo Testamento -- è stata data dall'interno, per giustificarli”. Un altro elemento
appartiene alla legge del Vangelo in maniera secondaria: cioè le testimonianze della fede
e i precetti che ordinano gli affetti umani e gli atti umani. E quanto a ciò, la legge nuova
non giustifica. Per questo l'Apostolo dice in 2Cor. 3,6: “La lettera uccide, ma lo Spirito dà
la vita”. E Agostino spiega, in De Spiritu et littera, che con “lettera” s'intende qualsiasi
scrittura che sta fuori dell'uomo, anche quella dei precetti morali quali sono contenuti nel
Vangelo. Dunque anche la lettera del Vangelo ucciderebbe, se non ci fosse dall'interno la
grazia sanante della fede” (Somma teologica 2/1, q106a2c).
Dunque, così come le virtù naturali vengono portate a perfezione e completate da quelle
teologiche, così la legge naturale è assunta e trasfigurata all'interno della libera
autocomunicazione di Dio attraverso quel dono di sé che è lo Spirito.
Lo straordinario successo ottenuto lungo i secoli tanto dalla filosofia quanto dalla teologia
di Tommaso d'Aquino è certamente un segno del loro valore.
La profondità, l'equilibrio, l'armonia tra esigenze razionali ed esigenze di fede condussero
rapidamente alla loro assunzione nell'insegnamento ordinario della Chiesa.
Non va però dimenticato che il pensiero di Tommaso si sviluppa in un contesto culturale
estremamente vivace e ricco, all'interno del quale la sua figura non è affatto quella di un
genio isolato. Bisognerebbe anzi notare che la recezione dei secoli successivi, oltre che
essere legata ad un giudizio sul valore delle tesi di Tommaso, è in gran parte motivata
dalla sua grande sensibilità didattica.
Il testo più letto e studiato diventa la Somma teologica, che si presenta espressamente
come un'opera solo ad eruditionem incipientium, “per la formazione dei principianti”.
Bisogna però rammaricarsi che spesso lo spirito del pensiero di Tommaso sia stato
frainteso e dimenticato: la ricerca instancabile ed equilibrata di nuove soluzioni,
rigorosamente confrontate usando tutti gli strumenti razionali e le più aggiornate premesse
filosofiche, divenne così o una disquisizione puramente verbale su questioni pressoché
impalpabili (che susciterà la rivolta del Rinascimento), oppure una stanca e arida
ripetizione di tesi (che nella Chiesa cattolica sarà travolta dal rinnovamento ispirato
dall'ultimo Concilio ecumenico). La riflessione e la valutazione della filosofia di Tommaso è
così ancora oggi un compito in gran parte da svolgere.
Tomismo http://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_d%27Aquino
Il suo pensiero filosofico, da molti considerato il più significativo dell'età medievale,
viene definito Tomismo.
Il metodo della metafisica
La metafisica studia la realtà tutta secondo l'orizzonte più ampio possibile e non si
occupa delle singole determinazioni del reale, che sono oggetto delle scienze
particolari, ma la studia in quanto tale.
«La scienza filosofica riguarda l'ente in quanto ente, cioè considera l'ente dal punto di
vista della ratio universale di ente, e non dal punto di vista della ratio specifica di qualche
ente particolare.» (In Met. XI, l.3 n.1)
La realtà colta nella sua assolutezza ci rivela la sua struttura e i suoi principi che
sono così evidenti da abbagliarci, tanto che se è impossibile coglierne in modo
completo la verità, è altrettanto impossibile non coglierla in modo assoluto.
«Come gli occhi della nottola sono abbagliati dalla luce del sole che non riescono a
vedere, ma vedono bene le cose poco illuminate, così si comporta l'intelletto umano di
fronte ai primi principi, che sono tra tutte le cose, per natura, le più manifeste. » (In Met. II,
l.1 n.10)
Ecco perché lo studio della metafisica è facile e difficile allo stesso tempo. Facile
perché i principi di cui tratta sono ovvi e di per sé noti a tutti tanto da essere impliciti
in ogni discorso umano. Difficile perché, per quanto siano ovvi, questi principi non
sono banali e non li si coglie mai in tutta la loro profondità. « ...la nostra conoscenza
è talmente debole che nessun filosofo ha mai potuto investigare in modo esaustivo la
natura di una singola mosca... » (In Symbolum, proemium)
I principi della metafisica
La verità dei principi non si afferma da sola, ed è sempre colta in modo umano,
ossia imperfetto; per questo al filosofo è chiesta un'umile disposizione d'animo per
accoglierla. Per cogliere questa verità nascosta non si può partire da principi,
perché sono proprio quelli che si stanno indagando, ma si deve fare un'analisi
fenomenologica della realtà e dell'esperienza dell'uomo per far venire a galla il non
detto del detto, ossia ciò che necessariamente si deve ammettere, anche solo
implicitamente, perché quello che si dice sia un dire sensato.
Così come un illetterato può parlare correttamente la sua lingua pur non
conoscendo le regole della grammatica, e solo studiando la sintassi si rende conto
delle regole che ordinano il suo parlare; regole che peraltro anche ignorandole
venivano da lui usate anche prima di conoscerle. Così tutti gli uomini nel loro
pensiero e nel loro parlare usano correttamente i principi della metafisica, almeno
implicitamente, e il compito del filosofo è condurre alla luce della ragione questi
principi.
La grande forza della filosofia aristotelico - tomista è mettere in evidenza quei
principi così innati nella ragione che, essendo verissimi, è persino impossibile
pensare di negarli, perché nel momento in cui li si nega ne si fa surrettizio uso, e
quindi li si riafferma. «I principi innati nella ragione si dimostrano verissimi: al punto che
non è neppure possibile pensare che siano falsi.» (Contra Gentiles I, c.7 n.2)
Il metodo elenchico
È da questa osservazione che nasce il famoso metodo confutativo (o elenchico),
che confronta diverse tesi poste nell'agone della dialettica per scartare quelle che si
mostrano contraddittorie, o quelle che risultano estranee all'esperienza.
I percorsi per invalidare una tesi metafisica sono, infatti, due: nel primo si mostra
l'intrinseca contraddittorietà di quegli assunti che implicano la negazione e
l'affermazione della stessa cosa nel medesimo tempo e sotto il medesimo aspetto;
nel secondo si evidenzia l'insostenibilità di tesi che non hanno riscontro
nell'esperienza comune e che quindi, non rientrando nell'indagine razionale, sono
catalogabili come opinione o fede.
Il metodo confutativo procede per negazioni: scartando le dottrine contraddittorie e
insostenibili fa emergere, come una statua da un blocco di marmo, la verità, e
perché la figura che viene mano a mano emergendo sia ben definita, bisogna
ricercare tutte le tesi possibili per vagliarle e ottenere, per negazione, una verità
sempre più profonda.
In questa incessante ricerca non esiste un oggetto d'indagine perché chi ricerca si
ritrova a studiare anche se stesso, il suo pensiero e il suo linguaggio. È più corretto
dire allora che la metafisica abbia un tema, un tema che è come un orizzonte unico
e ampio fino a comprendere tutto, la realtà e chi la indaga.
In proposito è bene ricordare che non è possibile separare acriticamente l'oggetto
dal soggetto conoscente giacché: «uno e identico è l'atto del sentito e del senziente,»
(De Anima III, l.2 n.9)
per cui l'oggettività della cosa conosciuta, l'oggettività dell'oggetto, si risolve tutta
nell'essere conosciuto, ossia nell'esser presente, mentre la soggettività del
soggetto si risolve tutta nella presenza dell'oggetto. Soggetto e oggetto sono due
concetti distinti ma non separabili, in quanto l'uno è tale grazie alla presenza
dell'altro.
L'essere, il pensiero e il linguaggio
L'essere, il pensiero e il linguaggio sono i poli del tema della metafisica, sono
diversi modi di un'unica realtà, e questo non perché si stabilisce arbitrariamente
che il pensiero dell'uomo sia rivelatore della realtà, bensì perché non è possibile
che sia altrimenti. Il pensiero è sempre pensiero dell'essere, e l'essere è sempre
colto nel pensiero. Ipotizzare una dimensione alternativa, come per esempio
l'esistenza di una realtà che fugga di per sé la nostra conoscenza, è agli occhi del
filosofo una tesi acritica e insostenibile in sede filosofica, essa può al massimo
essere considerata come opinione o fede. « Se invero uno propone ad un altro cose
che non sono incluse nei principi per sé noti, o che non appaiono chiaramente incluse,
non produrrà in lui sapere, ma forse opinione o fede» (De Veritate, q.11 a.1 - co)
L'unità intenzionale di essere e pensiero è l'esperienza stessa, intesa come
insieme di conoscenze, sentimenti, cultura, vita e storia. L'esperienza è per questo
un tema onnicomprensivo, circoscrivente e non circoscritto, tale da escludere
assolutamente che ci si possa porre al di fuori di essa.
Nello studio della metafisica non esiste un inizio privilegiato, proprio perché essa
non ha un oggetto isolato di indagine, ma un tema (e come tale non è possibile
vederlo dal di fuori), non è possibile partire da principi e dedurre conclusioni, come
si usa invece fare con le scienze esatte. Ogni esperienza non ci si presenta mai in
modo di per sé concluso, ma la si coglie solo nel suo riferimento organico con tutte
le altre esperienze.
L'identità di una singola cosa la si vede nella differenza dalle altre, e la differenza
tra le cose la si vede nell'identità dei singoli; identità e differenza si intendono solo
dialetticamente e si semantizzano reciprocamente (In Met. X, l.4 nn.33-34). Tutte le
singole cose si relazionano a tutto, ogni entità viene intesa nella relazione con tutte
le altre, e all'uomo non è possibile esaurire la verità su di una cosa, perché questa
coinvolge il tutto. Se, per esempio, volessimo capire tutta la verità della Divina
Commedia, non potremo esimerci dallo studiare l'autore e il suo pensiero, e così
ancora dovremo studiare il suo tempo e la mentalità della sua gente. Quindi si
dovrebbe recuperare tutta la storia precedente per capire come è potuto nascere
un tale poeta, e la storia successiva per vedere come ha influenzato la società, e
così ogni nuovo elemento ne richiede un altro, in una continua correlazione.
Un sistema filosofico
Ma quando anche fossimo riusciti ad esaurire tutte le possibili relazioni della realtà,
cosa impossibile vista la nostra finitezza, e fossimo in grado di costruire un enorme
e straordinario puzzle dove ogni pezzo si incastra perfettamente con gli altri, e
l'insieme ci si rivelasse come un grandioso disegno di cui allora capiremmo, forse, il
senso, avremo allora finito le nostre domande? Potremmo dichiarare chiuso il
problema della filosofia? Assolutamente no. Perché quand'anche potessimo vedere
l'insieme del puzzle, che ripeto è cosa ineseguibile essendo noi stessi una tessera
di quel puzzle, avremo risposto a tutte le domande del come, ma rimarrebbero
insolute quelle del perché. Perché questo disegno e non un altro? Perché questa
realtà e non un'altra? Cosa giustifica questa realtà, cosa le dà ragione di essere se
non può darsela da sola in modo esaustivo?
Queste domande arrivano per ultime nell'indagine filosofica, ma sono di per sé le
prime, in quanto riguardano il fondamento stesso della realtà. Dallo studio della
realtà (in senso generico, la fisica), si arriva allo studio del suo fondamento che sta
oltre la realtà: la metafisica. Per condurre un discorso metafisico si può partire da
qualunque esperienza, ma se vogliamo insegnare la metafisica a qualcuno
dovremo partire da esperienze che il discente possa personalmente verificare.
Come già visto la conoscenza dei principi è naturalmente insita nell'uomo, e ogni
nuovo apprendimento viene allora da una conoscenza già acquisita anche se non
pienamente in atto. « I primi concetti dell'intelletto preesistono in noi come semi di
scienza, questi sono conosciuti immediatamente dalla luce dell'intelletto agente
dall'astrazione delle specie sensibili...in questi principi universali sono compresi, come
germi di ragione, tutte le successive cognizioni. » (De Veritate, q.11 a.1 - co)
Uno dei migliori inizi per il discorso metafisico è quello che descrive un'esperienza
accessibile e verificabile a tutti: il processo di conoscenza e la sua espressione nel
linguaggio. Non ci si aspetti però un discorso che parte da principi e giunge a
conclusioni, questo è il metodo delle scienze particolari, il filosofo deve invece
partire nell'esposizione da esperienze facilmente verificabili per introdurre una
visione d'insieme della realtà che non può essere dedotta ma intuita. Colui che
ascolta, se vuole capire, deve inizialmente accettare come valide alcune categorie
di pensiero e alcune dimostrazioni, anche se la giustificazione è data in un secondo
tempo. Questo perché è più importante intendere, intuendo, l'insieme del discorso
che capire ogni singola dimostrazione, la quale dipende per la sua comprensione
proprio dall'intero del sistema.
Lo sviluppo del sistema filosofico è sempre più dettagliato grazie all'esplorazione
sempre più profonda della realtà, e tutti i discorsi in questo sistema si legano tra
loro con un'infinita serie di relazioni, quindi si può sostenere che la validità del
sistema è che sia rispondente all'esperienza e che tutto si tenga, ossia che non si
contraddica internamente.
Le cinque vie di Tommaso e la metafisica
Tommaso propone dunque 5 vie per dimostrare l'esistenza di Dio. Per rendere
valide le argomentazioni, Tommaso ricorre (in ordine) alle categorie aristoteliche di
"potenza" e di "atto", alla nozione di "essere necessario" e di "essere contingente"
(desunta da Avicenna), ai gradi di perfezione (di stampo platonico) e alla presenza
di finalità negli esseri privi di conoscenza.
▪ Prima via: "Ex motu": « [...] tutto ciò che si muove è mosso da un altro. [...] Perché
muovere significa trarre qualcosa dalla potenza all'atto; e niente può essere ridotto
dalla potenza all'atto se non mediante un essere che è già in atto. [...] È dunque
impossibile che sotto il medesimo aspetto, una cosa sia al tempo stesso movente e
mossa, cioè che muova sé stessa. [...] Ora, non si può procedere all'infinito, perché
altrimenti non vi sarebbe un primo motore, e di conseguenza nessun altro motore,
perché i motori intermedi non muovono se non in quanto sono mossi dal primo
motore [...]. Dunque è necessario arrivare ad un primo motore che non sia mosso
da altri; e tutti riconoscono che esso è Dio. »
▪ Seconda via: "Ex causa": « [...] in tutte le cause efficienti concatenate la prima è
causa dell'intermedia e l'intermedia è causa dell'ultima [...] ora, eliminata la causa è
tolto anche l'effetto: se dunque nell'ordine delle cause efficienti non vi fosse una
prima causa, non vi sarebbe neanche l'ultima, né l'intermedia. Ma procedere
all'infinito nelle cause efficienti equivale ad eliminare la prima causa efficiente [...].
Dunque bisogna ammettere una prima causa efficiente, che tutti chiamano Dio.
»
▪ Terza via: "Ex contingentia": « [...] alcune cose nascono e finiscono, il che vuol dire
che possono essere e non essere. Ora, è impossibile che cose di tal natura siano
sempre state [...]. Se dunque tutte le cose [...] possono non esistere, in un dato
momento niente ci fu nella realtà. Ma se questo è vero, anche ora non esisterebbe
niente, perché ciò che non esiste, non comincia ad esistere se non per qualcosa
che è. [...] Dunque, non tutti gli esseri sono contingenti, ma bisogna che nella realtà
vi sia qualche cosa di necessario. [...] negli enti necessari che hanno altrove la
causa della loro necessità, non si può procedere all'infinito [...]. Dunque, bisogna
concludere all'esistenza di un essere che sia di per sé necessario, e non tragga da
altri la propria necessità, ma sia causa di necessità agli altri. E questo tutti dicono
Dio. »
▪ Quarta via: "Ex gradu perfectionis": « [...] il grado maggiore o minore si attribuisce
alle diverse cose secondo che si accostano di più o di meno ad alcunché di sommo
e di assoluto; [...] come dice Aristotele, ciò che è massimo in quanto è vero, è tale
anche in quanto ente. Ora, ciò che è massimo in un dato genere, è causa di tutti gli
appartenenti a quel genere [...]. Dunque vi è qualche cosa che per tutti gli enti è
causa dell'essere, della bontà e di qualsiasi perfezione. E questo chiamiamo Dio.
»
▪ Quinta via: "Ex fine": « [...] alcune cose, le quali sono prive di conoscenza, cioè i corpi
fisici, operano per un fine [...]. Ora, ciò che è privo d'intelligenza non tende al fine se
non perché è diretto da un essere conoscitivo ed intelligente, come la freccia
dell'arciere. Vi è dunque un qualche essere intelligente, dal quale tutte le cose
naturali sono ordinate a un fine: e quest'essere chiamiamo Dio. » (Tommaso d'Aquino.
Summa theologiae, I, questione 2, articolo 3)
Tommaso fornisce queste 5 prove dell'esistenza di Dio al culmine della metafisica,
la disciplina nata nell'antichità con l'intento di partire dalla "physis" (natura) per
raggiungere induttivamente e per caratterizzare il mondo immateriale ed invisibile.
Forte è l'interesse di Tommaso per il mondo dei fenomeni e per le scienze
(notiamo, che ebbe anche fama di alchimista di valore: secondo alcuni, avrebbe
potuto disporre, grazie al maestro Alberto Magno, della pietra filosofale, ma si tratta
di un accertato falso storico).
Però, ci avverte di non dare mai per assolutamente certe le teorie scientifiche,
perché può sempre accadere che gli uomini pensino a qualche nuova teoria, da
nessuno elaborata prima. Si noterà, qui, la fiducia critica nella ragione umana, che
contraddistingue l'Aquinate: libertà di indagine, ma cautela nelle conclusioni.
Aristotele era giunto a concepire l'essere come pensiero di pensiero; essere che si
pone pensando sé stesso, superando il politeismo antico verso un monoteismo più
vicino al nostro. Tommaso inizia una trattazione teologica dell'essere, ritenendo
questo compito un'opera che la ragione non può assolvere compiutamente. Si apre
qui lo spazio per l'esame di quanto la fede ci propone, come sussidio ed
integrazione del lavoro puramente razionale: Tommaso pensa che, in linea di
principio, ragione e fede, provenienti entrambe da Dio, non possano mai essere in
contrasto tra loro.
Le cinque vie di san Tommaso costituiscono tuttora per la Chiesa Cattolica e per
altri laici un argomento valido e incontestato per giungere alla conoscenza di Dio.
Immanuel Kant argomentò che le cinque vie di san Tommaso sarebbero
riconducibili alla prova ontologica di sant'Anselmo d'Aosta, prova di cui lo stesso
Kant avanzò una confutazione, sebbene anche Tommaso l'avesse già a sua volta
contestata: per Tommaso infatti la dimostrazione esclusivamente a priori di
Anselmo non sarebbe valida, perché l'uomo nelle sue conoscenze procede anche
a posteriori.
Sono note tra l'altro varie refutazioni all'argomento di Kant (che comunque non si
occupò mai delle cinque vie: egli non le conosceva direttamente ma solo tramite le
argomentazioni della tarda scolastica filtrate attraverso Wolff).
La Trinità ed i misteri della fede
Il Dio cristiano è "Uno e Trino", ossia Dio è la comunione delle tre Persone
nell'unica natura divina (Padre, Figlio e Spirito Santo). Tommaso nota come il
Padre esca continuamente fuori di sé in estasi, in un'incontenibile esplosione di
amore, rendendo il Figlio partecipe di tutto ciò che Dio ha creato; lo Spirito Santo è
la relazione di amore che lega il Padre al Figlio. Come l'Uno ineffabile di Plotino
(Neoplatonismo), il Padre uscendo fuori di sé diventa Uno-che-è, l'essere di
pensiero che non avendo il bene fuori di se (l'Uno è ineffabile e nemmeno l'essere
può vederlo o parlarne) pensa se stesso, divenendo pensiero di essere e infine
(come diceva Aristotele) pensiero di pensiero. Queste operazioni avvengono
nell'eterno, dove non esiste tempo, dove non è differenza fra il prima e il poi, e
perciò non si deve confondere una priorità logico - ontologica con una temporale.
L'essere e gli enti
La proprietà dell'essere è l'identità di unità-verità-bontà. Da ciò deriva che vi sono
due cose che nemmeno Dio può fare: Dio non può fare il male (è buono) e non può
creare un altro Dio (è uno, ergo non possono esservene due). Importante è anche
che Dio non può mentire perché è vero (verità): a questo argomento ricorrerà
Cartesio con i suoi studi scolastici per dimostrare che il mondo davanti a noi è reale
e non un'illusione, in quanto creazione di un Dio che è verità e non può illuderci o
mentirci.
Gli enti creati (fra cui l'uomo) sono in qualche modo lontani dall'essere
con infiniti gradi di perfezione (partendo dal più basso), non solo "sono meno" nelle
singole attribuzioni, ma con infinite gradazioni viene anche a mancare la relazione
d'identità esatta fra verità, bontà, unità. Ci sono persone veramente malvagie,
unitamente (senza incoerenze interne) buone, ma non vere, ma per opportunismi,
etc.
Causalità e Creazione
Se due enti hanno qualcosa in comune, esiste allora un ente che è loro causa.
L'ente-causa ha poco o nulla in comune con gli altri due enti che si ritengono un
suo effetto. In essi causa-effetto non sono costruiti considerando un solo effetto e
una sola causa (fra due enti), ma fra tre: due "enti-effetto" e un terzo "ente-causa".
La ragione procede così a costruire non delle semplici catene causa-effetto, ma un
albero ramificato in cui ogni nodo è causa dei due enti sottostanti, suoi effetti. La
causa non è un ente completamente distinto dai suoi effetti, con gli effetti e fra loro
anche la causa ha qualcosa in comune con i due effetti: due enti qualunque (anche
di coordinate temporali e/o spaziali diverse), anche se non hanno niente in comune,
hanno quanto meno in comune di essere nella stessa dimensione spaziale e
temporale. In particolare, anche due enti di spazi ed epoche diverse a cui pensa un
essere cosciente sono, comunque, nello stesso spazio-tempo, sebbene solo nella
sua mente; quando nessuno li pensa, non sono proprio. Intuitivamente, se un ente
è uguale a quello visibile, un istante dopo si pensa che si tratta dello stesso ente;
quanto maggiore è la diversità tanto più è ipotizzabile che quello che si manifesta
per primo sia la causa di quello successivo. La causa non è più definita dal
precedere sempre un dato ente: diciamo che "A" causa l'ente "B", se prima di "B"
vediamo sempre manifestarsi "A"; si aggiunge una seconda condizione per definire
un ente come causa, che esso non ha poco o nulla in comune con gli altri due; e
un'altra che si potrebbe raggruppare con la precedente, nota come pensavano la
"causa" gli antichi Greci, che la causa si da se due enti hanno qualcosa in comune
(la causa è di due effetti). Un ente è causa d'altri quanto meno ha in comune con gli
effetti. Poiché l'essere è comune a tutti gli enti, non esiste un ente che sia causa
dell'essere; la domanda "perché?" dell'essere non può avere risposta, ossia non si
può dire perché il mondo è così e non altrimenti.
Essendo l'essere comune a tutti gli enti, esso se deriva da qualcosa, non può che
derivare da un non-ente, ovvero dal nulla (che da Platone in poi è stato inteso in
senso relativo anche dai filosofi che storicamente non poterono accedere ai suoi
scritti). L'alternativa, come pensava Aristotele, è ipotizzare che l'essere non abbia
proprio una causa e che il mondo esista da sempre.
Tommaso sostiene l'idea della Creazione per un motivo di fede (il racconto della
Genesi), ma anche per un motivo filosofico che è una prova a sostegno del dato di
fede ed una forte convinzione personale: l'esistenza delle cause seconde. Causaeffetto sono sinonimi di potenza-atto; parlare di cause seconde significa articolare
la distinzione aristotelica di potenza ed atto in potenza di una potenza, potenza di
un atto, atto di una potenza, atto di un atto. La potenza, come la definiva Aristotele,
sarebbe potenza di un atto; quello che era chiamato "atto" è con maggior
precisione "atto di una potenza". La prima e l'ultima di queste, sono categorie
ignorate dalla filosofia antica; Tommaso estende la nozione di potenza ed atto in
una che include le due categorie aristoteliche e va oltre (aggiungendone altre due);
propriamente non si dovrebbero più usare le parole "potenza" ed "atto", ma una
delle 4 categorie proposte. Il passaggio non è un vuoto cambio di parole, ma
introduce due concetti che sono sostanzialmente diversi da quelli di potenza ed atto
aristotelici.
La Creazione è avvenuta una sola volta; soltanto Dio può creare; Dio può agire nel
mondo soltanto creando; ovvero il Creato non è dato una volta per tutte, ma la
Creazione è continua, nel senso che in alcuni momenti (non in ogni causa-effetto),
Dio vi interviene creando.
In particolare, lo stato che precede la Creazione è potenza di potenza, non potenza
come la definiva Aristotele; in tale modo, col poter essere, è definibile una potenza
che non è materia, e che può essere informe, essendo la materia indissolubilmente
legata alla forma per Aristotele come per Tommaso.
Potenza di potenza e atto di un atto sono due modi di essere, due stati, in cui atto e
potenza (forma e materia) non sono legati indissolubilmente. Entrambi dipendono
dal fatto che potenza e atto possano esistere separatamente, e uno implica quindi
l'altro. Il primo afferma la possibilità del mondo di evolversi, e il secondo l'esistenza
di Dio come Atto puro.
Da notare è che il concetto di causa seconda che fonda l'idea di un mondo che
evolve in modo indipendente (e libero, nel caso dell'uomo) dalla causa prima che è
Dio, è lo stesso che fonda la potenza di potenza e la dipendenza del mondo da un
Dio Creatore.
L'antropologia di san Tommaso
L’antropologia tomista nasce dall’esigenza di conciliare la dottrina PlatonicoAgostiniana dell’immortalità dell’anima e di per sé sussistente, e la concezione
aristotelica, che spiegava bene il sinolon di anima e corpo, ma, vista secondo
errate interpretazioni, poteva portare ad affermare la mortalità dell’anima. Averroè
aveva provato a superare questa difficoltà affermando che l’anima non è la forma
razionale del corpo, perché l’intelletto, sia passivo che attivo trascende il corpo ed è
universale, unico per tutti gli uomini. In questo modo salvaguardava l’immortalità
dell’anima, ma finiva per annullare l’individualità dell’anima del singolo, e tale
interpretazione era contraria alla Bibbia, secondo la quale dopo il giudizio
universale ogni anima si ricongiungerà col proprio corpo. Tommaso risponde
affermando che: se la forma è il principio che caratterizza la natura di un ente, e
quindi anche nelle sue specifiche facoltà, e se l’uomo è caratterizzato dal suo
essere razionale e dalla sua facoltà intellettiva, necessariamente la sua forma deve
essere un principio intellettivo. L’anima è fortemente legata e relazionata al corpo
(e questo è dimostrato dal fatto che è lo stesso uomo quello che coglie i principi
primi, le realtà intelligibili, e contemporaneamente avverte i più bassi appetiti
sensoriali), ma possiede un’esistenza autonoma e indipendente dal corpo. A
dimostrazione di questa duplice esistenza dell’anima (una legata al corpo, l’altra da
esso indipendente) Tommaso porta tre fatti: la reale constatazione del fatto che
l’anima conosce tutti i corpi (ciò non avverrebbe se fosse un ente reale e corporeo),
la capacità di cogliere realtà immateriali o concetti universali, e la capacità di
configurarsi come autocoscienza. L’immortalità dell’anima è dimostrata dal fatto
che essa è caratterizzata dal desiderio di vita, e pertanto ogni desiderio presente
sulla terra vi è stato posto da Dio, ed Egli non ha creato nessun desiderio che non
possa essere soddisfatto. Pertanto anche la “sete” di vita dell’anima deve essere
per forza soddisfatta. In questo modo, inoltre, conserva l’individualità della vita
dopo la morte.
Ogni ente che si muove è mosso da altro, e nella natura non si ha un moto senza
fine; al contrario, anche in fisica ogni movimento è descritto da un vettore che ha
intensità, direzione e verso e dunque pare avere un qualche fine. Anche le
traiettorie di comete ed astri, pur essendo ellittiche (senza verso, o meglio con una
sua inversione periodica), mantengono una direzione calcolabile e avranno una fine
del loro movimento (prima o poi si scaglieranno contro qualche corpo dell'universo).
Anche alla luce di scoperte astronomiche posteriori a Tommaso si è confermata
l'impossibilità teorica e pratica del moto perpetuo.
Il fine è per l'uomo qualcosa di unico (l'uomo tende a porsi un solo obiettivo per
volta) e di vero, almeno in potenza, e completamente vero quando sarà atto
raggiunto (poiché la ragione non ha senso che si dia obiettivi velleitari e non
raggiungibili). Dall'identità ampiamente dimostrata di uno, vero e buono, segue che
il fine che è unico e vero (in quanto raggiungibile) è anche il bene dell'uomo.
Dunque, darsi degli obiettivi è una regola etica; il problema del contenuto si limita
alla scelta di obiettivi raggiungibili che siano veri. I mezzi che ogni io impiega per
raggiungere questo fine sono proporzionali a tale obiettivo e dunque l'"io" è un
essere proporzionato al suo bene: il bene è il fine che cerca di raggiungere e, l'"io"
è in quanto agisce. L'"io" è un agire (come più tardi diranno gli idealisti) ed è in vita
solo mentre agisce e si muove per qualche cosa; Dio, come il nostro Io che è a sua
immagine e somiglianza, è un agire. Senza la Provvidenza diviene inconcepibile
l'esistenza stessa di Dio. Per una sorta di unità dei contrari, l'identità di unità, verità
e bontà, che fondano le 5 vie per dimostrare l'esistenza di un Dio trascendente,
coimplica anche la continua azione di questo Dio nel mondo e nella vita di ogni Io.
Nell'atto creativo la divinità è passata da uno stato di non-mosso e non-movente ad
uno stato di movente non-mosso. Nel Creato vale che "omne quod movetur ab alio
movetur" ed ogni ente è in uno stato di "mosso" (mosso non-movente o mossomovente).
Per Tommaso questo movimento non può essere eterno e tende ad uno stato di
non-mosso che, a seconda del grado di unità, verità e bontà della creatura, sarà
uno stato di non-mosso e non-movente (fine di ogni movimento) oppure il ritorno
alla causa prima del movimento nello stato di movente non-mosso, ossia una
creatura fuori dallo spazio-tempo, fisicamente non più in grado di muoversi, ma
comunque libera di muovere parte del mondo.
Questo movimento non è un vagare senza senso eterno, con una fine qualunque,
ma ha una fine determinata (non infinite possibili) che, essendo unica, è anche il
suo fine. Dunque, la fine è il fine.
Etica
per approfondire http://it.wikipedia.org/wiki/Il_male_(Tommaso_d%27Aquino)
La natura dell'uomo
Per Tommaso l'etica non è il pieno raggiungimento del fine ultimo dell'uomo, ma è
solo un orientamento per la condotta umana che ha lo scopo di indirizzare l'uomo al
suo proprio fine. Tale fine ultimo, come per Aristotele, è la felicità, cioè la
beatitudine. Per Aristotele il bene era ciò che perfezionava l'uomo e portava a
compimento la sua natura, ma Tommaso va oltre, e dice che è il sommo bene che
realizza davvero e al massimo grado la natura umana. Poiché il carattere specifico
dell'uomo è la ragione, allora, per Tommaso, l'unica "azione" possibile per
raggiungere la beatitudine è di genere intellettuale; tuttavia, al contrario di
Aristotele, che poneva l'uomo stesso come oggetto di tale contemplazione
intellettuale, Tommaso pone invece Dio come oggetto primo ed ultimo della
contemplazione. La beatitudine, per Tommaso, è infatti la visione dell'essenza di
Dio, che è nient'altro che l'operazione più nobile e più alta dell'uomo. In ogni uomo,
infatti, vi è naturale desiderio di conoscenza, poiché ciascuno, vedendo un effetto,
vuole conoscerne la causa; questo vale per le cose superficiali e terrene, e tanto
più vale per le cose spirituali e divine. Se l'uomo non si sforza di soddisfare tale
desiderio andando oltre il mondo fisico, rimarrà in eterno insoddisfatto; tale,
dunque, sarebbe la vera condanna eterna, cioè l'esser privati della visione di Dio.
Il libero arbitrio e la morale
L'etica di Tommaso si fonda sulla libertà dell'uomo, poiché, come egli dice, solo
l'uomo possiede il libero arbitrio, inteso nel senso originale di "libertà di giudizio", in
quanto solo l'uomo è padrone del giudizio, in quanto egli solo può giudicare
attraverso la ragione il suo stesso giudizio. Inoltre, il libero arbitrio, per Tommaso,
non è affatto in contrasto con la Provvidenza divina che ordina le vicende del
mondo, perché essa è al di sopra d'ogni giudizio e libertà umana, e nel Suo agire
già ne tiene conto; il libero arbitrio non è in contraddizione nemmeno con la
predestinazione alla salvezza, per Tommaso, poiché la libertà umana e l'azione
divina di Grazia (che è la conseguenza della predestinazione) tendono ad unico
fine, ed hanno una medesima causa, cioè Dio. Per quanto riguarda la morale,
Tommaso, come Bonaventura da Bagnoregio, dice che l'uomo ha sinderesi, ovvero
la naturale disposizione e tendenza al bene e alla conoscenza di tale bene.
Tuttavia, egli necessita di opportuni mezzi, per valutare ogni caso di
comportamento che gli si presenti. Tali mezzi sono:
1.La coscienza, intesa come capacità di ragionamento pratico e dunque di
applicazione dei principi morali universali alle situazioni concrete particolari;
2.La prudenza, cioè la virtù pratica che consente di valutare rettamente in ogni
caso particolare;
3.La volontà, che è il mezzo per decidere se tendere ad un bene per sé stesso,
oppure per tendere ad un altro comportamento, moralmente sbagliato;
4.La virtù, ovvero l'agire secondo natura e secondo ragione. Tuttavia, la virtù è un
"habitus", un abito consolidato nella natura.
Tommaso riprende da Aristotele le quattro virtù cardinali (ovvero giustizia,
temperanza, prudenza e fortezza) ma introduce, in più, le tre virtù teologali cristiane
(fede, speranza e carità), che occorrono al conseguimento della beatitudine eterna.
Liceità della pena di morte
Sant'Agostino e san Tommaso d'Aquino sostengono la liceità della pena di morte
sulla base del concetto della conservazione del bene comune. L'argomentazione di
Tommaso d'Aquino è la seguente: come è lecito, anzi doveroso, estirpare un
membro malato per salvare tutto il corpo, così quando una persona è divenuta un
pericolo per la comunità o è causa di corruzione degli altri, essa viene eliminata per
garantire la salvezza della comunità (Summa Theologiae II-II, q. 29, artt. 37-42). Il
teologo sosteneva tuttavia che la pena andasse inflitta solo al colpevole di
gravissimi delitti, mentre all'epoca veniva utilizzata con facilità e grande
discrezionalità.
La posizione sulla donna
Nella Summa Theologiae scrive:
« dicitur Gen. II, non est bonum hominem esse solum; faciamus ei adiutorium simile
sibi. » ( Iª q. 92 a. 1 co)
« Il Signore ha creato l'uomo, poi ha voluto creare la donna per dargli un aiuto simile a lui.
[...] »
Questo è nient'altro che è una riesposizione del testo biblico. Ma poi Tommaso
prosegue dicendo che: «...necessarium fuit feminam fieri, sicut Scriptura dicit, in
adiutorium viri, non quidem in adiutorium alicuius alterius operis, ut quidam dixerunt, cum
ad quodlibet aliud opus convenientius iuvari possit vir per alium virum quam per muliebre
m; sed in adiutorium generationis.» (Iª q. 92 a. 1 ad 1)
Si tratta qui di altri autori della Scolastica, cosa che indica dunque la presenza,
all'epoca, di un dibattito sul tema della sessualità. Per Tommaso, dunque, la donna
non avrebbe doveri pari a quelli degli uomini, ma il suo unico dovere sarebbe la
generazione, cosa che nessun uomo potrebbe fare.
Il testo prosegue poi con una breve esposizione della differenza tra riproduzione
asessuata e riproduzione sessuale, per chiarire il punto di vista: evidentemente,
quello biologico. Tommaso, tuttavia, mantiene il legame con la tradizione del
pensiero cristiano medioevale del secolo precedente (definito da alcuni storici il
"secolo delle donne"), senza lasciarsi totalmente trascinare dal richiamo ai
pregiudizi del mondo antico.
Pertanto, scrive anche:
«Ad tertium dicendum quod, si omnia ex quibus homo sumpsit occasionem peccandi,
Deus subtraxisset a mundo, remansisset universum imperfectum.» (Iª q. 92 a. 1 ad 3)
Dalla teologia di Tommaso, attenta ai fenomeni naturali, la Chiesa deriva dunque la
concezione della sessualità come complementarità soprattutto spirituale (in ogni
caso antropologica), oltre che biologica, dove la donna non è solo un mezzo
necessario per la generazione (che tale sarebbe la sua funzione biologica), ma è
anche la parte mancante senza la quale l'uomo sarebbe monco, e lo stesso
mondo, inteso come ordine, sarebbe incompleto, cioè privo di ordine. Per
Tommaso, in sostanza, a livello biologico la donna è inferiore all'uomo, ma in ogni
livello (compreso quello biologico) è l'armonico che completa la disarmonia (cioè
l'uomo).
La legge e la politica
Tommaso studiò a fondo il diritto e la giustizia, considerandoli i pilastri della società
e differenziandone le fonti. Infatti, la prima fonte della giustizia, per Tommaso, è la
ragione divina, insondabile e inconoscibile per l'intelletto umano, e che pure
dev'essere accettata dagli uomini con umiltà. Tale giustizia concerne la legge
divina, che è guida dell'uomo verso la beatitudine eterna. Altra fonte di giustizia è
poi la legge naturale, che è ben conosciuta dalla ragione ed è formata da principi
universali che sono comuni a tutti gli uomini (come ad esempio la generazione).
Dunque, la legge umana ha come suo fondamento sia la legge divina che quella
naturale, ma serve in realtà solamente a guidare ed a frenare in certi limiti il
comportamento degli uomini che non si sottomettono alla legge divina e che,
dunque, sono malvagi per definizione. Il teologo fa, anche, una precisa differenza
tra diritto e giustizia: per Tommaso il diritto è "la proporzione tra il profitto che il mio
atto produce ad un altro e la prestazione che questi mi deve in cambio"; la giustizia,
invece, è "la perpetua e costante volontà di riconoscere e attribuire a ciascuno il
suo diritto". Per quanto concerne lo Stato e la politica, Tommaso afferma che la
migliore forma di governo è la monarchia, non solo come trasposizione nell'umano
della monarchia divina, ma anche in quanto il re non è il tiranno, ma è bensì colui al
quale il popolo ha delegato la propria libertà e sovranità in nome della pace,
dell'unità e del buon governo (ovvero il bene comune). Comunque, anche se
riconosce la positività dello Stato (monarchico), Tommaso pone dei solidi limiti
all'azione della società e della politica quando afferma che l'uomo "nel suo essere,
nel suo potere e nel suo avere deve essere ordinato a Dio" e non alla società
politica. In sostanza, afferma che, al di là dei diritti e dei doveri sociali e politici,
l'uomo deve tendere interamente a Dio, poiché il suo governo spirituale è affidato
ad un solo re, cioè Cristo. Tale però non è affatto una visione teocratica, come
hanno detto alcuni, ma è la distinzione tra la sfera visibile e la sfera invisibile
dell'uomo: esteriormente egli deve obbedire ad un re terreno, ma interiormente
deve obbedire solo a Cristo Re, e può (anzi, deve) disobbedire al re terreno solo se
egli viene in contrasto col re interiore Gesù Cristo.
Le posizioni economiche della Scolastica
La Scolastica condannò con durezza il prestito di denaro contro interesse, come
usura, qualunque fosse il tasso d'interesse applicato. Tommaso fece un'apertura,
dichiarando legittimo il pagamento di un interesse per la disponibilità (immobilizzo)
di denaro del creditore, considerando che fino alla restituzione del debito il creditore
è privato delle sue finanze.
La Scolastica sosteneva il valore convenzionale della moneta, per il quale la
moneta vale soltanto se le persone che la usano le riconoscono un valore,
usandola come mezzo di scambio. Tale condizione è necessaria, ma non
sufficiente. Le monete non acquistano valore perché le persone lo riconoscono
usandole; devono avere un valore intrinseco. La Scolastica univa valore intrinseco
e valore convenzionale della moneta, che sono spesso contrapposti. Nell'Alto
Medioevo cominciavano a circolare note-da-banco (poi chiamate banconote) di
sola carta che erano utilizzate nei pagamenti e valevano quanto le monete d'oro:
ciò provava che la moneta può avere un valore per il semplice fatto che le persone
lo riconoscono (valore convenzionale come condizione sufficiente della moneta).
Secondo i filosofi scolastici la moneta era una merce come le altre che serve ad
acquistare altre merci. La moneta-merce si compra contro un'altra merce che può
essere un'altra moneta oppure oro; perché chi detiene moneta possa incassare oro
è necessario che la moneta possegga un valore tale da giustificare il prezzo
pagato. Tale valore non è la capacità di acquistare beni di importo equivalente che
garantisce la moneta (valore della moneta, ma non intrinseco), ma è un valore
intrinseco che avrebbe anche senza essere usata come mezzo di scambio; ad
esempio l'oro con cui è coniata. In questo modo, chi compra monete compra l'oro di
cui sono fatte, o l'oro che è depositato in garanzia della nota-da-banco. Il valore
intrinseco implica un valore convenzionale, mentre non dovrebbe valere il contrario
(anche se il valore convenzionale, cioè la sicurezza che altri accetteranno in
pagamento il denaro, è un valore della moneta).
Noi diremmo che la moneta è un prodotto (della zecca) e, come avviene per
definizione di prodotto, pagamento e fruizione sono contemporanei; anche per la
Scolastica, la relazione fra chi acquista moneta e chi riceve in cambio oro, altra
moneta o una merce si esaurirebbe con lo scambio. Non ci sono rapporti successivi
che giustificherebbero il pagamento d'interessi. Un'apertura al mondo del credito
avviene considerando che chi presta denaro se ne priva per un certo periodo,
immobilizza delle somme che da al debitore; il pagamento di interessi secondo
Tommaso è un legittimo risarcimento del denaro che il creditore tiene a
disposizione del debitore.
Altrimenti chi emette moneta priva di valore intrinseco dovrebbe pagare quanti la
accettano come mezzo di pagamento, che sono gli stessi che la acquistano. All'atto
d'emissione una moneta non legittima alcun tipo di interessi e, se è priva di valore
intrinseco, nemmeno il pagamento di un prezzo (deve essere emessa
gratuitamente). Una moneta già esistente e prestata legittima un pagamento
d'interessi per il tempo per il quale la sua disponibilità è stata sottratta al creditore.
Tomismo e neo-tomismo nell'Ottocento e nel Novecento
A cura di Andrea Porcarelli
http://www.filosofico.net/ttom213297masdoe.htm
La ricchezza del pensiero di Tommaso e la grande varietà dei temi affrontati
hanno fatto di lui un autore molto letto e citato, talora da studiosi che si sono
addentrati in profondità nello spirito e nei contenuti del suo pensiero, talora da
interpreti più frettolosi che hanno contribuito a diffondere una visione distorta
del tomismo. È bene, in ogni caso, accennare anche solo di sfuggita al fatto
che quando si parla di "tomismo" non ci si riferisce – ovviamente – al solo S.
Tommaso, ma all'insieme di tutti coloro che – nel corso dei secoli – a qualche
titolo ne hanno esplicitamente ripreso l'insegnamento, a partire dai grandi
commentatori della "tarda scolastica", di cui ci limitiamo – in questa sede –
citare i principali: Giovanni Capreolo (1380-1444), Francesco Silvestri da
Ferrara, più noto come "Ferrarese" (1468-1528), Tommaso de Vio, più noto
come "Gaetano" (1469-1534), Domenico Bañez (1528-1604), Giovanni di San
Tommaso (1589-1644) che hanno prodotto studi monumentali, sia come
commento alle opere di Tommaso, sia come veri e propri strumenti per lo
studio. Alla linea tomista "domenicana" a cui si è appena fatto riferimento, si
affianca la linea "gesuitica", visto che fin dalla "Ratio studiorum" del 1599 (ma
anche prima, nella Ratio del Collegio Romano) l'ordinamento degli studi dei
Gesuiti prescrive esplicitamente di attenersi alla dottrina di S. Tommaso; ma
tale riferimento comporterà un certo grado di libertà interpretativa, per cui
possiamo di fatto distinguere una linea ermeneutica distinta, che si esprime
attraverso alcuni grandi autori, tra cui citiamo: Pedro Da Fonseca (1528-1599),
Gabriel Vàzquez (1549-1604), Luis de Molina (1536-1600) ed il "doctor
eximius" Francisco Suàrez (1548-1627).
La filosofia tomista nell'Italia del XIX secolo
Tra i centri che hanno favorito la rinascita e la diffusione degli studi tomistici
nel XIX secolo va ricordato, innanzitutto, il Collegio Alberoni di Piacenza, attivo
dal 1751, caratterizzato fin dal suo sorgere da una particolare sensibilità per la
filosofia aristotelico-tomista. Nel 1879, qualche mese prima della pubblicazione
della stessa enciclica Aeterni Patris, Alberto Barberis fondò – presso il Collegio
piacentino – la rivista "Divus Thomas", la prima al mondo interamente dedicata
interamente a san Tommaso, che fu subito bene accolta in molti paesi
d'Europa (Belgio, Francia, Spagna, Ungheria, Germania), da dove studiosi
insigni mandarono i loro scritti e dove il periodico ebbe notevole diffusione
(fatto, peraltro, non comune per la stampa del nostro Paese). Altri centri di
diffusione degli studi tomistici in Italia furono strettamente legati all'azione
dell'Ordine dei Gesuiti, soprattutto dopo la sua ricostituzione nel 1814.
Quando per esempio il Collegio Romano venne nuovamente loro affidato, nel
1824, il rettore (Luigi Taparelli d'Azeglio) si rese conto che le scienze ecclesiali
potevano essere risollevate dalle misere condizioni in cui versavano attraverso
la riproposizione dell'antica Ratio Studiorum del 1599, che concretamente
comportava la ripresa dell'insegnamento della filosofia di Tommaso d'Aquino.
Trasferito a Napoli dai suoi superiori, il Taparelli operò per rilanciare gli studi
tomistici anche in quella città, finché nel 1846 un altro studioso (Gaetano
Sanseverino) fonda l'Accademia di Filosofia Tomista di Napoli. Nel 1850,
sempre a Napoli, appare per la prima volta la rivista "La Civiltà Cattolica", non
dedicata specificamente agli studi tomistici, ma che ebbe di fatto una notevole
importanza per il loro rilancio contribuendo alla diffusione del pensiero dei
filosofi neoscolastici. Altri centri di studi tomistici, legati in particolare all'ordine
domenicano, si trovavano a Bologna (1) e a Roma (presso il convento di Santa
Maria sopra Minerva). Non va dimenticato nemmeno il centro di Perugia. Nel
1880 fu fondata l'Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino, inaugurata
dallo stesso Leone XIII e caratterizzata per il fatto di essere una istituzione
pontificia a carattere internazionale.
La filosofia tomista nell'area tedesca nel XIX secolo
Nell'area culturale di lingua tedesca il fenomeno della riscoperta di Tommaso
d'Aquino nella seconda metà del XIX secolo si lega da un lato alle divisioni
interne all'hegelismo dopo la morte di Hegel e – dall'altro lato – al rafforzarsi
della coscienza cattolica dopo il 1848. Di particolare interesse è l'opera di
alcuni autori, come Franz Jakob Clemens e Joseph Kleutgen. I principali centri
di elaborazione culturale furono il liceo di Eichstätt, l'Accademia di Münster e i
licei reali di Baviera, oltre alle istituzioni di alcuni ordini religiosi. I centri
culturali cattolici ebbero un ruolo particolare durante gli anni del Kulturkampf,
quando molte istituzioni cattoliche furono soppresse e gli studenti di teologia
confluivano in quelle che erano state risparmiate. Dopo il fallimento del
progetto di istituire un'università cattolica in Germania, nel 1876 – proprio nel
cuore del Kulturkampf – i cattolici crearono un organismo di cultura a cui
appoggiarsi, vista l'emarginazione che pativano nelle università statali, la
Görres-Gesellshaft, la cui sezione filosofica fu largamente influenzata dal
pensiero di autori neoscolastici.
L'enciclica Aeterni Patris
Una sottolineatura a parte merita l'enciclica Aeterni Patris (4 agosto 1879) di
Leone XIII, al secolo Gioacchino Pecci, che era stato uno degli animatori del
Centro di studi tomistici di Perugia. L'enciclica parte dalla considerazione che
molti errori del tempo presente derivano dall'adesione a visioni filosofiche false
e fuorvianti e rilancia la "mirabile armonia" ed il "misurato rigore" della sintesi
di Tommaso d'Aquino come modello di filosofia in grado di garantire
quell'armonia tra fede e ragione che il razionalismo laico contemporaneo
metteva fortemente in discussione. Il pontefice invita i vescovi a ripristinare
pienamente l'insegnamento della filosofia tomista nei seminari e nelle
università cattoliche, con l'esortazione ad andare direttamente ai testi di
Tommaso e dei suoi immediati commentatori. La linea di Leone XIII fu
proseguita ed accentuata dal suo successore – Pio X – che era particolarmente
preoccupato per gli esiti infausti della crisi modernista e, nell'enciclica Pascendi
(1907), rende più rigorosamente prescrittive le indicazioni dell'Aeterni Patris,
probabilmente spingendosi con questo ben oltre le intenzioni del suo
predecessore. Il contributo più duraturo dell'enciclica di Leone XIII non va
tanto cercato nei riflessi che ha generato negli studi ecclesiastici perché –
come si è detto – questi furono ben presto condizionati dalle chiusure che
derivarono dalla reazione alla crisi modernista (2), ma piuttosto nell'impulso
che fu dato al sorgere di nuovi centri di studi e dal lavoro svolto dalla
"Commissione leonina", costituita nel 1880 con l'incarico di curare l'edizione
critica di tutte le opere di Tommaso.
La filosofia tomista in Francia Tra Ottocento e Novecento
Il contributo fondamentale dell'area culturale di lingua francese al
neotomismo contemporaneo si lega indubbiamente alla fondazione dell'Istituto
Superiore di Filosofia a Lovanio (in Belgio), ad opera del Card. Mercier nel
1882, che di fatto pose le basi per un positivo incontro tra il pensiero di
ispirazione tomista ed il pensiero filosofico moderno. Dopo la pubblicazione
dell'enciclica Aeterni patris, fu lo stesso pontefice – nel 1880 - a prendere
l'iniziativa, incaricando il Card. Dechamps, arcivescovo di Malines, di creare
una cattedra speciale di filosofia tomista presso l'Università cattolica di Lovanio
che era, all'epoca, l'unica università cattolica completa, che comprendeva –
oltre alla facoltà di teologia – la facoltà di diritto, di lettere e filosofia, di
medicina e scienze naturali. Nel 1882 i vescovi belgi designarono Désiré
Mercier, allora professore di filosofia al seminario di Malines, di istituire a
Lovanio un corso "di alta filosofia secondo san Tommaso". Per il Mercier la
filosofia non è tanto una "dottrina" da insegnare, ma è soprattutto ricerca della
verità, aperta e libera, accogliendo ogni pensiero saggio ed ogni scoperta utile,
da qualunque parte provengano, come faceva ed invitava a fare lo stesso
Tommaso. Verso la fine del secolo l'Istituto di Lovanio è già pienamente
avviato e i primi discepoli e poi successori del Mercier vi operano con lo zelo
dei pionieri, estendendo progressivamente il suo raggio d'azione ed il suo
prestigio in tutta Europa. Interprete acuto del pensiero di Tommaso nella
prima metà del XX secolo fu Antonin–Dalmace Sertillanges (1863-1948) che
pubblicò nel 1910 la sua opera in due volumi dal titolo Thomas d'Aquin, in cui
affronta con originalità sul piano speculativo alcune tematiche che saranno
oggetto di acceso dibattito. Ci limitiamo qui ad accennare all'ultimo capitolo di
questo testo che – significativamente – si intitola Il futuro del tomismo, in cui
l'autore si domande in quale direzione il tomismo debba rivolgere le proprie
ricerche, a partire da quella che il Sertillanges individua come la sua
caratteristica peculiare, ossia "lo sforzo scrupoloso di soddisfare tutte le
condizioni dell'esperienza, di accogliere tutte le idee reali, di raccoglierle in una
struttura e limitarle di volta in volta secondo la necessità, ottenendo così il
massimo equilibrio e una giusta comprensione per ogni momento di una
scienza in continua evoluzione" (3). Caratteristica peculiare del pensiero di
Tommaso è la ricerca di una visione d'insieme, in modo vivo e sotto l'influsso
di alcune "idee guida". Tale è, per Sertillanges, la prerogativa che rende il
pensiero tomista particolarmente adatto ad affrontare positivamente i problemi
del nostro tempo: si offrono principi di unità per un mondo che va alla deriva
per i troppi contrasti, lealtà e correttezza come metodo per le relazioni umane
in un universo sempre più individualista, capacità di analisi per studiare chi ha
opinioni differenti, al fine di cogliere ciò che può esservi di vero nel pensiero di
chiunque. Di grande importanza sono anche le ricerche storiche sulla filosofia
medievale che attraggono l'interesse di molti studiosi che estendono alle opere
dei grandi autori il metodo storico-critico, che veniva applicato – non senza un
dibattito ancora piuttosto vivace – alla stessa interpretazione delle Scritture.
Di particolare interesse sono i contributi della scuola francese di Victor Cousin,
che si interessò in prima persona del pensiero di Abelardo e stimolò le ricerche
di Jean-Barthélémy Hauréau sulla filosofia scolastica (nel 1850 e poi con la
grande Histoire de la philosophie scolastique, in 3 volumi, usciti tra il 1872 e il
1880) e di Ernest Renan su Averroé e l'averroismo (del 1852). Sulla stessa
linea si collocano le ponderose ricerche di alcuni autori tedeschi, tra i quali
possiamo citare la Storia della filosofia del Medioevo di Albert Stökl (18641867), i cinque volumi de La scolastica del Tardo Medioevo di Carl Werner
(1881-1887) e la sua opera su Tommaso d'Aquino in tre volumi (1889). Le
opere di carattere storico-critico che segnarono una vera svolta nella
ricostruzione del pensiero filosofico scolastico in genere e tomista in particolare
furono quelle di Clemens Beaumker (1853-1924), Pierre Mandonnet (18581936) e Maurice De Wulf (1867-1947). Beaumker fondò, nel 1891, la collana di
pubblicazioni chiamata Contributi alla storia della filosofia del Medioevo, che
diresse fino alla morte, quando gli successe Martin Grabman (1875-1949), che
pubblicò lavori ancora oggi importanti sulla Storia del metodo scolastico (2
voll., 1909-1911), su Tommaso d'Aquino e la scuola tomista. Ancora più
illuminanti sono i contributi del domenicano francese Pierre Mandonnet, che
coglie – da storico – il significato della reazione conservatrice contro Tommaso
d'Aquino: la tradizione agostinista, che costituiva la dottrina tradizionale dei
pensatori pre-tomisti fino a Bonaventura, si caratterizza per il fatto di
conoscere senza rendere del tutto effettiva la distinzione tra filosofia e teologia
tanto cara ad Alberto Magno e Tommaso d'Aquino. È Mandonnet il primo
autore a cogliere la specificità del contesto storico-culturale dell'opera di
Tommaso, simultaneamente impegnato su due fronti: nell'attacco contro
l'averroismo latino e nella difesa contro l'agostinismo reazionario. Mandonnet
inizia nel 1921 la serie di pubblicazioni della Bibliotèque thomiste, con lavori
prevalentemente di carattere storico ed avvia, dal 1924, la rivista critica
Bulletin thomiste, che si caratterizza sempre per la straordinaria attenzione alla
ricostruzione storica del pensiero di Tommaso.
I frutti di tale paziente lavoro di indagine storico-critica confluiscono nella
Storia della filosofia medievale di De Wulf (professore a Lovanio), pubblicata in
prima edizione nel 1900 e costantemente rieditata, tenendo conto degli
sviluppi progressivi della ricerca storica.
Étienne Gilson
Nel periodo fra le due guerre la ricerca storica sull'età medievale riceve un
grandissimo impulso dalla fondazione di numerosi istituti di ricerca con questa
specifica finalità: si avvia l'edizione critica dell'opera di molti autori (da
Alessandro di Hales ad Alberto Magno, per citarne solo due), a Parigi inizia ad
operare un altro grandissimo studioso, Étienne Gilson, che avvia nel 1926 la
pubblicazione degli Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen-Age e,
dal 1930, della serie degli Études de Philosophie Médiévale, raccogliendo
attorno a tali organi un cospicuo numero di collaboratori di grande valore. Gli
orizzonti degli studi storici specialistici si aprono oltre oceano, con la
fondazione della Medieval Academy of America, a Cambridge (Massachussetts)
nel 1925 e l'Institute of Medieval Studies, fondato a Toronto nel 1929, con la
collaborazione dello stesso Gilson. Egli si muove ancora come storico della
filosofia, ma opera ad un livello diverso rispetto ai suoi colleghi e predecessori:
non si è mai occupato personalmente di ricerca di manoscritti, ma ha sempre
favorito il lavoro erudito e ne ha fatto la base delle sue ricerche, spostando
solo l'asse della domanda storica non tanto sulla constatazione di "quello che è
stato detto", quanto sulla ricerca "di che cosa si stesse veramente parlando",
sempre su un piano di ricostruzione storicamente accurata. Il suo testo sul
tomismo (Le Thomisme) appare per la prima volta nel 1919, riceve la forma
attuale nella IV edizione, del 1941, ma la quinta e la sesta apportarono
ulteriori cambiamenti. Lo stesso si dica del suo celebre compendio, La
philosophie au moyen-âge (apparso nel 1922 e ripubblicato in diverse edizioni,
sempre aggiornate alla luce dei progressi della ricerca storica). Un discorso a
parte merita la sua opera, più filosofica che storica, L'être et l'essence, del
1948, mentre nel 1932 era stata pubblicata un'altra opera fondamentale,
L'Esprit de la philosophie médiévale. Forse in tale opera – dal titolo
particolarmente evocativo – risiede la cifra dell'importanza dell'opera di Gilson
e della sua lettura della scolastica in genere e di Tommaso in particolare: la
filosofia medievale si caratterizza in quanto filosofia cristiana, non nel senso
che la ricerca filosofica sia "condizionata" dalla fede cristiana, ma nel senso che
le verità della fede cristiana hanno offerto all'indagine filosofica gli "spunti
euristici" (4) per porsi in modo nuovo alcune domande eterne dell'uomo. È
attraverso la ricerca storica che è possibile ricostruire il vero volto di Tommaso
e dunque essere, autenticamente, "tomisti". Nella sua opera esplicitamente
dedicata al profilo speculativo di Tommaso (Le thomisme. Introduction au
système de saint Thomas d'Aquin) in cui si sottolinea come i temi filosofici ed i
temi teologici – nelle opere dell'Aquinate – siano materialmente congiunti e
formalmente distinti: quando Tommaso si occupa di filosofia è sempre anche
"teologo", nel senso che non trascura di mettere in luce i riflessi teologici delle
proprie riflessioni, mentre nei passaggi del proprio ragionamento che non si
basano su premesse desunte dal patrimonio della rivelazione egli non solo
argomenta in termini strettamente filosofici, ma si premura di attivare un
"dialogo a distanza" con i filosofi di varie impostazioni e correnti, proprio su
quelle tematiche. In altre parole Gilson osserva come la teologia di Tommaso
sia quella di un filosofo e la sua filosofia sia quella di un santo. Sl libro sul
sistema filosofico di Tommaso in generale seguì, nel 1925, un testo sulle
dottrine morali dell'Aquinate (il testo fu pubblicato con il titolo Saint Thomas
d'Aquin nella collana dedicata ai moralisti cristiani), in cui Gilson sottolinea
come la morale di Tommaso non sia separabile dalla sua metafisica,
discutendo in particolare la dottrina del Sommo Bene come chiave di volta
dell'edificio etico tomista. Oltre alla controversia sulla filosofia cristiana, di cui
si è già fatto cenno, Gilson fu coinvolto – negli anni Trenta – in un altro
dibattito molto vivace, circa la validità del realismo critico sostenuto da molti
neoscolastici. Due sono le opere da lui pubblicate in tale contesto, Le réalisme
méthodique (1936) e Réalism Thomiste et critique de la connaissance (1939),
in cui prende in esame anche le idee di quanti sostenevano che per portare la
riflessione scolastica al livello della discussione filosofica moderna fosse
necessario assumere la prospettiva gnoseologica del dubbio cartesiano e del
criticismo kantiano.
Gilson afferma che se si parte dal cogito cartesiano o dal criticismo kantiano
non si potrà mai giungere all'affermazione "le cose esistono in sé": il realismo
scolastico è tutt'altro che "ingenuo" (come asseriscono alcuni suoi detrattori),
ma si tratta di "un realismo consapevole, meditato e voluto, che tuttavia non
muove dal problema posto dall'idealismo, poiché i presupposti di questo
problema implicano necessariamente l'idealismo stesso come sua soluzione. In
altre parole: anche se questa tesi di primo acchito può sorprendere, il realismo
scolastico non è al servizio del problema gnoseologico - piuttosto sarà vero il
contrario - bensì la realtà viene vista in esso come indipendente dal pensiero,
l''esse' viene posto come distinto dal 'percipi', e questo sulla base di una certa
rappresentazione di che cosa sia la filosofia e come condizione della sua stessa
possibilità. Questo è un realismo metodico" (5).
Le ricerche di Gilson porteranno ad una complessiva revisione della maggior
parte dei manuali di filosofia scolastica circolanti nelle università cattoliche e
nei seminari, anche per eliminare le numerose ingenuità sul piano della
ricostruzione storica che non potevano sfuggire a studiosi che andavano
progressivamente maturando una forte sensibilità di tipo storico-critico, pur
mantenendo una costante tensione verso la acquisizione degli elementi
teoretici di quella philosophia perennis, di cui Tommaso veniva – comunque –
considerato maestro (anche da studiosi storicamente attrezzati come Gilson).
In tale impostazione emerge una logica per cui da un lato vi sono dei motivi
storici per cui è in un'epoca piuttosto che in un'altra e in un ambiente culturale
piuttosto che in un altro che i filosofi maturano la convinzione della necessità di
appellarsi a determinati principi e giungono – di conseguenza – a determinate
conclusioni; dall'altro lato però il valore teoretico di tali principi e la coerenza
logica dei ragionamenti che ad essi si appellano, non devono necessariamente
venire relegati nel tempo in cui i principi ed i percorsi logici vennero – di fatto pensati.
Fernand Van Steenberghen
Su posizioni distinte, rispetto a quelle di Gilson, si collocano altri notevolissimi
interpreti del pensiero di Tommaso, con particolare riferimento a Fernand Van
Steenberghen, successore di De Wulf alla cattedra di Lovanio. Egli,
evidentemente, non nega l'ispirazione cristiana della filosofia medievale, ma
critica il concetto di "filosofia cristiana" nella forma indicata da Gilson che
sarebbe estraneo alla cultura del periodo: autori come Bonaventura – per
esempio – sono in primo luogo teologi, che non elaborano una filosofia
autonoma, ma ne usano semplicemente alcuni concetti in funzione della
trattazione teologica (in tali autori si può cogliere in senso più proprio una
visione "ancillare" della filosofia nei confronti della teologia), mentre è
prerogativa peculiare di Alberto di Colonia e più ancora di Tommaso d'Aquino
l'avere organizzato in modo sistematico questa filosofia autonoma ed averne
sottolineato l'importanza in rapporto alla teologia. Per questo motivo – afferma
Van Steenberghen, che ha scritto un'opera in due volumi su Sigieri di Brabante
attraverso le sue opere inedite – Tommaso è in grado di incontrare sul suo
stesso piano (quello di una riflessione filosofica autonoma) sia l'aristotelismo
"radicale" di Sigieri, sia i presupposti filosofici utilizzati dai teologi agostiniani,
sia una rilettura più attenta della filosofia di Aristotele che passa attraverso
l'analisi attenta delle sue opere. È interessante notare come Van Steenberghen
da un lato prenda le distanze da alcuni elementi dell'interpretazione storica del
pensiero medievale operata da Gilson, ma dall'altro affermi con forza la
necessità di un "neotomismo" che sappia "riscrivere" la filosofia di Tommaso
nello stile del nostro tempo e tenendo conto delle istanze proprie del nostro
tempo.
La filosofia tomista in Italia nella prima metà del Novecento
In Italia un punto di riferimento importante è costituito, nella prima metà del
XX secolo, dalla nascita della "Rivista di Filosofia Neoscolastica" (1909) e dalla
fondazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (nel 1921, riconosciuta
dallo Stato italiano nel 1924); ricordiamo anche la rivista "Vita e Pensiero"
(fondata nel 1914), che si rivolgeva ad un pubblico più ampio, con un largo
ventaglio di interessi culturali.
Campeggia in questa fioritura di iniziative la figura di Agostino Gemelli (18781959) che animò il centro milanese per circa mezzo secolo, muovendo dalla
convinzione che una robusta base filosofica fosse il fondamento ineludibile di
tutta l'impresa culturale che fioriva attorno al centro milanese. Nel periodo che
va dalla fondazione dell'Università al secondo conflitto mondiale la scena
filosofica italiana è dominata dal neoidealismo di Croce e Gentile, con cui i
docenti della Cattolica intrecciano un fitto dibattito. Di particolare rilievo in
questo senso è l'opera di Amato Masnovo (1880-1955) che volse i propri sforzi
nella direzione di una ricostruzione rigorosa ed essenziale della metafisica
classica, insistendo in modo particolare sul problema del "fondamento" della
metafisica stessa, a partire dalla domanda sul fondamento del possibile (il
possibile è pensabile da un'intelligenza finita solo conseguentemente alla
conoscenza di ciò che è attualmente reale). Interessanti sono le conseguenze
di tale posizione nel campo della critica della conoscenza: "nell'ordine ideale,
cioè dei principi, non vi può essere certezza riflessa senza la coscienza della
possibilità dell'ente. Ora la coscienza della possibilità dell'ente – nozione
semplicissima – non può essere conquistata per analisi: deve essere
conquistata attraverso l'esperienza esterna o interna, secondo l'effato 'ab esse
ad posse datur illatio': dalla realtà di una cosa si è autorizzati ad affermare la
sua possibilità" (6). Francesco Olgiati (1886-1962), fondatore della Cattolica
assieme a Gemelli, difese la purezza della metafisica classica saldamente
ancorata al principio dell'immediatezza e trascendentalità del suo principio,
l'ente. La tesi di fondo su cui si basa la sua difesa del tomismo parte dall'idea
che la negazione del valore della prospettiva realista non era – in realtà – il
cuore delle più autentiche acquisizioni del pensiero moderno, ma una
conclusione indebita rispetto a premesse di cui era possibile recuperare il
valore. I campi in cui la modernità ha portato i frutti migliori sono – secondo
Olgiati – quelli della scienza e della storia, che possono trovare una loro
fondazione sintetica ad un livello più profondo proprio nella prospettiva
realista, attraverso un recupero della dottrina dell'astrazione, in una visione
della riflessione filosofica che pone al centro e al culmine la speculazione
metafisica.
Panorama complessivo della seconda metà del Novecento
Nella seconda metà del XX secolo, dopo la guerra, la situazione degli studi
tomisti presenta un panorama decisamente interessante: sul piano
dell'indagine storica la ricerca è proseguita in modo non del tutto uniforme, ma
continuativo; giungono a conclusione alcune iniziative a lungo termine che
erano state intraprese nel periodo tra le due guerre; le grandi edizioni critiche
delle opere si arricchiscono di volumi completi, con ritmo lento, ma con una
elevatissima qualità critica. Intorno agli anni '60 ha inizio un'ondata di
ristampe anastatiche di libri ormai rari (soprattutto edizioni della prima età
moderna), tra cui numerosi testi di fonti scolastiche che non costituiscono un
vero e proprio progresso nel campo della ricerca, ma consentono una maggiore
disponibilità di testi utili a quegli studi a cui viene così dato un notevolissimo
impulso. Sorgono nuovi centri di studi come il "Thomas Institut" (fondato da
Josef Koch presso l'Università di Colonia nel 1950). Sempre nel 1950 iniziano i
"congressi medievistici" interdisciplinari, i cui contributi iniziano ad apparire dal
1962 nella collana Miscellanea mediaevalia. Nel 1954 Michael Schmaus fonda –
a Monaco – il "Martin Grabmann Institut" e nel 1956 sorge il "Centre De Wulf
Mansion" a Lovanio, per la storia della filosofia antica e medievale, dove – nel
1958 – si tiene il primo Congresso Internazionale per la Filosofia Medievale,
con la fondazione della SIEPM (Société Internationale pour l'Étude de la
Philosophie Médieévale) che, a partire dall'anno successivo, inizia a pubblicare
un Bulletin, diffuso a livello mondiale. Centri analoghi, con compiti specifici che
spaziano per tutto l'arco e le correnti della filosofia medievale, nascono in tutto
il mondo, ma volendoci concentrare solo sui centri con un particolare interesse
per lo studio di Tommaso d'Aquino sorti nella seconda metà del XX secolo,
dobbiamo ancora citare perlomeno il "Thomas Institut" di Kyoto (Giappone),
sorto nel 1955. Di particolare rilievo anche il fatto che Centri di studi operanti
nel Medio Oriente (come quelli del Cairo, Beirut e Gerusalemme),
particolarmente attivi nell'area delle ricerche sul pensiero arabo del Medioevo,
siano ormai stabilmente entrati "in rete" con i centri operanti in Occidente,
partecipando abitualmente ai congressi della SIEPM. Lo stesso Istituto di
Lovanio si rinnova e si rafforza: nel 1946 la rivista dell'Istituto fu ribattezzata
"Revue Philosophique de Louvain", a sottolineare la fisionomia specifica
assunta dalla "scuola di Lovanio" nel corso degli anni; e nel 1951 il re del
Belgio organizza celebrazioni "giubilari" in occasione del centenario della
nascita del Card. Mercier, istituendo anche una Cattedra a lui intitolata, nel
1956 nasce presso l'Istituto una nuova sezione, ossia il "Centre De WulfMansion, Recherches de philosophie anciénne et médiévale – De Wulf-Mansion
Centrum. Navorsing over antieke en middeleeuwse filosofie".
Sul piano della
ricerca teoretica il panorama muta notevolmente – soprattutto a partire dagli
anni del Concilio Vaticano II – rispetto alla prospettiva dell'enciclica Aeterni
patris: si registra una generale apertura del pensiero scolastico alla filosofia e
più ancora alle scienze moderne e contemporanee, con un progressivo
affievolirsi di una prospettiva prevalentemente apologetica che aveva
caratterizzato il tomismo del XIX e della prima metà del XX secolo. Il pensiero
moderno viene preso sul serio nei suoi intenti più profondi, accettato come
qualcosa di positivo (del resto Tommaso stesso affermava che "omne verum, a
quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est"), utile per ripensare ed approfondire
la riflessione scolastica che non si limita più a "tramandare" una nobile
tradizione (nella logica dell'Aeterni patris), ma si pone il problema di portare
un proprio contributo per accrescere il patrimonio comune della riflessione
umana, interrogandosi sulle grandi questioni del tempo presente.
Erich Przywara Erich Przywara (1889-1972) può essere considerato – in questo senso – un
autore che segna una linea di spartiacque: la sua apertura a problemi e
pensatori in certo modo "nuovi" dal punto di vista della tradizione
neoscolastica, contribuì a creare un clima culturale diverso, all'interno della
cultura cattolica di area tedesca. Emblematiche le parole con cui annunciò il
proprio programma teoretico in occasione del congresso della Società
Accademica Cattolica a Ulma nel 1923: "Ciò di cui abbiamo bisogno e che
quindi oggi ci proponiamo come programma, è una filosofia dell'equlibrio, un
equlibrio non 'oggi per sempre', ma piuttosto 'che procede all'infinito': la
filosofia della polarità, equidistante da una filosofia di inquieti capovolgimenti
come da una filosofia della statica medietà, la filosofia della polarità dinamica"
(7). La polarità, come "unità di tensione", richiama il senso del mistero, con
un'apertura che va oltre una prospettiva riduttivamente immanentistica, senza
configurarsi come una fuga immediata in un trascendentalismo ingenuo, ma si
caratterizza come ricerca di risposte alle domande che provengono dall'abisso
degli opposti. Tra le riflessioni di Przywara che più hanno fatto discutere vi è
indubbiamente la sua lettura del tema – tipicamente tomista – dell'analogia
entis, a partire dalle due parti che compongono la parola ana-logia. Il termine
logia dice riferimento al nesso tra "Logos" e "leghein" e viene interpretato da
Przywara come il "raccogliersi a formare un senso nella parola"; il suffisso ana
può a sua volta designare un duplice significato. Da un lato può avere il senso
di "conforme a", dall'altro si confonde in tutte le parole composte con anô , nel
senso di "sopra, su, di nuovo". Il mondo può in tal modo manifestarsi secondo
un duplice ritmo, sul piano dell'ana (dimensione orizzontale) e sul piano dell'
anô (dimensione verticale) che si incontrano in quello che sarebbe il
"proprium" dell'analogia intesa come "incrocio di coordinate" in una lettura
dinamica di una realtà che si colloca su una pluralità di piani.
Edith Stein
Interessantissima in questo senso è anche Edith Stein (1891-1942) (8), di
famiglia ebrea, prima allieva e assistente di Edmund Husserl, poi avvicinatasi
al tomismo dopo la conversione al cattolicesimo, ha operato profondi tentativi
di sintesi tra la fenomenologia husserliana e la filosofia di Tommaso. Nel 1933
entra nell'Ordine Carmelitano di Colonia, continua i propri studi filosofici, ma
non può pubblicare in quanto ebrea. Viene arrestata dalla Gestapo nel 1942 e
condotta ad Auschwitz-Birkenau, dove troverà la morte nella camera a gas. Nel
1950 inizia l'edizione delle sue opere a Bruxelles; nel 1962 viene istruita la
causa di beatificazione, il 1° maggio 1987, a Colonia, Giovanni Paolo II ha
dichiarato beata la martire Edith Stein. La Stein abbracciò l'impostazione
filosofica husserliana in un contesto culturale in cui il dibattito ruotava attorno
alla fondazione delle scienze dello spirito di contro alle scienze della natura, ed
ella si sentì "corresponsabile" di questa impresa scorgendo il metodo di tali
scienze non nella spiegazione causale, ma nella "comprensione che si
immedesima" per cui ogni soggetto spirituale afferra "per immedesimazione"
gli altri soggetti e si rende presente come "datità" il loro agire. L'incontro con il
pensiero scolastico le fece maturare la convinzione che il suo ruolo culturale
dovesse proprio collocarsi in questa area di mediazione tra antico e moderno,
attraverso la lettura di Tommaso con le chiavi interpretative della
fenomenologia husserliana.
Jacques Maritain
Una figura del tutto particolare nel panorama del XX secolo è rappresentata
da Jacques Maritain (1882-1973), di cui è davvero interessante seguire le
vicende biografiche (9), e il cui pensiero campeggia nel panorama culturale
della rinascita del tomismo per tutta la parte centrale del XX secolo. Dopo la
"conversione" dalla prospettiva bergsoniana (che pure aveva avuto un ruolo
importantissimo nella formazione della sua personalità intellettuale e
spirituale) Maritain si proclama "un fedele seguace di S. Tommaso d'Aquino" e
non propriamente un "tomista": la sua attenzione principale non è centrata
sull'analisi ed il commento della dottrina di Tommaso, ma si preoccupa di
riprendere e ri-esprimere secondo il proprio linguaggio e la propria sensibilità
alcuni temi filosofici (talora centrali in Tommaso, talora più marginali) aventi
come principale caratteristica la particolare "attualità" nel tempo in cui si
svolge l'avventura intellettuale di Maritain. I più significativi punti di incontro
tra Tommaso e Maritain riguardano il primato dell'esistente (prendendo le
distanze dall'intellettualismo razionalistico che pervadeva anche gli studi
tomistici del tempo), il ruolo decisivo dell'intuizione intellettuale, la pluralità dei
gradi del sapere in funzione metodologica e per un incontro sapienziale tra le
diverse discipline, il rapporto tra individuo e persona, l'elaborazione di un
"umanesimo integrale" che possa fungere da modello, da "ideale storicoconcreto" per una nuova umanità ed una nuova cristianità. Se leggiamo tali
tematiche sullo sfondo delle vicende storiche con cui si è intrecciata la vita di
Maritain (le due guerre mondiali, i totalitarismi, l'incontro con il pragmatismo
edonistico americano, la speranza per una giustizia internazionale fondata sui
Diritti Umani, il Concilio Vaticano II), possiamo capire quanto la sua rilettura di
Tommaso fosse effettivamente orientata alla ricerca di risposte profonde alle
questioni "epocali" dell'umanità. Volendo cogliere – a titolo puramente
esemplificativo – alcune suggestioni dai numerosi temi affrontati da Maritain, ci
soffermiamo sulla sua idea di un Umanesimo integrale (opera pubblicata nel
1936), in cui – di fronte al volto drammatico dei diversi totalitarismi – si
propone una visione della società che ha al centro un ideale con due punti di
riferimento, espressi dalle parole del titolo: un "umanesimo", perché l'uomo –
la persona umana – deve essre posta al centro dell'organizzazione eticopolitica della vita singola e associata; "integrale", perché integrato (nel senso
di completato) da un'apertura alla trascendenza di Dio, contro le varie forme di
"umanesimo riduzionistico" che di fatto costituivano il fondamento teorico dei
totalitarismi del tempo. Nel testo, pubblicato nel 1932, Distinguer pour unir: ou
Les degrés du savoir, Maritain offre in qualche modo i fondamenti della sua
rilettura di Tommaso nella cultura del proprio tempo, in dialogo con il sapere
scientifico che – a sua volta – si colloca entro un orizzonte sapienziale più
ampio: "Il filo conduttore ci è fornito dalla dottrina dei tre gradi di astrazione, o
dei tre gradi secondo cui le cose offrono allo spirito la possibilità di cogliere in
esse un oggetto più o meno astratto e immateriale, quanto all'intelligibilità
stessa che discende dalle premesse alle conclusioni e, in ultima analisi, quanto
al modo di definire. Lo spirito può considerare oggetti astratti e purificati
solamente dalla materia, in quanto è fondamento della diversità degli individui
in seno alla specie, in quanto, cioè, è principio di individuazione; l'oggetto
resta, così, e anche in quanto presentato all'intelligenza, impregnato di tutte le
note derivanti dalla materia, eccettuate solamente le particolarità contingenti e
strettamente individuali che la scienza trascura. (...) Oppure lo spirito può
considerare degli oggetti astratti e purificati dalla materia in quanto essa, in
generale, fonda le proprietà sensibili, attive e passive, dei corpi. Allora lo
spirito considera soltanto una proprietà che isola dai corpi – quella che resta
quando tutto il sensibile è caduto – la quantità, numero ed estensione
considerati in sé: oggetto di pensiero che non può esistere senza la materia
sensibile, ma che può essere concepito senza di essa (...). Infine lo spirito può
considerare oggetti astratti e purificati da ogni materia, non conservando nelle
cose altro che l'essere stesso di cui sono penetrate, l'essere in quanto tale e le
sue leggi: oggetti di pensiero che non soltanto possono essere concepiti senza
materia, ma che anche possono esistere senza di essa, sia che non abbiano
mai l'esistenza nella materia, come Dio e i puri spiriti, sia che la loro esistenza
si dia nelle cose tanto materiali quanto immateriali, come la sostanza, la
qualità, l'atto e la potenza, la bellezza, la bontà, ecc. (...) Per precisare,
notiamo che, poiché tutti i nostri concetti si risolvono nell'essere, che è il primo
oggetto raggiunto (in confuso) dall'apprensione intellettuale, i concetti della
METAFISICA si risolvono nell'essere come tale, ens ut sic, quelli della
MATEMATICA in quella sorta d'essere (isolato dal reale) che è la quantità
ideale, quelli della FISICA nell'essere mobile o sensibile, ens sensibile. Ma per
la filosofia della natura, bisognerà, in questa espressione ens sensibile, mettere
l'accento su ens: scienza esplicativa, essa rivela la natura e le ragion d'essere
del suo oggetto. (...) Per la scienza empirica della natura, invece, quando
diciamo ens sensibile, essere sensibile, non sarà su ens, bensì su sensibile che
bisognerà porre l'accento" (10). Tra gli altri temi centrali del pensiero di
Maritain segnaliamo ancora la distinzione tra individuo e persona, che
rappresenta un'originale rielaborazione di temi tomisti e viene espressa con
chiarezza nell'opera del 1925 Trois réformateurs: Luther, Descartes, Rousseau,
in un percorso che tende a rinvenire le radici dell'individualismo moderno, in
cui si assiste ad un'esaltazione dell'individualità "camuffata da persona" e –
conseguentemente – ad un impoverimento della nozione autentica di persona
(che, come dice Tommaso, è "nome che esprime una dignità", porta l'impronta
del divino, un mondo di valori spirituali e morali, si configura come una
singolarità ineffabile e inviolabile). Il tema forse più caro alla speculazione
maritainiana è la proposta di un Umanesimo integrale, capace di reagire alla
"tragedia dell'umanesimo contemporaneo" che si configura come un
"umanesimo inumano", avendo perso il riferimento alla dimensione metafisica
della persona umana, che la colloca all'interno di un quadro di valori che ha Dio
al vertice. Un cenno meritano anche le opere educative di Maritain (11), in cui
egli riprende la concezione educativa di Tommaso, sia per quanto
esplicitamente scriveva l'Aquinate nel De Magistro, sia rintracciando
nell'antropologia tomista i fondamenti di una filosofia dell'educazione capace di
resistere alle opposte tentazioni del totalitarismo e del pragmatismo: "Il
compito principale dell’educazione è soprattutto quello di formare l'uomo, o
piuttosto di guidare lo sviluppo dinamico per mezzo del quale l'uomo forma se
stesso ad essere un uomo. Questa è la ragione per cui avrei potuto adottare
come titolo: l'educazione dell'uomo. (...) L'educazione è un'arte, un'arte
particolarmente difficile. Tuttavia essa appartiene per la sua natura stessa alla
sfera della morale e della sapienza pratica. L'educazione è un'arte morale (o
piuttosto una sapienza pratica in cui è incorporata una determinata arte). Ora
ogni arte è una spinta dinamica verso un oggetto da realizzare che è lo scopo
dell'arte stessa. Non c'è arte senza finalità; la vitalità stessa dell'arte consiste
nell'energia con cui tende al suo fine, senza fermarsi a nessuno stadio
intermedio" (12).
L'Università Cattolica di Milano
L'opera dei grandi maestri dell'Università Cattolica di Milano che hanno operato
nella prima metà del secolo è stata ereditata da Gustavo Bontadini (19031990) e Sofia Vanni Rovighi (1908-1990). Bontadini amava definirsi come "un
metafisico radicato nel cuore del pensiero moderno" ed è proprio l'attenta
lettura di molte opere di impostazione idealistica che lo porta ad affermare
quella che egli considera la "verità metodologica" dell'idealismo: il primato
metodologico della coscienza quale orizzonte per poter parlare dell'essere
costituisce il guadagno speculativo dell'età cartesiana, ma proprio all'interno di
tale guadagno si insinua l'affermazione aporetica che considera l'essere come
"altro" dalla coscienza, ciò di cui si dovrebbe "provare" la corrispondenza con
quanto è dato nella conoscenza sensibile o intellettiva; l'idealismo sopprime
questa aporia (il dilemma del "ponte" per passare dalla coscienza all'essere),
rimanendo però nell'orizzonte del "cogito", riaffermando l'originaria identità del
pensiero con l'essere (in una sorta di ritorno a Parmenide). La prospettiva di
Bontadini cerca a sua volta di cogliere – come si è detto – la "verità profonda"
del superamento idealistico dell'aporia cartesiana, recuperando una prospettiva
metafisica che egli chiama "neoclassica": "la metafisica neoclassica conserva la
verità dell'idealismo (l'intrascendibilità del pensiero come organo dell'interno,
come orizzonte assoluto...) e la perfezione inserendovi l'impianto problematico,
la struttura della mediazione dell'esperienza: in una parola l'esatta – rigorosa!
– metodica e non generica posizione dell'antinomia di trascendenza e
immanenza, per cui si parlerà di trascendere – se mai sia possibile –
l'esperienza nell'orbita del pensiero!" (13). Il principio o "cominciamento" della
filosofia è, secondo quanto affermava lo stesso Tommaso, l'ente (ciò che per
primo l'intelletto concepisce) a cui Bontadini applica quello che egli stesso
chiama "Principio di Parmenide", riformulato in termini non-monisti: "la
constatazione del divenire, da un lato, e la denuncia della sua
contraddittorietà, dall'altro. Due protocolli che fanno capo rispettivamente, ai
due piloni del fondamento: l'esperienza e il principio di non contraddizione
(primo principio). I due protocolli sono tra loro in contraddizione, e tuttavia
godono entrambi del titolo di verità ... sono verità, però, che in quanto prese
nell'antinomia (antinomia dell'esperienza e del logo) si trovano a dover lottare
contro un'imputazione di falsità. Giacché l'esperienza oppugna la verità del
logo e il logo quella dell'esperienza" (14).
Cornelio Fabro
Da istanze simili muove l'opera di Cornelio Fabro (1911-1995) che ha
dedicato gran parte della propria attività al tentativo di riscoprire un tomismo
autentico, liberandolo dall'essenzialismo sistematico della tradizione grecoscolastica e dal soggettivismo immanentistico del pensiero moderno, per farne
emergere i tratti caratteristici di filosofia dell'essere e della libertà. Principio o
"cominciamento" del pensiero è proprio l'ens, l'ente, inteso come
"trascendentale fondante" ogni possibile conoscenza concettuale. Oltre ai suoi
contributi fondamentali nel campo dei fondamenti della metafisica, ci preme
segnalare di Fabro le sue riflessioni sull'uomo e la libertà: all'umanesimo senza
fondamento del pensiero moderno, la speculazione tomistica oppone l'idea che
l'esse è implicato nella stessa struttura costitutiva della persona ed è questo il
modo più alto di celebrare la dignità dell'uomo. Ogni uomo, in quanto essere
spirituale, è un soggetto libero e intelligente e lo spirito umano risulta come
costituito – nell'ordine etico-esistenziale – da una "libertà assoluta per
partecipazione", la quale, ben lungi dal disperdersi in una cieca indifferenza
rispetto agli oggetti da scegliere, si configura come facoltà autenticamente
umana proprio in quanto capace di tendere a Dio come Sommo Bene.
Josef Pieper
Il contributo di Josef Pieper (1904 - 1997) muove a partire dalle aspre critiche
che gli ambienti esistenzialisti (con particolare riferimento a Heidegger e
Jaspers) hanno rivolto contro l'idea di una "filosofia cristiana" che Heidegger
dipingeva come una sorta di "ferro di legno", una contraddizione in termini.
Pieper sottolinea – sulla scorta del pensiero di Tommaso – come il domandare
proprio della filosofia si configuri come una ricerca reale di una risposta:
"Nonostante si sappia che alla fine sta l'incomprensibile, essere alla ricerca di
una risposta e tenersi aperti per essa; mentre per Heidegger 'domandare'
sembra piuttosto significare: rifiutare in linea di principio qualsiasi possibile
risposta, e chiudersi di fronte ad essa (perché essa, di fatto, intaccherebbe il
carattere di domanda della filosofia)" (15). Nella filosofia di Pieper si può
riscontrare un'indubbia centralità del problema antropologico, che si dipana in
tre filoni essenziali: 1) l'uomo deve lottare per vivere da uomo; 2) l'uomo deve rapportarsi con la realtà (non è l'uomo la misura dell'essere,
ma l'essere è misura dell'uomo); 3) l'uomo ha come fine supremo Dio e realizza pienamente la propria umanità
nella misura in cui partecipa di Dio, conosciuto nell'amore. L'attualità del tomismo, per Pieper, non risiede tanto nel fatto che esso offra
alla modernità ciò che essa esplicitamente chiede, ma ciò di cui ha
profondamente bisogno, come risposta ai propri problemi irrisolti. Pieper ha
costruito una sintesi originale, che assimila in un impianto autenticamente
tomistico elmenti platonici, neoplatonici, agostiniani e aristotelici: fossilizzarsi
nella pura ripetizione di tesi tomistiche sarebbe decisamente "anti-tomistico". Il
tomismo infatti – secondo Pieper – unisce alla capacità di cogliere i valori
trascendentali e i principi metafisici della realtà, la consapevolezza del limite di
ogni conoscenza umana, superando tentazioni storiciste o relativistiche; esso
esclude altresì prospettive come quelle hegeliana e marxista che pretendono di
possedere la chiave di lettura dell'Assoluto che si realizza nella storia. In
conclusione di un saggio sulla questione della verità, Pieper scrive che
"giammai l'uomo comprenderà – ossia conoscerà fino in fondo – la natura delle
cose. E mai saprà misurare la totalità dell'universo. (...) La conoscenza
dell'essenza delle cose e la conoscenza della totalità delle cose, è stata
concessa all'uomo 'come speranza futura'. Ciò significa: ogni sforzo conoscitivo
sarà sì un positivo progresso, e non sarà per principio inutile; ma avrà anche
sempre come risultato un nuovo non-ancora. (...) L'uomo è capax universi (e a
tal punto che lo stesso universo, proprio perché non è 'tutto', non riesce a
saziarlo). (...) Perché l'uomo è situato nel centro di un mondo che al di là di
quanto è da noi via via conosciuto tiene sempre pronto l'imprevedibile; perché
egli è un essere che vive al cospetto della totalità delle cose esistenti e la cui
interiore sconfinatezza non è che la risposta alla inesauribile immensità del suo
mondo. Questo mondo a sua volta risponde – questa è la sua natura – al verbo
creatore dell'intelligenza divina, nella cui 'arte' gli archetipi del mondo sono
vita. Poiché l'universo delle cose esistenti 'è posto fra due intelletti', il divino e
l'umano. E il ciò, come ben sa la tradizione metafisica occidentale, si fonda la
verità delle cose" (16).
Note
(1) L'Accademia tomistica di Bologna fu fondata nel 1853 da Marcellino
Venturoli, da Francesco Battaglini Ufuturo cardinale di Bologna, da
Giambattista Corsoni e Achille Sassoli Tomba, per citare solo i principali.
(2) Possiamo anzi affermare che il "tomismo imposto per decreto" che
caratterizza il pontificato di Pio X e si traduce nella pubblicazione, il 27 luglio
1914, delle 24 tesi tomiste, redatte dal p. Guido Mattiussi (successore di Billot
alla Gregoriana) per conto della Congregazione degli Studi non ha certamente
giovato al progresso dell'autentica riflessione filosofica genuinamente ispirata a
Tommaso. Si trattava di un tomismo semplificato, coartato in formule riduttive,
ben lontano dall'autentica tensione filosofica che caratterizzava gli scritti
dell'Aquinate.
(3) A. D. Sertillanges, Le Thomisme, cit. in Aa. Vv., La filosofia cristiana nei
secoli XIX e XX, II. Ritorno all'eredità scolastica, Città nuova, Roma 1994, p.
570.
(4) Può essere utile citare un passaggio cruciale dell'opera del nostro autore:
"Il contenuto della filosofia cristiana è dunque il corpo delle verità razionali che
sono state scoperte, approfondite, o semplicemente salvaguardate, grazie
all’aiuto che la rivelazione ha apportato alla ragione. Se questa filosofia sia
realmente esistita, o se essa non sia che un mito, è una questione di fatto che
noi chiederemo alla storia di risolvere. (...) Il filosofo cristiano si domanda
semplicemente, se tra le proposizioni ch’egli crede vere, ce ne sia un certo
numero che la sua ragione potrebbe saper vere. Finché il credente fonda le sue
asserzioni sulla persuasione intima, che la sua fede gli conferisce, egli rimane
un puro credente e non è ancora entrato nel dominio della filosofia; ma dal
momento in cui egli trova nel numero delle sue credenze alcune verità che
possono divenire oggetto di scienza, egli diventa filosofo, e se deve questi
nuovi lumi filosofici alla fede cristiana, diventa un filosofo cristiano" [E. Gilson,
Lo spirito della filosofia Medievale, trad. it. ed. Morcelliana, Brescia 1983, pag.
42].
(5) E. Gilson, Le réalisme, cit. in Aa. Vv., La filosofia cristiana nei secoli XIX e
XX, II. Ritorno all'eredità scolastica, Città nuova, Roma 1994, p. 618.
(6) Amato Masnovo, Gnoseologia e metafisica, cit. in Aa. Vv., La filosofia
cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all'eredità scolastica, Città nuova,
Roma 1994, p. 772.
(7) Cit. in Aa. Vv., La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno
all'eredità scolastica, Città nuova, Roma 1994, p. 660.
(8) Ci siamo permessi di collocare la figura di Edith Stein nella seconda metà
del XX secolo, a dispetto delle coordinate anagrafiche in cui appare evidente la
prematura morte nel 1942, perché – oltre ad essere contemporanea di altri
intellettuali come Przywara (che ella conobbe personalmente e dal cui pensiero
fu profondamente stimolata) e Maritain, il fatto che le sue opere non potessero
essere pubblicate durante gli anni del totalitarismo nazista, ha portato ad una
circolazione delle sue idee (quindi ad un suo influsso reale sulla storia del
pensiero) solo nella seconda metà del secolo.
(9) Nato a Parigi nel 1882 in una famiglia di tradizioni repubblicane e di fede
protestante, studiò filosofia alla Sorbona (in un clima di relativismo e
scetticismo, mentre la cultura era dominata dalla tradizione positivista), visse
in modo travagliato la propria esperienza religiosa, frequentò ambienti
socialisti (dove conobbe Raissa, sua futura consorte, a sua volta atea, ma figlia
di pii ebrei russi), finché non ebbe modo di ascoltare le lezioni di Bergson che
fecero rinascere – in lui e molti altri – la fiducia nella verità, nella vita, negli alti
ideali. Nel 1904 vi è l'incontro con Léon Bloy, da cui nasce un'intensa amicizia
ed un profondo dibattito interiore che porta i coniugi Maritain (nel 1906) al
battesimo cattolico. Maritain è ancora vicino al bergsonismo, finché l'incontro
con il p. Clérissac lo introduce allo studio di S. Tommaso. La sua riflessione
"tomista" inizia negli anni del primo conflitto mondiale (dove perdono la vita
molti suoi cari amici) e prosegue nel periodo fra le due guerre, finché – nel
1940 – non è costretto a trasferirsi in America per sfuggire alla persecuzione
nazista. Insegna a Princeton ed alla Columbia University. Torna a Parigi nel
1960, anno in cui muore l'amata consorte Raissa. Maritain si stabilisce presso i
Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld, a Tolosa, di cui entrerà a far parte nel
1970. Morirà nel 1973, più che novantenne.
(10) Jacques Maritain, Distinguere per unire: i gradi del sapere, tr. it.
Morcelliana, Brescia 1974, pp. 58-61.
(11) Si tratta di due opere pubblicate negli anni del secondo conflitto mondiale,
durante la permanenza di Maritain negli Stati Uniti: L'educazione al bivio (tit.
originale: Education at the Crossroads, Yale University Press, New Haven
1943; ed. francese: L’éducation à la croisée des chemins, Egloff, Paris 1947),
ed. it. a cura di A. Agazzi, La Scuola, Brescia 1963; e L'educazione della
persona (tit. originale: Pour une philosophie de l'éducation, Librairie Fayard,
Paris 1959), tr. it. di P. Viotto, La Scuola, Brescia 1962.
(12) Jacques Maritain, L'educazione al bivio, cit., pp. 14-15.
(13) Gustavo Bontadini, Conversazioni di metafisica, cit. in Aa. Vv., La filosofia
cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all'eredità scolastica, Città nuova,
Roma 1994, p. 805.
(14) Gustavo Bontadini, Metafisica e de-ellenizzazione, cit. in Aa. Vv., La
filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all'eredità scolastica, Città
nuova, Roma 1994, p. 806.
(15) Josef Pieper, Verteidigungsrede für die Philosophie (Monaco, 1966), cit. in
Aa. Vv., La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, II. Ritorno all'eredità
scolastica, Città nuova, Roma 1994, p. 760.
(16) Josef Pieper, Verità delle cose. Un'indagine sull'antropologia del Medio Evo
(tit. orig. Wahrheit der Dinge. Eine Untersuchung zur Anthropologhie des
Hocmittelaters, Monaco 1944, IV ed. 1966), tr. it. di L. Frattini, Massimo,
Milano 1981, pp. 117-123, passim.
LA CONTROVERSIA TRA SEVERINO E BONTADINI: SPUNTI E RIFLESSIONI
di Andrea Damiani http://www.filosofico.net/bontadiniseverinocontroversia.htm
Iniziato nel 1964, con la pubblicazione dell’articolo Ritornare a Parmenide, il confronto tra
Emanuele Severino e il suo antico maestro Gustavo Bontadini si protrasse per circa un
ventennio. Stando al parere di molti critici, i due protagonisti della discussione, peraltro
legati da profondo affetto e sincera stima reciproca, non hanno mai modificato in modo
essenziale le loro posizioni originarie; questo anche se a volte, per quanto riguarda
Bontadini, si è voluto parlare di un “certo cambiamento di rotta”.
Alcuni studiosi, poi, hanno riscontrato in tale discussione una specie di impasse, in cui
essa è venuta a trovarsi, a causa dei non pochi fraintendimenti generati dal differente
utilizzo, da parte dei due autori, di concetti basilari quali “essere”, “contraddizione” o
“divenire”. In ogni caso, prendendo in esame gli scritti in cui è concentrato il dibattito fra i
due, ci pare di poter concordare con quanti sostengono la seguente tesi: pur se la critica
bontadiniana non riesce ad argomentare in modo risolutivo i problemi che emergono dalle
considerazioni di Severino, occorre tuttavia ammettere che Bontadini ha ragione nel
ritenere insoddisfacenti, in certi punti, le repliche del suo discepolo.
A distanza di più di quarant’anni dalla comparsa di Ritornare a Parmenide e dell’articolo di
Bontadini Sozein ta fainomena, che di quello costituiva la prima e immediata risposta, che
valore possiamo attribuire oggi a questa controversia? Non è possibile, in questa sede,
presentare in modo esaustivo il pensiero dei due illustri filosofi, e non ve n’è neppure
l’intento. Ciò che qui si vuole mostrare è lo svolgimento di questo interessante dibattito nei
suoi punti più salienti, perché questo potrebbe essere lo spunto per proporre alcune
importanti considerazioni e riflettere su determinati problemi ancora aperti.
Nonostante Severino avesse già accuratamente elaborato ed esposto la sostanza del
proprio pensiero ne La struttura originaria, (l’opera in cui tutti i suoi scritti, come egli stesso
ebbe ad affermare nell’Introduzione del 1981, “ricevono il senso che è loro proprio”), il
dibattito vero e proprio ebbe inizio, come già detto, con la pubblicazione di Ritornare a
Parmenide nel 1964. Il neo-parmenidismo severiniano imponeva di ripensare, alla luce
della verità del logos, tutta la storia della metafisica nei termini di un fondamentale
nichilismo. Partendo dall’istanza parmenidea in base a cui “l’essere è e non può non
essere”, si doveva constatare che, dopo Parmenide (ma forse già a partire dallo stesso
eleate), questa caratteristica fondamentale dell’essere (cioè la sua eterna opposizione al
non-essere, al nulla) fu applicata soltanto ad un certo tipo di essere, ossia l’Assoluto.
Soltanto di questo ente privilegiato, trascendente rispetto al mondo, ci si sentì autorizzati
ad affermare che esso non potesse non essere. Tutte le altre cose (uomini, alberi, case
ecc…) di cui è costituito il mondo, e nelle quali quotidianamente ci imbattiamo, potevano
tranquillamente essere concepite come indifferenti all’esistenza (come oscillanti, cioè, tra
l’essere e il nulla). Questa l’essenza del nichilismo: l’essere è (almeno un certo tipo di
essere), ma può anche non essere. Tale è la follia dell’Occidente, magistralmente
espressa, secondo Severino, da questa breve asserzione tratta dal De interpretazione di
Aristotele: “E’ necessario che l’essere sia, quando è, e che il non essere non sia, quando
non è”. Il “quando” starebbe appunto ad indicare la possibilità di un tempo in cui l’essere
non è ; o, che è lo stesso, l’inserimento dell’essere nel tempo. E il nichilismo sarebbe
oramai diventato il modo di pensare comune a tutti gli uomini.
Chiunque prenda in mano un manuale di storia della filosofia constaterà che, dopo le
pagine in cui si discorre di Parmenide e dei suoi discepoli, i capitoli successivi sono quasi
sempre dedicati a quei filosofi, detti “pluralisti”, che hanno tentato di risolvere l’aporia del
divenire, generata dalla potenza argomentativa del pensiero dell’Eleate, che rendeva
l’essere immobile ed immutabile, e dalla attestazione del divenire nell’esperienza, che
negava invece tale verità. Anche dal punto di vista del senso comune, immagino che la
maggior parte di quanti si siano accostati per la prima volta allo studio della filosofia
(magari al liceo!) abbiano provato, leggendo il pensiero di Parmenide, un senso di
ammirazione e di insoddisfazione al contempo; quasi che, dopo aver assurto alle alte vette
speculative del pensiero (per altro affascinanti), si attendesse con ansia un ritorno alle
cose del mondo, che da Parmenide erano state relegate nell’ambito di una mera illusione.
Pena, un’irrimediabile scissione tra la verità che si può ottenere attraverso la pura teoresi
e la nostra vita di tutti i giorni; e, da ultimo, la sensazione di una sostanziale inutilità della
filosofia la quale, pur discorrendo di cose nobilissime, non riesce a spiegare la sterminata
varietà e ricchezza di cose che popolano l’universo in cui abitiamo. Continuando a
sfogliare il nostro manuale, questo processo di riconciliazione tra la verità del logo e il
referto dell’esperienza sembra giungere alla sua prima rilevante tappa, dopo gli sforzi di
Empedocle, Anassagora e Democrito, con il pensiero di Platone; l’intento del quale, come
ben sappiamo, fu proprio quello di rendere ragione della molteplicità dei fenomeni e
insieme dell’unicità dell’essere. E tale intento si realizzò mediante l’introduzione della
“Dottrina delle Idee” e del cosiddetto “parricidio”.
Rendere ragione della molteplicità dei fenomeni, ossia “salvare i fenomeni”: Sozein ta
fainomena, appunto. L’essenziale della prima replica bontadiniana si scorge già a partire
dal titolo dell’articolo suddetto; la critica principale rivolta a Severino è proprio quella di
aver lasciato il mondo dell’esperienza in balìa della propria contraddittorietà, e di non
averla risolta. La storia della metafisica, dunque, contrariamente a quanto aveva sostenuto
il suo antico discepolo, non era affatto per Bontadini la storia della comprensione
inautentica dell’essere, dominata dal nichilismo. Al contrario, essa rappresentava lo sforzo
filosofico di superare la contraddizione del divenire attestato nell’esperienza. In essa,
infatti, il divenire è qualcosa di evidentemente manifesto; e se la ragione guarda a questo
divenire come a qualcosa di contraddittorio (perché il divenire altro non è che il passaggio
dall’essere al non essere, e viceversa) è compito della ragione stessa il togliere di mezzo
tale contraddizione (che sarà quindi, soltanto, una contraddizione apparente). L’errore di
Severino sarebbe quello di aver creato una distinzione ipostatica fra i due mondi, cioè
quello immutabile dell’Essere e quello diveniente dell’esperienza; lo stesso errore che
aveva commesso Parmenide, con l’aggravante che adesso non è più accettabile
rinchiudere il sensibile-diveniente nella casella dell’illusione.
Lo sforzo filosofico della metafisica di conciliare i due mondi, dunque, dopo i tentativi
inadeguati (ma sempre sullo sfondo della Verità) di Platone prima e del neoplatonismo poi,
giungeva a realizzarsi pienamente con la filosofia patristica e con la scolastica, mediante il
concetto (sconosciuto alla mentalità greca) di creatio ex nihilo.
Infatti, la potenza del Dio creatore (l’essere originario e immutabile) toglieva di mezzo la
contraddizione del divenire, visto ora non più come qualcosa di originario, ma di derivato.
Secondo Bontadini, dunque, se il divenire viene pensato come qualcosa di derivato (quindi
non originario), allora esso non è più contraddittorio; l’immutabilità originaria dell’essere,
(o, che è lo stesso, l’immutabilità dell’essere originario, Dio), rimane comunque garantita, e
la sua potenza creatrice (e conseguenzialmente anche quella annichilitrice) permette di
pensare senza contraddizione al divenire delle cose sensibili.
Non solo. Severino aveva affermato, sempre in Ritornare a Parmenide, che il Dio della
patristica e della scolastica rappresentava la più grande elaborazione metafisica della
ragione alienata, essendo un Dio creatore dell’assurdo (cioè di un essere che esce dal
nulla e ritorna nel nulla; un essere che è ma può anche non essere; un essere che è un
niente); Bontadini, al contrario, poteva replicare che l’unico modo possibile di pensare la
non assurdità (cioè la non contraddittorietà) della realtà, in continuo divenire, era quello di
pensare ad un Dio onnipotente che l’avesse creata. Non già un Dio assurdo creatore
dell’assurdo, bensì un Dio che ci salva dall’assurdità.
La replica di Bontadini sembra a prima vista essere convincente. Non solo essa ci toglie
da quell’imbarazzo misto a incredulità, che pervade il nostro animo dopo aver letto le
pagine di Ritornare a Parmenide (sensazione molto simile a quella, cui si è accennato
prima, provata dallo studente che s’imbatte per la prima volta negli scritti di Parmenide);
ma presenta anche il vantaggio, molto rassicurante, di ripercorrere la storia della filosofia
seguendo quell’impostazione “classica” che ci è stata trasmessa, da insegnanti e manuali,
sin da ragazzi. Tutti noi, sicuramente, abbiamo avuto modo di leggere sui libri o di sentire
in qualche lezione che la filosofia greca, mancando di concetti fondamentali quali
“creazione” o “libertà”, non riesce a risolvere le aporie in cui essa è venuta ad imbattersi.
Soltanto pensando ad una creatio ex nihilo, concetto ereditato dalla cultura giudaicocristiana, ci è possibile ripensare le istanze della speculazione ellenica sotto una luce
diversa, che elimina gran parte delle contraddizioni. Non si tratta di una adesione
personale ad una fede particolare (di cui gli autori di patristica e scolastica sono stati illustri
esponenti); non si vuole cioè affermare che l’unico modo possibile di pensare la realtà sia
quello di credere in Dio; diciamo semplicemente che, se il pensiero metafisico ha ritenuto
valido il principio parmenideo (l’essere è e non può non essere), allora ci accorgiamo che
tale pensiero (sempre se vuol tenere saldo di fronte a sé il principio) va incontro a diversi
problemi, e che questi problemi sembrano trovare un’adeguata soluzione soltanto
attraverso il concetto di creazione, di origine cristiana.
La risposta di Bontadini, dunque, ci potrebbe apparire soddisfacente e ci potrebbe far
pensare a Severino come ad un bizzarro personaggio che, incallitosi testardamente con
una delle prime sentenze del pensiero metafisico, ha poi deliberatamente ignorato due
millenni e mezzo di storia della filosofia, misconoscendone il valore. Ma l’apparenza
spesso inganna, e Severino non è certamente un filosofo che si lascia intimidire dai
manuali di storia della filosofia o dal senso comune; in effetti, con la pubblicazione nel
1965 del suo Poscritto, il filosofo bresciano chiarisce definitivamente quanto ancora era
rimasto implicito del suo pensiero, rispondendo in modo inequivocabile alle obiezioni
rivoltegli fino a quel momento (in primis proprio a quelle di Bontadini).
Se la critica mossa a Severino era stata, come si è detto, essenzialmente incentrata sul
fatto che egli aveva deliberatamente lasciato il mondo dell’esperienza in balìa della propria
contraddizione, cioè della contraddizione del divenire; ora, dalle pagine del Poscritto,
emerge una considerazione ancora più sconcertante: il divenire (inteso come il passaggio
dal non essere all’essere, e viceversa) non è assolutamente attestato dall’esperienza. La
comprensione inautentica del senso dell’essere, che domina tutto il pensiero
dell’Occidente, ha prodotto come sua principale conseguenza una comprensione
inautentica del senso del divenire, sì che il divenire è erroneamente interpretato come un
processo in cui ne vada dell’essere. Ma ciò è un’assurdità, perché all’essere (ad ogni
essere) non è consentito in alcun modo di non essere.
L’esempio del pezzo di carta che brucia, addotto dallo stesso Severino, è rimasto celebre:
vedendo un pezzo di carta che brucia, e che “diventa” cenere, il senso comune (o, come
dice Severino, la “ragione alienata”) afferma appunto che, dopo essersi completamente
bruciato, quel pezzo di carta non c’è più. Quell’essere, che noi chiamavamo “il pezzo di
carta”; quell’essere che prima era e che, nel tempo in cui era, si opponeva al nulla; quel
positivo, adesso che si è bruciato ed è stato ridotto in cenere, non esiste più. L’essere è
trapassato nel non essere; l’essere che, appunto, si oppone al non essere fin tanto che
esso è. E, secondo la ragione alienata, questo non esser più dell’essere è attestato
dall’esperienza.
Ma l’esperienza, afferma Severino, non attesta affatto questo non esser più dell’essere. Il
dato fenomenologico puro, libero da ogni interpretazione nichilistica, mostra soltanto che
quell’essere, che è il pezzo di carta, non appare più. Il fatto che quell’essere non appaia
più non ci autorizza ad affermare che esso non è più. Esso si è semplicemente dileguato
dalla scena dell’apparire, ma l’esperienza (vista alla luce della comprensione autentica del
logos) non dice nulla circa le sue sorti una volta che abbia abbandonato tale scena. In tal
modo, ciò che non viene mostrato all’interno dell’apparire (la sorte appunto di quel pezzo
di carta che ora non appare più, perché al suo posto sta apparendo un’altra cosa) è
comunque conosciuto in base alla verità originaria dell’essere. E’ soltanto la ragione
alienata che, interpretando quanto si mostra nel phainesthai, deduce che ciò che più non
appare non sia neanche più; in realtà, in base al principio del logos, noi possiamo sapere
con certezza che quel pezzo di carta, che adesso non appare più, è ancora (ed è
eternamente).
A questo punto, risulta abbastanza evidente che quelle obiezioni di Bontadini comparse in
Sozein ta fainomena, che abbiamo prima sommariamente riportato, vengono a cadere. Se
infatti nell’esperienza, una volta che ci siamo liberati dei nostri pregiudizi alienati e
nichilistici, non si dà alcuna attestazione del divenire (inteso come uscita e ritorno nel nulla
da parte degli enti), in essa non v’è più alcuna contraddizione. Tale contraddizione, infatti,
rimarrebbe insoluta se, una volta affermata l’immutabilità dell’essere, continuassimo a
sostenere che, almeno in questa regione dell’essere, gli enti divengono; ma se il divenire
non è un qualcosa di attestato, bensì soltanto il frutto di una nostra inautentica
interpretazione della realtà, allora non si tratta più di dover conciliare la verità del logos col
referto del phainesthai, giacchè questi due elementi non entrano più in contraddizione tra
di loro.
La contraddizione del divenire, dunque, si risolve pensando il divenire stesso in termini di
apparire-scomparire degli enti, anziché nei termini del loro essere-non essere. Solo in
questo modo, per Severino, il mondo dei fenomeni è veramente tratto in salvo (giacchè
esso è già stato tratto in salvo sin dall’eternità).
Al contrario, la contraddizione non potrebbe essere risolta pensando il divenire in senso
nichilistico, come fa Bontadini insieme a tutta la metafisica occidentale; in realtà, è proprio
in questo atteggiamento nichilistico che si viene creare una separazione ipostatica tra due
mondi (quello “fisico” e quello “metafisico”) e l’introduzione di un Dio trascendente e
creatore ex nihilo non solo sarebbe l’ammissione di un ente creatore dell’assurdo, ma non
sarebbe neppure in grado di operare la riconciliazione fra i due mondi.
Ogni singola determinazione dell’essere (questa casa, questo albero, questo pezzo di
carta) esiste eternamente; ciò che varia non sono dunque gli enti, ma è l’apparire di essi
(poiché quando qualcosa appare, per esempio la cenere, qualcos’altro non appare più,
per esempio il pezzo di carta). Il senso comune e la ragione alienata, invece, permeati
dalla concezione nichilistica dell’essere, credono di constatare il divenire degli enti, cioè il
loro passaggio dall’essere al non essere. E il linguaggio occidentale ha elaborato dei
termini specifici per descrivere (inautenticamente) sia quelle situazioni in cui un ente (che
non era mai comparso prima) compare per la prima volta, sia quelle situazioni in cui ente
(che prima compariva) si suppone che non debba comparire più: tali termini sono appunto
“nascita” e “morte”.
Siamo qui di fronte al nucleo vero e proprio del dibattito: l’interpretazione del divenire.
Questo nucleo ci sembra anche essere il luogo concreto da cui si dipanano tutte le
successive argomentazioni dei due filosofi e, al contempo, l’occasione in cui la
controversia si è imbattuta in quell’impasse di cui si parlava all’inizio. Il confronto fra
Severino e Bontadini, naturalmente, non può essere circoscritto a questo argomento,
giacchè tale confronto comprende tutta una serie di argomentazioni che spaziano
dall’analisi del principio di non contraddizione alla definizione del pensiero contraddittorio,
che in questa sede non è possibile ripercorrere in dettaglio. Tuttavia, il senso complessivo
di tutte queste analisi, dell’uno e dell’altro pensatore, ci pare scaturisca da questo
medesimo nucleo problematico, che è appunto l’interpretazione del divenire. E’ in base a
tale interpretazione, infatti, che è possibile comprendere, dei due interlocutori, le istanze
fondamentali coinvolte nel dibattito. Inoltre, è sempre a partire da questa problematica, e
dai suoi successivi sviluppi, che si può rintracciare il senso di quel “certo cambiamento
cambiamento di rotta” che alcuni addetti ai lavori (primo fra tutti proprio Severino)
avrebbero riscontrato nella speculazione bontadiniana.
Abbiamo visto che le repliche di Severino alle obiezioni del maestro acquistano una valida
potenza argomentativa allorchè venga dimostrato che, nel referto fenomenologico puro,
non si dà alcuna attestazione del divenire in senso nichilistico. Tuttavia, a difesa di
Bontadini, dobbiamo dire che solamente a partire dal Poscritto Severino fornisce
un’adeguata spiegazione del mondo del divenire, in termini di apparire-scomparire. Infatti,
se ci limitassimo alla sola lettura di Ritornare a Parmenide, noteremmo che l’autore, in
alcuni passi, sembra lasciare spazio proprio a quell’interpretazione in base a cui egli, una
volta affermata l’immutabilità dell’essere e l’impossibilità del divenire, non abbia spiegato
come mai il divenire ci appare nell’esperienza. Naturalmente, il divenire di cui ora si
discorre è quello inteso in senso nichilistico, ossia il processo in cui l’essere trapassa nel
non essere (e viceversa). Dando modo di pensare che anch’egli intenda il divenire in base
a questo significato, si comprende perché le obiezioni di Bontadini risultino ragionevoli e
convincenti. Per confermare quanto si è appena detto, riportiamo alcune righe tratte dalle
ultime battute di Ritornare a Parmenide:
“Obiettare a questo punto che la negazione che l’essere non sia resta smentita dal mondo,
in cui l’essere sopraggiunge e dilegua, e cioè in cui l’essere non è, significa, né più né
meno, non tener conto del discorso che è stato fatto. Questo albero è un positivo, e come
tale è e non gli può accadere di non essere, e quindi è eterno, e come eterno dimora nella
casa ospitale dell’essere: tutta la sua positività è già da sempre e per sempre tratta in
salvo laggiù. Se a questo punto si obietta che quest’albero nasce e perisce, e quindi non
è, e quindi c’è un essere di cui si può e si deve dire che non è, onde è manifesta
nell’apparire la falsità della negazione che l’essere che non sia: se così si obietta, si
dimentica che il positivo – ogni positivo -, che appare sottoposto alle vicissitudini del
tempo, è già stato tratto in salvo (appunto mediante il rilevamento dell’impossibilità che
esso, come tutto l’essere, non sia); si che non rimane una qualche porzione o dimensione
del positivo, la quale non sia così salvata e resti abbandonata al tempo: ciò che resta nel
tempo non è qualcosa che non sia posseduto dall’eterno (appunto perché di tutto, e quindi
anche dell’essere che appare nel tempo, si deve dire che è eternamente); sì che il non
essere dell’essere che è nel tempo non smentisce ciò che, per altro, non può essere in
alcun modo smentito: che l’essere è e non può non essere.”
Se teniamo presente il brano appena riportato e le considerazioni fatte poco prima, ci pare
che Bontadini abbia ragione nell’affermare che Severino non tenga in alcun modo conto
del problema del divenire che riscontriamo nell’esperienza, e nel ritenere “strano” questo
suo discorso conclusivo:
“Strana, dico, questa Tua protesta, perché, eadem ratione, un tale, il quale avesse scritto
dei grossi volumi, oppure un opuscoletto, sulla caducità delle cose umane e mondane,
potrebbe, alla fine, lui pure protestare, contro chi gli obiettasse che ‘l’essere è e non può
non essere’, che con ciò non si terrebbe conto di tutte le sue considerazioni. La verità è
che entrambe le proteste sono ingiuste, in quanto è necessario tener conto di entrambe le
istanze: salvare l’incontraddittorietà dell’essere, e, insieme, salvare i fenomeni.”
Soltanto a partire dall’esplicitazione severiniana dell’autentico senso del divenire esposta
nel Poscritto, dunque, è possibile interpretare Ritornare a Parmenide, e
conseguenzialmente anche Sozein ta fainomena, sotto una luce diversa. E, dunque, come
dicevamo, il nocciolo della controversia non sarà più incentrato sulla riconciliazione tra la
sfera dell’immutabile e la sfera del diveniente, bensì sull’interpretazione del divenire, cioè
sulla possibilità di accettare o meno la tesi di Severino in base a cui il divenire, inteso in
senso nichilistico, non solo è assurdo, ma non è neppure attestato dall’esperienza.
Questa tesi è, come era abbastanza facile prevedere, respinta da Bontadini nell’articolo
che costituisce la risposta al Poscritto e che egli intitola Postilla. Le argomentazioni che
portano Severino a sostenere che, nell’autentico referto del phainesthai, non si dà alcun
elemento per affermare la nascita o l’annichilimento dell’essere, non sembrano per
Bontadini essere convincenti.
Anche ammettendo, infatti, che quel famoso pezzo di carta, che la “ragione alienata”
afferma non esistere più, in quanto ha visto bruciare, esiste invece ancora (e eternamente)
nella casa dell’essere; anche ammettendo questo, non si riesce però ad eliminare quel
certo residuo di divenire, cioè il divenire dell’apparire della carta, che è attestato
dall’esperienza. Eccoci qui di fronte alla famosa impasse! Ma per comprendere
pienamente il senso di questa impasse, è necessario riportare, sinteticamente ma con
precisione, alcuni passaggi chiave del pensiero severiniano, che sono stati in parte
equivocati da Bontadini. Ciò che potremmo dire, dopo queste riflessioni, si allinea
sostanzialmente con quanto è affermato nel saggio di Leonardo Messinese intitolato
Essere e divenire nel pensiero di E. Severino:
“La critica di Bontadini non riesce a togliere la tesi di Severino che l’autentica
fenomenologia non attesta il divenire in senso nichilistico. Eppure, occorre aggiungere che
Bontadini ha delle ragioni per continuare a restare insoddisfatto della soluzione
severiniana. Infatti, fermo restando che anche il divenire dell’apparire non può essere
immediatamente identificato al suo ‘annullamento’, resta pur vero che Severino non è
riuscito a fornire un’adeguata spiegazione del variare dell’apparire.”
Prendendo in considerazione alcune pagine fondamentali del Poscritto, ci accorgiamo che
lo stesso Severino si era già in parte cautelato dalle possibili obiezioni che poi gli saranno
effettivamente rivolte nella Postilla. Dopo aver esposto accuramente le sue considerazioni
in merito al senso autentico del divenire, che andrebbe appunto inteso come un processo
in cui non ne va dell’essere bensì dell’apparire, il pensatore bresciano osserva che questa
soluzione potrebbe essere vista come un semplice spostamento dell’aporia; l’entrata
nell’apparire, infatti, è essa stessa un positivo, cosicchè, prima che qualcosa appaia, e
dopo che qualcosa scompare, questo positivo (che è l’essere dell’apparire) non è. (E’,
come si vede, l’obiezione di Bontadini).
La base di questa obiezione, tuttavia, è anch’essa pregna, secondo Severino, di
presupposti nichilistici. Per risolvere questa aporia, il nostro filosofo elabora una
argomentazione per la verità alquanto complessa, sostenendo la seguente tesi: qualcosa
può apparire soltanto se appare il suo apparire. Di solito, invece, si ritiene che l’apparire
sia qualcosa cui sia consentito di non avere come contenuto sé medesimo, e quindi si
pensa che l’apparire sia soltanto l’apparire delle cose, senza essere anche apparire del
loro apparire. Ma questo, osserva Severino, è errato. Infatti, se un ente appare (ad
esempio una lampada), ma non appare l’apparire di questa lampada, allora questa
lampada non può apparire; se, quando questa lampada appare, appare anche il suo
apparire, allora –se questa lampada incomincia ad apparire- incomincia ad apparire anche
il suo apparire; e se questa lampada non appare più, non appare più nemmeno il suo
apparire.
La base dell’obiezione fatta prima, dunque, non può essere una constatazione (ossia non
può essere l’apparire dell’annullamento dell’apparire), perché il discorso che si era fatto
più sopra sul pezzo di carta (o sulla lampada) vale anche per l’apparire di questo pezzo di
carta (o di questa lampada). Come non appare che il pezzo di carta, bruciandosi, divenga
nulla, così non appare nemmeno che l’apparire del pezzo di carta, svanendo, divenga
nulla. Quando si obietta nel modo di cui sopra, si afferma (nichilisticamente) il non essere
di ciò che è già stato posto come un non apparire. Pertanto, Severino può dichiarare che:
“E’ solo perché non ci si rende conto che il comparire e lo scomparire di qualcosa è
insieme il comparire e lo scomparire dell’apparire di qualcosa, è solo per questo motivo
che, in relazione alla posizione del divenire come comparire e sparire dell’essere, ci si
sente autorizzati ad inferire che, dunque, se qualcosa compare e scompare, allora il suo
apparire non è”.
Il divenire che appare è sempre il divenire di una determinazione particolare o empirica del
contenuto che appare, e in ciò si distingue dall’apparire inteso come evento
trascendentale, ossia come l’orizzonte della totalità di ciò che appare. Inoltre, come ogni
altro positivo, l’evento trascendentale è eterno e immutabile: l’unico senso secondo il
quale si può affermare il divenire dell’evento trascendentale è dato dunque dal divenire del
suo contenuto empirico. Infine, si può supporre che delle determinazioni particolari del
contenuto dell’apparire sarebbero potute non apparire, o che non appaiano più; ma non si
può supporre che non sarebbe potuto non apparire nulla, o che potrebbe non apparire più
nulla, perché in tal modo si supporrebbe che quel positivo, che è l’orizzonte totale
dell’apparire, sarebbe potuto o potrebbe essere un niente.
A questo punto, possiamo rimetterci sott’occhio la critica di Bontadini che
precedentemente avevamo iniziato ad esporre; la prima parte di questa, come si ricorderà,
consisteva nel rilevamento che, se anche il divenire di un ente non poteva essere
fenomenologicamente attestato dall’esperienza, tuttavia rimeneva una sorta di residuo di
divenire (perciò di non essere) costituito dal divenire dell’apparire di quell’ente. Questa
prima parte dell’obiezione, non potrebbe forse già essere tolta a partire dalle
considerazioni di Severino appena riportate? Non siamo qui di fronte a quei passaggi
chiave che il filosofo milanese ha in parte equivocato? Ma la critica di Bontadini non si
arresta qui; infatti, proseguendo immediatamente il suo discorso, egli fa notare che:
nonostante sia possibile in qualche modo disgiungere un ente dal suo apparire (in quanto
si afferma che tale ente esiste anche fuori dell’apparire), tuttavia non è possibile
disgiungere l’apparire da sé medesimo (affermando che l’apparire dell’ente esiste anche
fuori dell’apparire, cioè fuori di sé stesso!). Facciamo parlare l’autore stesso:
Quando Severino assevera che, come la carta è eterna, così è anche eterno, eadem
ratione, l’apparire della carta, si deve osservare che, codesto eterno e immutabile apparire
(chiamiamolo S, in omaggio al suo scopritore) non è lo stesso di quell’apparire
(chiamiamolo A) in cui si verifica che, scomparendo la carta, vien meno, con ciò stesso,
l’apparire della carta. Se, infatti, S e A fossero lo stesso, allora, essendo eterno l’apparire
della carta in S, lo sarebbe anche in A. Perciò si deve ammettere che almeno questo
residuo –“l’apparire della carta in A”, o, che è lo stesso, “l’apparire A della carta”- è
soggetto al divenire (in senso classico, cioè come implicante il non essere dell’essere).
Oramai, ci sembra essere giunti proprio in quel punto nevralgico in cui la controversia si
arena perché, se anche la critica di Bontadini non riesce a cogliere pienamente il senso
del discorso severiniano (discorso che, lo ripetiamo, è tutto incentrato sulla considerazione
che ogni divenire, quindi anche quello dell’apparire, deve essere pensato in base alle
categorie dell’apparire-non apparire, e non in termini di essere-non essere); se anche
avviene ciò, sembra che, per quanto siano pienamente coerenti con il suo sistema, le
argomentazioni di Severino non riescano in fin dei conti a togliere quel fastidioso “prurito”
causato dalla legittima domanda: perché accade che in un determinato momento mi
appare qualcosa e nel momento successivo quel qualcosa non mi appare più? Vedremo
più avanti che questo discorso ci porterà a svolgere alcune riflessioni intorno a quel
particolare ente che comunemente chiamiamo “coscienza”, giacchè è proprio in questo
elemento che si può riscontrare quel “residuo” di divenire di cui parla Bontadini.
Finora abbiamo preso in considerazione, dei due autori, soltanto quattro opere: Ritornare
a Parmenide e Poscritto di Severino, e Sozein ta fainomena e Postilla di Bontadini. Le
risposte di Severino alle ultime critiche di Bontadini di cui si è poco anzi parlato, apparse
nella Postilla, sono esposte in un altro breve articolo, intitolato appunto Risposta ai critici.
In particolare, all’obiezione bontadiniana per cui non era possibile disgiungere l’apparire
da sé medesimo, Severino replica che il vecchio maestro, nella sua critica, non aveva
tenuto in alcun modo presente la distinzione essenziale tra l’apparire empirico e l’apparire
trascendentale; in base a tale distinzione, dunque, non si intende affatto negare che
l’apparire empirico “venga meno”, ma il suo “venir meno” è il suo sparire, il suo uscire
dall’apparire trascendentale, e non (come si era voluto sostenere) un divenire in senso
classico (implicante il non essere dell’essere). Per la verità dell’essere, infatti, ciò che
diviene è appunto l’eterno; l’eterno, che non può divenire in senso nichilistico, è appunto
ciò che diviene in senso non nichilistico, e cioè si rivela storicamente, processualmente.
Per comprendere meglio il punto che è stato frainteso da Bontadini, è opportuno rilevare
che, quando Severino si serve di espressioni come “entrare” o “uscire” dall’apparire, egli
utilizza questi verbi di “movimento” in un senso fondamentalmente metaforico, e non per
esprimere un qualche movimento reale; “entrare nell’apparire” significa semplicemente:
l’apparire è attestato; così come “uscire dall’apparire” significa che l’apparire non è
attestato. Ma, pur non essendo attestato, l’apparire comunque è, ed è eternamente. Una
volta compreso questo, possiamo notare che:
Contrariamente a quanto sostiene Bontadini, si deve dire che l’apparire immutabile della
carta (=S) è lo stesso apparire che entra ed esce dall’apparire ed è altro dall’apparire in
cui esso appare, cioè l’apparire trascendentale, laddove il filosofo milanese, identificando
“l’apparire della carta in A” con “l’apparire della carta” simpliciter, pone l’eguaglianza tra
un’espressione che comprende l’apparire empirico e quello trascendentale, con un’altra
che esprime il mero apparire empirico.
Ma, come abbiamo già detto in precedenza, anche se Bontadini non riesce a cogliere
appieno il senso dell’apparire severiniano, resta pur vero che un qualche “residuo” di
divenire rimane ineliminabile, perché, anche laddove volessimo intendere il divenire come
il rivelarsi progressivo e processuale dell’eterno, tuttavia ci sembra di poter dire che
qualcosa “varia”, si “muove”, perlomeno all’interno della coscienza. E dunque bisognerà
fare alcune riflessioni intorno a questo particolare ente (che è l’ente che attesta l’apparire
degli enti).
Severino, dunque, rimprovera il suo maestro di non aver tenuto conto della differenza tra
apparire empirico e apparire trascendentale; Bontadini, dal canto suo, replicherà all’ex
allievo che la sua critica era proprio basata su tale distinzione (che egli non accettava). A
questo punto, ci troviamo di fronte ad una semplice domanda: ha senso dire che qualcosa
appare, ma che non appare il suo apparire (e, quindi, non appare)? Per Severino, ciò che
appare, appare eternamente; quindi, se qualcosa ora non appare più (per esempio il
pezzo di carta che è andato bruciato), è semplicemente scomparso il suo apparire (e cioè
il suo apparire non è più attestato): ma da ciò non si può inferire che il suo apparire non è
più. Se questo pezzo di carta, ora, mi appare, ciò significa che non solo mi appare il pezzo
di carta, ma che mi appare anche il suo apparire; e se il pezzo di carta non mi appare più,
ciò significa semplicemente che non mi appare più il suo apparire, anche se in realtà il
pezzo di carta continua eternamente ad apparire (solo che tale apparire non è più
attestato).
Per Bontadini, invece, tutto questo discorso è errato, giacchè non ha senso dire che un
ente, che non appare più, appare eternamente. Se in un momento x mi appare la carta, e
nel momento x’ la carta non mi appare più, allora essa simpliciter non appare più.
Si è già notato che Bontadini, affermando che l’apparire eterno della carta S non coincide
con l’apparire empirico della carta A, commette un errore, in quanto, nella prospettiva
severiniana, l’apparire S è lo stesso dell’apparire A; l’apparire A significa che l’apparire S è
attestato (o, che è uguale, che nell’apparire di A, ciò che appare è S).
Per meglio comprendere il concetto severiniano di “apparire dell’apparire” si può fare un
esempio molto banale. Supponiamo di avere davanti a noi una penna; questa penna ci
appare, e ciò significa che l’apparire è strutturalmente connesso a questo ente, che è
appunto la penna. Ebbene, se noi ora prendessimo questa penna e la chiudessimo dentro
un cassetto, in modo tale che non la vediamo più, potremmo sostenere – secondo la
logica severiniana - che la penna appare ancora, solo che non ci appare il suo apparire.
La penna, che ha come sua proprietà quella di apparire, appare anche quando è chiusa
nel cassetto; ma, dal momento che noi non riusciamo a vedere che cosa c’è dentro il
cassetto, avviene che il suo apparire non ci appare (cioè non è attestato, è uscito
dall’“apparire trascendentale”).
Tale considerazione, tuttavia, porta a spostare l’attenzione sull’elemento della coscienza
(cui qualcosa appare). Se è la coscienza ciò a cui appare l’apparire, cioè se è la coscienza
ciò che compie l’attestazione dell’apparire; e se, d’altra parte, “entrare” ed “uscire”
dall’apparire trascendentale significano, rispettivamente, che la coscienza attesta oppure
non attesta l’apparire; e se, infine, dire che il pezzo di carta non appare più significa che la
coscienza non attesta più il suo apparire (eterno); in base a tutte queste premesse,
possiamo fare due supposizioni:
a) O la stessa coscienza presenta nel “tempo” due determinazioni diverse, cioè (1)la
coscienza che ha come contenuto l’apparire della carta e (2)la coscienza che non ha tale
contenuto (cioè avviene che “prima” essa attesta l’apparire dell’ente, e dopo essa non
l’attesta più); in tal modo è possibile recuperare l’obiezione bontadiniana in quanto quel
positivo, costituito dalla mia coscienza che ha come contenuto 1 si annulla (diviene) per
far posto a quell’altro positivo (che di quel primo costituisce il negativo, il non essere)
costituito dalla mia coscienza che ha come contenuto (2).
b) Oppure, anche per la coscienza, vale il medesimo discorso che Severino ha fatto per gli
altri enti. Se ogni determinazione dell’essere è eterna e immutabile, allora gli enti non
divengono; il divenire degli enti sarebbe il semplice susseguirsi di tanti enti diversi.
Prendiamo come esempio il solito pezzo di carta che brucia e consideriamo, per comodità,
soltanto quattro momenti: 1) il pezzo di carta è integro; 2) il pezzo di carta inizia a
prendere fuoco; 3) il pezzo di carta è bruciato a metà; 4) il pezzo di carta è tutto ridotto in
cenere. Ebbene, laddove (secondo Severino) il senso comune e la ragione alienata
sostengono che, ciò che si è visto nel susseguirsi di 1, 2, 3 e 4, è lo stesso pezzo di carta
che si modifica e diviene, fino addirittura a diventare nulla; la verità del logos e l’autentico
referto fenomenologico impongono invece di pensare che 1, 2, 3 e 4 sono tutte eterne
determinazioni dell’essere che, semplicemente, appaiono in successione. 1 è eterno, così
come eterni sono 2, 3 e 4. Ciò significa che la carta che appare in1 non è la stessa carta
che appare in 2, e che la carta che appare in 2 non è la stessa carta che appare in 3, e
così via. E così ci sarebbero tanti pezzi di carta, ognuno dei quali eterno e immutabile, che
appaiono in successione. Ebbene, tale discorso, seguendo la logica severiniana, va
applicato anche a quell’essere che è la coscienza; in tal modo, certamente, non saremmo
più obbligati a pensare ad una coscienza in divenire (in quanto diviene il suo contenuto),
ma dovremmo pensare che “la coscienza che attesta l’apparire della carta” non è lo stesso
de “la coscienza che non attesta l’apparire della carta”. Entrambe le coscienze, coi
rispettivi contenuti, sono eterne e immutabili e, semplicemente, si susseguono
nell’apparire (in questo caso nel loro auto-apparire). Dovremmo allora discutere anche su
questo aspetto, cercando di capire in che modo sia possibile una qualche unità della
coscienza: giacchè, se anche di un pezzo di carta in divenire possiamo pensare che, in
realtà, siano tanti pezzi di carta eterni e immutabili, il discorso sembra risultare un po’ più
problematico per quanto riguarda la coscienza, sulla cui unità crediamo di avere maggiori
certezze.
Le considerazioni che abbiamo appena svolto ci portano dunque a rivolgere la nostra
attenzione su di un altro aspetto della controversia, che finora è stato discusso solo
parzialmente. Ogni teoria filosofica, infatti, (ma in generale ogni teoria), non solo si può
distinguere dalle altre per ciò che riguarda i presupposti da cui essa parte e per il modo in
cui tali presupposti vengono sviluppati per costituire un “sistema”; ma anche in base alle
conseguenze che tale teoria implica.
Una teoria materialistica, per esempio, non solo differisce da una teoria creazionistica
religiosa per ciò che concerne l’origine dell’uomo o del mondo; ma è anche evidente che
essa avrà, come coerente conseguenza, il toglimento di categorie quali “bene” o “male”
intese in senso “assoluto”, e pertanto queste categorie verranno concepite in base ad
un’accezione convenzionalistica o utilitaristica. E’ chiaro che queste conseguenze, poi,
non sono riducibili a meri fatti; esse hanno invece un peso specifico per la condotta
dell’uomo. Esse non solo rispondono alla domanda: come stanno le cose? Ma anche alla
domanda: come ci dobbiamo comportare?
L’aspetto della controversia su cui ora vogliamo discutere è appunto quello basato sulle
conseguenze che sono implicate nelle tesi di Severino, perché anche su di esse Bontadini
si è fermato a riflettere. Queste conseguenze sono chiamate da Bontadini “inconvenienti”,
e vengono esposte dall’autore nella seconda parte della Postilla. Il primo di questi
“inconvenienti” è la cosiddetta proliferazione degli enti. Se, infatti, eliminiamo la
concezione “volgare” dell’unico pezzo di carta che, bruciandosi, diviene, e, infine, diventa
un nulla (concezione nichilistica del divenire), allora, dato che dobbiamo ammettere
l’esistenza di un numero infinito di momenti in cui avviene questo bruciarsi della carta,
dovremmo anche ammettere un numero infinito di pezzi di carta (tutti eterni e immutabili)
per ognuno di questi momenti. E Bontadini osserva che questa è una “strana concezione
del reale mondano”. Inoltre, se consideriamo valida tale concezione, sorge (sempre
secondo Bontadini) un altro paradosso: non si comprende come mai al fenomeno “uomo
con barba a1” debba succedere il fenomeno “uomo con barba a2”, e non piuttosto un’altra
cosa (ad esempio un tubo di stufa!), dato che l’uomo con barba a1 è tutta un’altra cosa
dall’uomo con barba a2.
Ma questo non è tutto; scorrendo infatti questo “elenco di inconvenienti”, ci troviamo a
dover fare i conti con quel problema cui abbiamo accennato più sopra, cioè la questione
dell’unità della coscienza. Di fronte a tale problema, infatti, gli aspetti paradossali della
filosofia di Severino, diventano per Bontadini addirittura aporetici, giacchè quando si parla
dell’io, si “tira di mezzo” l’autocoscienza: ovvero, rileva Bontadini, l’io è io perchè si
riconosce come tale (e cioè perché si percepisce come unità, e come unità che diviene).
Se invece eliminiamo questo aspetto, ci troviamo di fronte ad una serie di conseguenze
inconcepibili, e per esempio dovremmo supporre che colui che fa una promessa non sia lo
stesso che è tenuto a mantenerla, e che colui che pecca non sia lo stesso che si pente (di
un peccato pertanto non suo). Ed è anche in questo aspetto che Severino opera una
“deformazione del mondo umano”, in quanto elimina ogni unità del molteplice.
Anche a questo secondo gruppo di obiezioni, che consiste nel rilevamento dei principali
“inconvenienti” che scaturiscono dal pensiero di Severino, il filosofo bresciano ha dato la
sua risposta (in Risposta ai critici). E’ interessante notare che in un suo lavoro precedente,
intitolato Sull’aspetto dialettico della dimostrazione dell’esistenza di Dio (su cui torneremo
in seguito per accennare alla cosiddetta “svolta”), Bontadini aveva affermato che, qualora
nel mondo intelligibile esistesse eternamente ogni singola determinazione che appare nel
sensibile, allora Socrate dovrebbe essere eternamente seduto ed eternamente in piedi;
ma questi positivi sarebbero tra di loro incompatibili, giacché solo nel tempo è possibile
che il medesimo assuma atteggiamenti contraddittori.
Nella Postilla invece, come ha osservato Severino, l’autore milanese definisce tale
molteplicità (lo abbiamo visto) una “strana concezione del reale mondano” e non più – si
badi bene - come un concetto contraddittorio (come aveva fatto in precedenza), e così può
pensare che Socrate in piedi e Socrate seduto esistono eternamente e
incontraddittoriamente. Tuttavia, come si è rilevato prima, ammettendo questo si toglie di
mezzo ogni unità del molteplice: Socrate seduto non sarebbe lo stesso che Socrate in
piedi, e non si comprende nemmeno in che modo sia possibile l’ordine delle successioni.
Unità del molteplice e ordine delle successioni: questi, in sintesi, i concetti su cui si articola
la risposta di Severino che andremo ora ad analizzare. E a questi due problemi egli
risponde facendo due diversi rilievi.
Per quanto riguarda il problema dell’unità del molteplice, che secondo Bontadini sarebbe
stata “tolta di mezzo”, Severino replica che in realtà tale unità continua ad esistere.
Ogni molteplice, infatti, costituito per esempio da Socrate in piedi, Socrate seduto, Socrate
giovane e Socrate vecchio, rimane comunque sotteso da una identità: l’essere Socrate,
appunto. Questa unità è da Severino definita essenza, e tale essenza è ciò che
comunemente viene chiamato “individuo” oppure “cosa”, e che si rapporta ad una
molteplicità.
Ma come si spiega, a questo punto, che certe essenze coappaiono nel medesimo
contenuto (dell’apparire), mentre altre essenze appaiono soltanto in successione? Perché,
in poche parole, accade che l’essenza “uomo” si rapporta ad una molteplicità non
successiva (cioè, per esempio, appaiono insieme e contemporaneamente Socrate e
Alcibiade), mentre l’essenza “Socrate” si rapporta sempre ad una molteplicità successiva
(di modo che non appaiono mai – nell’apparire trascendentale - Socrate seduto e Socrate
in piedi contemporaneamente)?
Per comprendere bene la risposta di Severino è fondamentale tenere presente la sua
definizione di “necessità”; la necessità è, per il pensatore bresciano, ciò la cui negazione è
contraddittoria. Che un triangolo abbia tre lati è quindi necessario, perché la negazione di
tale affermazione è una contraddizione. Ora, al concetto di “necessità” si oppone quello di
“fatto”; il fatto è, per Severino, ciò che non è determinato dalla struttura della necessità. Un
fatto è dunque qualcosa che accade, o che si mostra, o che si presenta in un determinato
modo ma la cui negazione non costituisce affatto una contraddizione (così è avvenuto, ma
poteva anche avvenire diversamente).
Tornando al nostro discorso, dunque, alla luce di quanto adesso abbiamo detto,
comprendiamo perché Severino può rispondere alla domanda precedente in questo modo:
che Socrate e Alcibiade coappaiano, mentre Socrate in piedi e Socrate seduto no, è un
fatto. In quanto fatto, dunque, questo diverso modo di rapportarsi alla molteplicità da parte
di alcune essenze (cioè in modo successivo o in modo non successivo) è un semplice
accadere, ovvero non soggiace ad alcuna necessità. Infatti, Severino non ha problemi ad
ammettere che:
Socrate eterno è pertanto una certa essenza, eternamente reale in una molteplicità di
determinazioni eterne (e dove la stessa successione del loro apparire appartiene al loro
eterno determinarsi). Nell’apparire ruota il ventaglio di questa eterna molteplicità,
mostrando successivamente gli elementi che la compongono (ed è innanzitutto
l’esperienza a dire di quali elementi sia composto). Ma la successione è un fatto, e il
ventaglio potrebbe tutto insieme comparire, il passato insieme al presente e al futuro.
Non solo: anche l’ordine delle successioni è, per Severino, un semplice fatto. E così, alla
domanda di Bontadini che chiedeva perché al fenomeno “uomo con barba a1” dovesse
succedere il fenomeno “uomo con barba a2”, (e non piuttosto un tubo di stufa), dal
momento che si era eliminata la concezione “volgare” dell’unico uomo con barba in
divenire, Severino risponde facendo due osservazioni: in primo luogo, come abbiamo già
detto, anche l’ordine della successione è un mero fatto; in secondo luogo, secondo il
filosofo bresciano, nemmeno la concezione “volgare” dell’unico uomo con barba in
divenire sarebbe in grado di sostituire il fatto con una necessità.
Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un problema che non è di poco conto.
Il discorso severiniano, infatti, introducendo il concetto di “essenza” (che sarebbe ciò che
si rapporta ad una certa molteplicità) ci spinge a chiederci quale sia, in definitiva, il valore
di tale essenza. Anche se volessimo prescindere da tutte quelle essenze che il linguaggio
comune chiama “cose”, ci dovremmo comunque interrogare sul significato di quelle
particolari essenze che il linguaggio comune chiama “individui”. Severino nega che
esistano “individui in divenire” (cioè prima giovani e poi vecchi, prima seduti e poi in piedi),
affermando che con questa espressione si intende in realtà un’essenza che si rapporta ad
un certo molteplice, e che appare –come semplice fatto- in una successione ordinata. Ma
non si ha qui l’impressione che il concetto di “individuo (che diviene)” stia qui, una volta
cacciato fuori dalla porta, rientrando dalla finestra? Lo stesso Severino, infatti, riconosce
che un’essenza, ad esempio l’essenza di Socrate, si rapporta ad un determinato
molteplice omogeneo, rilevando che Socrate seduto e Socrate in piedi sono tra loro meno
eterogenei di quanto non lo siano Socrate seduto e Alcibiade. L’essenza “Socrate”,
dunque, è un’unità di molteplici omogenei, e questa omogeneità costituisce appunto
l’individuo. Sarebbe interessante capire quale siano la natura di questa “essenza” e di
questa molteplicità omogenea.
Bontadini, dal canto suo, rileverà che l’errore di Severino è dato in questo caso dal fatto
che egli utilizza il termine “essenza” sia per indicare l’individuo, sia per indicare
l’universale:
Altro è che due individui, che abbiano caratteri contraddittori (uno dotto e l’altro indotto)
convengano nella stessa specie e/o nello stesso genere, altro è che lo stesso individuo
abbia determinazioni contraddittorie (fuori del tempo). La praedicatio recta è “Socrate è
uomo” e non “l’uomo è Socrate”; ma anche adottando questa ultima predicazione, non è
contraddittorio affermare che “l’uomo è Socrate” e insieme che “l’uomo è Alcibiade” (= non
Socrate), perché l’essenza uomo riceve i predicati contraddittori (se pure si vuol
considerarli tali; giacchè non-Socrate significa diverso da Socrate e non la negazione di
Socrate) in due zone diverse (le due individualità distinte). (Così come questa carta è
bianca dove non è scritta e nera dove è scritta). La cosa va diversamente nel caso di
Socrate dotto e indotto. E’ contraddittorio, cioè, che lo stesso soggetto abbia e non abbia
(insuccessivamente) lo stesso predicato. La “proliferazione” degli enti è inevitabile.
Che Socrate e Alcibiade siano uomini, prosegue Bontadini in una nota dello stesso scritto,
è un dato dell’esperienza, per cui la distinzione tra individuo e universale è necessaria per
evitare la contraddizione (giacchè in tal modo è possibile pensare che l’universale “uomo”
abbia predicati contraddittori, come dotto e ignorante, attribuiti a diversi individui). Ma che
lo stesso individuo sia, contemporaneamente, dotto e ignorante, questa è una
contraddizione insanabile. Ora, secondo Bontadini, la contemporaneità è un’espressione
che riguarda il mondo empirico, sensibile; il suo analogo, nel mondo intelligibile è dato
dalla eternità. Severino aveva sostenuto che è contraddittorio che “Socrate seduto” sia in
piedi (così come è contraddittorio che Socrate sia Alcibiade), ma non è contraddittorio che
l’essenza Socrate si realizzi, eternamente, come Socrate seduto e insieme Socrate in
piedi. Ma, secondo Bontadini, è proprio il termine “insieme” che qui indica la
contraddizione; com’è possibile, infatti, che chi è seduto sia insieme non seduto? Se è
impossibile che Socrate-che-è-in-piedi sia seduto, è altresì impossibile che Socrate si
realizzi eternamente come Socrate seduto e insieme come Socrate in piedi.
Prima di passare alla parte finale del nostro lavoro, nella quale faremo qualche
considerazione personale in merito a questioni non soltanto teoretiche (ma anche
metodologiche e antropologiche), è opportuno fare adesso una breve incursione in quella
questione di cui si è parlato all’inizio: il cosiddetto “cambiamento di rotta” da parte di
Bontadini. Con questa espressione si è voluto alludere ad una specie di “ripensamento”
che, dopo la lettura di Ritornare a Parmenide, Bontadini avrebbe operato nella sua
filosofia; tale ripensamento non è stato osservato soltanto da Severino, ma pure da molti
critici ed amici del pensatore milanese. Tuttavia è opportuno rilevare che, mentre
Bontadini ha sempre considerato la sua “svolta” una mera esplicitazione di quanto,
peraltro, egli aveva sempre sostenuto (e pertanto egli parla di “continuità” tra le sue prime
e le sue ultime riflessioni, negando che contrastino le une con le altre); Severino, da parte
sua, sostiene che l’unica continuità tra il primo e il secondo pensiero bontadiniano,
radicalmente diversi, sia data unicamente dall’atteggiamento nichilistico.
Se, infatti, (osserva Severino), prima della comparsa di Ritornare a Parmenide, Bontadini
aveva sostenuto, nella sua impostazione metafisica, l’impensabilità del divenire originario
(e, quindi, non l’impensabilità del divenire in quanto tale) dimostrando di non avere nulla in
contrario a sostenere che almeno un certo tipo di essere (quello che si incontra
nell’esperienza) diviene; ora, dopo l’articolo del ’64, egli si rende conto che il divenire in
quanto tale risulta contraddittorio (cioè è contraddittorio pensare che l’ente non sia), ma
utilizza questa affermazione per costruire una “nuova dimostrazione dell’esistenza di Dio”.
(Ricordiamo che le dimostrazioni metafisiche dell’esistenza di Dio, che troviamo ad
esempio nella scolastica medievale, sono per Severino la massima espressione del
nichilismo, in quanto esse suppongono che non l’ente in quanto tale, ma soltanto un certo
tipo di ente, divino, privilegiato, abbia come proprietà quella di non poter non essere). E in
tal modo Bontadini si sarebbe servito di un’istanza non nichilistica (l’affermazione che
l’ente non può diventare un niente) per iscriverla all’interno di una prospettiva nichilistica
(la dimostrazione dell’esistenza di Dio).
Questa dimostrazione dell’esistenza di Dio è contenuta in un brevissimo articolo di
Bontadini, intitolato Sull’aspetto dialettico dell’esistenza di Dio, che appare negli Atti del
“Sesto congresso internazionale tomista”, del 1965. All’inizio dell’articolo troviamo scritto:
La dimostrazione dell’esistenza di Dio si istituisce nell’incontro tra un’istanza razionale ed
una empirica; la prima corrispondendo all’affermazione della immutabilità, e la seconda al
riconoscimento della mutevolezza del reale. Sta in questo incontro la radice del suo
carattere dialettico.
Se prendessimo in esame soltanto questo brano, potremmo affermare la sua sostanziale
continuità con quanto si dice in Sozein ta fainomena, poiché anche lì si prospettava la
necessità di tenere presente sia la verità del logos (che parla dell’immutabilità dell’essere),
sia il referto dell’esperienza (in cui si attesta il divenire). Proseguendo nella lettura
dell’articolo del ’65, tuttavia, troviamo scritto poco dopo quanto segue:
L’essere è. Questa suprema identità, di cui il divenire è la suprema smentita, riguarda ogni
essere [corsivo nostro]. Riguarda perciò ogni essere di cui abbiamo contezza. L’essere di
cui abbiamo originariamente contezza, prima di ogni dimostrazione o mediazione, è
l’esperienza. Ora l’esperienza stessa ci informa che ogni essere –ogni essere di cui essa è
l’attestazione- non è. Contraddizione tra l’esperienza e la ragione. Contraddizione tra la
contraddizione del divenire (che significa la sua impossibilità) e la sua realtà. (…) La
metafisica è la conciliazione di tale suprema ed originaria contraddizione.
Come abbiamo messo in evidenza in questo breve estratto, Bontadini sta ora affermando,
categoricamente, l’impossibilità del divenire in quanto tale (la contraddittorietà di ogni
atteggiamento nichilistico, l’assurdità che qualsiasi ente trapassi nel non essere). Ed è
proprio in tale affermazione che, secondo Severino, il vecchio maestro avrebbe accolto
l’eredità di Ritornare a Parmenide. Eppure, nonostante il filosofo milanese abbia colto il
primo grande aspetto della verità dell’essere, contenuto nell’articolo suddetto, il suo
atteggiamento nichilistico non gli avrebbe permesso, stando a quanto dice Severino, di
cogliere l’altra istanza fondamentale di quello scritto: l’autentica interpretazione
dell’esperienza (cioè il fatto che nell’esperienza il divenire non è attestato, bensì frutto di
interpretazione nichilistica). E così, sempre secondo il suo vecchio discepolo, Bontadini si
verrebbe a trovare adesso in un vicolo cieco, in quanto –da un lato- egli afferma
l’impossibilità che ogni ente si annulli e –dall’altro- sostiene di vedere l’annullamento
dell’ente. Infatti, nella seconda parte del brano che abbiamo riportato, l’autore afferma
esplicitamente che, nell’esperienza, avviene che ogni ente non è (in quanto appunto
diviene).
Siamo tornati, come si vede, ancora una volta a quel punto nevralgico della discussione,
costituito dall’interpretazione del divenire. Infatti, mentre Severino continua a sostenere
che, non riconoscendo l’autentica configurazione dell’esperienza (in cui non si dà il
divenire), Bontadini è ancora affetto dall’infezione nichilistica, e non riesce pertanto –come
invece vorrebbe- a salvare i fenomeni, perché la loro natura sarebbe irreparabilmente
contraddittoria e la loro creazione da parte di un Dio non riuscirebbe a toglierne l’assurdità;
Bontadini continua ad affermare che, dal momento che il divenire è attestato
dall’esperienza, il compito della metafisica è quello di risolvere l’apparente contraddizione
tra l’istanza empirica e quella razionale, e tale soluzione è data dalla postulazione di un
Dio trascendente e creatore della realtà diveniente, e quindi dall’affermazione che il
divenire non può essere originario.
Il “cambiamento di rotta” nella posizione bontadiniana risiederebbe nel fatto che, dopo
Ritornare a Parmenide, l’autore milanese avrebbe riconosciuto la contraddittorietà logica di
ogni divenire in quanto tale. Tale riconoscimento implica che, se ogni divenire è
contraddittorio, allora è contraddittorio pensare che un qualsiasi ente divenga o si annulli.
Ma Bontadini stesso rileva che ciò era già implicito nella sua affermazione precedente alla
comparsa dello scritto severiniano: il divenire è contraddittorio se assolutizzato. Questa
affermazione sarebbe dunque il risultato dell’incontro e della soluzione fra l’istanza logica
dell’immutabilità ed il riscontro empirico del divenire.
In fin dei conti, come abbiamo più volte rilevato, e come anche lo stesso Bontadini ebbe a
sottolineare in uno scritto (anch’esso rivolto a Severino) intitolato Dialogo di metafisica, la
differenza fondamentale tra il pensiero del maestro e il pensiero dell’allievo è tutta qui:
“nell’ammettere o no che l’esperienza attesti il divenire”.
Che si vogliano intepretare o meno come un “ripensamento” le istanze presentate da
Bontadini nel periodo successivo alla comparsa di Ritornare a Parmenide, è pur vero che i
due autori protagonisti della controversia non hanno modificato in modo rilevante le
rispettive posizioni di partenza; e in tal modo, noi oggi ci troviamo non soltanto di fronte a
due diverse “visioni del mondo” ma, in fin dei conti, anche a due differenti modi di
intendere la filosofia. Forse, a parer nostro, quando si affronta il problema della
controversia tra Severino e Bontadini, bisognerebbe prestare maggiore attenzione ad
alcuni aspetti che, nonostante possano essere successivamente inclusi e rielaborati
all’interno dei rispettivi sistemi, segnano tuttavia il punto di partenza dei sistemi stessi e,
conseguenzialmente, determinano il valore e il metodo di ciascuna filosofia.
Negli scritti che abbiamo analizzato (che, lo ricordiamo, sono quelli espressamente
coinvolti nel dibattito tra i due), questo punto di partenza è accennato, sia dall’uno che
dall’altro autore; ma è accennato quasi di sfuggita, proprio perché esso non fa parte della
struttura dell’argomentazione filosofica, bensì è (azzardiamo a dire) una scelta iniziale, un
presupposto. Stiamo parlando, ovviamente, dell’adesione ad una Fede, la quale adesione
può determinare il presupposto originario di tutto un approccio metodologico, rispondendo
sostanzialmente a questa fondamentale domanda: qual è il luogo privilegiato in cui si
mostra la Verità? In Ritornare a Parmenide troviamo scritto quanto segue:
La filosofia è il luogo, la custode della verità. Il disvelamento originario e assoluto
dell’essere –la verità dell’essere, appunto- accade non altrove che nel filosofare. E nel
filosofare autentico. Altrove –in ogni attività o dimensione che non sia la stessa apertura
originaria della verità dell’essere- esiste la non-verità (che è pur sempre la non-verità
dell’essere, il suo aprirsi non veritativo). Alla filosofia, intesa come il solo pensiero
dell’essere (‘pensiero’ in senso forte, cioè come sapere assoluto e incontrovertibile), spetta
inoltre di stabilire in che rapporto stiano con l’essere tutte le altre attività dell’uomo, e le
trova tutte eccentriche rispetto alla verità dell’essere, le trova tutte decadute rispetto a sé:
l’uomo che le vive non vive nella verità, vive nella doxa (nella non-verità). […] In altri
termini, le convinzioni e forme di coscienza diverse da quella convinzione e coscienza
assoluta, in cui consiste l’atto del filosofare autentico, possono trovare il loro fondamento
(nel filosofare) solo in quanto siano sussunte nel filosofare e non in quanto siano vissute
come tali.
Risulta evidente, da questo brano, come per Severino sia soltanto la filosofia il luogo
dell’apertura della verità dell’essere; tutte le altre attività umane, come ad esempio l’arte o
la religione, non solo si trovano al di fuori della verità dell’essere, ma necessitano anche di
essere dedotte e interpretate in base alle strutture della filosofia, perché essa sola ne può
mostrare l’infondatezza e la mancata apertura alla verità. La filosofia e la fede, dunque,
non possono entrare in contrasto tra di loro, giacchè esse non si trovano, per così dire,
sullo stesso piano. La fede deve essere sussunta nella filosofia.
Leggiamo invece ora un brevissimo passo tratto da Sozein ta fainomena, di Bontadini:
Certo questo Tuo evangelo, secondo cui tutto l’essere è già salvo da sempre e per
sempre presso di sé, sicuro da ogni insidia del divenire, “sottratto alla rapina del nulla”,
come Tu sempre bellamente dici, stava per sedurmi […] Poi mi sovvenni che, purtroppo,
ero impegnato, fin dalla puerizia, a mettermi in salvo, e che, per questa salvezza, mi ero
affidato più alla parola di Cristo che non a quella della metafisica. E che non mi riusciva di
cambiare parere.
Se analizzassimo questa diversità di vedute alla luce del classico problema del rapporto
tra ragione e fede, probabilmente ci troveremmo di fronte ad un vicolo cieco; in effetti,
prendendo in considerazione le due differenti impostazioni sistematiche di ciascun autore,
si può notare che, all’interno di ciascun sistema, questo contrasto tra ragione e fede non
esiste. Da un lato, infatti, troviamo l’approccio di Severino, secondo il quale, partendo dal
presupposto che soltanto nella filosofia si dà l’apertura autentica della verità, tutte le forme
di conoscenza non-filosofiche devono essere dedotte e spiegate a partire dalla filosofia.
La fede, pertanto, non essendo un sapere autonomo (in quanto non trova in se stessa il
proprio fondamento) non può entrare in contrasto con la ragione, poiché queste due forme
di conoscenza non hanno la stessa validità. Questa concezione è ulteriormente sviluppata
da Severino in altri scritti che non abbiamo preso in considerazione, in cui l’autore affronta
il problema dell’incompatibilità della sua filosofia con i dogmi della Chiesa Cattolica; tale
incompatibilità, in ultima analisi, sorge a causa dell’adesione (da parte della Chiesa) alla
metafisica classica, quindi della sua apertura al senso alienato e nichilistico dell’essere.
Non si vuole in questa sede discorrere di quanto Severino afferma in merito al contrasto
tra la sua filosofia ed il pensiero religioso (in particolare quello cristiano-cattolico); ciò che
qui interessa rilevare è semplicemente il fatto che, per il filosofo bresciano, ogni forma di
conoscenza diversa dalla filosofia è, di per sé, non veritativa e può (anzi deve) essere
dedotta ed interpretata (qualora se ne voglia conoscere il valore) dall’unico strumento
valido in grado di mostrarci la verità dell’essere: la filosofia, appunto. Il valore della filosofia
è, pertanto, onnicomprensivo. Nessun contrasto, dunque, può sorgere tra fede e ragione:
perché si abbia contrasto, infatti, è necessario che due tesi contrapposte, egualmente
fondate, forniscano entrambe delle valide motivazioni per essere considerate come
assolutamente vere. Ma la fede non fornisce tali motivazioni: esse si trovano solo nella
filosofia.
D’altro canto, neppure Bontadini, strettamente legato ad una concezione tomistica, può
parlare di contrasto tra ragione e fede. Se, infatti, sia la ragione che la fede hanno il loro
fondamento in Dio, il quale è autore di entrambe, allora non è possibile che tra le due ci
sia un contrasto reale. Se vi è contrasto, se cioè la ragione produce un pensiero che è in
disaccordo con una verità di fede, ciò avviene a causa della naturale imperfezione umana;
giacchè, se è lecito supporre che l’intelletto umano nei propri ragionamenti possa
sbagliare e non sia in grado di attingere la verità del tutto, non è invece lecito pensare che
la Parola di Dio sia falsa. Ed è per questo che, per la sua salvezza, il nostro autore ha
dichiarato di fidarsi più della Parola di Cristo, che di quella della metafisica!
Non v’è alcuna intenzione, qui, di analizzare il problema del rapporto tre fede e ragione
nella sua impostazione tomistica; il nostro intento, invece, è quello di offrire qualche
spunto, affrontando la questione sotto una luce leggermente diversa, guardandola (per
quanto è possibile) dall’ “esterno”.
Si è parlato prima dei presupposti che, in un modo o nell’altro, stanno alla base dei due
differenti sistemi proposti da Severino e da Bontadini. Ebbene, che cosa implicano tali
presupposti? Quali scelte metodologiche ne derivano? Sembra che sia possibile, sulla
base delle istanze di questi due autori, ricavare due differenti concezioni dell’uomo e della
filosofia. Se prendiamo in considerazione l’impostazione severiniana, in base alla quale (lo
ricordiamo) la filosofia è l’unica custode della verità, ne deriva che questa (la filosofia) non
può essere considerata, in senso proprio, come un’attività umana, perlomeno non come
un’attività simile alle altre. La filosofia, in questa prospettiva, non è un’atteggiamento
dell’uomo in base al quale egli si mette in cerca della verità adoperando diversi strumenti
(primo fra tutti quello razionale); non esiste più l’uomo che filosofa, nel senso “socratico”
del termine. Esiste, invece, “La Filosofia”, appunto come il luogo unico ed esclusivo nel
quale si dà l’autentica verità dell’essere; e le altre forme di conoscenza devono essere
sottoposte al suo veritiero giudizio. Ma questo è l’unico modo possibile di intendere la
filosofia?
In effetti, ci sembra che sia possibile inquadrare la filosofia secondo un approccio diverso,
dando maggior rilievo, anziché all’aspetto logico, all’aspetto antropologico di questa.
Potremmo pensare, infatti, che all’origine di tutte le attività umane (e di tutte le sue forme
di conoscenza ad esse connesse) ci sia, appunto, l’uomo. In tal modo, ci troveremmo di
fronte ad un ente che, per sua natura, si rapporta all’essere seguendo differenti approcci;
e così potremmo definire la filosofia come la tendenza dell’uomo a comprendere se stesso
e la realtà di cui è parte attraverso lo strumento della ragione; e, allo stesso modo,
potremmo definire la religione come la tendenza, sempre dell’uomo, ad istaurare un
qualche tipo di rapporto con una realtà soprannaturale. Queste caratteristiche dell’essere
umano, poi, allorchè si voglia aderire ad una fede (in particolare la fede cristiana), ricevono
una giusta luce in virtù di una Rivelazione, intesa come l’irruzione della Parola divina
all’interno della storia dell’uomo. L’evento della rivelazione, dunque, sarebbe quel
particolare accadimento storico in base al quale ogni tensione dell’uomo riceve il senso
che le è più proprio. La filosofia e la religione (intese rispettivamente come aspirazione alla
conoscenza razionale e alla comunione col divino) non sarebbero in tal modo negate dalla
fede (cioè dall’accoglimento della Parola rivelata) ma, al contrario, perfezionate da essa.
Questa concezione, tuttavia, è possibile soltanto se si riconosce, in primo luogo, che
l’uomo ha una sua propria natura a cui sono legate tutte le sue tensioni e, in secondo
luogo, che tale natura è imperfetta; dunque, neppure la filosofia (che è un’attività
dell’uomo) può raggiungere un sapere incontrovertibile. Severino, lo sappiamo bene, non
sarebbe d’accordo. L’istanza antropologica non è per lui alcunchè di rilevante giacchè
essa non ha in sé il proprio fondamento. Egli, non partendo dall’anthropos nella sua
totalità, bensì dal logos, dalla verità logica dell’essere, non può che relegare su di un piano
secondario e derivato tutti gli altri aspetti dell’essere, compreso l’essere umano. La scelta,
naturalmente, è legittima. Ma noi, personalmente, ci sentiamo più vicini alla
considerazione di Bontadini, con la quale egli chiude il suo Dialogo di metafisica, e con cui
anche noi vorremmo concludere il nostro articolo: “C’è infatti un certo primato
dell’antropologico sul logico; ed è giusto che tale primato si faccia luce nel dialogo,
soprattutto nel dialogo”.