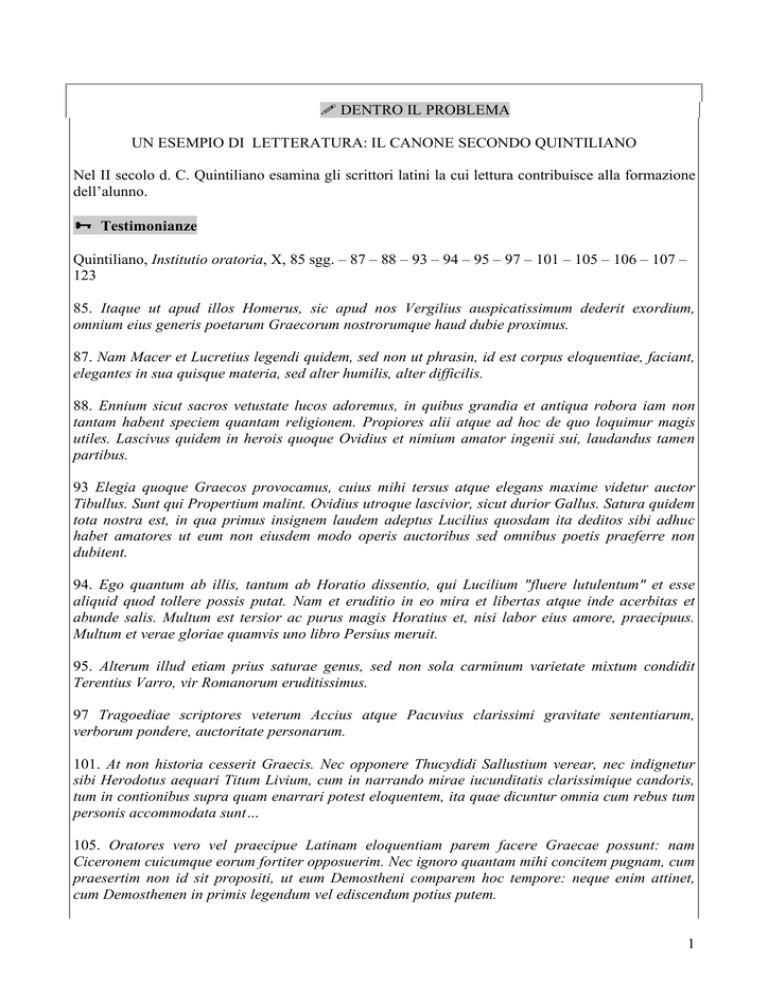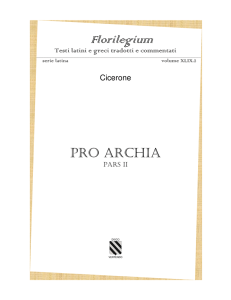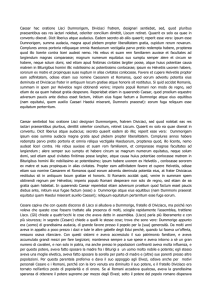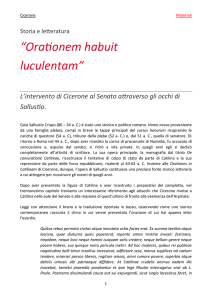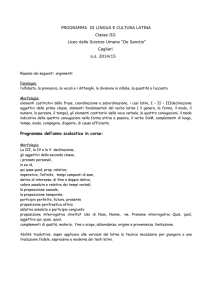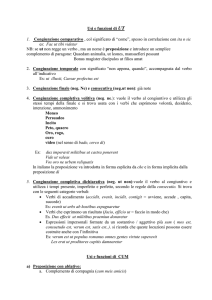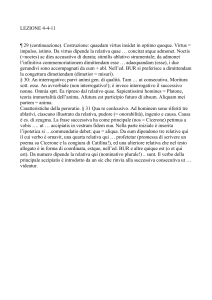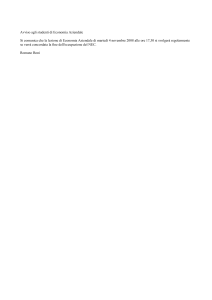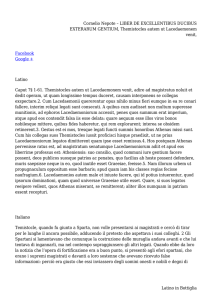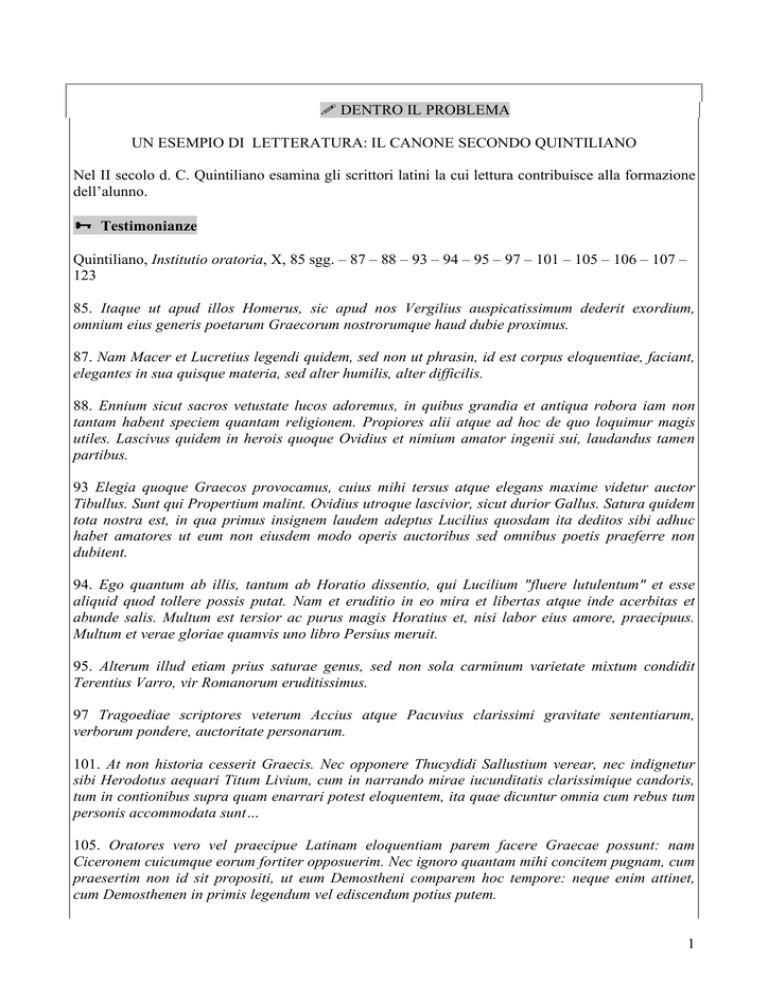
DENTRO IL PROBLEMA
UN ESEMPIO DI LETTERATURA: IL CANONE SECONDO QUINTILIANO
Nel II secolo d. C. Quintiliano esamina gli scrittori latini la cui lettura contribuisce alla formazione
dell’alunno.
Testimonianze
Quintiliano, Institutio oratoria, X, 85 sgg. – 87 – 88 – 93 – 94 – 95 – 97 – 101 – 105 – 106 – 107 –
123
85. Itaque ut apud illos Homerus, sic apud nos Vergilius auspicatissimum dederit exordium,
omnium eius generis poetarum Graecorum nostrorumque haud dubie proximus.
87. Nam Macer et Lucretius legendi quidem, sed non ut phrasin, id est corpus eloquentiae, faciant,
elegantes in sua quisque materia, sed alter humilis, alter difficilis.
88. Ennium sicut sacros vetustate lucos adoremus, in quibus grandia et antiqua robora iam non
tantam habent speciem quantam religionem. Propiores alii atque ad hoc de quo loquimur magis
utiles. Lascivus quidem in herois quoque Ovidius et nimium amator ingenii sui, laudandus tamen
partibus.
93 Elegia quoque Graecos provocamus, cuius mihi tersus atque elegans maxime videtur auctor
Tibullus. Sunt qui Propertium malint. Ovidius utroque lascivior, sicut durior Gallus. Satura quidem
tota nostra est, in qua primus insignem laudem adeptus Lucilius quosdam ita deditos sibi adhuc
habet amatores ut eum non eiusdem modo operis auctoribus sed omnibus poetis praeferre non
dubitent.
94. Ego quantum ab illis, tantum ab Horatio dissentio, qui Lucilium "fluere lutulentum" et esse
aliquid quod tollere possis putat. Nam et eruditio in eo mira et libertas atque inde acerbitas et
abunde salis. Multum est tersior ac purus magis Horatius et, nisi labor eius amore, praecipuus.
Multum et verae gloriae quamvis uno libro Persius meruit.
95. Alterum illud etiam prius saturae genus, sed non sola carminum varietate mixtum condidit
Terentius Varro, vir Romanorum eruditissimus.
97 Tragoediae scriptores veterum Accius atque Pacuvius clarissimi gravitate sententiarum,
verborum pondere, auctoritate personarum.
101. At non historia cesserit Graecis. Nec opponere Thucydidi Sallustium verear, nec indignetur
sibi Herodotus aequari Titum Livium, cum in narrando mirae iucunditatis clarissimique candoris,
tum in contionibus supra quam enarrari potest eloquentem, ita quae dicuntur omnia cum rebus tum
personis accommodata sunt…
105. Oratores vero vel praecipue Latinam eloquentiam parem facere Graecae possunt: nam
Ciceronem cuicumque eorum fortiter opposuerim. Nec ignoro quantam mihi concitem pugnam, cum
praesertim non id sit propositi, ut eum Demostheni comparem hoc tempore: neque enim attinet,
cum Demosthenen in primis legendum vel ediscendum potius putem.
1
106. Quorum ego virtutes plerasque arbitror similes, consilium, ordinem, dividendi praeparandi
probandi rationem, omnia denique quae sunt inventionis. In eloquendo est aliqua diversitas:
densior ille, hic copiosior, ille concludit adstrictius, hic latius, pugnat ille acumine semper, hic
frequenter et pondere, illic nihil detrahi potest, hic nihil adici, curae plus in illo, in hoc naturae.
107. Salibus certe et commiseratione, quae duo plurimum in adfectibus valent, vincimus.
123. Supersunt qui de philosophia scripserint: quo in genere paucissimos adhuc eloquentes litterae
Romanae tulerunt. Idem igitur M. Tullius, qui ubique, etiam in hoc opere Platonis aemulus exstitit.
E così, come per gli scrittori greci è stato di inizio Omero, così per noi potrebbe dare un
felicissimo esordio Virgilio, senza dubbio il più vicino ad Omero di tutti i poeti di tal genere greci
e nostri…Infatti Macro e Lucrezio sono certamente da leggersi, non perché ci insegnino la frase,
cioè la sostanza dell’eloquenza, eleganti ognuno nella propria materia, ma l’uno dimesso, l’altro
difficile…Adoriamo Ennio come i boschi sacri per la loro antichità, nei quali le grandi ed
antiche querce ormai non hanno la bellezza tanto quanto la religiosità. Altri sono più vicini a
Virgilio e più utili a quello di cui parliamo. Ovidio certamente è lascivo anche nei suoi versi epici
e troppo amante del suo ingegno e degno tuttavia di lodi in alcune parti…Anche nell’elegia
gareggiamo con i Greci, in questa mi sembra scrittore massimamente raffinato ed elegante
Tibullo. Ma ci sono quelli che preferiscono Properzio. Ovidio è più lascivo di ambedue gli altri,
così come Gallo è più aspro. Il genere satirico è certamente completamente nostro, nel quale
Lucilio, che per primo vi conseguì insigne lode, ha degli amatori a lui così ancora affezionati che
non esitano ad anteporlo non solo agli scrittori del medesimo genere, ma a tutti i poeti. Invece
dissento tanto da costoro quanto da Orazio il quale pensa che Lucilio scorra fangoso, e che c’è
qualcosa che tu potresti togliere. Giacché in lui vi è ammirevole erudizione e libertà e quindi
mordacità e molto spirito. Ma molto più puro e limpido di lui è Orazio e il primo, se non mi
inganno per amore di lui. Anche molta gloria, sebbene con un unico libretto meritò Persio.
Terenzio Varrone, l’uomo più erudito dei Romani, fondò anche un altro genere di satira, più
antico, ma misto non solo per la varietà di versi…Gli scrittori di tragedia, Accio e Pacuvio sono i
più grandi degli antichi per la profondità dei concetti, per il peso delle parole, per l’autorità dei
personaggi…Ma la storia non potrebbe cedere ai Greci. Né io esiterei a contrapporre Sallustio a
Tucidide ed Erodoto non si sdegnerebbe se gli venisse confrontato Tito Livio essendo questi nella
narrazione di mirabile grazia e di famosissima limpidezza ed eloquente oltre ogni dire nelle
pubbliche orazioni, così tutto quanto viene detto è adattato ai fatti ed alle persone… Ma gli
oratori, massimamente possono fare l’eloquenza latina pari alla greca: infatti io potrei
contrapporre validamente Cicerone a qualunque di loro E non ignoro quanta battaglia io susciti
contro di me, non essendo particolarmente proprio del mio compito ciò, di raffrontarlo in questo
momento a Demostene; né, infatti, ciò è pertinente, dal momento che reputo che Demostene
debba leggersi tra i primi, o piuttosto debba essere imparato a memoria. Ed io reputo simile la
maggior parte delle virtù di questi due oratori, nel disegno, nell’ordine, nel modo di dividere, di
preparare, di dimostrare, insomma in tutto ciò che è proprio dell’invenzione. Vi è una qualche
diversità nell’eloquio; più condensato quello, più ricco questo; quello ha periodi più serrati,
questo più ampli, quello combatte sempre di punta,questo spesso anche col peso. A quello nulla si
può togliere; a questo nulla aggiungere, in quello c’è più cura, in questo più ingegno naturale.
Noi vinciamo certamente nelle facezie e nel patetico, due doti che hanno massima importanza nel
suscitare i sentimenti…Restano coloro che hanno scritto di filosofia, genere in cui la letteratura
romana produsse sin qui pochissimi esempi eloquenti. Dunque il medesimo Marco Tullio, il
quale, come dappertutto, anche in questo genere, riuscì emulo di Platone.
2
Dalla lettura del brano possiamo trarre alcune considerazioni. Per prima cosa era inevitabile, ancora
al tempo di Quintiliano, attuare un raffronto tra letteratura greca e latina perchè quest’ultima era
intesa come subordinata alla prima (ad esempio il timoroso raffronto tra Cicerone e Demostene).
L’altro problema che emerge è quello della scelta degli autori che il fanciullo deve leggere per
raggiungere una formazione oratoria ottimale. Le scelte di Quintiliano sono sintomatiche di
un’epoca tutta tesa a rivalutare il classico e quindi contraria alle innovazioni degli ultimi anni
dell’età imperiale, ma comunque lo stile del maestro risulta poi più simile al deprecato Seneca,
clamorosamente assente nel suo personale “canone”, che a quello del tanto lodato Cicerone.
E’ interessante notare che già ai tempi di Quintiliano un maestro si ponesse il problema delle scelte,
consapevole che queste rimangono sempre personali e che nell’insegnamento bisogna fare dei tagli
e che molto dipende dai gusti, dal “sentire” o dalla formazione del docente.
Quintiliano introduce così il concetto di “canone letterario”, cioè cosa è opportuno leggere e perché.
I suoi giudizi sui vari autori, al di là dell’ossessione di ricercare l’originalità della letteratura latina,
oggi sarebbero inammissibili, tanta è la loro genericità. L’oratore e maestro in pratica, non dice
nulla, ricorrendo ad aggettivi che sono talmente personali e circostanziati, che finiscono per non
caratterizzare tanto l’autore quanto piuttosto il “critico” stesso.
Se oggi dovessimo dare giudizi o analizzare lo stile di un autore saremmo sempre aiutati dal testo
stesso e dedurremmo da alcuni esempi il suo stile; nulla di tutto questo in Quintiliano, ad esempio
quando parla delle eccelse qualità del “suo” Cicerone, non ricorda nemmeno una delle sue opere.
Un’ultima riflessione: il canone sopra riportato è molto vicino a quello talora imposto ai nostri
alunni dai docenti o dai libri di testo, potremmo chiederci se i loro interessi si potrebbero indirizzare
verso altri autori o oltre opere appunto meno “canoniche”.
DENTRO IL PROBLEMA
IL TEATRO IN GRECIA
Il teatro greco fu inizialmente progettato per le rappresentazioni in onore di Dioniso in ditirambi. La
parte centrale era formata dall’Orchestra (dal verbo greco orcheomai “danzare”), uno spazio
circolare riservato alla danza, nel mezzo del quale si ergeva l’altare del dio. Il theatron (dal verbo
greco theaomai “osservare, guardare”) aveva una struttura a ferro di cavallo ed era composto da una
serie di sedili scavati in una cavea naturale sul pendio di una collina, più tardi i sedili furono
rivestiti di marmo o di pietra. Tra l’orchestra e il pubblico c’era la skené, originariamente una
struttura lignea con tre porte, attraverso le quali, quando dal semplice coro ditirambico si sviluppò il
dramma, gli attori potevano entrare e uscire. Una macchina speciale azionata da una sorta di
carrucola, serviva per far apparire degli dei che scendevano dall’alto sulla scena (deus ex machina),
inoltre esistevano altri meccanismi per ovviare, per esempio, ai cambi di scena. Il coro entrava da
passaggi situati tra la skené e l’orchestra, poteva rimanere sul palco, mentre un flautista
accompagnava il canto forse seduto sui primi gradini. La costruzione non era coperta, in quanto le
rappresentazioni avvenivano a cielo aperto.
IL TEATRO A ROMA
A Roma non esisteva nessun teatro permanente fino alla costruzione del teatro di Pompeo nel
Campo Marzio, in seguito al bottino della guerra mitridatica. Era in pietra e poteva contenere
40.000 spettatori. Più tardi furono costruiti altri due teatri stabili in pietra, entrambi nel Campo
Marzio: uno, fatto erigere da Cornelio Balbo nel 13 a. C., l’altro voluto da Augusto in onore del
figlio adottivo Marcello, conosciuto appunto come teatro di Marcello.
3
Prima di queste costruzioni, le commedie o le tragedie venivano rappresentate su palchi temporanei
nel Circo Massimo o nel Foro, con sedili posti in forma semicircolare, il pubblico però non sedeva
comodamente, come si evince da un passo di Ovidio (Ars am. I, 141 e 157), in cui ci riferisce che
gli spazi che separavano gli spettatori erano stretti e che le ginocchia di coloro che erano seduti
dietro si conficcavano nelle spalle di quelli davanti. Plinio nella Naturalis Historia (XXXVI, 24)
descrive un singolare teatro circolare in legno costituito da due semicerchi, cioè un anfiteatro. I
teatri romani presentavano una cavea semicircolare, mentre quelli greci ne avevano una più ampia,
ma il palcoscenico nelle strutture romane era più vasto e più profondo. Le prime file dei posti erano
riservate per coloro che ricoprivano le cariche più importanti. Il coro nelle rappresentazioni a Roma
non sempre era presente, ma andava e veniva sulla scena. Gli attori erano spesso di origine servile,
erano coordinati da un direttore detto dominus gregis ed erano pagati dai magistrati che
organizzavano i giochi. Dapprima gli attori erano scarsamente considerati, poi cominciarono ad
acquistare importanza. Questi indossavano delle maschere e le parti femminili erano recitate da
uomini. Gli attori della tragedia portavano una veste lunga e dei sandali alti chiamati cothurni, gli
attori comici avevano abiti normali e ai piedi calzavano il soccus.
Testimonianze
Vitruvio, De architectura, V, 6:
La forma del teatro la si ottiene seguendo questo procedimento: determinate le dimensioni
dell’area inferiore dove sarà l’orchestra e puntando il compasso al centro si tracci una
circonferenza in cui andranno iscritti quattro triangoli equilateri i cui vertici toccheranno ad egual
distanza la circonferenza. … Il palcoscenico risulterà più largo che nei teatri greci, perché tutti gli
attori operano sulla scena, mentre nell’orchestra si trovano i posti assegnati ai senatori. L’altezza
del palcoscenico non superi i cinque piedi, affinché chi ha trovato posto nell’orchestra possa
vedere tutte le mosse degli attori. I cunei della cavea siano suddivisi in modo che le scale di
accesso alla prima recinzione siano in corrispondenza dei vertici dei triangoli iscritti alla
circonferenza. Nella parte superiore invece i cunei siano divisi a metà dalle scalinate disposte in
senso alterno. … Il tetto del portico in cima alla gradinata venga a trovarsi allo stesso livello
corrispondente all’altezza della scena in modo che la voce si propaghi omogeneamente e arrivi in
alto fino all’ultimo ordine di gradini, in caso contrario il suono si interromperebbe disperdendosi
in corrispondenza del livello più basso al quale fosse giunto. … La lunghezza della scena sia il
doppio del diametro dell’orchestra. In ogni caso queste proporzioni non possono essere applicate
indistintamente per tutti i tipi di teatro, ma è opportuno che l’architetto valuti secondo quali criteri
si debbano applicare i rapporti proporzionali e secondo quali soluzioni adattarle alla natura del
luogo e alla mole della costruzione. … La scena sia disposta in modo che le porte centrali
appaiano ornate come quelle di un palazzo reale e quelle di destra e di sinistra, destinate agli
ospiti, abbiano di fianco degli spazi predisposti per le decorazioni; questi si dicono in greco
“perìaktoi” per il fatto che vi sono istallate delle macchine girevoli a tre facce, ciascuna con tre
diversi tipi di raffigurazioni, cosicché, quando si verificano colpi di scena, o quando subentra una
qualche divinità, con improvviso rimbombo di tuoni esse, ruotando, mutano, appunto, la scena
Sempre in questo settore si hanno delle pareti ad angolo, sporgenti in avanti, che costituiscono
l’entrata in scena da una parte come se l’attore provenisse dal Foro, dall’altro, come se giungesse
da fuori città.
4
DENTRO IL PROBLEMA
LA COMMEDIA GRECA
Aristotele nella Poetica dice che i Megaresi, sia quelli in Sicilia che quelli nell’Istmo, affermano di
aver dato origine alla Commedia, il vocabolo deriva da kòme, in greco “villaggio”, perché i
commedianti vagavano di villaggio in villaggio. Altri sostengono che derivi da coloro che
guidavano le processioni dette Falloforie, ma i passi compiuti dalla rappresentazione sin dalle sue
origini sono oscuri. Un’altra ipotesi è quella di far derivare la commedia da kòmos, cioè una sorta di
canto religioso, in occasione di alcune feste, soprattutto in onore di Dioniso, durante le quali si
danzava, si cantava e si onorava il dio. Comunque Aristotele aveva ragione nel sostenere il carattere
fallico, associato al culto dionisiaco: sicuramente queste processioni avranno influenzato le
rappresentazioni di Megara.
Le commedie erano rappresentate ad Atene, nelle feste in onore di Dioniso. Cinque poeti erano in
gara in ogni occasione, ognuno con un’opera.
La commedia di Aristofane, detta Antica, è formata dalle seguenti parti: il prologo espositivo; la
parodos cioè l’entrata del coro; l’agon o disputa tra i protagonisti, che costituiva il nucleo della
rappresentazione; la parabasis, in cui il coro poteva esprimere il sentire del poeta, consisteva in un
canto anapestico e presentava un inno per la divinità o un attacco satirico ad aspetti sociali e
politici; seguivano gli episodi separati dai canti del coro che spesso approfondiva gli argomenti
trattati nell’agon. Infine vi era l’exodos, o scena finale lieta e gioiosa che terminava con un
festeggiamento o con un matrimonio.
Gli argomenti trattati erano storie semplici, spesso immaginarie e divertenti, ma al tempo stesso
satiriche e s’incentravano su un personaggio di pubblico interesse che veniva messo in ridicolo; il
poeta così, anche attraverso il riso, poteva far conoscere il suo pensiero. L’intervento del coro
serviva più a fomentare che a pacificare e a conciliare i due antagonisti, e spesso si schierava con il
più forte. I personaggi, anche se presi dalla vita reale o personificazioni di idee astratte, come la
Pace o il Popolo, erano solo caricature o simboli, non responsabili del loro agire né rappresentativi
di un’ideologia morale. I personaggi, maschili o femminili, erano interpretati da uomini; i loro abiti
erano quelli della vita comune, le maschere permettevano subito di individuare le tipologie e ne
esageravano l’aspetto grottesco. Il coro era probabilmente composto di ventiquattro elementi e
diviso in due semicori, la danza costituiva un elemento fondamentale.
La Commedia Antica era un insieme di rito sacro, satira e critica politica, sociale o letteraria in
un’ottica di divertimento. Il rappresentante di questo genere è Aristofane che visse dal 448 al 380 a.
C. ad Atene. Come si evince dalla datazione egli partecipò a molti degli eventi che mutarono il
volto della Grecia e soprattutto la perdita della supremazia politica di Atene. Nelle sue commedie
abbiamo quindi una presa di posizione ben definita, egli è il paladino della tradizione e tutto quello
che mina i costumi antichi è visto da lui con diffidenza e quindi diventa oggetto di satira. Così, ad
esempio, nella Pace, egli attacca tutti coloro che traggono addirittura un vantaggio dalla guerra, nel
caso specifico, i commercianti di armi. Tra i sospetti di destabilizzare la supremazia ateniese rientra
anche Socrate di cui il poeta non recepì il messaggio innovatore, per cui, nelle Nuvole, lo paragona
ad uno dei tanti venditori di sapienza che popolavano la città e lo mette in ridicolo relegandolo nel
“pensatoio” attorniato dalle nuvole, che costituiscono il coro, a dare consigli ad un vecchio babbeo
e al suo scellerato figlio. Negli Uccelli si rappresenta l’ambiente di odio e di guerra che ad Atene è
divenuto intollerabile, ecco quindi che due personaggi decidono di abbandonare la città e andare a
vivere a Nefelocuccugia in un luogo popolato dagli uccelli. La satira non risparmia neanche il
tragediografo Euripide che nelle Rane finisce a gracidare nella palude dello Stige: anche costui
aveva rappresentato la violenza delle passioni e i primi dubbi sull’equilibrio di una grande cultura
come quella ateniese. In uno stato che perde il suo prestigio, le donne hanno la meglio, tanto e vero
che Aristofane le rende protagoniste di ben tre commedie: Lisistrata, Tesmoforiazuse ed
Ecclesiazuse. Nella prima, le donne, capeggiate da Lisistrata, non a caso una spartana, decidono di
5
“mettersi in sciopero” quando tra una battaglia e l’altra i loro mariti torneranno. Viene così
ridicolizzata la guerra e il rapporto uomo-donna viene deformato in nome di una morale che
comincia a vacillare. La commedia aristofanesca diventa in tal modo motivo di divertimento non
disgiunto dalla riflessione sull’utilitarismo di alcuni personaggi politici artefici della disfatta
ateniese. Il poeta attraverso il riso vuole spingere alla riflessione, ma si dimostra troppo
intransigente nelle sue scelte e miope nel non riconoscere il valore di alcuni personaggi come
Socrate. Nelle sue opere comunque il divertimento è assicurato sia per le battute, sia per le
caricature dei personaggi.
Verso il 400 a. C. dopo la sconfitta ateniese fiorì la Commedia di Mezzo, nella quale la scurrilità
prende il posto della parodia e scompare la critica letteraria e politica. La caratteristica era quindi la
battuta fine a se stessa e le maschere fisse di personaggi intorno ai quali ruotava un intreccio con
infinite variazioni; non abbiamo titoli di questa Commedia, ma sappiamo che costituisce il punto di
raccordo con la Commedia Nuova: quest’ultima è la fonte, come si è visto, del teatro comico latino.
La Commedia Nuova si sviluppa a partire dal 336 a. C.: la sua caratteristica è la rappresentazione
della vita quotidiana vissuta da personaggi di fantasia, in cui si riscontrano tematiche che
coinvolgono e suscitano il riso, ma nelle quali avviene una sorta di identificazione, soprattutto a
livello di sentimenti. Sembra quasi che costituisca il proseguimento della tragedia di Euripide,
piuttosto che del teatro di Aristofane: nel tragediografo si era assistito agli intrecci dovuti alla sorte
e al caso, contro cui l’uomo cerca di combattere, forte dei suoi sentimenti e, nel caso di molte
eroine, della loro passionalità. La commedia Nuova è l’antefatto del dramma moderno, anche se le
vicende sono piuttosto esili, tutto si risolve positivamente perché vi è una certa fiducia nelle
possibilità di riscatto dell’uomo. Questo rimane in balia del caso, ma il lieto fine è assicurato dal
buon carattere e dalle qualità intrinseche. In questo tentativo di evasione costituito dal teatro e dal
lieto fine scorgiamo un desiderio di allontanarsi dagli avvenimenti politici che avevano determinato
la fine dell’egemonia ateniese e avevano spalancato le porte al dominio della Macedonia. I
rappresentanti del genere furono Menandro, Filemone e Difilo, degli ultimi due non abbiamo nulla,
sono però citati come fonti da Plauto.
Menandro, nato nel 342 a. C., scrisse un centinaio di commedie, ma poco ci rimane della sua
produzione. Numerosi frammenti delle sue opere furono scoperti in un papiro nel 1905, soprattutto
della Samia, degli Epitrepontes, della Perikeiromene. Menandro presenta la vita dell’Atene
contemporanea in un aspetto serio e pieno di pathos, per cui, insieme ad situazioni divertenti e ad
un intreccio interessante, ci si interroga anche su alcuni aspetti dell’esistenza. Nelle commedie
appaiono quindi spunti di riflessione, il poeta si mostra tollerante nei confronti dei vizi dei
personaggi che considera solo difetti; vi è una sorta di accettazione dell’altro e di condivisione dei
problemi per cui molti episodi sono velati di malinconia. Le sue commedie non ebbero grande
successo, vinse il primo premio soltanto otto volte, ma subito dopo la sua morte divenne famoso
perché incarnava degli ideali nuovi e proponeva un teatro più introspettivo. Gli intrecci sono basati
sull’amore e l’avventura, insieme con i soliti scambi di persona che generano equivoci. Un tipico
tema è quello della seduzione di una fanciulla che è schiava, ma che poi si scopre essere libera; un
altro aspetto trattato è quello della violenza subita durante una festa ai danni di una ragazza che in
quella occasione rimane incinta, alla fine vi è il riconoscimento (il padre del bambino, cioè il
violentatore, è il promesso della giovane), la riconciliazione dei contrasti e dei fraintendimenti e il
solito matrimonio. I protagonisti riproducono i “tipi” delle maschere: il vecchio, lo schiavo astuto,
la cortigiana dal cuore d’oro. Proprio quest’ultima spesso aiuta gli amanti a capirsi e a ritrovarsi,
lontana dallo stereotipo della donna avida e senza scrupoli.
DENTRO IL PROBLEMA
6
IL CIRCOLO DEGLI SCIPIONI
La cultura greca penetrò a Roma e si fuse con i valori della tradizione romana attraverso
l’esperienza culturale e politica del cosiddetto circolo degli Scipioni: questo era formato da
intellettuali esponenti dell’aristocrazia che si raccoglievano intorno alla figura di Scipione Emiliano,
uomo politico e condottiero di grande spessore. L’Emiliano era persuaso che Roma, divenuta
padrona del Mediterraneo, dovesse altresì incontrarsi con la cultura greca, superiore dal punto di
vista del pensiero teorico; un grande stato doveva fondarsi su teorie filosofiche, come premessa di
future strategie per la gestione e il mantenimento del potere. Tra la seconda e la terza guerra punica
Roma si impegnava a trovare un’ideologia che supportasse il potere e la classe dirigente. Sappiamo
quanto Catone il Censore si opponesse all’ingerenza della cultura greca, sostenendo che la forza dei
romani era costituita dal legame con le tradizioni e con le virtù tipiche di una società agricola.
La fama della famiglia degli Scipioni era iniziata con Scipione l’Africano, il vincitore a Zama (202
a. C.), era proseguita con Lucio Emilio Paolo che aveva sconfitto a Pidna (168 a. C.) il re macedone
Perseo; tale battaglia era stata fondamentale per l’incontro con la cultura greca perché tra i
prigionieri condotti a Roma vi era lo storico Polibio, il teorico della grandezza di Roma. Figlio di
Emilio Paolo fu Scipione l’Emiliano, il distruttore di Cartagine nel 146 a. C.: dopo questa data, a
Roma giunge il pensiero filosofico di impronta stoica. Come si è detto, fu Polibio di Megalopoli ad
elaborare una teoria politica che tenesse presente l’evoluzione di Roma, che aveva visto in un lasso
di tempo relativamente breve accrescere il suo potere in territori sempre più vasti. La speculazione
di Polibio parte quindi dall’interrogativo sul perché e sul come Roma abbia potuto realizzare un
grande potere universale. La costituzione romana ha la sua grandezza nella così detta mikté (cioè
“costituzione mista”) che contempla la monarchia (i due consoli), l’aristocrazia (il Senato) e la
democrazia (il tribunato della plebe); Polibio, pur nella convinzione della positività di tale forma di
governo, fondata appunto sull’equilibrio dei poteri, in nome di una dottrina stoica legata all’eterno
divenire e alla trasformazione del tutto, afferma che il ciclo positivo della potenza romana sarà
comunque destinato ad esaurirsi con la degenerazione di tali poteri, rispettivamente in tirannide,
oligarchia, oclocrazia.
Un altro personaggio importante a Roma fu il filosofo stoico Panezio di Rodi, il quale fu il teorico
di uno stato universale fondato sulla giustizia, sulla tolleranza e l’equilibrio, di cui la Roma degli
Scipioni sembrava fornire un esempio. Nel circolo vigeva un ideale di humanitas, affine alla
philantropia greca, fondata sul principio che tutti gli esseri umani sono uguali per natura perché
dotati di logos; chi è votato all’azione politica deve agire per il bene dei cittadini, così come il
potere universale di Roma deve assumere il ruolo di garante dell’equilibrio nei confronti dei popoli
sottomessi.
Gli Scipioni, forti di questa base teorica, fondarono quella classe dirigente romana non più soltanto
custode del mos maiorum, ma capace di instaurare con i popoli sottomessi un legame di pace e di
armonia basato appunto sul concetto di humanitas.
L’idea di cosmopoli universale sarà quella di Posidonio di Apamea, cui si ispirerà anche Cicerone,
nell’opera De officiis, prendendo in esame ciò che è giusto e ciò che è onesto, ciò che attiene alla
sfera del privato e del pubblico e come questi due aspetti debbano interagire.
7
DENTRO IL TESTO
L’AULULARIA E IL TEMA DELL’AVARO
Il tema dell’avarizia che abbiamo visto trattato nell’Aulularia di Plauto fornisce un’occasione per
riflettere e, magari divertirsi, su un difetto umano. Gli scrittori comici ne traggono spunto per
situazioni esilaranti e che suscitano il riso, gli autori satirici o quelli che scrivono con intento
moralistico invece, si indignano e ne fanno risalire la causa alla società che punta più sull’avere che
sull’essere. Questa distinzione ci fa capire quali siano i diversi punti di vista che riscontreremo nei
vari autori.
Esopo, Favole, 344
Un avaro, avendo convertito in denaro tutti i suoi beni, comprò un lingotto d’oro e, scavata una
fossa in un certo luogo, ve lo nascose, chiudendo lì anche i suoi pensieri e la sua mente; e ogni
giorno, andando lì se lo guardava. In quel posto c’erano degli operai e uno di loro,, avendolo
osservato e avendo capito di che si trattava, dissotterrò il lingotto d’oro e se lo portò via. Poi,
venuto anche l’avaro e constatato che non c’era più l’oro, cominciò a piangere e strapparsi i
capelli. Un tale vedendolo così disperato, quando venne a sapere da lui la causa di ciò, gli disse:
“Non ti abbattere così, amico, infatti quando tu avevi l’oro in quel modo, era come se non lo
avessi. Allora prendi una pietra, mettila al suo posto e fai conto di avere ancora il tuo lingotto: la
pietra farà per te la stessa funzione, perché, a quanto posso vedere, neanche quando l’oro era lì ne
facevi alcun uso”. La favola insegna che gli averi non sono nulla se non se ne fa nessun uso.
Fedro, Favole, IV, 21
Vulpes cubile fodiens dum terram eruit
agitque plures altius cuniculos,
pervenit ad draconis speluncam intimam,
custodiebat qui thesauros abditos.
Hunc simul aspexit: “Oro ut imprudentiae
des primum veniam; deinde si pulchre vides
quam non conveniens aurum sit vitae meae,
respondeas clementer: quem fructum capis
hoc ex labore, quodve tantum est praemium
ut careas somno et aevum in tenebris exigas?”
“Nullum”, inquit ille,"verum hoc ad summo mihi
Iovem adtributum est.” “Ergo ne sumis tibi
nec ulli donas quicquam?” “Sic fatis placet”.
“Nolo irascaris libere si dixero;
dis est iratis natus qui est similis tibi.”
Abiturus illuc quo priores abierunt,
quid mente caeca miserum torques spiritum?
Tibi dico, avare, gaudium heredis tui,
qui ture superos, ipsum te fraudas cibo,
qui tristis audis musicum citharae sonum,
quem tibiarum macerat iucunditas
obsoniorum pretia cui gemitum exprimunt,
qui dum quadrantes adgeras patrimonio
caelum fatigas sordido periurio,
qui circumcidis omnem impensam funeri
Libitina nequid de tuo faciat lucrum.
8
La volpe scava la sua casa, ma fa le gallerie troppo profonde: giunge in fondo alla grotta del
dragone custode di tesori nascosti. Come lo scorge: “Prima di tutto ti prego di perdonarmi, non
immaginavo.Ma poi rispondi con la tua bontà (L’oro non fa per me, lo vedi bene) che frutto trai
da questa tua fatica? E quale grande ricompensa avrai, tu che mai non dormi in questa eterna
tenebra?” “Nessuna” disse “Questa è l’altissima missione che Giove mi affidò.”” Nulla ricevi
mai e non doni nulla ?” “E’ la necessità.” “ Se parlo schietto non ti arrabbiare: chi somiglia a te
è nato sotto l’ira degli dei.”Andrai laggiù dove da sempre si va, cieco di mente, e ti torturi
l’anima! Parlo a te, avaro, gioia dell’erede! Rubi al cielo l’incenso e il pane a te; per te la cetra
suona di mortorio, la letizia dei flauti ti fa male, il costo della roba ti fa piangere, ogni soldo che
aggiungi al patrimonio stanchi il cielo di sconci giuramenti; limi le spese del tuo funerale perché
non vuoi che ti sfrutti la morte?
La Fontaine, Fables, IV, 20
(nella versione di Emilio De Marchi)
Mal possiede colui che ben non usa
del suo denar, seppiatelo, o taccagni,
che i guadagni ammucchiate sui guadagni
e non avete un soldo all’occorrenza.
Chi trova differenza
tra un Giobbe che languisce sul letame,
e gli avari che muoiono di fame?
Parlando di un avar che il suo tesoro
nascose in terra, Esopo in una favola
ha detto cose d’oro.
Questo avaraccio sordido,
padrone no, ma schiavo egli dell’oro,
di nascere aspettava un’altra volta
il suo denar per spendere.
Teneva egli sepolta
sotto terra una pentola ripiena
di bei doppioni ed il suo cor con loro;
e giorno e notte andava, anima in pena,
sempre il pensier raccolto
al morto suo sepolto.
In strada, a letto, a tavola
sempre temea che qualche temerario
osasse, oh Dio! toccarne il santuario.
Seguendo i passi dell’avaro un dì,
un certo beccamorto sospettò
dove era il morto e lo disseppellì.
Quando venne il vecchione e ritrovò
vuoto il nido, per poco non morì.
Chi mi sa dire i gemiti
del nostro pover uomo e chi le lagrime
e l’ira onde si lacera
le vesti a quell’orribile misfatto?
“ Il mio tesoro mi hanno rubato, ahimé”
gridava il mentecatto.
9
“Il tuo tesoro” un passegger chiedè.
“il mio tesor ch’era sepolto qui
sotto una pietra”. Tempo ora non è
da seppellir il tuo tesor così.
E’ meglio il tuo denar, almen mi pare,
in casa conservare o non lontano,
se vuoi di volta in volta ad un bisogno
averlo sotto mano.
“ Di volta in volta, dici, oh buon Gesù,
io non avrei mai più
toccato ciò che a stento
si raccoglie e sparisce in un momento”.
“Allora, amico, a che servono i guai?”
Il passeggier rispose a quell’ossesso
“Se il tuo tesoro non lo tocchi mai,
mettici un sasso e servirà lo stesso”.
Marziale, Epigrammi, I, 103:
“Si dederint superi decies mihi milia centum”
dicebas nondum, Scaevola, iustus eques,
“qualiter vivam, quam large quamque beate!”
Riserunt facile et tribuere dei.
Sordidior multo post hoc toga, paenula peior,
calceus est sarta terque quaterque cute;
deque decem plures semper servantur olivae,
explicat et cenas unica mensa duas,
Veientani bibitur faex crassa rubelli;
asse cicer tepidum constat et asse Venus.
In ius,o fallax atque infitiator, eamus!
Aut vive aut decies, Scaevola, redde deis.
“Mi dessero gli dei solo un milione - dicevi, Scevola, quando non eri ancora cavaliere – sai che
vita farei grandiosa, beata!” Gli dei risero compiacenti e te lo dettero. E adesso la tua toga è
ancor più sporca, il mantello più liso, le tue scarpe rappezzate non si sa quante volte. Di dieci
olive ne metti da parte sette o otto, una tavola imbandita deve servirti per due cene e bevi quello
schifo che è il vino rosso di Veio, compri ceci bolliti per un soldo, compri l’amore per un soldo.
Andiamo in tribunale, bugiardo, imbroglione! Scevola, goditi la vita o restituisci il milione agli
dei.
Teofrasto, Caratteri, XVII
La diffidenza è evidentemente una presunzione di disonestà contro ognuno, e il diffidente
suppergiù è un tale che, quando manda il servo a fare la spesa, gli spedisce dietro un altro con
l’incarico di informarsi quanto abbia pagato il primo. E, quando ha addosso una somma di
denaro, si mette a sedere ad ogni stadio per ricontare quanto è. E, quando si è già coricato
domanda alla moglie se ha chiuso bene lo scrigno e se sono apposto i suggelli dell’armadio
dell’argenteria e se è tirato il catenaccio dell’uscio di casa; e, per quanto quella gli risponda di sì,
pure si leva nudo e scalzo dal letto, e, accesa la lampada se ne va in giro a riscontrare ogni cosa,
e ancora, dopo ciò a stento riesce a prendere sonno. E da chi gli deve denaro esige gli interessi in
10
presenza di testimoni, perché non possa negare. Ed è capace di non voler consegnare quell’abito
a quel lavandaio, che lavori meglio, ma soltanto se ha un mallevadore sicuro. E quando uno gli
viene a chiedere in prestito vasellame, se può, tira a ricusarlo, ma se è un intimo o un parente, lo
consegna solo dopo averlo poco meno che segnato a fuoco e pesato e fattosi presentare un
garante. E si fa camminare dietro e non davanti, il servo che l’accompagna, per badare bene che
non se la svigni per la via. E a chi ha preso in prestito qualcosa da lui dice: “Fa la somma e metti
in conto perché ora non posso mandare i denari”, risponde: “Non ti scomodare, io ti
accompagnerò finché non li trovi”.
DENTRO IL PROBLEMA
LA TRADUZIONE DEL MILES GLORIOSUS DI PIER PAOLO PASOLINI: “IL VANTONE”
Nel 1963 Pasolini progettò di tradurre il Miles gloriosus di Plauto su invito di Vittorio Gassman,
che poi non poté recitarlo per impegni di lavoro; il titolo fu reso con Il Vantone. La prima edizione
andò in scena al Teatro della Pergola di Firenze il 13 novembre 1963 con la regia di Franco
Enriquez; la critica si divise nettamente in sostenitori e denigratori.
Pasolini era profondamente convinto della forza espressiva dei dialetti e credette di far rivivere la
vis comica del teatro plautino nel dialetto romanesco. Riteneva inoltre che lo scambio di battute tra
l’attore comico e il pubblico potesse reincarnarsi in un dialetto “popolare e plebeo”. Il problema era
innanzi tutto, quale vernacolo scegliere, tenendo conto che Pasolini era friulano e che quindi non
avvertiva l’evoluzione che il gergo romanesco aveva avuto negli anni del dopoguerra. Il dialetto che
il poeta ha scelto di usare non è quello del Belli, né tanto meno quello di Trilussa, ma quello che si
parlava nelle borgate sorte negli anni Cinquanta, dove vivevano non i romani autentici, ma quelli
immigrati. La traduzione di Pasolini appare perciò un adattamento, un rifacimento e una
rielaborazione, piuttosto che un lavoro di resa filologica. Le parole del regista a questo punto sono
illuminanti: “Quando sono i classici ad essere tradotti, occorrerebbe riconoscere che più che
tradurre si tratta di “traslare” l’anima della lingua dal suo corpo morto in cui è chiusa, in un’altra
lingua, in un corpo che vive e che parla”.
Il dialetto usato da Pasolini esprime quindi non un valore culturale, ma, semmai, un significato
sociale, è un qualcosa di imbastardito in cui si sente una disperazione che si esprime con volgarità e
concretezza: è solo lo strumento espressivo di una realtà emarginata, priva spesso di identità.
Pasolini tentò anche di riprodurre la metrica, il senario giambico plautino, adottando i doppi
settenari rimati e quindi rifacendosi al verso alessandrino usato da Molière. Nelle parole in rima,
inoltre, inserisce una battuta spiritosa.
Abbiamo accennato alle vivaci discussioni che sollevò lo spettacolo, non solo in occasione della
prima, ma anche nelle repliche successive e nei nuovi allestimenti. Aggeo Ravioli in un articolo
apparso sull’Unità con un titolo esplicitamente polemico “Il Vantone. Da Plauto al Sor Capanna”
esprime il suo giudizio severo sull’operazione pasoliniana. Il critico sostiene che manca anche
un’attualizzazione a cui il personaggio di Pirgopolinice si potrebbe rifare, per esempio in esponenti
della vita politica contemporanea, all’opposto non si nota neppure una nota polemica, cosa che in
Plauto era verosimilmente presente; quanto poi all’uso del dialetto romanesco esso è solo un
guazzabuglio gergale da periferia, laddove nell’autore latino non manca una ricercatezza linguistica
e verbale.
Questo il giudizio del critico dell’Unità a cui Pasolini replicò sostenendo che sarebbero stati fuori
luogo dei riferimenti al presente e che il problema sociale non poteva essere nemmeno sfiorato da
Plauto e che sarebbe inattuale fare di esso un marxista ante litteram. Vero è che il problema della
schiavitù è forte e presente e così un certo antimilitarismo che all’epoca del commediografo doveva
apparire ancor più evidente: su questo si è puntato nella resa in italiano. A tale risposta seguì
11
l’ultima replica del giornalista che bolla l’opera come una semplice traduzione senza la capacità di
rileggerla e farla leggere in un’ottica di problematicità contemporanea.
Accanto a tali giudizi non mancarono le lodi soprattutto della traduzione pasoliniana (cfr. P. E.
Poesio, “Plauto impara a parlare come i ragazzi di vita” in La Nazione 12 novembre 1963), in cui si
sostiene che il linguaggio greve era quello di Plauto e che al giorno d’oggi la grevità della Suburra
può essere paragonata a quella del quartiere Prenestino. La rappresentazione a Firenze fu comunque
ben accolta dal pubblico, non così quando venne riproposta al teatro Quirino di Roma; critica fu
anche la posizione di Renzo Tian sulle pagine del Messaggero che si oppone alla riduzione di
Pasolini che sceglie il dialetto e le battute da “avanspettacolo”, cosa che non ci avvicina a Plauto e
che risulta essere più un gioco filologico e letterario che un’opera di traduzione per il teatro.
Sulla stessa linea la posizione di Ennio Flaiano, in un articolo uscito sull’Europeo nel 1964,
perplesso di fronte all’uso di una specie di dialetto che è invece un misto di romanesco, quello delle
borgate e non dei veri romani, e di contaminazioni linguistiche, il tutto scritto in doppi settenari,
come a dire “da Molière al Sor Capanna”. Illuminanti sul senso di questa opera sono le parole stesse
di Pasolini: Nel “Vantone”c’è innanzi tutto quello che a me sembra un interessante pastiche
linguistico italo-romanesco: i servi parlano un romanesco strettissimo; i grossi personaggi, i
signori altolocati parlano italiano con qualche fondo romanesco; le donne invece, le meretrici si
esprimono in un linguaggio comune, molto plebeo, un po’ di avanspettacolo (intervista al Paese
Sera, 27 dicembre 1963).
Il testo rimane comunque un importante documento sulla tecnica di “traduzione” come traslazione e
traslitterazione, mentre si perde in questa operazione tutta la vivacità scenica e la motilità del teatro
plautino. Pasolini voleva mettere anche in evidenza le tante possibilità del linguaggio e del dialetto
romano che, sebbene non romano, amava e studiava con interesse, come risulta evidente dai suoi
romanzi e dai suoi primi film. Probabilmente anche quest’opera era un omaggio sofferto da
tributare ad una città che lo aveva accolto e dalla quale era affascinato proprio per i suoi aspetti
contradditori.
Pasolini, Il Vantone
Atto I Pirgopolinice:
Guarda che il mio scudo luccichi più del sole,
quand’è estate,che spacca i selci e copre di sudore:
se si presenta l’occasione, e ciò da fa a cazzotti
voglio che ai miei nemici, ‘sto scudo je cechi l’occhi.
Sta bajaffa è un bel pezzo che sta ferma, se lamenta,
voglio riconsolarla,voglio farla contenta:
lo sento che je rode, che l’ha presa il capriccio
de riduce i nemici come tante salcicce.
Artotrogo, indò stai?
Artotrogo:
Ecchime, sto accanto a te,
padroncino mio bello, più gajardo de un re!
Manco il dio della guerra sarebbe tanto gaggio
Da mettere in confronto il suo col tuo coraggio!
Pasolini nella nota introduttiva al volume Il Vantone affermò che più che tradurre, si trattava di
“traslare” l’anima della lingua dal suo corpo morto in un’altra lingua, in un corpo che vive e parla.
Il poeta si rendeva conto che non servono a molto né le “belle infedeli”, né le fedelissime. Il
problema se lo era già posto Plauto quando non tradusse gli originali greci, ma li reinterpretò in un
contesto di un teatro non più greco. La traduzione pasoliniana fu ultimata in tre settimane.
Ibidem:
12
Palestrione:
Ve lo farei il riassunto, di questa commedia
Se un poco d’attenzione mi voleste concedere …
Se ci stasse qualcuno che proprio nun je va
Prenda e lasci il posto: ‘n’altro l’occuperà.
Dato che avete preso posto qui tutti arzillotti
Come ad una festa, bene: vi voglio fare edotti
Dei fatti e del titolo di questa sceneggiata.
Il titolo in greco sarebbe Alozanone,
ma noi in nostra lingua, diciamo Er Vantone.
Questa città è Efeso. Quel soldato che mo’,
da qui, è ito al centro, io gli sottostò:
è il padrone, ‘sto zozzo, lavannaro, sbruffone
pieno de merda, bravo soltanto a fare l’imbroglione.
Per lui, dice, le donne cianno tutte la pece:
tutte lo sanno bene ch’è un cafone, invece.
A forza di mandargli i bacetti le mignotte,
secondo lui, ciavrebbero tutte gonfie le bocche.
Mica è tanto tempo ch’io sto a servizio suo:
anzi, ecco com’è che mi s’è preso lui.
Fate bene attenzione, che qui comincia il bello.
Il mio vero padrone, ad Atene, era un bravo pivello;
e s’era innamorato d’una pischella greca,
e pure lei di lui: ‘na relazione quieta.
Possiamo osservare che come la lingua di Plauto era comunque “letteraria” e si rivolgeva ad un
pubblico non più greco, così Pasolini sceglie il romanesco rivolgendosi a fruitori non assuefatti
all’italiano aulico; la scelta del metro settenario consente comunque di rimanere pur sempre in un
ambito letterario. Sembra quindi che Pasolini abbia attuato una sorta di contaminatio tra la lingua
del Belli ed ritmo di Moliére.
L’aggettivo gloriosus viene tradotto dal Paratore “spaccone”, mentre Pasolini utilizza il termine
“vantone”, anche perché successivamente il miles viene caratterizzato da altri aggettivi: impudens,
stercoreus, plenus periuri atque adulteri. Pasolini adopera tutta una serie di epiteti preoccupandosi
più della contestualizzazione che della fedeltà lessicale. Il termine meretrix, utilizzato due volte da
Plauto in due differenti accezioni, viene reso con “mignotta” una prima volta, una seconda con
“pischella”.
Ibidem.
Periplecomeno:
Magna e bevi, fa tutto che te pare!
A stupido, ce pensi? Se ‘na persona vale,
io do tutto per lei, ch’è tutto guadagnato!
Fa come a casa tua, essi pure sfacciato
Me fa piacere! Io, qua so’ er padrone,
e, pure, ‘n omo libbero! Io l’approvazione
me la do da me solo! Che co’ tutta ‘sta grana
che me ritrovo, pensa un po’ te che anima
de moje che potevo pijà, e non l’ho fatto.
13
Da questi versi ci si può chiedere se il romanesco di Pasolini sia autentico, oppure una lingua da lui
soltanto orecchiata e più vicina, per sua stessa ammissione, a quel gergo di “avanspettacolo” che il
poeta trovava affine al latino plautino. Sappiamo comunque che le riletture pasoliniane dei classici
latini e greci non si limitano mai ad una traduzione, ma sempre ad un’interpretazione, evidente
soprattutto nella filmografia dell’autore (si pensi alla Medea e all’Edipo re).
Terminiamo con le parole di Pasolini a proposito dell’uso della rima: Quanto alla rima le dirò
questo: i latini non conoscevano la rima, noi invece neolatini siamo ormai abituati a non
prescindere più dalla rima quando pensiamo alla poesia, soprattutto, naturalmente, quando
pensiamo alla poesia classica. Quindi ho adottato la rima, che è un procedimento prosodico, che è
nelle nostre abitudini e l’ho adottato per un testo come quello di Plauto che la rima non ce l’ha per
ragioni storiche (da “Le belle infedeli, ovvero i poeti a teatro” di Ruggero Jacobi, intervento di P. P.
Pasolini sulla traduzione dell’Orestiade e del Vantone, gennaio 1968).
DENTRO IL PROBLEMA
La filosofia a Roma: l’epicureismo
A partire II secolo a. C. con la conquista della Grecia e l’influsso di quest’ultima sulla cultura
romana, si diffonde il pensiero filosofico che rielabora le principali correnti ellenistiche. I Romani
erano più portati alla vita pratica che a quella contemplativa, per cui l’accettazione dell’epicureismo
e dello stoicismo, che aspiravano entrambi ad un ideale di distacco dalla vita pubblica, viene
mediata e resa meno drastica nell’ambiente romano. La diffusione del pensiero epicureo era stata
ostacolata dalla classe intellettuale e nel 173 a. C. furono allontanati due discepoli di Epicuro,
perché diffondevano, tra l’altro, una teoria fondata sulla casualità dell’agire che escludeva il valore
pratico dell’azione per il raggiungimento di un fine.
La dottrina epicurea portava all’autocontrollo, all’isolamento del saggio ed all’allontanamento da
tutto ciò che determina il rapporto con gli altri. Quest’ultimo aspetto era invece fondamentale
nell’organizzazione socio-politica romana. Altri motivi di ostilità potevano essere il non credere
agli dei e soprattutto a quell’insieme di riti che costituivano il patrimonio culturale romano;
eliminare la paura della morte e ribadire l’autosufficienza del saggio non era accettato in una società
basata sulle ricchezze di una ristretta cerchia, sull’ambizione in campo militare, su una virtus che
cercava la sua affermazione nel giudizio degli altri.
Ci si può chiedere chi fossero i seguaci di Epicuro a Roma e se il messaggio di tale filosofia fosse
osteggiato perché ritenuto eversivo. Cicerone, come vedremo, confutò tale dottrina in molte opere,
condannando l’idea del piacere fine a se stesso. Sicuramente questo era solo un aspetto della
filosofia epicurea, in quanto la ricerca dell’edoné è l’approdo di un iter fatto di riflessione sulle
leggi della natura e sul ruolo che in essa occupa l’uomo. L’opposizione di Cicerone e di molti
tradizionalisti nasceva da una lettura di questa filosofia anche in chiave di egualitarismo, in quanto
tutti potevano aspirare alla saggezza e, quindi, al raggiungimento dell’atarassia.
Probabilmente l’epicureismo ebbe i suoi centri a Napoli e ad Ercolano; un luogo di diffusione della
dottrina fu la villa di Pisone, dove visse e compose le sue opere Filodemo di Gadara (110-35 a.
C.), in cui probabilmente si formò Lucrezio e, più tardi, sotto la guida del maestro Sirone, Virgilio. I
ritrovamenti dei papiri ercolanensi che hanno restituito frammenti delle opere di Epicuro, lo
testimoniano. L’opera di Lucrezio è fedele al verbo del maestro, ma rimane isolata, in quanto la
società romana non era matura per un’adesione incondizionata e fideistica, mentre viene accettato il
poema lucreziano come opera poetica. Influssi epicurei troveremo invero in Virgilio, specie nelle
Bucoliche, e in Orazio, che si definisce “grasso porcellino del gregge d’Epicuro”. Si ha, però,
14
l’impressione che il
sia più una moda letteraria che un’adesione al pensiero
filosofico. Il precipitare della situazione politica verso l’assolutismo portò molti intellettuali a
distaccarsi dall’“impegno” pubblico ed a seguire i precetti di Epicuro.
La filosofia a Roma: lo stoicismo e il sincretismo
Nel circolo degli Scipioni, come abbiamo potuto constatare, molti uomini di cultura greca diffusero
a Roma lo stoicismo, grazie alla protezione di questa potente famiglia. Non si tratta dello stoicismo
delle origini, quello di Zenone di Cizio che era altrettanto intransigente quanto l’epicureismo,
poiché affermava che il sapiente deve raggiungere attraverso una severa disciplina di vita il distacco
dalle passioni; si diffuse invece lo stoicismo cosiddetto di mezzo, quello meno utopico e più
pragmatico di Panezio e Posidonio. Attraverso questi ultimi lo stoicismo a Roma contempera
l’intransigenza delle origini con una maggiore apertura del saggio agli altri ed alla vita politica.
S’introdurrà inoltre il concetto di “provvidenza” (prónoia) che verrà inteso come destino
universale di guida che Roma dovrà assumere.
Le virtù proposte dallo stoicismo si innestano in quelle romane ereditate dal mos maiorum. La virtus
univa le due qualità tipiche del romano, pietas e fides, grazie alle quali si realizzava il vir bonus.
Quest’ultimo è membro di una comunità e mette al servizio della res publica le sue energie ed è la
collettività stessa che lo riconosce come sapiente e gli concede onori e cariche pubbliche. Tale
aspetto trovava nello stoicismo la forma di pensiero più adatta: l’uomo obbedisce ad una legge
razionale (lógos) che gli indica i suoi compiti ed i suoi ruoli. Solo l’esercizio della virtù porta alla
felicità. La virtus dei Romani era molto diversa dall’areté greca, che riguardava l’uomo in quanto
spirito e non in quanto espressione della forza e del valore militare. Mentre il pensiero greco poneva
l’accento sull’armonia con le leggi della natura, i Romani consideravano bonum ciò che è
honestum.
Quando Roma allargò i confini dello stato cominciò a farsi sentire l’esigenza di un diritto che fosse
vincolante per tutti gli uomini e che si basasse sul lógos: da questo concetto stoico si sviluppa l’idea
di diritto naturale, cui allude Cicerone nel De legibus. La Stoa non influì solo sul diritto, ma
anche sulla linguistica, come testimonia l’opera di Varrone. Si fa risalire al 100 a. C.
l’elaborazione di una grammatica che, secondo Panezio, partiva dagli elementi basilari del
linguaggio e spiegava l’evoluzione della lingua con una complessità sempre maggiore.
A questo proposito furono coniati vocaboli corrispondenti a quelli greci, soprattutto nel campo della
filosofia. Sarà proprio Cicerone a far conoscere ai suoi concittadini il pensiero stoico, quando le
guerre civili sconvolgevano le certezze della tradizione e spingevano a fare appello al pensiero
filosofico.
Nella figura di Catone l’Uticense lo stoicismo trovò finalmente un esempio concreto di sapiens,
simbolo della libertà e dell’invincibilità del saggio, che vive secondo le sue idee e per queste sa
affrontare la morte, ricorrendo anche al suicidio. Lo stesso Bruto aderì al rigorismo morale dello
stoicismo, divenendone il simbolo da opporre alla tirannia che vuole soffocare il lógos.
Cicerone si mosse nel solco della tradizione risalente al circolo scipionico e, se dal punto di vista
artistico ebbe come riferimento Platone, nell’affrontare problemi concreti seguì Panezio: il suo
concetto di virtus ricalcava quello della Stoa. Egli, però, non voleva seguire fideisticamente una
dottrina, semmai essere l’iniziatore di un pensiero filosofico adatto ai Romani, si parla quindi di
sincretismo filosofico.
In quanto homo novus Cicerone era ambizioso ed era persuaso che la gloria fosse il riconoscimento
universale della virtus. Questo concetto lo allontana dall’apátheia stoica, ma l’oratore era portato ad
una fusione delle varie correnti di pensiero: da romano pone accanto alla virtus l’humanitas che
appartiene alla sfera privata dell’individuo e che sarà il filo conduttore della poesia augustea.
15
Dentro il testo
Catullo, Carme V
Questo carme è il quinto della raccolta, tuttavia va ricordato che i carmi di Catullo non sono ordinati
secondo un criterio cronologico. Nel liber, quindi, si esprime la continua tensione emotiva che
percorre l’opera in cui si alternano il ricordo dei momenti felici trascorsi con la donna e i sentimenti
contrastanti derivati dagli innumerevoli tradimenti da parte di lei.
Il componimento, a prima vista, può sembrare scritto per celebrare un momento felice vissuto con la
propria amata e in parte è così. Catullo invita Lesbia a baciarlo innumerevoli volte, senza curarsi dei
rumores… senum severiorum. D’altro canto questo carme è venato da una certa inquietudine che
conduce il poeta ad amare considerazioni sul rapporto tra vita e morte e sulla fugacità delle gioie
amorose.
Proprio a causa della molteplicità dei temi trattati il brano può essere diviso in quattro sequenze.
La prima sequenza occupa i primi tre versi (v. 1 - 3): Catullo si rivolge direttamente alla sua
Lesbia, “ incorniciando” il nome di quest’ultima tra due parole chiave: vivamus e amemus. Sono
due congiuntivi esortativi che Catullo rivolge a se stesso e alla propria amata, attraverso i quali
compie una scelta di vita.
In questo primo verso si può cogliere l’eco di tematiche trattate già nei carmi precedenti, infatti c’è
una palese contraddizione in alcune affermazioni catulliane: desidera Lesbia così com’è,
spregiudicata, ma la vorrebbe fedele e rispettosa dei valori della proba matrona. Viene infatti da
chiedersi come mai Catullo, desiderasse stabilire un sacro foedus amicitiae (basato sui valori della
fides), e abbia scelto una donna come Lesbia, chiacchierata a causa dei suoi comportamenti liberi e
addirittura accusata di aver commesso incesto con il fratello (a ciò si allude nel carme LXXIX).
Proprio a queste dicerie allude Catullo quando esorta Lesbia a considerare “pochi spiccioli” (unius
assis) i rumores1…. senum severiorum2.
In altri carmi, tuttavia, Catullo sembra dare credito ai rumores (nel citato c. LXXIX), da un canto si
rende conto dell’impossibilità di stabilire una relazione duratura e salda, dall’altro egli aspira ad un
legame di tipo coniugale.
Le aspettative di Catullo vengono però costantemente deluse: nonostante Lesbia prometta fedeltà
assoluta, ella tradisce il sacro e inviolabile foedus che la lega al poeta, generando nell’anima di
quest’ultimo un drammatico contrasto di sentimenti. Nel carme LXXII ciò spinge addirittura
Catullo ad affermare che nonostante aumenti in lui il disprezzo nei confronti della donna e vengano
meno la stima e l’affetto, cresce anche la passione nei suoi confronti (amare magis…. sed bene
velle minus), passione a cui si allude anche in questo carme nella terza sequenza.
La seconda sequenza (v. 4-6) è dominata da un tono più cupo. Il verbo principale del primo
periodo è possunt, da cui dipendono due infiniti (occidere et redire). Il soggetto del periodo è soles,
che “possono cadere e ritornare”: soles è in realtà una metonimia per “giorni”, già utilizzato nel
carme VIII (fulsere quondam candidi tibi soles): al ricordo della donna amata e dei bei momenti
trascorsi con lei è associata la sfera semantica della luminosità. Il verso successivo si apre con
nobis, un dativo d’agente “per noi”: questa è una delle parole chiave del componimento in quanto
gli amanti sono il perno attorno al quale ruota l’esperienza di vita. “Una volta che per noi è finita
la breve giornata, dovremo dormire una notte eterna”: l’immagine “della breve giornata” (il
tempo vola quando lo si trascorre con la donna amata, di qui l’invito a vivere e amare quanto più si
può: vivamus/amemus è il corrispettivo del carpe diem oraziano) è un tòpos ripreso, tra gli altri
dalla lirica greca. Anche “nox” è una metafora della morte, insieme a soles, è una delle parole
chiave della seconda sequenza.
1
2
Termine onomatopeico che rende i mormorii
Comparativo assoluto.
16
Alla fine del terzo verso si trova l’espressione brevis lux: questa può essere considerata una climax.
Notiamo infatti la gradualità con cui si passa da una luce intensa (soles), ad una più debole (brevis
lux), al buio dell’eternità (nox). E’ come se, gradualmente, anche la speranza di un’eternità trascorsa
con la propria amata si “spenga” in Catullo.
La terza sequenza occupa i versi da 7 a 9 ed è costituita da un unico periodo. L’imperativo iniziale
(da) è l’unico verbo della sequenza: “Dammi mille baci, e poi cento, altri mille, e poi cento, altri
mille, e poi un’altra volta cento…” .
Catullo utilizza il termine basia, altra parola–chiave termine del sermo familiaris per osculum.
Probabilmente esso veniva usato nella Gallia Cisalpina in luogo di savium.
Il poeta si serve spesso termini desunti dal linguaggio quotidiano a sottolineare che il suo amore non
è letterario, ma è puro e sincero. Il da è un termine chiave nel componimento: sembra quasi che
Catullo voglia scacciare i pensieri cupi e inquieti della sequenza precedente, e perciò ricorre alla
richiesta di un’infinità di baci.
È facile individuare l’anafora di mille (mille….mille… altera mille) e di deinde/dein (deinde…
dein… dein…. deinde…. deinde), nonché l’epifora di centum (centum …. centum… centum…).
Questo accavallarsi di notazioni numeriche e congiunzioni, scandite dalla presenza delle virgole,
serve a rendere l’ansia del poeta, generata dalla consapevolezza (espressa nella II sequenza) che i
bei momenti trascorsi con la donna amata giungeranno inevitabilmente alla fine. Non a caso,
l’ultimo verso della II sequenza è occupato da una perifrastica passiva, la quale esprime necessità,
obbligo: si dovrà dormire una notte eterna. La morte è inevitabile e l’aspirazione del poeta
all’eternità della passione amorosa deve fare i conti con le leggi immutabili del divenire.
Infine, vi è l’ultima sequenza, che occupa i versi 10 -13.
In apertura viene ripresa la congiunzione dein, già in anafora nei versi precedenti.
Vi è poi la costruzione del cum narrativo: il soggetto del verbo al congiuntivo è ancora la coppia di
amanti, nucleo dell’esperienza di vita narrata nel carme, sancita anche da nobis al v. 5.
“Quando ne avremo sommate molte migliaia” (milia multa è il complemento oggetto, riferito a
basia), conturbabimus illa: il verbo è un termine tecnico che significa “imbrogliare sulla cifra”.
Viene subito spiegata la ragione di tale comportamento, con una finale negativa coordinata ad
un’altra finale (ne sciamus… aut nequis malus invidere possit): i due amanti non sono interessati a
conoscere il numero dei baci e vogliono evitare che qualche (nequis - ne aliquis) malus, “malvagio”
getti su di loro il malocchio (ne possit invidere).
Catullo, dopo aver rivolto la propria polemica contro i senum severiorum, si scaglia ora contro
aliquis malus: non a caso per il carme è stato utilizzato l’endecasillabo falecio, riservato solitamente
alla poesia satirica.
L’ultima proposizione è riferita all’aliquis malus, che potrebbe invidere … cum tantum sciet esse
basiorum (“sapendo che esiste un tale numero di baci”), in cui basiorum è genitivo partitivo ed è
presente il costrutto del cum narrativo (sciet).
Dentro la parola
A proposito della scelta lessicale, è importante notare come Catullo scelga di utilizzare il verbo
amo (amemus, v. 1). “Amo” indica, appunto, “amare”, “voler bene” (da cui deriva poi “amante”,
“amica”), analogo al file/w greco, che indica, a volte, anche un amore morboso. Il verbo amare
italiano deriva dal latino, ma per i composti si ricorre al greco (suffisso -filia di solito in eccezione
negativa, necro-filia, pedo-filia).
Altri modi di tradurre “ amare” sono: diligo (levius amo, “scegliere”, “stimare”), analogo al greco
stergo. Cupio (“bramare”, “desiderare”), analogo al greco erào, libet (“piace”) ha il suo
corrispondente in iméiro.
17
Dentro il testo
L’INVOCAZIONE A VENERE
-
Aeneadum genitrix: i Romani discendevano da Enea, la cui madre era Venere; Aeneadum sta
per Aeneadarum. Si noti che sono celebrati nel proemio gli amori di Venere e Marte, i due
progenitori dei Romani, in quanto Marte era ritenuto padre di Romolo.
Divom: divum = deum, cioè deorum; i termini conferiscono una patina arcaica al linguaggio.
Voluptas: è la voluptas catastematica, la felicità tranquilla degli dei e l’obiettivo degli
uomini saggi (l’atarassia degli epicurei).
Alma: “divina”, dal verbo alo, “che dà nutrimento”.
Labentia: allude al moto degli astri, dal verbo labor.
Navigerum ... frugiferentis: vocaboli usati solo qui (ápax legómenon) composti dal poeta
con un nome e una radice verbale.
Quae … quae: anafora, la ripetizione del pronome per invocare la dea è frequente nel brano,
secondo la tradizione innologica.
Concelebras: “riempi di te”, il prefisso con rafforza il valore del verbo.
Per te quoniam: anastrofe, quoniam per te.
Animantum: declinazione atematica del genitivo del participio presente.
Fugiunt venti … nubila caeli: l’epifania di Venere si rivela con l’avvento della primavera; la
scena ispirerà l’iconografia rinascimentale, come ad esempio la Primavera del Botticelli
(1478).
Suavis … flores: enjambement, suavis vale suaves.
Daedala: dal greco daidállein (creare), vuol dare l’idea della creazione della bellezza.
Summittit: "fa spuntare"; l’idea della primavera è associata alla rinascita della forza creatrice
della natura rappresentata da Venere.
Verna: ipallage, verna è accordato con species, ma logicamente si riferisce a diei.
Favoni: vento di primavera, zefiro, che soffia dalla metà di febbraio.
Corda: accusativo di relazione.
Ferae pecudes: la forza dell’amore rende furiosi gli animali (pecudes).
Persultant: da per-salto, frequentativo di salio.
Laeta: “ricchi di vegetazione”.
Rapidos: i fiumi diventano copiosi per la neve che si è ormai sciolta.
Tranant: da trano, trans-no.
Capta: si riferisce a pecus, come anche il quamque seguente, dopo il soggetto plurale
seguono espressioni al singolare.
Frondiferas domos: metonimia per indicare gli alberi.
Virentis: virentes.
Generatim: avverbio "specie per specie".
Saecla: forma sincopata per saecula, traduci "la vita".
Quae quoniam: vale et quoniam tu.
Rerum naturam: l’universo.
Dias: “celesti”.
Studeo: "desidero vivamente", "supplico".
Scribendis versibus: dativo di fine con il gerundivo
De rerum natura: è il titolo dell’opera, come in Epicuro ed Empedocle (Perì phýseos).
Memmiadae nostro: dativo di vantaggio; Memmio è il dedicatario dell’opera.
Moenera: arcaico per munera
18
-
Militiai: per militiae, genitivo arcaico.
Mavors: forma arcaica di Mars.
Tereti cervice: teres deriva dal verbo tero, tornisco, consumo (da cui attrito), qui vale “ben
fatto"; cervix, collo, indica la testa.
Pascit amore: gli amori di Marte e Venere, ovvero Ares ed Afrodite, erano uno dei soggetti
mitologici più frequentemente rappresentati.
Memmi propago: la stirpe dei Memmi, allude al dedicatario dell’opera.
Desse: per deesse.
Communi saluti: il cives deve dedicarsi innanzi tutto al bene comune e solo nei momenti di
otium può interessarsi alla filosofia.
Dentro il problema
La peste di Atene
La descrizione della peste nel De rerum natura ha il suo antecedente in quella raccontata dallo
storico Tucidide nella Guerra del Peloponneso. Si trattava di un’epidemia che si diffuse ad Atene
nel 430 a. C.; probabilmente fu un contagio dovuto ad una febbre tifoidea la cui causa è
rintracciabile nella contaminazione dell’acqua. La peste fu devastante in quanto la città era molto
affollata perché gli abitanti della campagna, in seguito alle invasioni degli Spartani, vi si erano
rifugiati. Tucidide descrive molto dettagliatamente i sintomi della malattia e afferma che neanche i
medici riuscivano a curarla in quanto, a contatto diretto con l’infezione, morivano prima e più degli
altri. Le conseguenze furono nefaste perché gli Ateniesi, nella consapevolezza della fine imminente,
non seguirono più né leggi né regole e questo contribuì alla loro sconfitta.
Nel De rerum natura la narrazione della peste è inserita per dimostrare che le epidemie non sono i
segnali della collera divina, semmai la malattia va analizzata in modo scientifico per trovarne i
rimedi.
Diodoro Siculo ci racconta che gli Ateniesi, quando scoppiò il contagio, si recarono nell’isola di
Delo per purificarsi, quindi si pensava che la divinità reagisse ad un comportamento empio degli
uomini, inviando loro tali sciagure. Nell’inizio dell’Iliade Apollo per vendicarsi dell’oltraggio
subito, invia la peste nell’esercito acheo.
Anche la tragedia sofoclea Edipo re si apre con l’immagine della città di Tebe in preda al contagio
pestilenziale, in quanto l’uccisore del precedente re vive impunito in essa e la contamina.
Da questi esempi si ricava che la malattia è inviata dagli dei per una colpa che deve essere espiata,
perché il male contamina. Lucrezio invece osserva il fenomeno con gli occhi dello scienziato.
Il tema della pestilenza è stato variamente inserito in molte opere, a cominciare dal Decamerone del
Boccaccio, alla dettagliata descrizione dei Promessi Sposi, fino alle immagini di desolazione e di
morte nel romanzo La peste di Albert Camus, in cui in assenza del divino, di una visione
provvidenziale e di un interesse scientifico, il tema riflette il nulla che circonda l’esistenza
dell’uomo.
Testi
Boccaccio, Decamerone, I Giornata, Introduzione:
E non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto segno
di inevitabile morte: ma nascevano nel cominciamento d’essa a’ maschi e alle femine parimente o
nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal
mela, altre come uno uovo, e alcune più e alcun’altre meno, le quali i volgari nominavan
gavoccioli. E dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavocciolo
19
mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire: e da questo appresso
s’incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle
braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade e
a cui minute e spesse. E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio
di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno. A cura delle quali infermità né
consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto: anzi, o che
natura del malore nol patisse o che la ignoranza de’ medicanti (de’ quali, oltre al numero degli
scienziati, così di femine come d’uomini senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai,
era il numero divenuto grandissimo) non conoscesse da che si movesse e per consequente debito
argomento non vi prendesse, non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti infra ‘l terzo
giorno dalla apparizione de’ sopra detti segni, chi più tosto e chi meno e i più senza alcuna febbre
o altro accidente, morivano.
Il Boccaccio racconta gli effetti della peste nera del 1348 che si diffonde a partire dal nord
Europa con altissima mortalità. Essa annulla ogni differenza sociale e toglie all’uomo la dignità.
Non compare nel testo la presenza del divino e la descrizione risulta molto realistica, anche se non
priva di suggestioni letterarie. Proprio l’epidemia di Firenze porterà i protagonisti delle novelle ad
allontanarsi dalla città e a rifugiarsi nella fantasia del raccontare per evadere dalla paura del
contagio ed esorcizzare la morte.
Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXI
… Sia come si sia, entrò questo fante sventurato e portator di sventura, con un gran fagotto di vesti
comprate o rubate a soldati alemanni; andò a fermarsi in una casa di suoi parenti, nel borgo di
porta orientale, vicino ai cappuccini; appena arrivato, s'ammalò; fu portato allo spedale; dove un
bubbone che gli si scoprì sotto un'ascella, mise chi lo curava in sospetto di ciò ch'era infatti; il
quarto giorno morì. … Ma sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima nel borgo di porta
orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti
strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di
bubboni; morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di
malattia. I medici opposti alla opinion del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevan
deriso, e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo
palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti: miserabile
transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; perché, figurando di riconoscere
la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere, che il
male s'attaccava per mezzo del contatto. I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno,
principiarono a dare un po' più orecchio agli avvisi, alle proposte della Sanità, a far eseguire i suoi
editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale. Chiedeva esso di continuo
anche danari per supplire alle spese giornaliere, crescenti, del lazzeretto, di tanti altri servizi; e li
chiedeva ai decurioni, intanto che fosse deciso (che non fu, credo, mai, se non col fatto) se tali
spese toccassero alla città, o all'erario regio. Ai decurioni faceva pure istanza il gran cancelliere,
per ordine anche del governatore, ch'era andato di nuovo a metter l'assedio a quel povero Casale;
faceva istanza il senato, perché pensassero alla maniera di vettovagliar la città, prima che
dilatandovisi per isventura il contagio, le venisse negato pratica dagli altri paesi; perché
trovassero il mezzo di mantenere una gran parte della popolazione, a cui eran mancati i lavori. I
decurioni cercavano di far danari per via d'imprestiti, d'imposte; e di quel che ne raccoglievano, ne
davano un po' alla Sanità, un po' a' poveri; un po' di grano compravano: supplivano a una parte
del bisogno. E le grandi angosce non erano ancor venute.
Le parole di Manzoni offrono un’interpretazione provvidenziale della pestilenza. La descrizione
è estremamente dettagliata e il lettore percepisce che è tutto in funzione del lieto fine della vicenda:
20
un evento tanto luttuoso è quello che permetterà ai due protagonisti di ricongiungersi e consentirà la
punizione dei malvagi. L’episodio descritto si verificò nel 1630 in Europa e dilagò soprattutto nel
nord Italia.
Albert Camus, La peste, cap. I
Gli strilloni dei giornali della sera annunciavano che l'invasione di sorci era bloccata. Ma Rieux
trovò il suo malato che pencolava quasi fuori dal letto, con una mano sul ventre e l'altra intorno al
collo, vomitando a forti strappi una bile rossastra in un bidone d'immondizie. Dopo lunghi sforzi, senza
fiato, il portiere si ricoricò. La temperatura era a trentanove e mezzo, i gangli del collo e le membra
erano gonfi, due macchie nerastre gli si allargavano sul fianco. Si lamentava, adesso, d'un dolore
interno.
(trad. B. Dal Fabbro)
Il racconto di Camus si riferisce ad un’epidemia di peste bubbonica causata da cadaveri di topi in una città
algerina, Orano, negli anni quaranta (il romanzo fu pubblicato nel ‘47). Non è difficile capire l’allusione al
flagello del nazismo e della seconda guerra mondiale ed alla debolezza dell’animo umano: nella città, chiusa da
un cordone sanitario, ognuno si abbandona alla propria natura, chi specula sulle disgrazie altrui, chi si prodiga
per salvare gli altri (come il protagonista, il medico Rieux), chi si chiude nella religione, chi vorrebbe fuggire
per seguire le proprie passioni, ma poi resta per aiutare gli altri. La peste è quindi il simbolo del male umano,
sempre presente e sempre riemergente, perché il virus è nell’uomo stesso.
Dentro il problema
Henri Bergson (1859-1941): Lucrezio
Il testo di Bergson (Extraits de Lucrèce avec commentare, études et notes, Delagrave, Paris, 1883)
risale al 1883 ed è un’opera esclusivamente didattica, destinata agli studenti. Il filosofo in
quell’anno insegnava al liceo Pascal di Clermont Ferrand e proponeva lo studio di Lucrezio non
solo sotto l’aspetto linguistico e testuale, ma anche filosofico. Entrando nello spirito del poeta
latino, Bergson voleva dimostrare che l’espressione di un pensiero filosofico può anche trasformarsi
in poesia, il giovane professore parte proprio dalla tematica “la poesia ad uso della filosofia”.
Affinché gli studenti capissero e acquisissero un metodo di lavoro filosofico era opportuna la lettura
antologica di un testo, analizzando la dottrina rigorosamente, senza lasciarsi troppo sviare dai
problemi lessicali, metrici e morfologici. Bergson, nel proporre la lettura del testo, pone l’accento
sulle contraddizioni evidenti nell’opera, convinto che, per poter comprendere ed eventualmente
confutare un sistema filosofico, bisogna prima saperlo ben analizzare. Sull’influenza di Lucrezio
nella filosofia di Bergson rimangono molte perplessità, forse al filosofo interessava più il metodo
che il contenuto.
Diverso fu l’atteggiamento del giovane Karl Marx che nell’opera Differenza tra le filosofie naturali
di Democrito e di Epicuro (Dissertazione dottorale tenuta a Jena il 15 aprile 1841) cercava un
antecedente al materialismo storico. La dottrina epicurea e la diffusione fattane da Lucrezio
permettevano a Marx di sfruttare l’atomismo e applicarlo ai sistemi della storia attuale.
21
DENTRO IL PROBLEMA
La Congiura di Catilina
I fatti sono narrati da Cicerone, Sallustio, Plutarco e Cassio Dione.
Tra l’anno 66 ed il 65 a. C. Catilina cospirò con Calpurnio Pisone per uccidere i consoli nominati
in sostituzione di Publio Autronio e Cornelio Silla, le cui elezioni furono annullate per broglio, e
per rimettere in carica costoro o sostituirsi ad essi. Le lagnanze dell’ambasceria di provinciali
d’Africa in senato contro Catilina e le accuse di vessazione (de vi) sugli amministrati durante il suo
governo da parte di Publio Clodio, gli preclusero la via al consolato. Ne uscì assolto, ma col
sospetto che i giudici fossero stati corrotti.
Ai Comizi consolari per l’anno 63 a.C. Catilina presentò la sua prima candidatura al consolato.
Nonostante l’appoggio di Cesare, risultarono eletti Cicerone, per la concordia verificatasi tra
senato, cavalieri e tutti coloro che erano amanti della legalità, e Gaio Antonio, uomo infido e
compromesso con i democratici, ma che Cicerone trasse dalla sua parte cedendogli il governo della
Macedonia.
Le nuove elezioni consolari per l’anno 62 a. C. si tennero a fine luglio o ai primi di agosto del 63,
in quanto subirono una proroga di alcuni giorni perché si erano verificati violenze e tumulti.
Il sostegno a Catilina veniva dal partito democratico, dai veterani di Silla venuti dall’Etruria su
istigazione di Gaio Manlio, dagli aristocratici indebitati, da cavalieri economicamente rovinati e da
giovani dissoluti.
Fu questo il secondo fallimento di Catilina nella candidatura al consolato: furono eletti D. Giulio
Silano, uomo probo, e P. Licinio Murena (già difeso da Cicerone dall’accusa di broglio da parte di
S. Sulpicio Rufo) esperto militare, luogotenente di Lucullo nella guerra Mitridatica.
Nonostante ciò la speranza di novità e la simpatia della plebe, il dissesto agrario per le guerre civili
e le conseguenti gravose usure su terreni e capitali, costituivano il sostrato sociale su cui Catilina
ancora poteva contare.
Si rendevano necessarie, a questo punto, delle decisioni e Catilina inviò a Fiesole il centurione
Manlio per arruolare i veterani di Silla, in difficoltà economiche per gli sperperi compiuti, che li
costringevano a disfarsi delle terre loro assegnate. Nel Piceno inviò Gaio Settimio e in Apulia Gaio
Giulio, altri mandò in Campania per arruolare gladiatori o militi per fornire aiuto a Manlio.
Nell’urbe erano dalla sua parte anche alcuni pretori, alcuni senatori e cavalieri e quel Q. Curio che,
tramite la sua amante Fulvia, informò del fatto Cicerone.
Le prime prove tangibili della congiura furono date al console Cicerone la notte del 20 ottobre da
Crasso, M. Marcello e Metello Scipione che gli portarono delle lettere anonime in cui si accennava
al massacro di vari personaggi di spicco (tra cui i latori delle missive) che si sarebbe verificato
quella notte in favore di Catilina.
Convocato il senato, il mattino seguente, furono lette le lettere, fu dato l’annuncio della rivolta
armata in Etruria e preannunciato l’eccidio degli ottimati.
L’agitazione della città, delle matrone in particolare, è ben descritta da Sallustio (De con. Cat. 31,
3). Giunto Q. Arrio in senato con le notizie dei preparativi militari in Etruria, si emise il decreto per
i pieni poteri al console (Senatus consultum ultimum). La congiura fu bloccata dai solleciti
preparativi di Cicerone, che fece presidiare la città e le fortezze (Preneste fu difesa in modo tale che
i congiurati la notte del primo novembre, rinunciarono al tentativo di sollevazione). Regnava
comunque molta incertezza. Vistosi scoperto, Catilina convocò a casa del senatore M. Porcio Leca,
la notte tra il 6 e il 7 novembre, i capi della rivolta: organizzò la sollevazione in Roma e si preparò a
recarsi in Etruria. Il cavaliere Gaio Cornelio e il senatore Lucio Vargunteio si offrirono di recarsi a
casa di Cicerone il giorno dopo per ucciderlo. Il console, informato da Curio per mezzo di Fulvia,
sventò il tentativo e la mattina stessa del giorno 8 novembre, convocò il senato nel tempio di Giove
22
Statore ai piedi del Palatino, fra le forze schierate. Catilina ignorando il fatto, accusato de vi da L.
Emilio Lepido, si presentò in senato per discolparsi ed affidarsi alla compiacente custodia
domiciliare del suo complice M. Marcello, ma intorno a lui fu il vuoto (cfr. il quadro di Gérôme
collocato nell’aula del Senato).
Cicerone
La I Catilinaria fu pronunciata l’8 novembre davanti al senato nel tempio di Giove Statore.
L’oratore sapeva di essere oggetto d’invidia come homo novus e la prudenza lo portava a cercare
delle prove: il suo gioco psicologico tendeva a smascherare il rivale e per ciò lo investiva con
impeto, tanto che l’orazione fu ammirata anche da Sallustio; a volte impone, a volte chiede, ma la
logica dell’accusa porta verso un’unica possibilità: che lasci Roma!
Intorno alla curia erano schierati i cavalieri, i boni cives. Catilina uscì furioso dal senato e gettò la
maschera, partendo per il campo di Manlio in Etruria: era la guerra.
La II Catilinaria
Pronunciata dinanzi al popolo dalla tribuna dei rostri il 9 novembre, voleva persuadere gl’incerti,
ricordando le proscrizioni sillane, i giovani corrotti dediti alle lussurie, ma abili col pugnale, i
complici e i favoreggiatori. È l’annuncio del futuro trionfo: si uniscano pure al traditore! Egli
oppone alle scompaginate forze dei ribelli le forti e disciplinate milizie dello Stato.
La III Catilinaria
I congiurati fissarono per il 16 e 17 dicembre la strage degli ottimati e cercarono di tirare dalla loro
parte gli ambasciatori degli Allobrogi. Essi, però, tramite il loro patrono Q. Fabio Sanga,
avvisarono il console, e per aver prove si concordò che si facessero rilasciare lettere con impegno
scritto da portare al loro senato. Sarebbero inoltre stati accompagnati da T. Volturcio al campo di
Catilina. Il 3 dicembre fu teso l’agguato a Ponte Milvio e i congiurati furono arrestati dai pretori. Il
senato fu convocato nel tempio della Concordia e Gabinio, Statilio, Cetego e Lentulo furono
condannati dalle testimonianze delle loro stesse lettere, dalle accuse degli Allobrogi e di Volturcio,
delatore sotto promessa d’impunità. Cicerone fu salutato da Q. Lutazio Catulo come “padre della
patria” (cfr. In Pis. 3,6). La sera Cicerone si presentò al popolo per informarlo e poi al senato,
riunito ancora nel tempio di Giove Statore, per accusare i colpevoli. Nell’aula essi confessarono,
schiacciati dalle accuse e l’oratore invitò tutti a rendere grazie non a lui, ma agli dei!
La IV Catilinaria
Durante le memorabili None (il 5 del mese) del dicembre del 63 a. C. si verificò il momento critico
per la battaglia legale circa l’appello al popolo per la condanna a morte. Decimo Giulio Sillano,
console designato, parlò per primo e propose la pena di morte per i congiurati. Così anche si
espressero altri senatori. Seguì il discorso abile di Cesare, pretore designato, che propose, invece, il
carcere perpetuo, l’affidamento in qualche municipio d’Italia e la confisca dei beni. Si appellava
alla tradizione dei padri, sempre moderati, e al fatto che la condanna a morte senza un regolare
processo né l’appello al popolo, ius provocationis, dava alla condanna capitale stessa un carattere
d’illegalità. Molti senatori, scossi dal discorso, fra cui lo stesso fratello di Cicerone, Quinto, e Gaio
Silano aderirono alla proposta.
Il discorso di Cicerone, la IV Catilinaria, fu risolutivo: dimostrò coraggio, rispettò l’idea di Cesare,
ma propose la condanna come un sereno atto di giustizia (Sallustio ignora il discorso e Plutarco
non lo capisce). Egli sarà in grado, come console, di garantire l’ordine, nel rispetto delle decisioni
del senato; per sé avrebbe voluto solo la gratitudine e la gloria, frutto della virtù.
Il fiero discorso di Catone, che convinse il senato alla pena capitale, stroncò la congiura.
I colpevoli, trasferiti la sera stessa nel carcere Mamertino, furono uccisi per soffocamento.
Catilina in seguito fu vinto presso Pistoia da Petreio (luogotente del console Antonio che si era
ammalato) e morì combattendo.
Sallustio
23
Narra i fatti nel De coniuratione Catilinae, spiegandoli come una conseguenza della corruzione di
Roma. A quel tempo il futuro storico era ventitreenne, quindi non ancora partecipe della vita
politica. L’opera sulla congiura sarà composta più tardi, tra il 43 e il 42 a. C.. Come plebeo, se pur
di famiglia facoltosa, simpatizzava con i democratici, mentre Catilina era aristocratico.
Nell’introduzione evita di condannare i popolari, il ritratto di Catilina presenta molti toni positivi, lo
scagiona da accuse ingiuste su presunti delitti (22, 3), la fine è quella di un eroe, senza ombra di
riserve per il suo operato. È certo che vuole scagionare anche Cesare, suo protettore, che forse
aveva avuto parte nella congiura, o almeno l’aveva favorita senza compromettersi, come forse in un
primo momento anche Crasso (cfr. 17, 7). Del resto verso Cicerone non ha simpatia, non è mai
espressa una lode, pur nel riconoscimento dell’abilità oratoria; ne evidenzia anzi la debolezza per
essersi lodato. La sua Invettiva contro Cicerone del resto non ci può dire molto, data la dubbia
autenticità.
Plutarco
Scrive in greco verso la fine del I secolo d. C.. La sua opera, Le vite parallele, è più simile ad una
sorta di biografia romanzata che ad un trattato storico.
I fatti della congiura sono narrati nella Vita di Cicerone (in parallelo con la vita di Demostene) dal
cap. 14° al 22°: la sua ottica è quella di un osservatore curioso, ma rispettoso del coraggio,
dell’abilità oratoria e dell’onestà dimostrata dal console in quell’occasione. Ne biasima però la
propensione alla vanità, talora veramente eccessiva e fuori posto. Dalle sue parole comunque
sembra emergere l’idea che tali uomini possono pure avere difetti notevoli, ma restano sempre dei
grandi.
Cassio Dione
Vissuto tra il II e il III secolo d. C., scrive in greco la Storia Romana (Romaiké Istorìa), dallo sbarco
di Enea in Italia ai tempi di Alessandro Severo (229 d. C.), in ottanta libri di cui ci son pervenuti
quelli dal XXXVI al LX, relativi agli anni dal 68 a. C. al 47 d. C.; per le parti mancanti abbiamo
compendi bizantini.
Cassio Dione è uno storico attento ai fatti, scrupoloso, ingenuo nel prestar fede ai prodigi e nel far
parlare i personaggi con le proprie idee. E’ poco interessato alle colorite interpretazioni, ha un forte
senso dello stato e, come senatore, vede nel potere assoluto il fulcro della sicurezza dei cittadini, se
è contemperato dalla collaborazione con il senato.
La congiura è narrata nel libro XXXVII, dal capitolo 29 al 42. Conosceva l’opera di Plutarco e
Sallustio, anche se non sembra aver usato come fonte quest’ultimo. Loda l’abilità e il coraggio di
Cicerone, biasima la corruzione dei congiurati, compiange la lotta fratricida che ha visto morire
combattendo coraggiosamente anche i congiurati, mette in rilievo la responsabilità del senato, più
che quella di Cicerone che ne fu il capro espiatorio, per aver condannato a morte dei cittadini
romani senza l’appello al popolo.
DENTRO IL PROBLEMA
I - II sistema retorico ciceroniano: una sintesi culturale
La cultura in materia di oratoria a Roma si fa risalire ai tempi dei Gracchi, i famosi tribuni
plebis, morti durante i tumulti per l’approvazione delle leggi agrarie per la ridistribuzione delle terre
dell’ager publicus: essi furono i primi tecnici dell’eloquenza. L’esperienza nell’ambito del circolo
degli Scipioni definì, inoltre, che parlare al popolo implica anche il possesso della virtù, per
preservare e rinvigorire l’autorità del senato su cui si fondano le istituzioni.
24
Dall’esame delle orazioni e delle opere di retorica di Cicerone, che in pratica lo hanno impegnato
per tutto l’arco della sua vita, si nota che egli ha operato una sintesi di eloquentia popularis secondo
il modo dei Gracchi e di quella espressa dalla tradizione dell'Emiliano e di Catone: l'eloquenza,
unita alla tecnica, tende alla saggezza, dirige le deliberazioni politiche, fonda il diritto.
La parola non può essere neutra: Cicerone lega l’inizio della sua attività (l’orazione Pro S. Roscio
Amerino) allo scacco di Silla, il dittatore; i suoi vari trattati non sono innocui manuali, ma manifesti
discreti in favore della libertà di parola e toccano i grandi problemi politici del tempo: la sovranità
popolare, la composizione delle giurie (per esempio da parte dei cavalieri per le leggi giudiziarie);
si citano i Gracchi e Scipione ed il consensus bonorum (unione di tutti i cittadini onesti) per
ottenere un equilibrio fra ottimati e popolari, di cui il senato doveva farsi garante.
Per rispondere a tutto ciò ed esserne all’altezza, il Nostro fa appello alla filosofia: l'Oratore, come
già Crasso (il suo modello ideale citato nelle opere retoriche), sentiva in sé la grande responsabilità
di parlare (De Oratore I, 26, 119 - 27, 125) e per ciò chiedeva aiuto alla sapienza (De Inventione I
1, 1 sgg.) ed ai precetti dei filosofi.
Da costoro gli derivavano molti riferimenti: da Platone la necessita della saggezza per la retorica; da
Posidonio l’idea dei saggi come fondatori delle città; da Aristotele la considerazione della politica
come parte della retorica (De Inventione I, 5,6), infine dagli stoici la distinzione tra officium e finis,
in quanto il genere deliberativo ha come fine l'utile e l'onesto.
II - La procedura romana
Cicerone si trovava però anche a dover affrontare i problemi impostigli dalla pratica forense
a Roma: la tipicità della procedura era legata all'abilità dell'avvocato, detto patronus (l’advocatus
era un semplice assistente); invece nel procedimento giudiziario greco in cui i giudici avevano già
ascoltato le testimonianze ed avevano avuto modo di farsi un'idea propria, l’orazione doveva tener
conto di ciò.
A Roma l'avvocato era come un direttore d'orchestra: prendeva le redini del processo e lo istruiva a
suo modo. L'escussione dei testi era riservata ad un secondo momento, prima venivano le orazioni
degli avvocati. La procedura lasciava, quindi, ampio spazio al pathos per creare l'ambiente favorevole all'interpretazione più o meno rigorosa delle testimonianze.
Di qui l'importanza della vita anteacta dell’imputato, non solo perché si faceva leva sui sentimenti
per attirare il favore popolare della giuria, ma soprattutto perché si tendeva a creare nel giudice una
pregiudiziale favorevole.
L'avvocato (patronus) poteva prendere più volte la parola, e non era importante solo la natura
causarum (De Oratore II, 76, 307) del dibattito, ma anche prudentia e iudicium dell'oratore che
doveva sapere come disporre le argomentazioni.
Spesso si verificava il caso di più patroni alla difesa di un accusato ed il Brutus (57, 207) ci
testimonia che, per cause importanti, si era arrivati anche a sei patroni.
Ad una pratica di un collegio di avvocati in cui ognuno si sceglieva la sua parte non si poteva,
quindi, applicare uno schema rigido, preparato per un discorso unico ed esauriente, ma lo si doveva
adattare alla mentalità romana, per cui l'assumersi la responsabilità di una causa era un
officium, un dovere e il patrocinio sottendeva un rapporto personale.
Lo schema retorico diviene null'altro che un riferimento, perché ogni causa ha i suoi punti oscuri e
l'oratore deve opportunamente saper lumeggiare ciò che gli conviene, o dissimulare le parti deboli
(cfr. De Oratore, II, 72, 291 sgg.). Col popolo doveva stabilirsi un vincolo di fides: l'Oratore, nella
Divinatio delle Verrine ad esempio, deve spiegare perché scenda in campo contro Verre; nella Pro
Archia esagera l'importanza dei rapporti fra sé ed il poeta; perché Sestio deve essere assolto (Pro
Sestio)? Perché durante il suo tribunato si era adoperato in favore del ritorno del Nostro e Cicerone,
che qui parla al quarto posto dopo Ortensio, Crasso e Calvo, dedica alla parte giudiziaria solo un
breve accenno, si dilunga invece molto sugli aspetti politici. Insomma Verre, Archia, Cluenzio,
Murena divengono, rispettivamente, il male personificato, l’elogio della poesia, l’invettiva contro la
corruzione di Cluenzio e della moglie Sassia, la critica della pedanteria dei giuristi.
25
Per contro si lascia alla parte giuridica della causa un posto quasi trascurabile.
III - L’orazione Pro Milone: un sillogismo.
L’orazione considerata come la migliore, fu purtroppo, a causa dell'ostilità popolare e dei
fermenti della guerra civile, uno dei peggiori insuccessi. Cicerone infatti, intimorito dallo
spiegamento di truppe, perse la necessaria lucidità. L’opera, comunque, fu trascritta in seguito.
Proprio in questa arringa Cicerone afferma che vuole mostrare l'innocenza del suo cliente (questione
congetturale) e, in secondo luogo, giustificare la sua azione (questione giudiziaria) (Pro Milone
2 , 6 ) . Invece il vero piano del discorso è filosofico e sviluppa un'idea generale: sin dall'inizio ( 3 , 7 4 , 1 1 ) si dimostra, rifacendosi agli antichi esempi sia delle leggende che delle tradizioni, che
talvolta è permesso uccidere in nome della legge. Si spiega poi (5, 12 - 8, 22) che portare Milone in
giudizio non è ammettere la colpa, ma solo il fatto. La parte centrale dell'arringa argomenta come
Milone non sia stato l'aggressore (9, 23 - 26, 71), poi si dimostra che, in ogni caso, ha difeso lo
stato, togliendo di mezzo un pericolo pubblico, quindi ha ucciso in nome della legge (27, 71 32,91). Questo metodo di argomentazione è quello che la retorica definisce un epicheirema (dalla
radice greca cheir = mano, “metto mano a”, “mi sforzo” e, quindi, “cerco di persuadere”).
Ecco come il ragionamento della Pro Milone collima con lo schema suddetto:
• l'affermazione generale, propositio, è che si può talvolta uccidere in nome della legge;
• come ratio, argomentazione, si dimostra che il reo si giudica proprio perché la sua colpa
non è provata rispetto al diritto, mentre si ammette il fatto (che abbia cioè ucciso);
• Milone ha ucciso, ma in nome della legge, perché non fu l'aggressore: questa è
l’assumptio, l’ipotesi;
• la conclusione, o complexio, è che egli non può essere punito in nome di quelle leggi che
ha difeso.
Il ragionamento è, quindi, un sillogismo deduttivo, la cui conclusione è un’applicazione particolare
della proposizione maggiore, cioè è un epicheirema. La spiegazione di questo concetto, che i retori
si limitavano ad assumere, la ritroviamo, invece, presso i filosofi: il termine appare spesso in
Aristotele che, nei Topica (II, 100a 25), definisce il sillogismo un discorso per cui da cose
presupposte ne conseguono altre diverse. E' un sillogismo dialettico che s'applica a casi dubbiosi,
opposto al filosofema, che è un sillogismo dimostrativo assolutamente vero. Il primo, quindi il
sillogismo dialettico, si può applicare alla discussione, ove niente è sicuro, ove serve la dialettica,
non la scienza.
IV - La tesi, ovvero la filosofia sposata alla retorica: un filosofo ai rostra.
Il pensiero filosofico, dunque, è presente nel modo di operare di Cicerone, l'ipotesi stessa che
dà il via all'argomentazione della Pro Milone è filosofica. Il luogo comune che compone la
propositio, cioè l’affermazione generale, è che esiste in noi una legge innata. L'argomentazione
ipotetica ha inizio con una formula valida per diritto e che, se è buona, spiegherà i fatti. Quindi in
una causa bisogna che sia buona l'idea, che essa sia fonte di verità: le migliori ipotesi le fornisce
chi ha le vedute più profonde, chi si rifà ai principi. Il ragionamento porta alle questioni
fondamentali, per cui le migliori ipotesi sono quelle che si chiamano tesi, che Cicerone rende con
propositum. Esse nei suoi discorsi sono l'ipotesi prima, la propositio che dà il via
all'argomentazione. Viene poi l’assumptio che è l'ipotesi, legata alle circostanze di luogo e di tempo
(p. es. Milone non ha ucciso): l’affermazione generale, presupposta per diritto, viene applicata al
fatto particolare.
Così l’epicheirema diviene un sillogismo applicato alla discussione.
Questo è il livello più basso dell'eloquenza e la filosofia non è più pensiero, ma semplice figura di
pensiero. Con l'età, egli tende sempre più a nascondere la filosofia dietro lo schema retorico, che è
in apparenza il più evidente: così nel nostro discorso l'oratore annuncia che dimostrerà che Milone
non è stato l'aggressore. Il vero piano del discorso, invece, è filosofico perché, con la scusa di
eliminare obiezioni preliminari, insinua la teoria che l'omicidio può essere legittimo.
26
L'Oratore è sensibile alle esigenze della procedura e dei costumi di Roma, ma la sua abilità fa
sì che non rinunci alle regole fondamentali della sua arte, solo che egli le applica a sua discrezione:
da giovane ci presenta delle lunghe argomentazioni ove cerca di convincere ragionando, divenuto
console preferisce moralizzare, ricorrendo alla filosofia.
Cicerone è condotto così alla ricerca di idee generali che, presentate come false digressioni,
conferiscono all’orazione la sua unità.
Possiamo dire che veramente la teoria delle questioni generali costituisce l'originalità dell'Oratore,
infatti omnis igitur res eandem habet naturam ambigendi (De Oratore III, 29, 111), l'eloquenza
diviene una copiose loquens sapientia, … quae in disputando est uberior atque latior et ad motus
animorum vulgique sensus accomodatior (Partitiones oratoriae 23, 79), perché Cicerone vuole
essere un filosofo alla tribuna (Epistulae ad familiares XV, 4, 16 e Pro Murena 30, 63).
Egli cerca, attraverso la dialettica, di conciliare filosofia e retorica, la prima nella sua aridità
scientifica, come la vogliono gli stoici; la seconda tutta tendente alla persuasione, che, pur
considerata fra le virtù, quamquam sunt omnes virtutes aequales et pares, sed tamen est species alia
magis alia formosa et illustris (De Oratore III, 14, 55): la virtus, in un mondo senza certezze, ha
bisogno di sembrare bella.
DENTRO IL TESTO
TULLIUS S. D. TERENTIAE SUAE (Ad fam. XIV, 5)
Si tu et Tullia, lux nostra, valetis, ego et suavissimus Cicero valemus. Pr. Idus Oct. Athenas
venimus, cum sane adversis ventis usi essemus tardeque et incommode navigassemus. De nave
exeuntibus nobis Acastus cum litteris praesto fuit uno et vicesimo die, sane strenue. Accepi tuas
litteras, quibus intellexi te vereri, ne superiores mihi redditae non essent: omnes sunt redditae
diligentissimeque a te perscripta sunt omnia, idque mihi gratissimum fuit. Neque sum admiratus
hanc epistolam, quam Acastus attulit, brevem fuisse; iam enim me ipsum exspectas sive nos ipsos,
qui quidem quam primum ad vos venire cupimus, etsi, in quam rem publicam veniamus, intelligo;
cognovi enim ex multorum amicorum litteris, quas attulit Acastus, ad arma rem spectare, ut mihi,
cum venero, dissimulare non liceat, quid sentiam; sed, quoniam subeunda fortuna est, eo citius
dabimus operam ut veniamus, quo facilius de tota re deliberemus. Tu velim, quod commodo
valetudinis tuae fiat, quam longissime poteris, obviam nobis prodeas. De hereditate Preciana quae quidem mihi magno dolori est; valde enim illum amavi -, sed hoc velim cures: si auctio ante
meum adventum fiet, ut Pomponius aut, si is minus poterit, Camillus nostrum negotium curet: nos,
cum salvi venerimus, reliqua per nos agemus; sin tu iam Roma profecta eris, tamen curabis, ut hoc
ita fiat. Nos, si di adiuvabunt, circiter Idus Novembres in Italia speramus fore. Vos, mea suavissima
et optatissima Terentia, si nos amatis, curate ut valeatis. Vale. Athenis a. d. XVII Kal. Novemb.
Lux: Cicerone si rivolge con l’appellativo “luce nostra” al figlio.
Cum sane adversis ventis usi essemus: “dopo aver avuto venti assai sfavorevoli”. Cicerone giunto
ad Atene dalla provincia della Cilicia informa la moglie, destinataria dell’epistola, di aver compiuto
un viaggio molto disagiato e desidera essere a Roma al più presto, benché preoccupato per le notizie
a lui giunte sulla situazione politica nell’Urbe.
De nave exeuntibus nobis Acastus: “Appena sbarcati dalla nave ci è venuto incontro Acasto”.
Acasto, lo schiavo adibito al recapito delle lettere, attendeva l’arrivo del padrone per consegnare le
missive di Terenzia.
27
Sane strenue: Acasto aveva impiegato per il tragitto da Roma ad Atene appena ventuno giorni!
Neque sum admiratus…: “Né mi ha sorpreso la brevità di questa lettera che mi ha consegnato
Acasto”. Terenzia aveva evidentemente riferito al marito tutti gli avvenimenti dell’Urbe, ora fa
giungere solo brevi parole di saluto e di augurio.
Nos ipsos: ritornavano con Cicerone anche il figlio Marco, il nipote Quinto e il liberto Tirone,
molto caro all’oratore.
In quam rem publicam veniamus, intelligo: “Benché io preveda in quali condizioni debba trovare
la patria, a causa dell’imminente divampare delle guerre civili”. Cicerone seguiva Pompeo, ma
apprezzava di più Cesare, per cui tornava a Roma pieno di amarezza.
Eo citius dabimus operam ut veniamus, quo facilius de tota re deliberemus: “Per ciò ci
adoperiamo a far ritorno al più presto per prendere anche noi più facilmente posizione su questa
vicenda”. È comprensibile l’ansia di Cicerone di venire a Roma per rendersi conto della situazione
che aveva potuto conoscere per sommi capi attraverso le lettere. Solo il ritorno a Roma avrebbe
permesso di valutare e di giudicare gli eventi in tutta la loro gravità.
Sed hoc velim cures: “Vorrei che tu te ne occupassi nel caso che la vendita avvenga prima che io
giunga, affinché se ne prenda cura Pomponio o, se egli non può, Camillo”. Si tratta di personaggi
che erano rimasti a Roma a curare gl’interessi del Nostro.
DENTRO IL TESTO
Sallustio, De coniuratione Catilinae, 5
a) analisi testuale morfosintattica
nobili genere: ablativo retto da natus
fuit : segue l’ablativo di qualità magna vi
fuere: fuerunt
patiens è seguito dal genitivo inediae
animus sottinteso fuit
simulator è seguito dal genitivo oggettivo cuius rei
adpetens è seguito dal genitivo oggettivo alieni
profusus è seguito dal genitivo sui
satis sottinteso fuit è seguito dal genitivo eloquentiae, sottinteso ei
parum sottinteso fuit è seguito dal genitivo sapientiae, sottinteso ei
maxuma: maxima
rei publicae capiundae: gerundivo al genitivo
quibus modis adsequeretur: proposizione subordinata interrogativa indiretta con il congiuntivo
imperfetto in rapporto di contemporaneità nel passato
28
dum è seguito dal congiuntivo imperfetto
sibi: dativo etico
habebat pensi: genitivo di stima
inopia: ablativo di causa efficiente
quae auxerat : proposizione subordinata relativa attributiva con l’indicativo
iis artibus: ablativo di mezzo
quas memoravi: proposizione subordinata relativa attributiva all’indicativo
quos vexabant: proposizione subordinata relativa attributiva all’indicativo
pessuma: pessima
b) analisi testuale etimologico lessicale
vi: ablativo di vis nella duplice accezione di coraggio e di forza: una attinente all’animo, l’altra al
corpo
lubido: libido, più forte di cupiditas (vedi il tedesco Lust)
pensi habebat: avere ritegno di … , avere preoccupazione: dal verbo pendo, gravare, esser di peso
(pensum era il peso di lana che una schiava doveva filare in un giorno, in senso traslato dovere,
impegno; anticamente anche compito scolastico)
magis magisque: superlativo ottenuto con la ripetizione del comparativo
luxuria: da luxus, esuberanza, eccesso
Tutti i termini riferiti a Catilina sono eccessivi o ampliati da tutta una serie di superlativi evidenziati
di seguito.
Il ritratto di Catilina è il seguente:
caratteristiche fisiche (positive): magna vi corporis, patiens algoris, inediae, vigiliae.
caratteristiche morali (positive): nobili
genere
caratteristiche morali (negative): ingenio malo pravoque, audax, subdolus, varius, simulator,
adpetens alieni, profusus sui, ardens in cupiditatibus, ferox,
libidinosus, luxuriosus, avarus
c) analisi testuale semantico-retorica
et animi et corporis sed … pravoque: variazione delle congiunzioni
huic: dimostrativo invece del nome
bella intestina …discordia civilis sono sinonimi in climax
animus audax … ardens : climax
satis eloquentiae .. sapientiae parum: costruzione a chiasmo
29
sapientiae parum: litote
immoderata, incredibilia: allitterazione ed iperbole
hunc: di nuovo il dimostrativo invece del nome
pensi habebat: espressione di uso familiare
nota l’abbondanza dei termini eccessivi e iperbolici e i superlativi: supra quam credibile est –
immoderata, incredibilia - nimis alta - maxuma lubido – magis magisque in dies - pessuma
luxuria _
nota i verbi che esprimono eccesso (i prefissi rafforzano l’azione del verbo stesso): adpetens –
profusus – cupiebat – invaserat – adsequeretur – auxerat – incitabant – vexabant
nota le forme arcaiche: maxuma – lubet – lubido
nota i molteplici costrutti con asindeti
d) analisi intratestuale
L. Catilina: incipit con il nome ed i lati positivi (in funzione di captatio benevolentiae). Il nome
scompare quando si evidenziano i lati negativi: huic .. hunc. Cambia poi il soggetto: corpus,
animus, come se fosse il suo istinto e la sua natura ad agire al suo posto. I corrupti civitatis mores
sono il risultato della sua condotta.
Nobili natus genere: Catilina aveva la possibilità di sviluppare ottime doti per la sua nobiltà, dice
l’aristocratico Sallustio; egli invece ab adulescentia (cioè quando si forma l’uomo) ribadito dal
termine iuventus (il verbo exercuit è volutamente ironico), coltivò gli aspetti peggiori della sua
indole.
Il corpus ha doti positive, l’animus invece è totalmente negativo perché non sa frenare le
cupiditates.
Magis magisque in dies: indica che la sequela dei delitti è inarrestabile, le notazioni dell’autore si
fanno sempre più pressanti, tanto è vero che egli interviene in prima persona: quas supra memoravi.
DENTRO IL TESTO
Sallustio, De Coniuratione Catilinae, 54
Analisi stilistica - Elenco delle caratteristiche dello stile sallustiano :
1. Uso della coordinazione
2. Frasi molto brevi (brevitas)
3. Uso di sostantivi astratti
30
4. Il verbo è spesso sottinteso (ellissi del verbo, gravitas)
5. Uso della variatio stilistica, cioè di costrutti diversi: è un espediente retorico, anche perché sta
parlando di due personaggi diversi, Catone e Cesare. Si osservi anche l’uso del chiasmo e dei
parallelismi.
6. Non vi sono subordinate tranne quod dono digum esset.
Nel momento in cui Sallustio scrive i due personaggi erano entrambi morti: l’uno suicida, l’altro per
mano dei congiurati.
ILLE FACTUS (EST) CLARUS (predicativo del soggetto)
Variatio
HUIC SEVERITAS (soggetto)
DANDO ecc. (gerundi con valore strumentale: brevitas )
PERFUGIUM ERAT (linguaggio concreto)
LAUDABATUR ( astratto )
AT (avversativo)
CATONI ERAT (variatio infatti Caesar è un nominativo e compie l’azione, qui invece c’è un
dativo di possesso)
Le doti di Cesare sono concrete, quelle di Catone interiori
sibi optabat virtus enitescere <->studium modestiae
Catone certabat grazie alle sue doti morali, Cesare prepara bellum novum
Analisi connotativo – comparativa
Somiglianze tra Cesare e Catone
genus
aetas
magnitudo animi
eloquentia
gloria
Diversità
Cesare
Catone
munificus
integer
mansuetus
severus
misericors
constans
facilis
modestus
dedito al negotium
dedito all’otium
31
guerriero
filosofo
DENTRO IL TESTO
C. Nepote, Annibale
Populus: popolo in quanto ha la consapevolezza di essere tale
Gentes: genti non aggregate dalla civiltà, quindi c’è una contrapposizione tra populus e gens che
viene poi ampliata dal sostantivo nationes più avanti nel testo
Virtute è il valore in questo caso soprattutto bellico
Infitiandum dal verbo deponente infitior vuol dire “non riconoscere, negare, contestare”
Prudentia: abilità, saggezza, buon senso
Fortitudine: coraggio, forza, abilità fisica
Nationes: popolo, questa volta come istituzione
Superior: superiore qui in senso bellico, vuol dire vincitore
Quod nemo dubitat: il quod ha valore relativo “cosa che”
Ut superarit: proposizione completiva retta da dubito in rapporto di anteriorità; è usato il perfetto
congiuntivo superarit (superaverit)
Infitiandum est: costruzione perifrastica passiva che regge la proposizione infinitiva
Hannibalem praestitisse: proposizione infinitiva in rapporto di anteriorità
Quanto antecedat: proposizione comparativa con il congiuntivo presente
Nisi debilitatus esset: proposizione condizionale irreale con il congiuntivo piuccheperfetto
DENTRO IL TESTO
Analisi strutturale della I Ecloga di Virgilio.
Bucoliche I,1-10:
Sono presenti due posizioni contrastanti accentuate dal tu/nos che rappresenta una struttura bipolare
tramite il vocativo dei due nomi. Le due figure sono presentate con caratteristiche differenti per
accentuarne il dualismo. Titiro è disteso all’ombra di un faggio, sotto il quale il pastore compone
musica. Dall’altra parte il nos dulcia linquimus arva accentua il contrasto drammatico ad indicare
che mentre l’uno rimane nel suo mondo bucolico, l’altro è costretto ad andare in quello civile, la
situazione si enfatizza con il nos patriam fugimus, mentre Titiro può continuare a cantare l’amore.
È necessaria una forza al di sopra di quell’ordine campestre ormai scardinato che garantisca la pace;
si tralascia allora il tu e il me, per passare ad una terza persona: il “deus” superiore a quelle forze
che spingono Melibeo a fuggire. Ci si trova quindi di fronte ad un codice linguistico-ideologico per
cui si passa al pronome ille: l’uditorio capiva il riferimento, tuttavia Ottaviano non è nominato
esplicitamente per lasciarne intatta la sacralità.
Deus nobis haec otia fecit: la situazione è circoscritta al presente, l’haec ci fa capire che per Titiro
ci sarà un lieto fine. Chi è questo dio? Sicuramente il suo benefico influsso avrà una durata nel
32
tempo: ille semper erit, sarà sempre venerato e garantirà la pace e la quiete agreste grazie alle quali
Titiro può continuare tutte le attività bucoliche tra cui il ludere quae vellem, espressione che indica
la massima libertà ed autonomia.
Alla libertà degli spazi agresti corrisponde quella di potersi dedicare all’attività artistica in piena
autonomia servendosi del calamus. Melibeo, invece, sempre in questa struttura binaria, cerca di
dare una regola alla libertà espressiva e usa, quindi, il verbo meditaris: parla di un altro strumento,
diverso oltretutto dal calamo, cioè l’avena. Il termine meditaris riporta ad una regola diversa dal
ludere, l’arte può considerarsi come gioco (ludere) o come regola ed insegnamento (meditari).
Ibidem I, 11-83:
Si parte dalla domanda: “Tuttavia dimmi, o Titiro, chi sia questo dio”. La risposta procede per via
indiretta, partendo dal luogo dell’incontro: Roma; l’umile pastore Titiro non si era mai allontanato
così tanto dalla sua terra. Si nota il motivo del rimpianto, perché la libertà è arrivata in ritardo,
quando ormai egli è vecchio e il passato di schiavitù d’amore ha lasciato il segno: se non fosse
rimasto inerte forse avrebbe già prima usufruito della possibilità di conoscere altro. Il motivo di tale
inerzia fu l’amore, ora Titiro spera in un miglioramento della sua situazione amorosa e quindi di
quella sociale. Titiro ha lasciato perciò la campagna e tutti ne sentono la nostalgia, ma non aveva
altra scelta, si ritorna allora al motivo dell’incontro con il deus a cui bisogna fare sacrifici.
L’oracolo però non garantisce nulla di sicuro, oltre tutto il responso (pascite …) si riferisce ai pueri
e non a Titiro che è ormai vecchio. Melibeo, invece, risponde di invidiarlo ed usa il futuro
manebunt per indicare tutto quello di cui lui è privo.
Il quadro è arricchito da immagini e sensazioni sonore: le fonti, l’ombra rinfrescante, il ronzio delle
api nella siepe di confine che è un motivo che unisce il piano bucolico a quello georgico. Le
immagini sono quelle consuete, il che ci riporta al tema della nostalgia di Melibeo. Questi è cacciato
ed ignora il desiderio di Titiro di guardare avanti e di rompere con alcune negatività del passato.
Titiro amplifica l’importanza dell’incontro con illum e ne enfatizza l’epifania (vidi); egli ormai è
tutto proiettato nel futuro che si prospetta sì indeterminato, ma in uno spazio ben determinato, a
Roma; l’esule invece vede il suo futuro molto incerto e non sa se potrà più contemplare la sua
capanna. La nostalgia per il passato si ripropone come la speranza in un lontano futuro, un futuro
composto con i motivi del passato: i campi, le piantagioni, la vigna; tutti dettagli enfatizzati proprio
perché Melibeo non sa se li potrà più avere. Il frutto del suo lavoro toccherà ad un impius miles. Per
Melibeo, compiutasi l’immagine della speranza come recupero del passato georgico, il dramma
ritorna al prossimo esilio e ad un’ultima risposta di Titiro. Melibeo non canterà più, tutti i verbi
sono al futuro, un futuro senza speranza. Nel congedo Titiro invita Melibeo a rimanere almeno per
un’altra notte, la chiusa riporta alla quiete dell’inizio dell’ecloga: l’ombra però non è più quella di
un faggio, riparo alla calura del mezzogiorno, ma quella lunga della sera. Il codice temporale ci fa
quindi capire che tutta la vicenda si svolge nell’arco di un pomeriggio.
Le motivazioni di questo quadro possono essere disposte su tre registri: motivi bucolici, georgici e
dell’impegno politico e civile:
Melibeo incarna il tema georgico, ma con la citazione dell’empio soldato si avvicina anche al tema
civile; Titiro sembrerebbe più agiato, possiede pecore e non solo caprette, ma anche lui non è mai
stato e Roma. La figura positiva del deus viene attenuata da quella dell’impius miles che in futuro
godrà i proventi del campo (si noti l’uso del futuro utilizzato anche per descrivere i sacrifici per il
nuovo deus).
L’incontro di Titiro con il deus a Roma, viene visto come un’epifania e il motivo civile si interseca
con quello bucolico. Compare poi una voce fuori campo, quella dell’oracolo, che invita a pascolare
le pecore come un tempo, come a significare che il deus vuole che tutto rimanga come prima
nell’ambito della tradizione; con questa notazione civile la distanza di Virgilio da Teocrito è
evidente. Il punto fondamentale dell’intera ecloga, quindi, consiste nell’esaltazione di quella
libertas in nome della quale era stato compiuto l’assassinio di Cesare e che ora Ottaviano vuole
paradossalmente ristabilire calpestandola.
33
Il dramma dei due protagonisti dell’ecloga sta proprio in questa contraddizione: l’atto
dell’esproprio, che non viene menzionato, anzi se ne espone solo il momento positivo, è quello che
ha consentito a Titiro sia la libertà che l’incontro a Roma col deus; per Melibeo invece ha
significato solo l’esilio.
DENTRO IL PROBLEMA
TEOCRITO
Nella IV ecloga Virgilio asserisce di voler innalzare il tono del canto bucolico perché non a tutti è
gradito e chiede aiuto ed ispirazione alle Sicelides Musae, si riferisce cioè alle Muse siciliane. E’
evidente l’allusione a Teocrito dalla cui opera il Nostro fu ispirato.
Teocrito nacque probabilmente a Siracusa verso il 270 a. C. e visse ad Alessandria alla corte di
Tolomeo Filadelfo. La sua produzione poetica è costituita dagli Idilli, poemetti in verso esametrico
di carattere bucolico in cui si alternano dialoghi tra pastori in un contesto naturale in cui è sempre
primavera e tutto è serenità e vivacità. Anche i componimenti in cui l’amore non è corrisposto e vi
sono i lamenti dell’innamorato respinto, sono inseriti in una cornice di natura ridente, a tratti
stereotipa. La suggestione subita da Virgilio è innegabile, ma compare una profonda distanza di
ispirazione. Quanto in Virgilio la natura partecipa al dolore dei pastori, sia per motivi
semplicemente amorosi, sia per tematiche più importanti come l’esproprio delle terre, tanto la
campagna teocritea è asettica e pittorica. Tutti i luoghi comuni sulla natura campestre sono presenti
in Teocrito, una campagna che non esiste se non nell’immaginazione poetica dell’autore in cui i
sentimenti personali sono banditi. La vita bucolica è vista come “quadretto” e come evasione, è un
locus amoenus in cui i pastorelli si raccontano le pene d’amore e suonano spensieratamente, è il
mondo dell’Arcadia, perduto e perciò sempre agognato.
L’eroe bucolico per eccellenza è Dafni, il pastore che era stato esposto sotto un alloro dalla madre,
una ninfa. Secondo gli antichi sarebbe l’inventore del canto bucolico: Teocrito, nell’Idillio I
propone una versione mitica della sua morte espressa dal pastore Tirsi.
Testo
Teocrito, Idillio I, vv.64-75
Intonate, Muse dilette, intonate il bucolico canto.
Questo è Tirsi dell’Etna e di Tirsi dolce è la voce.
Dove mai eravate, quando Dafni si struggeva, dove eravate, o ninfe?
Forse nelle belle vallate del Peneo, o in quelle del Pindo?
Certo non abitavate la grande corrente del fiume Anapo
Né la cima dell’Etna, né la sacra acqua dell’Achis.
Intonate, o Muse dilette, intonate il bucolico canto.
Per lui ulularono di dolore gli sciacalli, per lui ulularono i lupi,
lui morto anche il leone della boscaglia pianse.
Intonate, Muse dilette, intonate il bucolico canto.
Molte mucche ai suoi piedi, molti tori,
molte giovenche e vitelli gemettero.
DENTRO IL TESTO
34
Virgilio, Eneide, IV, vv. 15-29
Si mihi non animo fixum immotumque sederet
nec cui me vinclo vellem sociare iugali,
postquam primus amor deceptam morte fefellit;
si non pertaesum thalami taedaeque fuisset,
huic uni forsan potui succumbere culpae.
Anna, fatebor enim, miseri post fata Sychaei
coniugis et sparsos fraterna caede penates
solus hic inflexit sensus animumque labantem
impulit: adgnosco veteris vestigia flammae.
Sed mihi vel tellus optem prius prius ima dehiscat
vel pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras,
pallentes umbras Erebi noctemque profundam,
ante, Pudor, quam te violo aut tua iura resolvo.
Ille meos, primus qui me sibi iunxit, amores
abstulit; ille habeat secum servetque sepulchro.
-
20
25
Fixum immotumque: endiadi; Didone si rivolge ad Anna, ma più che altro a se stessa, per
ribadire che il giuramento di fedeltà al defunto Sicheo rimane saldamente stabile.
Vinclo: nel vocabolo è anticipato il dramma della regina, in quanto per lei non è pensabile
un amore se non nella forma di un vincolo coniugale.
Primus amor: "la persona che ho amato per la prima volta": il fatto che Didone usi primus
indica che è inconsciamente predisposta a vivere un altro amore.
Si non: anafora per accentuare l’autoconvincimento di Didone: "se non volessi evitare il
talamo e le fiaccole (nuziali) forse potrei cedere a questa sola colpa".
Culpae: così è visto un secondo matrimonio; Servio, il commentatore dell’Eneide, osserva
che le bis nuptae non potevano fare sacrifici al tempio della Fortuna muliebre.
Anna: per cercare sostegno al suo smarrimento invoca la sorella, forse cercandone la
complicità.
Coniugis: nota l’enjambement con la parola del verso precedente Sychaei: il marito è
rimpianto, ma anche sentito come impedimento.
Fraterna caede: si allude all’assassinio di Sicheo ad opera di Pigmalione, fratello di Didone.
Solus: non è citato il nome di Enea, intendi "solo costui ha piegato i miei sensi e ha
risvegliato l’animo tanto da farlo vacillare (labantem)".
Adgnosco veteris: cfr. Dante, Purgatorio, XXX, 48; il verso è un’esclamazione in cui la
donna riconosce che è di nuovo vinta dalla passione.
Sed mihi: “ma io desidererei piuttosto che la terra si apra profonda davanti a me”.
Ante … quam: è in correlazione con il prius del v. 24.
Pudor: è il pudore personificato, qui si evidenzia la concezione virgiliana.
Tua iura: si intendono le leggi sacre del pudore femminile.
Ille: anafora, serve per porre in rilievo la presenza di Sicheo nel momento in cui la nuova
passione tende a cancellarla.
Iunxit: è il legame coniugale di con-iugium.
Habeat … servet: congiuntivi ottativi, nota anche l’allitterazione secum servet sepulcrum per
accentuare la solennità religiosa dell’impegno di fedeltà.
Ibidem vv. 412-436
35
Improbe Amor, quid non mortalia pectora cogis!
Ire iterum in lacrimas, iterum temptare precando
cogitur et supplex animos summittere amori,
ne quid inexpertum frustra moritura relinquat.
415
«Anna, vides toto properari litore circum:
undique convenere; vocat iam carbasus auras,
puppibus et laeti nautae imposuere coronas.
Hunc ego si potui tantum sperare dolorem
et perferre, soror, potero. Miserae hoc tamen unum
exsequere, Anna, mihi; solam nam perfidus ille
te colere, arcanos etiam tibi credere sensus;
sola viri mollis aditus et tempora noras.
I, soror, atque hostem supplex adfare superbum:
non ego cum Danais Troianam exscindere gentem 425
Aulide iuravi classemve ad Pergama misi,
nec patris Anchisae cinerem manisve revelli:
cur mea dicta negat duras demittere in auris?
Quo ruit? Extremum hoc miserae det munus amanti:
exspectet facilemque fugam ventosque ferentis.
430
Non iam coniugium antiquum, quod prodidit, oro,
nec pulchro ut Latio careat regnumque relinquat:
tempus inane peto, requiem spatiumque furori,
dum mea me victam doceat fortuna dolere.
Extremam hanc oro veniam (miserere sororis),
435
quam mihi cum dederit cumulatam morte remittam».
-
420
Improbe Amor: l’apostrofe esprime l’intervento del poeta, che, secondo i dettami filosofici
dell’epicureismo, condanna l’amore inteso come passione sconvolgente.
Iterum … iterum: l’anafora indica l’affanno delle ultime ansiose parole di Didone.
Anna: è la stessa parola con cui Didone aveva cominciato ad aprire il suo animo alla sorella.
L’affettuoso appellativo soror questa volta è assente.
Properari: il verbo è usato nella forma impersonale.
Hunc: "Se io ho potuto prevedere un così grande dolore, lo potrò anche sopportare"; con
queste parole ha inizio l’inganno che la regina tende alla sorella Anna.
Perfidus ille: l’espressione ritorna tre volte nel libro.
Te colere: Didone ricorda i rapporti cordiali che intercorrevano tra Enea e Anna, ribaditi al
v. 423: “solo tu conosci i momenti in cui è più facile avvicinarsi al suo cuore”.
Hostem … superbum: Didone ha già deciso che Enea è un nemico inflessibile e superbo;
nota il variare degli appellativi con cui Didone si rivolge ad Enea: coniux … hospes …
hostis.
Cum Danais: Didone vuol far sapere che lei non ha niente in comune con i Danai e con tutte
le cause che portarono alla distruzione di Troia.
Quo ruit?: ha inizio una serie d’interrogative poste in climax; in questa domanda notiamo
una sorta di premura per l’eroe.
Miserae … amanti: aggettivo usato nell’Eneide nell’ambito dell’innamoramento; in questo
ritorno ciclico sugli stessi argomenti Didone rivela la follia che la sconvolge.
Facilem fugam ferentis: allitterazione; nota il senso di rimprovero nel vocabolo fuga.
36
-
Coniugium antiquum: ritorna l’ossessiva idea della regina che dice che Enea è traditore di un
vincolo sacro.
Pulchro Latio: l’aggettivo è ironico; Didone non conosceva il Latium.
Tempus inane: ultima disperata richiesta di Didone ad Enea; l’aggettivo inane si presta a
varie sfumature interpretative.
Ibidem 529-553
At non infelix animi Phoenissa, neque umquam
solvitur in somnos oculisve aut pectore noctem
530
accipit: ingeminant curae rursusque resurgens
saevit amor magnoque irarum fluctuat aestu.
Sic adeo insistit secumque ita corde volutat:
«En, quid ago? Rursusne procos inrisa priores
experiar, Nomadumque petam conubia supplex, 535
quos ego sim totiens iam dedignata maritos?
Iliacas igitur classis atque ultima Teucrum
iussa sequar? Quiane auxilio iuvat ante levatos
et bene apud memores veteris stat gratia facti?
Quis me autem, fac velle, sinet ratibusve superbis
inrisam accipiet? Nescis heu, perdita, necdum
Laomedonteae sentis periuria gentis?
Quid tum? Sola fuga nautas comitabor ovantis?
An Tyriis omnique manu stipata meorum
inferar et, quos Sidonia vix urbe revelli,
545
rursus agam pelago et ventis dare vela iubebo?
Quin morere ut merita es, ferroque averte dolorem.
Tu lacrimis evicta meis, tu prima furentem
his, germana, malis oneras atque obicis hosti.
Non licuit thalami expertem sine crimine vitam
550
degere more ferae, talis nec tangere curas;
non servata fides cineri promissa Sychaeo» .
Tantos illa suo rumpebat pectore questus.
-
540
In somnos: si distingue tra il sonno "superficiale" e quello "profondo", l’uno prende gli
occhi, l’altro il petto.
Magno … aestu: il ribollire dell’ira, come un mare in tempesta è un’immagine usata da
Virgilio, ripresa da Lucrezio.
Procos: pretendenti.
Supplex: in fine di verso pone in contrasto l’orgoglio di un tempo con l’umiliazione di oggi
che spinge la regina a cercare il matrimonio.
Quiane: "perché questo progetto giova a coloro che io ho soccorso con il mio aiuto".
Inrisam: è lo stesso aggettivo del v. 534 che accentua la paura dello scherno.
Perdita: vocativo che Didone rivolge a se stessa.
Laomedonteae: lo spergiuro di Laomedonte (che tradì Apollo e Poseidone) è l’effetto di una
maledizione che grava sui Troiani.
Sola: qui comincia una serie d’ipotesi su quella che potrebbe essere la sua fine.
Inferar: altra ipotesi della follia è che ella sia assalita insieme con il suo popolo, che aveva a
forza strappato dalla patria Tiro.
Morere: moreris.
37
-
Ferroque: il suicidio è visto come liberazione dai mali.
Tu … tu: anafora, qui si rivolge ad Anna.
Furentem: complemento predicativo dell’oggetto, sottinteso me.
Germana: nuovo appellativo nei confronti della sorella.
More ferae: avrebbe preferito una vita simile a quella delle fiere, priva di senso di colpa.
Non servata fides: è un compendio lapidario che esprime la motivazione del suicidio.
Ibidem vv. 659-670
Dixit, et os impressa toro «Moriemur inultae,
sed moriamur» ait «sic, sic iuvat ire sub umbras; 660
hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto
Dardanus, et nostrae secum ferat omina mortis».
Dixerat, atque illam media inter talia ferro
conlapsam aspiciunt comites, ensemque cruore
spumantem sparsasque manus. It clamor ad alta 665
atria: concussam bacchatur Fama per urbem.
Lamentis gemituque et femineo ululatu
tecta fremunt, resonat magnis plangoribus aether,
non aliter quam si immissis ruat hostibus omnis
Karthago aut antiqua Tyros, flammaeque furentes 670
culmina perque hominum volvantur perque deorum.
-
Moriemur … moriamur: consonanza.
Inultae: l’espressione anticipa la vendetta futura.
Hauriat: il verbo è molto efficace: il crudelis Dardanus beva il fiele del rimorso.
Ab alto: "dall’alto mare".
Omina mortis: presagio delle sventure.
Cruore: dipende apò koinoù da spumantem e sparsas.
Bacchatur : cfr. v. 301.
Ululatu: termine onomatopeico.
Non aliter: ha inizio la similitudine di tono epico.
Perque … perque: polisindeto.
DENTRO IL PROBLEMA
IL PERSONAGGIO DI DIDONE E LA TEMATICA DELL’ “ABBANDONO”
A differenza di tanti altri personaggi dell’epica Didone è una figura interamente latina e non ha
precedenti nella letteratura greca.
Prima di Virgilio vi è un probabile accenno alla regina nel Bellum Poenicum di Nevio in cui si tratta
dell’amore infelice con Enea, il che spiegherebbe, dopo l’abbandono, l’inimicizia e la rivalità tra
Roma e Cartagine (cfr. Nevio, fr. 23 Morel blande et docte percontat, Aenea quo pacto / Troiam
urbem liquerit). Molti studiosi hanno voluto vedere in questo frammento un riferimento all’infelice
donna, anche se la questione rimane ancora aperta.
La storia di Didone occupa l’intero IV libro dell’Eneide, ma già nel I compaiono dei riferimenti che
preludono alla sua fine (fati nescia Dido I, 299); né la vicenda si chiude con il IV libro in quanto,
nella parte finale del VI, quando Enea scende nel regno dei morti, si svolgerà l’ultimo, definitivo
incontro tra i due. L’eroe, giunto agli inferi, scorge, tra le ombre, quella di Didone: le si avvicina e
le giura che non l’aveva abbandonata per una sua decisione, ma per volere degli dei e la scongiura
38
di concedergli un ultimo momento, ma Didone non lo guarda e torna nel bosco ombroso dove
l’aspetta il marito Sicheo. In questo episodio, le parti si sono rovesciate, ora è Enea che supplica
Didone, che rimane distante e muta di fronte alle incalzanti domande dell’eroe e alla sua desolata
confessione di essere partito invitus, cioè non per sua volontà.
Per capire la tragedia di Didone in seguito alla partenza dell’eroe troiano, esemplificativi sono gli
ultimi 120 versi del IV libro in cui le parole della regina sono dettate dall’ira e dalla passione. Lei
stessa ne è consapevole, tanto è vero che si domanda: Quid loquor aut ubi sum? Quae mentem
insania mutat? (v.595); si fa uso di interrogative retoriche che accentuano il pathos della vicenda.
Didone non trovando altri interlocutori si rivolge a Giove, Enea questa volta viene apostrofato
come advena, non è più il pius. La parola ricorrente di questi ultimi momenti di Didone è flamma, il
fuoco un tempo quello della passione (adgnosco veteris vestigia flammae) e ora simbolo della
morte sul rogo. Dal v. 607 ha inizio la vera e propria invocazione affinché gli dei puniscano Enea:
qui l’eloquio si fa più solenne e le frasi acquistano quasi una cadenza rituale. Si inizia con
l’invocazione al Sole cui seguono quelle a Giunone, ad Ecate, alle Furie ed alla morente Elissa, cioè
a se stessa. Al v. 642, la regina è descritta con i segni realistici della follia: effera, pallida morte,
furibunda, chiari segnali della sintomatologia della passione amorosa. Didone rappresenta il
dissidio tra passione e fedeltà, tra ira contro Enea e contro se stessa, l’ambivalenza si coglie in
Dante che la riporta nei v. 61 e 62 del V canto dell’Inferno: l’altra è colei che s’ancise amorosa, e
ruppe fede al cener di Sicheo. E’ innegabile che alcuni accenti di Didone richiamino la Medea di
Euripide ed è sintomatico che la vicenda della regina possa avere un antecedente in quella di una
protagonista della tragedia. Ma in Didone non è presente la furia barbarica di Medea, l’idea di
punire e maledire Enea nasce da un momento di delirio, mentre l’eroina euripidea riesce a
mantenersi più lucida nella sua macchinazione; c’è inoltre da aggiungere che l’epilogo della
vicenda di Didone è il suicidio, mentre quello di Medea è l’uccisione dei propri figli. Forse
l’antefatto di una donna come Didone va piuttosto ricercato nell’Arianna del carme LXIV di
Catullo.
Dal v. 650, la regina pare placarsi resa più calma dai ricordi e dalle imprese che ha compiuto
espresse con i perfetti statui…vidi…recepi, forse sarebbe stata felice se le navi troiane non avessero
mai toccato i lidi di Cartagine (torna alla mente l’incipit della Medea di Euripide in cui la nutrice
vorrebbe che mai le navi di Argo fossero salpate alla volta della Colchide). Virgilio accenna solo al
suicidio della regina, le immagini cruente sono riferite dalle ancelle, il sangue della donna non viene
descritto. Anche nella tragedia greca le scene cruente erano raccontate e non si potevano vedere
sulla scena. Ma il momento è drammatico, la Fama si aggira per la città e riferisce la notizia della
sciagura, i lamenti giungono fino al cielo, tutto è sconvolto come se la città fosse distrutta dal fuoco;
segue la disperazione della sorella Anna, vera deuteragonista, ed infine la “catarsi”: questa è
espressa nell’intervento di Iride, inviata da Giunone, che recide il capello di Didone, ultimo legame
con la vita.
Nel carme LXIV di Catullo, in una vasta digressione si racconta la storia dolorosa di Arianna, figlia
del re Minosse che aveva aiutato Teseo e che fu poi da lui abbandonata nell’isola di Nasso. Ebbene
anche Arianna, come Didone, nel momento della disperazione apostrofa il suo amato come
immemor, perfidus e di mens crudelis, insistendo sul concetto di fides tradita (cfr. vv.132-138).
Simili sono le parole delle due donne, simile è la situazione psicologica: entrambe lamentano la
perfidia dell’uomo, la sua ingratitudine e si scagliano contro chi li ha generati; fatale è stato
l’approdo sulla loro terra delle navi straniere, la colpa sarà punita con una morte atroce per se stesse
e per l’amante.
Didone, pur essendo nella sua patria, si sente sola ed estranea a tutto ciò che la circonda, sente di
aver perduto anche la dignità che, unica, le aveva permesso di superare tante difficoltà: non le
rimane che il suicidio.
Arianna è in un’isola deserta, in un ambiente a lei estraneo, si salverà invece grazie all’intervento di
Bacco.
39
Non rimane che considerare le figure dei tre eroi maschili: Enea, Giasone e Teseo, ma Enea è anche
un eroe della propaganda augustea e perciò non può essere raffrontato con gli eroi del mito greco.
DENTRO IL TESTO
ORAZIO CARME I, 1
L’ode è destinata ad aprire la raccolta dei carmi di Orazio anche se è stata composta nella maturità,
quando il poeta aveva raggiunto non solo la consapevolezza dei suoi mezzi, ma anche una propria
originalità poetica e finezza stilistica. Orazio dice ciò che gli sta a cuore: poter fare versi e
raggiungere rinomanza attraverso questi. Tale aspirazione non è nuova nella poesia, ma il Nostro
riesce a romanizzare tale concetto, rivendicando un posto fra i “classici” senza eccessiva iattanza.
MAECENAS – Orazio fu sempre legato da affetto a questo personaggio anche quando fra i due vi
furono divergenti opinioni su cui il poeta sapeva anche scherzare. Mecenate apparteneva ad una
mobilissima famiglia di Arezzo, come si evince dal successivo atavis regibus.
EDITE – “messo in luce, generato, discendente”, seguito dall’ablativo di origine.
O ET PRAESIDIUM – “o mia difesa e mio onore”, tu che mi fai il piacere (dulce) e l’onore (decus)
di sostenermi e di difendermi.
SUNT – il soggetto è sottinteso ed indeterminato, da ricavarsi nella proposizione successiva: quos
iuvat.
CURRICULO – si allude ai giochi olimpici nei quali era ritenuto grande onore riportare vittoria. Qui
i giochi vengono citati per antonomasia e tra le varie gare Orazio sceglie quelle col cocchio veloce
trascinato da focosi cavalli che in corsa sollevano la polvere del circo.
COLLEGISSE – “raccogliere” nel significato di sollevare la polvere. Qui l’infinito passato è
utilizzato al posto di quello presente, forse perché si ritiene l’avvenimento anteriore alla gioia che
ne consegue.
META – le metae erano poste all’estremità della spina che divideva in due l’arena del circo e
attorno alla quale giravano i carri. L’auriga era tanto più valido quanto più rasentava la meta senza
sfiorarla, il che avrebbe pregiudicato la corsa.
PALMAQUE NOBILIS – la palma era il premio per i vincitori che così diventavano celebri e
celebrati. Qui sono rappresentati due momenti: sollevare la polvere ed evitare il contatto con la meta
ed ottenere la palma del vincitore per cui l’auriga si sente innalzato fino agli dei e simile ai
dominatori della terra.
HUNC…ILLUM – “a questo ... ad un altro” gli accusativi sono retti dal verbo iuvat. Si allude a
coloro che nutrono ambizioni politiche ed a coloro che aspirano a diventare grandi commercianti.
MOBILIUM – è il pubblico dei volubili Quiriti, i quali cambiavano sovente idea sui candidati alle
cariche pubbliche; si allude anche alle masse che mutano spesso opinione circa i loro
rappresentanti. Non sfugge la polemica di Orazio sulla propaganda corrotta e mistificatoria.
CERTAT – da notare l’uso del presente perché la soddisfazione del candidato si manifesta nel
momento della competizione, quando i suoi elettori inneggiano al suo nome. Nell’immagine
successiva il poeta usa condidit, cioè il perfetto, perché la gioia del commerciante viene dopo che ha
stipato i magazzini di merce.
TERGEMINIS HONORIBUS – si tratta delle più alte cariche politiche a Roma: questura, pretura,
consolato. L’ablativo strumentale è retto da tollere.
PROPRIO HORREO – nel granaio di cui è l’unico proprietario e nessun altro.
40
DE LIBYCIS AREIS – dalle aie dell’Africa settentrionale che era ritenuta il vero granaio per il
territorio di Roma, in cui l’attività agricola andava diminuendo, nonostante i tentativi di Augusto
per una ripresa.
VERRITUR – “si raccoglie”, ma letteralmente “si spazza”: è un’immagine di grande efficacia
plastica che mostra gli schiavi intenti ad ammassare il grano dopo il raccolto per riempire i
magazzini.
GAUDENTEM – qui la costruzione cambia: il verbo reggente non è più iuvat, ma demoveas in cui si
nota l’uso della seconda persona per creare un maggiore coinvolgimento con il lettore: “non si
potrebbe mai distogliere colui che si compiace…così da indurlo a solcare…”.
PATRIOS AGROS – Orazio potrebbe alludere ad un podere ricevuto in eredità dal modesto
agricoltore che lo “dissoda col sarchio”.
ATTALICIS CONDICIONIBUS – ablativo di mezzo, “con condizioni da Attalo”, cioè trattandolo da
re, facendogli sperare di diventare erede di un re, come Attalo III, re di Pergamo, le cui immense
ricchezze furono lasciate alla sua morte (133 a. C.) in eredità al popolo romano.
TRABE – metonimia al posto di nave; si tratta di un legno che proveniva dalle foreste cipriote.
MYRTOUM MARE – il mare Mirtoo, così detto dall’isola di Mirto, a sud dell’Eubea, era pericoloso
per i naviganti. Qui Orazio invece del generico mare adopera termini specifici come più avanti
Icarii fluctus (allusione al mare Egeo dove cadde Icaro).
PAVIDUS NAUTA – apposizione predicativa, “come un navigante che sempre teme”.
LUCTANTEM – con valore temporale, “quando lotta”, cioè nel momento in cui il mare è agitato. Il
participio è costruito con il dativo. L’Africo è il vento di Sud-Ovest, apportatore di tempeste.
OPPIDI - qui il significato è “paese”, costituisce iperbato.
OTIUM ET RURA – endiadi; “la pace dei campi”, il commerciante vorrebbe essere nella sua casa
tranquillo quando il mare è burrascoso.
INDOCILIS – costruzione con l’infinito come molti aggettivi oraziani. E’ frequente in greco e
probabilmente anche nel latino parlato “non potendo imparare ad…”.
EST QUI SPERNIT – “c’è qualcuno che non disdegna”. Il verbo spernit prima è seguito da un
sostantivo, poi da una proposizione infinitiva con valore di complemento oggetto. Si tratta di una
variatio usata anche nella prosa.
MASSICI – si tratta di un vino prodotto nei pressi del monte Massico, davanti al golfo di Gaeta.
NEC DEMERE – “e non disdegna di sottrarre una parte delle ore del giorno destinate agli affari”.
VIRIDI … AQUAE – sono immagini di quiete e di dolcezza campestre: il cittadino si allontana dalla
città per riposarsi all’ombra di un corbezzolo o presso la sorgente canora di una fonte sacra a
qualche ninfa o divinità agreste.
MEMBRA – accusativo di relazione dipendente da status, “con le membra distese”.
CASTRA – dipende da iuvat; le parole accentuano le immagini rapide di guerra.
LITUO – sono litui, si sopprime per brevità la ripetizione dello stesso termine. Il lituo era la tromba
ricurva della cavalleria, la tuba era dritta e pertinente alla fanteria. Si dà l’idea dell’agitarsi dei
soldati nell’interno degli accampamenti prima della battaglia.
MATRIBUS – dativo d’agente dipendente da detestata (verbo deponente considerato come passivo).
Il termine si riferisce non solo alle madri, ma a tutte le donne che sono in ansia per i loro cari in
guerra.
SUB IOVE FRIGIDO – “sotto il freddo cielo invernale” quando è il momento più propizio per la
caccia. Indicare il cielo con Giove è molto frequente.
TENERAE – la passione per la caccia fa dimenticare la tenera moglie rimasta a casa.
CATULIS FIDELIBUS – dativo d’agente; il padrone si può fidare dei cani che inseguono la
selvaggina.
TERETES PLAGAS – “le reti ben ritorte”, robuste, tali che solo un forte cinghiale può romperle.
MARSUS APER – si tratta del cinghiale dei monti della Marsica; Orazio ama determinare con
connotazioni locali le immagini.
41
DOCTARUM FRONTIUM – “le fronti dei poeti studiosi”, Orazio aspira alla corona d’edera di
poeta; la doctrina era intimamente congiunta con l’ispirazione poetica.
GELIDUM NEMUS...CHORI - endiadi in quanto le danze delle ninfe e dei satiri, al seguito di
Bacco, si svolgevano in luoghi appartati, lontano dal volgo e propizi all’ispirazione poetica.
LEVES – “lievi, piene di leggiadria”, dissimili dalle danze umane in cui il peso del corpo è di
impedimento.
POPULO – “dal volgo”, ablativo di separazione. Il poeta ispirato doveva disprezzare il volgo
profano e insensibile.
SI – non ha un valore ipotetico, ma piuttosto causale: “poiché le Muse mi amano e mi insegnano a
formare i miei canti secondo la loro ispirazione ed armonia”.
TIBIAS – il doppio flauto, lo strumento di Euterpe con cui accompagnava la poesia corale.
BARBITON – la lira, strumento della poesia lirica monodica, ispirata da Polinnia.
COHIBET – parallelo a refugit: “trattiene e rifiuta di accordare”, per indicare al poeta l’armonia dei
suoi carmi. La lira è detta “di Lesbo” perché Orazio si ispira alla poesia di Saffo e di Alceo nativi
dell’isola di Lesbo.
QUODSI … INSERES – viene usato l’indicativo futuro, ma il poeta è certo che Mecenate lo
considererà un vero poeta lirico.
LYRICIS VATIBUS – dativo dipendente da inseres, “mi annovererai tra”. Vates indica il poeta
ispirato dalle Muse.
SUBLIMI VERTICE – “con la testa alta”, per l’orgoglio e la gioia di aver raggiunto il suo ideale.
FERIAM SIDERA – “toccherò le stelle”; gli parrà di essere in cielo, perché i suoi desideri saranno
realizzati: sarà come un dio.
Il poeta oppone alle scelte degli altri uomini, e soprattutto agli stili di vita solitamente perseguiti, il
proprio modo di considerare la gloria che deriva dalla poesia. Nel carme si articolano così vari tipi
di uomini con ideali diversi, concreti, tesi alla gloria terrena o al guadagno, sempre immersi nei
pericoli e nell’angoscia; c’è chi preferisce la pace della campagna, chi la guerra e le battaglie.
Orazio oppone a tutto ciò il suo modo di vivere come poeta, beandosi dell’ispirazione delle Muse.
La struttura è quella del “Priamel”: alla rassegna delle scelte altrui il poeta oppone le proprie.
Per illustrare i tipi di vita Orazio si serve di vari Lebensbild in funzione di exempla. Il contrasto è
comunque filosofico, tra eudaimonismo ed edonismo. Il Nostro ha utilizzato un procedimento già
diffuso soprattutto nella letteratura greca e presente anche in Lucrezio nel proemio del libro
secondo.
Quanto agli stili di vita presentati nell’ode potremmo distinguere l’atleta olimpico e il politico,
seguaci del philodoxos bios; il latifondista, l’agricoltore, il mercante, seguaci del philochrematos
bios; l’epicureo, l’appassionato della caccia e della guerra, seguaci del philedonos bios; infine il
poeta philosophos. Non pensiamo che tali tipologie vengano poste nell’ode secondo un ordine di
importanza, ma è notevole che tutto si concluda con la scelta di essere poeta.
Il principio compositivo dell’ode è quello di una successione di quadri semplicemente accostati tra
loro, tra i quali l’asindeto getta un ponte di raccordo, lo stile è proprio quello delle descrizioni
enumerative. Ciascun quadro è ben caratterizzato soprattutto da “scene in movimento”: la polvere
sollevata, le ruote roventi per la corsa, la palma che eleva al cielo, l’affannarsi degli elettori, la
raccolta febbrile di grano sull’aia, la zappa che rompe le zolle, il legno che fende il mare, le onde
battute dal vento, il mercante che rinsalda la barca. Non è estranea la cura per il dettaglio, talora
erudito, l’esatta scelta degli epiteti e la quantità di metonimie.
42
DENTRO IL TESTO
L’ARS POETICA di Orazio
Epistula ad Pisones
Costituisce la terza ed ultima epistola del II libro e fu scritta dal poeta alcuni anni prima di
morire, forse intorno al 15 a. C.
Le fonti sono la Poetica di Aristotele (da cui si riprende il concetto della poesia come sapienza
in un organismo armonico, la funzione della mìmesis e l’ampia trattazione della tragedia) e la
cultura alessandrina (per l’unità inscindibile di mythos e lèxis), di cui forse l’esempio tenuto
presente fu il trattato Perì Poietikès di Neottolemo di Pario, grammatico del III sec. a. C..
L’opera è dedicata alla nobile e colta famiglia dei Pisoni e si compone di 476 esametri, e
costituisce una forma nuova per la letteratura latina: l’epistola poetica.
Lo schema della trattazione è il seguente:
I – Poesis (vv. 1-41) si tratta l’inventio (il contenuto), che deve essere semplice, unitario ed
adatto alle forze dell’artista.
II – Poiema (vv. 42-294) (la forma), si danno precetti per l’ordo (disposizione), la facundia
(scelta di parole, metafore, neologismi, metri, stile – verborum colores -, del confronto formacontenuto e dei generi poetici drammatici: tragedia, commedia, dramma satiresco).
III – Poietés (vv. 295-476) cioè la formazione e l’istruzione del poeta che medita sui doveri di
vita della tradizione socratica, da cui trae le sue figure vive; il poeta deve essere, secondo la
tradizione stoica, un vir bonus bene scribendi peritus; segue la trattazione del conveniente,
dell’utile, del morale, del fantastico; vero merito è mescolare opportunamente gli aspetti
seguendo il precetto della brevità e della verosimiglianza. Si tratta quindi l’aspirazione alla
perfezione e le conseguenze dell’errore; vera poesia è quella morale, come fu per Orfeo, Omero,
Tirteo. Il poeta deve essere un saggio, deve applicarsi con impegno e studio ed avere una guida
sincera e sicura. Si termina con la caricatura del poeta invasato.
Alcuni brani significativi dell’epistola chiariscono il concetto di cosa intenda Orazio per arte.
•
I grandi propositi sono seducenti …
Pictoribus atque poetis
quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.
10
E’ sempre stata giustamente concessa a pittori e poeti una certa libertà d’espressione.
Inceptis gravibus plerumque et magna professis
purpureus, late qui splendeat …adsuitur pannus
Chi si accinge a cose solenni e ne fa ampia professione cuce panni purpurei che possano
splendere
•
… ma ciò che vale è che l’argomento scelto sia adatto alle proprie forze e sinceramente
sentito:
Denique sit quod vis, simplex dumtaxat et unum.
Qualsiasi cosa va bene, purché semplice e unitaria.
43
Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam
viribus et versate diu quid ferre recusent,
quid valeant umeri. Cui lecta potenter erit res,
nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo.
40
Scegliete un argomento adatto alle vostre possibilità di scrittori e meditate bene cosa siete in
grado si affrontare. Ma chi ha scelto cose sentite veramente non dovrà faticare a cercar le
parole adatte, né l’armonia.
•
Un argomento che sta a cuore al poeta è la scelta delle parole, e raccomanda prudenza
nell’uso dei termini troppo nuovi :
… continget dabiturque licentia sumpta pudenter,
et nova fictaque nuper habebunt verba fidem, si
Graeco fonte cadent parce detorta. Quid autem
Caecilio Plautoque dabit Romanus, ademptum
Vergilio Varioque? Ego cur, adquirere pauca
si possum, invideor, cum lingua Catonis et Enni
sermonem patrium ditaverit et nova rerum
nomina protulerit?
55
Sarà apprezzata una moderata libertà se le parole di nuovo conio per essere accettate
avranno una derivazione stretta da quelle greche. Del resto si possono biasimare Virgilio e
Varo rispetto a Cecilio e Plauto? Quindi potrò anch’io concedermi qualche libertà se Ennio e
Catone hanno arricchito il patrio sermone con numerosi neologismi!
•
Ogni cosa ha il suo metro e il suo tono, si propone uno schema quasi di generi letterari,
che serva da modello per l’imitazione, intesa come rispetto della tradizione:
Res gestae regumque ducumque et tristia bella
quo scribi possent numero, monstravit Homerus.
…….. .
Archilochum proprio rabies armavit iambo;
hunc socci cepere pedem grandesque coturni,
alternis aptum sermonibus et popularis
vincentem strepitus et natum rebus agendis.
Musa dedit fidibus divos puerosque deorum
et pugilem victorem et equom certamine primum
et iuvenum curas et libera vina referre.
80
Omero ha mostrato il verso adatto per le gesta dei re, degli eroi e per le tristi guerre. …
Archiloco ha espresso la sua ira con il giambo; poi tale metro passò alla commedia ed alla
tragedia, fu adatto per il dialogo, per coprire lo strepito del popolo e per l’azione. Alle cetre la
Musa affidò il privilegio di celebrare gli dei, i loro figli, il pugile vincitore, il cavallo primo
nella gara, gli affanni dei giovani e il vino inebriante.
Soprattutto serve coerenza, sensibilità e senso dell’opportunità :
Versibus exponi tragicis res comica non vult;
indignatur item privatis ac prope socco
90
44
dignis carminibus narrari cena Thyestae.
Singula quaeque locum teneant sortita decentem.
Un’azione comica non ammette toni tragici, ed una cena come quella di Tieste non si confà a
versi colloquiali e da commedia. Ogni cosa ha un suo tono confacente per natura.
•
Altro punto fondamentale è la sincerità d’ispirazione :
Non satis est pulchra esse poemata; dulcia sunto
et, quocumque volent, animum auditoris agunto.
Ut ridentibus adrident, ita flentibus adsunt
humani voltus; si vis me flere, dolendum est
primum ipsi tibi …
100
Non basta che i poemi siano belli, devono essere suadenti e spingere dove vogliono l’animo
dell’uditorio. Come si corrisponde ad un sorriso, così ci si commuove con chi piange: se tu
vuoi che io sia triste, devi prima essere tu a commuoverti.
•
Un’importanza particolare riveste la tragedia ed i consigli sui caratteri dei personaggi
sono espliciti:
Aut famam sequere aut sibi convenientia finge
scriptor. Honoratum si forte reponis Achillem,
impiger, iracundus, inexorabilis, acer
iura neget sibi nata, nihil non arroget armis.
Sit Medea ferox invictaque, flebilis Ino,
perfidus Ixion, Io vaga, tristis Orestes.
120
Lo scrittore crei secondo la fama o il suo estro, ma, se si deve tratteggiare un Achille
verisimile, deve essere sempre in movimento, irascibile, inesorabile, crudele, pronto a
trasgredire le regole e a prender tutto con la forza. Medea deve apparire selvaggia e indomita,
Ino debole, Issione perfido, Io errabonda, torvo Oreste.
Le quattro fasi della vita dell’uomo puer, iuvenis, vir e senex son altrettanto ben delineate ai fini
di un componimento poetico:
Aetatis cuiusque notandi sunt tibi mores,
mobilibusque decor naturis dandus et annis.
Reddere qui voces iam scit puer et pede certo
signat humum, gestit paribus conludere et iram
colligit ac ponit temere et mutatur in horas.
Inberbus iuvenis tandem custode remoto
gaudet equis canibusque et aprici gramine Campi,
cereus in vitium flecti, monitoribus asper,
utilium tardus provisor, prodigus aeris,
sublimis cupidusque et amata relinquere pernix.
Conversis studiis aetas animusque virilis
quaerit opes et amicitias, inservit honori,
commisisse cavet quod mox mutare laboret.
Multa senem circumveniunt incommoda, vel quod
quaerit et inventis miser abstinet ac timet uti,
160
165
170
45
vel quod res omnis timide gelideque ministrat,
dilator, spe longus, iners avidusque futuri,
difficilis, querulus, laudator temporis acti
se puero, castigator censorque minorum.
Multa ferunt anni venientes commoda secum,
multa recedentes adimunt. Ne forte seniles
mandentur iuveni partes pueroque viriles;
semper in adiunctis aevoque morabitur aptis.
175
Bisogna prestare attenzione alle caratteristiche di ogni età per rendere bene il profilo degli
anni e della natura che si evolve. Il bambino che sa parlare e stare in piedi si azzuffa con i
coetanei e cambia umore senza motivo in ogni momento. Il giovane imberbe ama, senza
essere limitato, i cani, i cavalli e il verde prato solatio del Campo Marzio; è facile a cadere nel
vizio, ostile ai buoni consigli, lento a provvedere al suo bene, spendaccione, eccessivo,
bramoso, rapido nell’abbandonare ciò che ama. L’uomo adulto ha diverse aspirazioni: cerca
il benessere e l’amicizia, segue la carriera e non si mette in cose che poi non potrà lasciare
facilmente. Molti fastidi affliggono il vecchio, sia perché cerca delle cose che poi non vuole
più o teme, o perché usa tutto con freddo animo, rinvia, fa progetti a lungo termine, è inerte,
bramoso del futuro, scontroso, brontolone, lodatore del passato quando era lui giovane, ma
censore e fustigatore dei giovani. Gli anni danno e tolgono molti vantaggi, non dare mai a un
giovane le parti del vecchio, né a un fanciullo la parte del giovane, rimarrà sempre qualcosa
dell’età e dell’esperienza fatta.
•
E’ importante che ciò che si rappresenta sulla scena sia conforme al buon gusto, non
tutto va fatto vedere, sappiamo infatti che nella tragedia greca non si rappresentavano
scene cruente.
Aut agitur res in scaenis aut acta refertur.
Segnius inritant animos demissa per aurem
quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae
ipse sibi tradit spectator; non tamen intus
digna geri promes in scaenam multaque tolles
ex oculis, quae mox narret facundia praesens.
Ne pueros coram populo Medea trucidet,
aut humana palam coquat exta nefarius Atreus,
aut in avem Procne vertatur, Cadmus in anguem.
180
185
Gli avvenimenti si possono svolgere sulla scena o possono essere narrati. Meno efficacemente
toccano l’animo le cose narrate di quanto invece accade con quelle che sono fedelmente viste
e che lo spettatore segue direttamente. Tuttavia non si rappresenteranno esplicitamente quelle
azioni che sono più opportunamente sottratte alla vista e che la narrazione diretta illustrerà.
Medea non truciderà i figli in pubblico, né il nefasto Atreo cuocia pubblicamente membra
umane, né Procne si trasformerà in uccello, né Cadmo in serpente sotto gli occhi di tutti.
•
I classici sono il nerbo dell’arte :
… Vos exemplaria Graeca
nocturna versate manu, versate diurna.
268
Compulsate con insonne cura i grandi esempi dei Greci.
46
L’arte ha origine nella sapienza e gli ideali e la cultura dei padri devono alimentarla:
Scribendi recte sapere est et principium et fons.
Rem tibi Socraticae poterunt ostendere chartae,
verbaque provisam rem non invita sequentur.
Qui didicit, patriae quid debeat et quid amicis,
quo sit amore parens, quo frater amandus et hospes,
quod sit conscripti, quod iudicis officium, quae
partes in bellum missi ducis, ille profecto
reddere personae scit convenientia cuique.
Respicere exemplar vitae morumque iubebo
doctum imitatorem et vivas hinc ducere voces.
Interdum speciosa locis morataque recte
fabula nullius veneris, sine pondere et arte,
valdius oblectat populum meliusque moratur
quam versus inopes rerum nugaeque canorae.
310
315
320
L’arte dello scrivere si fonda sulla sapienza e da essa ha origine e nutrimento. I trattati
socratici ti mostreranno gli argomenti, le parole li seguiranno senza farsi troppo desiderare.
Chi conosce bene l’amor di patria e l’amicizia, l’amore filiale, quello fraterno, l’ospitalità,
gl’impegni di un senatore o di un giudice, i doveri di un comandante in guerra, saprà
delineare personaggi e discorsi convenienti per ciascuno. T’invito a considerare il tuo tipo
ideale di vita e di costumi imitando i dotti e trarrai da lì i tuoi caratteri. Talora un dramma
con luoghi comuni e ben costruito, senza particolare bellezza, né ricercatezza, né arte
conquista meglio il popolo e lo intrattiene più efficacemente di versi poveri di fatti e di
chiacchiere canore.
I Greci sono comunque modelli ineguagliabili:
Grais ingenium, Grais dedit ore rotundo
Musa loqui, praeter laudem nullius avaris
323
La Musa ha concesso in dono ai Greci l’ispirazione, la possibilità di una lingua armoniosa ed
essi sono avidi solo di gloria.
•
Eccoci al punto centrale del trattato, lo scopo dell’arte:
Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci,
lectorem delectando pariterque monendo
344
Raggiunge in pieno lo scopo chi mescola l’utile al dilettevole, divertendo il lettore ed
educandolo contemporaneamente.
Certo, l’arte non può mantenere troppo a lungo un livello elevato e in taluni casi è normale una
caduta di tono:
Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis
offendar maculis, quas aut incuria fudit,
aut humana parum cavit natura.
… et idem
indignor quandoque bonus dormitat Homerus;
351
47
verum operi longo fas est obrepere somnum.
Ut pictura poesis …,
360
…
haec placuit semel, haec deciens repetita placebit.
Invero se in un carme sono presenti molti pregi, non starò a rimarcare qualche difetto che ha
causato l’incuria o una mano poco cauta. … Sobbalzo anch’io se talora il buon Omero
dormicchia, ma è facile cedere al sonno in un’opera ponderosa. Così in pittura, così pure in
poesia … a volte l’opera piace subito, a volte dopo molti tentativi.
•
Cos’è l’arte, ispirazione o impegno? È un giudizioso connubio tra i due.
Natura fieret laudabile carmen an arte,
quaesitum est; ego nec studium sine divite vena
nec rude quid prosit video ingenium; alterius sic
altera poscit opem res et coniurat amice.
Qui studet optatam cursu contingere metam,
multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit,
abstinuit venere et vino; qui Pythia cantat
tibicen, didicit prius extimuitque magistrum.
410
Si è molto discusso se la perfezione per una poesia venga dall’ispirazione o dalla tecnica.
Io non concepisco l’impegno senza una ricca ispirazione e non capisco a che serva un incolto
ingegno. Sono entrambi necessari e reciprocamente implicati. Chi aspira alla vittoria nella
corsa ha sofferto e si è impegnato molto sin da fanciullo, ha sudato e sopportato il gelo, ha
scordato le donne ed il vino. Così chi suona il flauto in onore di Apollo Pitico ha studiato
molto prima con un maestro rigidamente esigente.
DENTRO IL PROBLEMA
LIVIO E LA STORIOGRAFIA
Livio, Libri ab Urbe condita, Praefatio
Facturusne operae pretium sim, si a primordio urbis res populi Romani perscripserim nec satis
scio nec, si sciam, dicere ausim, … [3] Utcumque erit, iuvabit tamen rerum gestarum memoriae
principis terrarum populi pro virili parte et ipsum consuluisse; … [4] Res est praeterea et
immensi operis, ut quae supra septingentesimum annum repetatur et quae ab exiguis profecta
initiis eo creverit ut iam magnitudine laboret sua; … [9] Ad illa mihi pro se quisque acriter
intendat animum, quae vita, qui mores fuerint, per quos viros quibusque artibus domi
militiaeque et partum et auctum imperium sit; labente deinde paulatim disciplina velut
desidentes primo mores sequatur animo, deinde ut magis magisque lapsi sint, tum ire coeperint
praecipites, donec ad haec tempora quibus nec vitia nostra nec remedia pati possumus
perventum est. [10] Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum. Omnis te
exempli documenta in inlustri posita monumento intueri; inde tibi tuaeque rei publicae quod
imitere capias, inde foedum inceptu foedum exitu quod vites. [11] Ceterum aut me amor negotii
suscepti fallit, aut nulla unquam res publica nec maior nec sanctior nec bonis exemplis ditior
fuit, nec in quam civitatem tam serae avaritia luxuriaque immigraverint, nec ubi tantus ac tam
diu paupertati ac parsimoniae honos fuerit. [12] Adeo quanto rerum minus, tanto minus
48
cupiditatis erat: nuper divitiae avaritiam et abundantes voluptates desiderium per luxum atque
libidinem pereundi perdendique omnia invexere. …
Non so bene, né se lo sapessi oserei dirlo, se faccia opera valida a narrare dall’inizio la storia
del popolo romano…. Comunque sia sarà buona cosa aver contribuito per quanto possa al
ricordo delle gesta del primo fra i popoli della terra..…. L’impresa è inoltre di notevole
impegno, poiché riguarda un periodo di oltre settecento anni ed uno stato che, partito da
piccole dimensioni, è cresciuto a tal punto da vacillare per la sua stessa grandezza. ….. Vorrei
che ciascuno prestasse grande attenzione a quale fu la vita, quali i costumi, attraverso quali
uomini e quali risorse in pace e in guerra fu formato ed esteso il potere e quindi venendo
meno a poco a poco la disciplina si capisca che dapprima decaddero i costumi, quindi
aumentando la corruzione cominciarono ad andare a fondo, finché si è giunti a questo
periodo in cui non possiamo sopportare più né i vizi né i rimedi. Ma soprattutto questo è
importante ed efficace nello studio dei fatti che tu possa ammirare i documenti di ogni
esempio posti in un illustre ricordo, quindi cosa tu possa prendere ad esempio per te e per lo
stato e cosa debba evitare perché pessimo per inizio e per fine. Del resto o io mi sbaglio per
l’entusiasmo dell’impresa, oppure non ci fu mai uno stato più grande, più sano, né più ricco
di buoni esempi, né un popolo in cui siano penetrate più tardi avarizia e lussuria, né dove
mai fossero tanto a lungo in onore la povertà e la parsimonia: al punto che tanto minore era
la ricchezza tanto minore la cupidigia. Ora invece le ricchezze hanno portato seco l’avarizia
ed i frequenti piaceri il desiderio di rovinarsi nel lusso e nella libidine e di rovinare ogni cosa.
Il metodo adottato da Livio è quello tradizionale annalistico (come del resto erano composte in
maggioranza le sue fonti) che offre il vantaggio della sincronia dei fatti che, per cura particolare
dello storico, si impongono di per sé, senza essere turbati in alcun modo dallo schema
cronologico nella narrazione si alternano eventi interni ed esterni a Roma.
La peculiarità di Livio non è la ricerca dell’esattezza del dato storico, come l’influsso dell’opera
di Polibio potrebbe far supporre, la sua cura è nell’esaltazione dello stato romano come
espressione del mos maiorum, delle antiche virtù che resero grande la repubblica e che il
conservatorismo augusteo sembrava in qualche modo resuscitare.
Spesso infatti sono citati miti e leggende, soprattutto per celebrare il periodo di Romolo e delle
origini. Per Livio Roma raggiunse nel periodo repubblicano il massimo della potenza, le
istituzioni resero grande la città e furono la base e la giustificazione ideologica del suo potere. I
grandi esempi di romani come Cincinnato e Scipione furono i simboli delle virtù repubblicane
fondate sulla povertà e la parsimonia; mentre ricchezza e lussuria hanno devastato l’impero (il
pessimismo sallustiano ha influito sulla visione del Nostro). Quest’ideale repubblicano, forte del
consensus bonorum di ciceroniana memoria, spinse Augusto a chiamare Livio “pompeiano”
(come seguace di Gneo Pompeo) e fece di lui non una voce del potere, ma l’espressione di
quell’ala moderata dei conservatori che speravano in una possibilità di mantenere il mos
maiorum ed i suoi valori come base della politica romana e come giustificazione del suo
imperialismo.
La sua storiografia, di conseguenza, eccelle nel rendere il tratto psicologico dei personaggi e la
drammatizzazione degli eventi, che meglio consentono allo scrittore di rendere con efficacia i
suoi ideali e le sue convinzioni, incarnandoli negli eroi o in esempi eccellenti.
49
DENTRO IL PROBLEMA
I Discorsi sulla prima “Deca” di Tito Livio di Niccolò Machiavelli
L’opera fu scritta in un periodo critico per il segretario fiorentino, dopo il crollo della repubblica di
Firenze e la ripresa del potere da parte dei Medici, quando con la famiglia si era ritirato nella sua
villa a San Casciano, tra il 1513 ed il 1519; la stesura dell’opera subì un’interruzione per la rapida
composizione del Principe.
Il trattato si compone di tre libri in cui il Machiavelli medita sugli eventi della storia romana narrata
da Tito Livio nei primi dieci libri, la prima Deca del suo Ab Urbe condita, che trattava i fatti dalla
venuta di Enea nel Lazio al 292 a. C. (terza guerra sannitica).
Il motivo della rilettura di Livio è dovuto alla convinzione del Machiavelli dell’insuperata
grandezza dello Stato romano sotto la repubblica. Del resto la sua attività politica era stata guidata
da quest’ideale e dal desiderio di attuarlo nella repubblica fiorentina di cui fu segretario; se aveva
dovuto accettare l’idea di un “principe”, cioè di una specie di sovrano assoluto, ciò era dettato dalla
necessità storica del momento che, nell’ottica del pragmatismo machiavellico, non poteva, per la
difficile situazione italiana, dar vita ad un stato nella forma repubblicana. Era l’accettazione di un
male minore, nella speranza di ottenere un buon governo.
Lo scrittore fiorentino non ricerca i fatti singoli della storia, ma le regole, le leggi ideali che causano
il sorgere ed il decadere degli stati, le regole eterne, come eterno e sempre uguale a se stesso è
l’uomo, che ne è protagonista.
I - Proemio
Ancora che, per la invida natura degli uomini, sia sempre suto non altrimenti periculoso trovare
modi ed ordini nuovi, che si fusse cercare acque e terre incognite, per essere quelli più pronti a
biasimare che a laudare le azioni d'altri; nondimanco, spinto da quel naturale desiderio che fu sempre
in me di operare, sanza alcuno respetto, quelle cose che io creda rechino comune benefizio a ciascuno,
ho deliberato entrare per una via, la quale, non essendo suta ancora da alcuno trita, se la mi arrecherà
fastidio e difficultà, mi potrebbe ancora arrecare premio, mediante quelli che umanamente di queste
mie fatiche il fine considerassino. E se lo ingegno povero, la poca esperienzia delle cose presenti e la
debole notizia delle antique faranno questo mio conato difettivo e di non molta utilità; daranno almeno
la via ad alcuno che, con più virtù, più discorso e iudizio, potrà a questa mia intenzione satisfare: il
che, se non mi arrecherà laude, non mi doverebbe partorire biasimo.
Considerando adunque quanto onore si attribuisca all'antiquità, e come molte volte, lasciando
andare infiniti altri esempli, un frammento d'una antiqua statua sia suto comperato gran prezzo, per
averlo appresso di sé, onorarne la sua casa e poterlo fare imitare a coloro che di quella arte si
dilettono; e come quegli dipoi con ogni industria si sforzono in tutte le loro opere rappresentarlo; e
veggiendo, dall'altro canto, le virtuosissime operazioni che le storie ci mostrono, che sono state operate
da regni e republiche antique, dai re, capitani, cittadini, latori di leggi, ed altri che si sono per la loro
patria affaticati, essere più presto ammirate che imitate; anzi, in tanto da ciascuno in ogni minima cosa
fuggite, che di quella antiqua virtù non ci è rimasto alcun segno; non posso fare che insieme non me ne
maravigli e dolga. E tanto più, quanto io veggo nelle diferenzie che intra cittadini civilmente nascano, o
nelle malattie nelle quali li uomini incorrono, essersi sempre ricorso a quelli iudizii o a quelli remedii
50
che dagli antichi sono stati iudicati o ordinati: perché le leggi civili non sono altro che sentenze date
dagli antiqui iureconsulti, le quali, ridutte in ordine, a' presenti nostri iureconsulti iudicare insegnano.
Né ancora la medicina è altro che esperienze fatte dagli antiqui medici, sopra le quali fondano e' medici
presenti e' loro iudizii. Nondimanco, nello ordinare le republiche, nel mantenere li stati, nel governare
e' regni, nello ordinare la milizia ed amministrare la guerra, nel iudicare e' sudditi, nello accrescere
l'imperio, non si truova principe né republica che agli esempli delli antiqui ricorra. Il che credo che
nasca non tanto da la debolezza nella quale la presente religione ha condotto el mondo, o da quel male
che ha fatto a molte provincie e città cristiane uno ambizioso ozio, quanto dal non avere vera
cognizione delle storie, per non trarne, leggendole, quel senso né gustare di loro quel sapore che le
hanno in sé. Donde nasce che infiniti che le leggono, pigliono piacere di udire quella varietà degli
accidenti che in esse si contengono, sanza pensare altrimenti di imitarle, iudicando la imitazione non
solo difficile ma impossibile; come se il cielo, il sole, li elementi, li uomini, fussino variati di moto, di
ordine e di potenza, da quello che gli erono antiquamente. Volendo, pertanto, trarre li uomini di questo
errore, ho giudicato necessario scrivere, sopra tutti quelli libri di Tito Livio che dalla malignità de'
tempi non ci sono stati intercetti, quello che io, secondo le cognizione delle antique e moderne cose,
iudicherò essere necessario per maggiore intelligenzia di essi, a ciò che coloro che leggeranno queste
mia declarazioni, possino più facilmente trarne quella utilità per la quale si debbe cercare la
cognizione delle istorie. E benché questa impresa sia difficile, nondimanco, aiutato da coloro che mi
hanno, ad entrare sotto questo peso, confortato, credo portarlo in modo, che ad un altro resterà breve
cammino a condurlo a loco destinato.
I, 4 - Che la disunione della Plebe e del Senato romano fece libera e potente quella republica.
Io non voglio mancare di discorrere sopra questi tumulti che furono in Roma dalla morte de'
Tarquinii alla creazione de' Tribuni; e di poi alcune cose contro la opinione di molti che dicono, Roma
essere stata una republica tumultuaria, e piena di tanta confusione che, se la buona fortuna e la virtù
militare non avesse sopperito a' loro difetti, sarebbe stata inferiore a ogni altra republica. Io non posso
negare che la fortuna e la milizia non fossero cagioni dell'imperio romano; ma e' mi pare bene, che
costoro non si avegghino, che, dove è buona milizia, conviene che sia buono ordine, e rade volte anco
occorre che non vi sia buona fortuna. Ma vegnamo agli altri particulari di quella città. Io dico che
coloro che dannono i tumulti intra i Nobili e la Plebe, mi pare che biasimino quelle cose che furono
prima causa del tenere libera Roma; e che considerino più a' romori ed alle grida che di tali tumulti
nascevano, che a' buoni effetti che quelli partorivano; e che e' non considerino come e' sono in ogni
republica due umori diversi, quello del popolo, e quello de' grandi; e come tutte le leggi che si fanno in
favore della libertà, nascano dalla disunione loro, come facilmente si può vedere essere seguito in
Roma; perché da' Tarquinii ai Gracchi, che furano più di trecento anni, i tumulti di Roma rade volte
partorivano esilio e radissime sangue. Né si possano per tanto, giudicare questi tomulti nocivi, né una
republica divisa, che in tanto tempo per le sue differenzie non mandò in esilio più che otto o dieci
cittadini, e ne ammazzò pochissimi, e non molti ancora ne condannò in danari. Né si può chiamare in
alcun modo con ragione una republica inordinata, dove siano tanti esempli di virtù; perché li buoni
esempli nascano dalla buona educazione, la buona educazione, dalle buone leggi; e le buone leggi, da
quelli tumulti che molti inconsideratamente dannano: perché, chi esaminerà bene il fine d'essi, non
troverrà ch'egli abbiano partorito alcuno esilio o violenza in disfavore del commune bene, ma leggi e
ordini in beneficio della publica libertà. E se alcuno dicessi: i modi erano straordinarii, e quasi efferati,
vedere il popolo insieme gridare contro al Senato, il Senato contro al Popolo, correre tumultuariamente
per le strade, serrare le botteghe, partirsi tutta la plebe di Roma, le quali cose tutte spaventano, non che
altro, chi le legge; dico come ogni città debbe avere i suoi modi con i quali il popolo possa sfogare
l'ambizione sua, e massime quelle città che nelle cose importanti si vogliono valere del popolo: intra le
quali, la città di Roma aveva questo modo, che, quando il popolo voleva ottenere una legge, o e' faceva
alcuna delle predette cose, o e' non voleva dare il nome per andare alla guerra, tanto che a placarlo
bisognava in qualche parte sodisfarli. E i desiderii de' popoli liberi rade volte sono perniziosi alla
libertà, perché e' nascono, o da essere oppressi, o da suspizione di avere ad essere oppressi. E quando
queste opinioni fossero false e' vi è il rimedio delle concioni, che surga qualche uomo da bene, che,
orando, dimostri loro come ei s'ingannano: e li popoli, come dice Tullio, benché siano ignoranti, sono
51
capaci della verità, e facilmente cedano, quando da uomo degno di fede è detto loro il vero.
Debbesi, adunque, più parcamente biasimare il governo romano; e considerare che tanti buoni
effetti, quanti uscivano di quella republica, non erano causati se non da ottime cagioni. E se i tumulti
furano cagione della creazione de' Tribuni, meritano somma laude, perché, oltre al dare la parte sua
all'amministrazione popolare, furano constituiti per guardia della libertà romana, come nel seguente
capitolo si mosterrà.
La storia romana fornisce i grandi esempi, i consoli sono i principi-dittatori, ma il cui potere è
limitato nel tempo, il dictator è scelto solo per casi di emergenza, la violenza è usata solo
eccezionalmente, dopo il decreto dello statusconsultum ultimum.
Tutti i sistemi legislativi e le magistrature dell’antica Roma sono nell’opera riportate per la loro
esemplarità e la violenza di Bruto è vista come una necessità storica per la difesa del bene pubblico,
mentre Cesare è descritto come il malefico distruttore di tutto quello che si era riusciti a costruire.
I, 3 - Quali accidenti facessono creare in Roma i Tribuni della Plebe, il che fece la republica più
perfetta.
Come dimostrano tutti coloro che ragionano del vivere civile, e come ne è piena di esempli ogni
istoria, è necessario a chi dispone una republica, ed ordina leggi in quella, presupporre tutti gli uomini
rei, e che li abbiano sempre a usare la malignità dello animo loro, qualunque volta ne abbiano libera
occasione; e quando alcuna malignità sta occulta un tempo, procede da una occulta cagione, che, per
non si essere veduta esperienza del contrario, non si conosce; ma la fa poi scoprire il tempo, il quale
dicono essere padre d'ogni verità.
Pareva che fusse in Roma intra la Plebe ed il Senato, cacciati i Tarquini, una unione
grandissima; e che i Nobili avessono diposto quella loro superbia, e fossero diventati d'animo popolare,
e sopportabili da qualunque ancora che infimo. Stette nascoso questo inganno, né se ne vide la cagione,
infino che i Tarquinii vissero; dei quali temendo la Nobilità, ed avendo paura che la Plebe male trattata
non si accostasse loro, si portava umanamente con quella: ma, come prima ei furono morti i Tarquinii,
e che ai Nobili fu la paura fuggita, cominciarono a sputare contro alla Plebe quel veleno che si avevano
tenuto nel petto, ed in tutti i modi che potevano la offendevano. La quale cosa fa testimonianza a quello
che di sopra ho detto che gli uomini non operono mai nulla bene, se non per necessità; ma, dove la
elezione abonda, e che vi si può usare licenza, si riempie subito ogni cosa di confusione e di disordine.
Però si dice che la fame e la povertà fa gli uomini industriosi, e le leggi gli fanno buoni. E dove una
cosa per sé medesima sanza la legge opera bene, non è necessaria la legge; ma quando quella buona
consuetudine manca, è subito la legge necessaria. Però mancati i Tarquinii, che con la paura di loro
tenevano la Nobilità a freno, convenne pensare a uno nuovo ordine che facesse quel medesimo effetto
che facevano i Tarquinii quando erano vivi. E però, dopo molte confusioni, romori e pericoli di
scandoli, che nacquero intra la Plebe e la Nobilità, si venne, per sicurtà della Plebe, alla creazione de'
Tribuni; e quelli ordinarono con tante preminenzie e tanta riputazione, che poterono essere sempre di
poi mezzi intra la Plebe e il Senato, e ovviare alla insolenzia de' Nobili.
La concezione rinascimentale della storia che vede l’uomo faber fortunae suae, ne esalta il senso
morale e religioso, ma di una religione laica, costui è un vir moralmente elevato, interessato al bene
dei suoi simili che si può attuare solo se ci si sottrae al caos con uno Stato ben organizzato.
I, 11 - Della religione de' Romani.
Avvenga che Roma avesse il primo suo ordinatore Romolo, e che da quello abbi a riconoscere,
come figliuola, il nascimento e la educazione sua, nondimeno, giudicando i cieli che gli ordini di
Romolo non bastassero a tanto imperio, inspirarono nel petto del Senato romano di eleggere Numa
Pompilio per successore a Romolo, acciocché quelle cose che da lui fossero state lasciate indietro,
fossero da Numa ordinate. Il quale, trovando uno popolo ferocissimo, e volendolo ridurre nelle
52
obedienze civili con le arti della pace, si volse alla religione, come cosa al tutto necessaria a volere
mantenere una civiltà; e la constituì in modo, che per più secoli non fu mai tanto timore di Dio quanto
in quella republica; il che facilitò qualunque impresa che il Senato o quelli grandi uomini romani
disegnassero fare. E chi discorrerà infinite azioni, e del popolo di Roma tutto insieme, e di molti de'
Romani di per sé, vedrà come quelli cittadini temevono più assai rompere il giuramento che le leggi;
come coloro che stimavano più la potenza di Dio, che quella degli uomini: come si vede
manifestamente per gli esempli di Scipione e di Manlio Torquato. Perché, dopo la rotta che Annibale
aveva dato ai Romani a Canne, molti cittadini si erano adunati insieme, e, sbigottiti della patria, si
erano convenuti abbandonare la Italia, e girsene in Sicilia; il che sentendo Scipione, gli andò a trovare,
e col ferro ignudo in mano li costrinse a giurare di non abbandonare la patria. Lucio Manlio, padre di
Tito Manlio, che fu dipoi chiamato Torquato, era stato accusato da Marco Pomponio, Tribuno della
plebe, ed innanzi che venisse il dì del giudizio, Tito andò a trovare Marco, e, minacciando di
ammazzarlo se non giurava di levare l'accusa al padre, lo costrinse al giuramento; e quello, per timore
avendo giurato, gli levò l'accusa. E così quelli cittadini i quali lo amore della patria, le leggi di quella,
non ritenevano in Italia, vi furono ritenuti da un giuramento che furano forzati a pigliare; e quel
Tribuno pose da parte l'odio che egli aveva col padre, la ingiuria che gli avea fatto il figliuolo, e l'onore
suo, per ubbidire al giuramento preso: il che non nacque da altro, che da quella religione che Numa
aveva introdotta in quella città.
E vedesi, chi considera bene le istorie romane, quanto serviva la religione a comandare gli
eserciti, a animire la Plebe, a mantenere gli uomini buoni, a fare vergognare i rei. Talché, se si avesse a
disputare a quale principe Roma fusse più obligata, o a Romolo o a Numa, credo più tosto Numa
otterrebbe il primo grado: perché, dove è religione, facilmente si possono introdurre l'armi e dove sono
l'armi e non religione, con difficultà si può introdurre quella. E si vede che a Romolo, per ordinare il
Senato, e per fare altri ordini civili e militari, non gli fu necessario dell'autorità di Dio; ma fu bene
necessario a Numa, il quale simulò di avere domestichezza con una Ninfa, la quale lo consigliava di
quello ch'egli avesse a consigliare il popolo: e tutto nasceva perché voleva mettere ordini nuovi ed
inusitati in quella città, e dubitava che la sua autorità non bastasse.
E veramente, mai fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie in uno popolo che non ricorresse a
Dio; perché altrimente non sarebbero accettate: perché sono molti i beni conosciuti da uno prudente, i
quali non hanno in sé ragioni evidenti da poterli persuadere a altrui. Però gli uomini savi, che vogliono
tôrre questa difficultà, ricorrono a Dio. Così fece Licurgo, così Solone, così molti altri che hanno avuto
il medesimo fine di loro. Maravigliando, adunque, il Popolo romano la bontà e la prudenza sua, cedeva
ad ogni sua diliberazione. Ben è vero che l'essere quelli tempi pieni di religione, e quegli uomini, con i
quali egli aveva a travagliare, grossi, gli dettono facilità grande a conseguire i disegni suoi, potendo
imprimere in loro facilmente qualunque nuova forma. E sanza dubbio, chi volesse ne' presenti tempi
fare una republica più facilità troverrebbe negli uomini montanari, dove non è alcuna civilità, che in
quelli che sono usi a vivere nelle cittadi, dove la civilità è corrotta: ed uno scultore trarrà più
facilmente una bella statua d'un marmo rozzo, che d'uno male abbozzato da altrui.
Considerato adunque tutto, conchiudo che la religione introdotta da Numa fu intra le prime
cagioni della felicità di quella città: perché quella causò buoni ordini; i buoni ordini fanno buona
fortuna; e dalla buona fortuna nacquero i felici successi delle imprese. E come la osservanza del culto
divino è cagione della grandezza delle republiche, così il dispregio di quello è cagione della rovina
d'esse. Perché, dove manca il timore di Dio, conviene o che quel regno rovini, o che sia sostenuto dal
timore d'uno principe che sopperisca a' difetti della religione. E perché i principi sono di corta vita,
conviene che quel regno manchi presto, secondo che manca la virtù d'esso. Donde nasce che gli regni i
quali dipendono solo dalla virtù d'uno uomo, sono poco durabili, perché quella virtù manca con la vita
di quello e rade volte accade che la sia rinfrescata con la successione, come prudentemente Dante dice:
Rade volte discende per li rami / L'umana probitate; e questo vuole / Quel che la dà, perché da lui si chiami.
Non è, adunque, la salute di una republica o d'uno regno avere uno principe che prudentemente
governi mentre vive; ma uno che l'ordini in modo, che, morendo ancora, la si mantenga. E benché agli
uomini rozzi più facilmente si persuada uno ordine o una opinione nuova, non è però per questo
impossibile persuaderla ancora agli uomini civili e che presumono non essere rozzi. Al popolo di
Firenze non pare essere né ignorante né rozzo: nondimeno da frate Girolamo Savonarola fu persuaso
che parlava con Dio. Io non voglio giudicare s'egli era vero o no, perché d'uno tanto uomo se ne debbe
53
parlare con riverenza: ma io dico bene, che infiniti lo credevono sanza avere visto cosa nessuna
straordinaria, da farlo loro credere; perché la vita sua la dottrina e il suggetto che prese, erano
sufficienti a fargli prestare fede. Non sia, pertanto, nessuno che si sbigottisca di non potere conseguire
quel che è stato conseguito da altri; perché gli uomini, come nella prefazione nostra si disse, nacquero,
vissero e morirono, sempre, con uno medesimo ordine.
DENTRO IL TESTO
TIBULLO ELEGIA I
E’ la prima in cui compare il nome di Delia (v. 57): l’incontro con la donna ha cambiato la vita di
Tibullo; pur di salvare il suo amore il poeta è pronto a rinunciare alla ricchezza, all’ambizione e alla
gloria, soprattutto quella militare. Il componimento è stato scritto prima che Messalla si imbarcasse
per l’oriente e prima che il poeta si fermasse, perché malato, a Corcira; quindi si può datare
approssimativamente all’inizio dell’anno 30 a. C. quando il poeta aveva ventisette anni.
In un quadro ideale che ricorda le scene pastorali del 700, il poeta innamorato si pone sotto la
protezione delle divinità della campagna legate a Cerere, rispettoso degli usi e dei riti, chiede agli
dei di lasciarlo vivere in pace nella sua modesta dimora, lontano dal fracasso delle guerre e dal
frastuono della città. Il sogno di una vita semplice e piacevole è dominato però dalla paura che gli
dei o qualche capriccio del fato allontanino il suo ideale di felicità.
Tibullo I, 1-40
Congerat - congiuntivo concessivo, fulvo auro è un epiteto poetico mentre l’aggettivo usato flavus,
è un ablativo di mezzo.
Iugerum - di solito usato al plurale è una misura di superficie corrispondente al lavoro quotidiano di
un bue (cfr. iugum e iungo).
Terreat - congiuntivo in una relativa; labor è usato al singolare invece del collettivo per indicare le
fatiche e le corvées della vita militare.
Pulsa - dal verbo pello è usato per gli strumenti a corda, qui applicato ad uno strumento a fiato, il
participio può suggerire la violenza del risveglio e il ripetersi dell’azione.
Traducat – “faccia passare”, il soggetto paupertas indica una condizione modesta e non la povertà il
cui termine è egestas; il verbo è seguito dall’ablativo vita inerti.
Facili manu – “con mano esperta”, l’aggettivo facilis è qui impiegato con valore di attività
Destituat – “non mi abbandoni”; la speranza è considerata come una dea, a Roma aveva molti
templi, uno sul Quirinale, uno vicino al forum holitorium.
Stipes - rappresenta il dio Termine e serve da confine come la pietra lavica, il culto consisteva in
una libagione di vino o di olio ed una corona di fiori; il verbo veneror è usato transitivament.
Educat – “produca”, gli antichi avevano l’abitudine di offrire agli dei le primizie dei loro prodotti
dei campi, come indica novus annus, questo tipo di offerte le ricevevano gli dei dell’agricoltura tra
cui Cerere, Bacco e i Lari, le feste Cerealia cadevano il 19 aprile.
Priapus - protettore dei giardini e dei vigneti era originario di Lampsaco, nell’Ellesponto e si
credeva figlio di Dioniso e di Afrodite, la sua statua era simile ad un tronco tagliato con un enorme
fallo ed era dipinto di rosso per allontanare dai campi gli uccelli.
Lares - erano all’origine divinità agricole a protezione del raccolto, in loro onore si celebravano le
Compitalia nel mese di gennaio. Divinità tutelari, sorvegliavano i commerci (compitales), le strade,
i campi e i giardini nonché le case. Portavano la cornucopia, simbolo dell’abbondanza, erano
54
venerate intorno al focolare domestico alle calende alle none e alle idi di ciascun mese e in caso di
ricorrenze familiari.
Lustrabat - purificava. Questo rito era destinato a togliere tutte le impurità e ad allontanare i cattivi
influssi. La cerimonia della lustratio comportava una processione di vittime sacrificali, la
purificazione delle armi aveva luogo il 19 ottobre (armilustrium). Durante la purificazione dei
campi vi era la festa degli Ambarvalia in cui si sacrificavano un maiale, un bue e un montone in
onore di Cerere.
Quam circum - anastrofe usata nelle proposizioni bisillabiche che si possono posporre, qui vi è un
pronome relativo con il verbo al congiuntivo.
Canis ortus - si intende l’apparizione del Cane, l’inizio della canicola si poneva al 26 luglio,
l’espressione vuole rappresentare il fenomeno dell’estate quando il calore è particolarmente
insopportabile.
Spargere - Pale è una delle più antiche divinità latine, le feste consacrate erano le Palilia, che
cadevano nell’anniversario della fondazione di Roma; erano vietati sacrifici cruenti, sostituiti da
offerte di latte e fiori.
Composuit - il verbo esprime una creazione originale, una ricerca artistica a differenza di facere che
vuol dire fabbricare.
A proposito delle feste per il dio Termine si può attuare un confronto con Ovidio, Fasti II, 639-656
: Trascorsa la notte, si rendano gli onori tradizionali al dio che, con il proprio segno delimita i
campi. Termine, sia tu una pietra oppure un tronco piantato nel terreno, anche tu sin dall’antichità
hai potere divino. Te due proprietari coronano da opposte parti e ti portano due ghirlande e due
focacce. Si erge un altare: qui la rozza contadina porta di sua mano in un piccolo vaso braci prese
dal tiepido focolare. Una vecchia spezza la legna, con arte ammucchia i pezzi tagliati, e con forza
pianta i rami nella dura terra; allora con asciutte cortecce suscita le prime fiamme; un fanciullo
sta a guardare, tenendo un gran cesto in mano. Poi, quando ha gettato tre volte il grano nel fuoco,
una piccola figlia porge dei favi divisi in frammenti. Altri portano il vino: parte di ciascun dono si
offre al fuoco: la gente vestita di bianco guarda e tace. Il dio Termine a tutti comune si bagna del
sangue di un agnello sacrificato e neppure si lamenta se gli si offre una scrofa di latte.
Tibullo I, 41-78
L’amore per Delia è presentato come una schiavitù che può essere accettata con gioia (servitium
amoris). Il poeta esprime la felicità di vedere Delia riposare al suo fianco con la speranza che non si
lasceranno mai e che questo amore sarà eterno ed anche la morte è attesa con serenità. L’elegia
termina con un vibrante appello all’amore.
Iuvat - il verbo è impersonale, qui è costruito con due proposizioni infinitive il cui soggetto è
indeterminato, ma i participi sono regolarmente all’accusativo.
Praeferat - era il verbo usato per “esporre”: ci si riferisce all’antica usanza di esporre all’entrata
della casa del vincitore una parte dei trofei di guerra presi al nemico; le colonne davanti al
Campidoglio erano egualmente adornate. Nei bollettini della vittoria non si mancava di citare il
nome delle spoglie.
Curo - seguito dall’infinito come tutti i verbi che indicano un impegno, il poeta non si cura della
gloria militare, appare qui come un anti-eroe.
Praecordia - il cuore considerato come la sede dei sentimenti che Delia non manifesta.
Manes - sono le anime dei morti per i quali si celebravano molti riti per placarli. Le feste relative a
questi culti erano: le Rosalia quando si adornavano di fiori i sepolcri, le Parentalia che terminavano
con le Feralia, le feste dei defunti.
Adoperta - con il capo coperto dalle tenebre (in ablativo di mezzo).
Cano capite - ablativo assoluto.
Per quanto riguarda i riti delle Feralia si può confrontare Ovidio, Fasti, I, 535-546:
….. si onorano anche le tombe: si placano le ombre degli avi, si portano piccoli doni nelle
costruzioni sepolcrali. I Mani chiedono poco: la devozione è a loro gradita più di un ricco dono; il
55
profondo Stige non ha dei avidi. La lastra coperta dall’offerta di ghirlande è già abbastanza, basta
che vi si spargano spighe e qualche granello di sale e pane inzuppato nel vino e viole disciolte, e
tutto ciò contenga un vaso di coccio lasciato in mezzo alla strada. Non vieto doni maggiori, ma
bastano questi a placare le ombre: una volta eretto il sepolcro, aggiungi preghiere e parole
appropriate. Fu Enea, ideale maestro di pietà, a portare tale costume nelle tue terre, o virtuoso
Latino. Egli recava al Genio del padre doni rituali e il popolo apprese da qui le cerimonie devote.
DENTRO IL TESTO
Tibullo, III, 1-48
L’elegia è indirizzata a Messalla che si deve recare in Oriente per affari di stato: questa spedizione,
forse contro i gladiatori di Cizico che avevano preso le parti di Antonio, o per sedare dei disordini
nella regione di Antiochia, si colloca tra la battaglia di Azio e la morte di Antonio; Tibullo fa parte
dello stato maggiore, ma non riveste nessun incarico militare. Durante il viaggio si ammala ed è
costretto a fermarsi a Corcira; alla paura di morire in terra straniera si aggiunge il cruccio di non
poter rivedere Delia. Afflitto dalla malattia, il poeta soffre per la solitudine morale alla quale è
condannato, ma riesce a sopravvivere tornando con il pensiero ai momenti che hanno preceduto la
sua partenza, quando Delia agitata e scossa dai presentimenti si rivolgeva supplice agli dei. Tibullo
maledice allora i suoi tempi, dominati dalla corsa alla ricchezza e agli onori, a cui oppone il mito
dell’età dell’oro.
Memores - seguito dal genitivo, si rivolge a quei giovani di buona famiglia che cercavano di farsi un
nome ponendosi al seguito di un personaggio importante, accompagnavano il generale durante le
campagne e il governatore nella sua provincia.
Ignotis - vuol dire sconosciute e quindi straniere, qui con un valore sia attivo che passivo.
Assirios odores - i profumi venivano dall’Oriente e dall’Arabia, altri provenivano dall’Armenia,
comunque qui l’aggettivo non indica una provenienza precisa ma porta un tocco di esotismo.
Sortes - si allude alle tavolette in legno o in piombo o in oro che permettevano di rivelare
l’avvenire. Erano presentate per mezzo di un assistente e interpretate per ottenere un buon ritorno, il
rito rivela la superstizione del tempo.
E triviis - i sortilegi si ottenevano nei trivi, negli incroci di strade dove era semplice incontrarsi;
uno di questi luoghi era il Circo Massimo, come riferisce Orazio (Satira I, 6, 114). Apuleio ci narra
che predire la sorte era un modo semplice di arricchirsi utilizzando una formula valida per tanti casi
(Apuleio, Metamorfosi, IX, 8).
DENTRO IL PROBLEMA
L’ELEGIA D’AMORE LATINA
Il grammatico Diomede indica, parlando del “canone”, il diretto passaggio di consegne dagli
alessandrini ai latini: quod genus carminis praecipue scripserunt apud Graecos Callimachum et
Euphoriona, poi ricorda che la caratteristica dell’elegia era il lamento e la metrica in distici. Esempi
di poesia con la tematica del dolore erano presenti nell’elegia greca, ma si riscontrano anche in
Virgilio (vedi l’episodio di Orfeo nelle Georgiche) e in Orazio. Quest’ultimo nel carme I, 33 esorta
56
Tibullo a non dolersi della sua passione non corrisposta, a non lamentarsi e cercare di guarire, lo
sente affine come poeta, ma lo ritrae come eccessivamente malinconico. Il canto elegiaco è
autoconsolatorio, anche Virgilio aveva citato nelle Bucoliche la sorte di Cornelio Gallo disperato
per amore, la strategia consolatoria si trova nella forza del canto e della poesia (cfr. Ecloga X).
Anche per Orfeo (cfr. Georg. IV), la poesia deve aiutare a superare la perdita di Euridice, la
catabasi è la prova estrema della sua follia e della fides verso la fanciulla amata, l’amore per la
quale lo spinge a tradire i foedera con gli dei: questo è il punto più alto della sofferenza amorosa in
cui si realizza il topos del legame amore-morte.
Nell’elegia latina, oltre al dolore ed alla malinconia, compare l’elemento erudito di chiara
derivazione ellenistica, già presente nei Carmina docta di Catullo.
Protagoniste dell’elegia latina sono le donne cantate dai poeti, spesso sposate, ma la passione era
superiore a qualsiasi vincolo coniugale. La situazione è quindi quella di un desiderio di fedeltà del
poeta da parte della puella, ma un’impossibilità della donna ad essere come il poeta la
desidererebbe; già in Catullo si sono visti gli effetti di tale atteggiamento contraddittorio.
Tibullo presenta Delia a volte come amante mite e fedele, a volte come cortigiana spietata ed astuta,
ma la ama tuttavia e per lei è disposto a non curarsi della gloria militare e a porsi al di fuori dei
dettami dell’etica del tempo. Questo è ancora più evidente in Properzio che rifiuta il servitium
militare per intraprenderne un altro, che è quello della militia amoris.
Si ricordi che Augusto all’epoca aveva intrapreso una politica matrimoniale per eliminare il celibato
e i suoi effetti nefasti, promulgando una legge di cui Properzio teme gli effetti. La donna è quindi
infedele e questa consapevolezza genera nel poeta un odio che rafforza la passione, come abbiamo
notato nel carme 85 di Catullo. Properzio vorrebbe che il rapporto con Cinzia durasse tutta la vita,
la vorrebbe semplice, pudica e casta, simile alle antiche matrone, ma la ama anche per quello che è.
Anche Tibullo immagina che Delia se ne stia in casa a filare la lana e ad accogliere gli ospiti venuti
con Messalla.
Gli elegiaci latini aspirano ad una fedeltà e ad un legame che la donna non è in grado di garantire. Il
punto di svolta è rappresentato da Ovidio che al di là di ogni convenzione mette da parte il concetto
di fedeltà della donna, contravvenendo ai dettami augustei e subendone le conseguenze con l’esilio.
DENTRO IL PROBLEMA
I LUOGHI DELL’AMORE NELL’ARS AMATORIA DI OVIDIO
Ovidio, Ars amatoria, I, 68-100; 135-178; 217-262.
I Portici
Il Portico di Pompeo, costruito dal 55 al 45 a. C., annesso al teatro omonimo, presso il Campo
Marzio, durante il mese di luglio, quando il sole entra nella costellazione del leone, con le sue
gallerie ed i suoi giardini era la meta preferita delle passeggiate dei Romani.
Altra meta molto frequentata era il Portico di Ottavia, che la sorella di Augusto, unitamente al teatro
di Marcello, del 13 a. C., volle erigere per ricordare il figlio M. Claudio Marcello, morto
giovanissimo nel 25 a. C. e designato come erede dal Princeps.
Anche il Portico di Livia Drusilla, moglie di Augusto, edificato nel 7 a. C., era adorno di bellissime
pitture che narravano le storie dell’antica Roma e invitavano a piacevoli incontri.
Il Portico del tempio di Apollo sul Palatino (28 a. C.) era ornato da cinquanta statue che ricordavano
le Danaidi, o Belidi, le fanciulle che nella prima notte di nozze uccisero i mariti per salvare il padre.
57
Tu modo Pompeia lentus spatiare sub umbra,
cum sol Herculei terga leonis adit:
aut ubi muneribus nati sua munera mater
addidit, externo marmore dives opus.
Nec tibi vitetur quae, priscis sparsa tabellis,
porticus auctoris Livia nomen habet:
quaque parare necem miseris patruelibus ausae
Belides et stricto stat ferus ense pater.
70
75
Tu intanto vai a passeggiare lentamente all’ombra del portico di Pompeo quando il sole è nel
segno dell’erculeo Leone o nel portico di Ottavia, dove l’illustre genitrice aggiunse ai ricordi i suoi
doni per il figlio, con bell’arte per l’esotico marmo. È anche utile bazzicare il portico di Livia, di
cui fu l’ispiratrice, ricco di storie antiche, e quello ornato dalle statue delle Danaidi, che osarono
uccidere i miseri cugini, con il padre che là ancora minaccia con la spada.
Le feste
Occasione d’incontri galanti era offerta anche dalle feste: quelle in onore di Adone, amato da
Venere, quindi di sicuro effetto sulle donne, cadevano in luglio, ed erano molto frequentate dalle
fanciulle, come auspicio di precoce sessualità e seduzione.
Anche le feste per i riti religiosi dei Giudei, numerosi a Roma, che si svolgevano in genere il sabato,
erano raccomandate per la frequenza di donne.
Molto adatte per gl’incontri galanti erano anche le feste in onore di Iside, identificata da Ovidio con
Io, amante di Giove e trasformata in giovenca da Giunone. Tale culto si era diffuso a Roma nel I
secolo a. C. ed aveva come centro famoso in Egitto la città di Menfi, i cui sacerdoti indossavano
solo vesti di lino. Erano feste con usanze particolarmente dissolute al punto che Iside a Roma era
spesso sinonimo di mezzana.
Nec te praetereat Veneri ploratus Adonis,
cultaque Iudaeo septima sacra Syro.
Nec fuge linigerae Memphitica templa iuvencae:
multas illa facit, quod fuit ipsa Iovi.
E non devi trascurare la celebrazione del dolore di Venere per Adone o i culti del settimo giorno
del sirio Giudeo. Attento anche al culto egizio della giovenca di Iside, ella rende molte donne come
lei rese Giove.
I Fori
I Fori, cioè il complesso allora esistente del foro Romano, di quello di Cesare e di quello di
Augusto, erano la sede degli affari e dell’amministrazione della giustizia, ma spesso dietro a questo
paravento si celavano trattative meno limpide e più piccanti, che Venere dal vicino tempio guardava
con occhio compiaciuto.
Et fora conveniunt (quis credere possit?) amori:
flammaque in arguto saepe reperta foro:
subdita qua Veneris facto de marmore templo
Appias expressis aëra pulsat aquis,
80
58
illo saepe loco capitur consultus Amori,
quique aliis cavit, non cavet ipse sibi:
illo saepe loco desunt sua verba diserto,
resque novae veniunt, causaque agenda sua est.
Hunc Venus e templis, quae sunt confinia, ridet:
qui modo patronus, nunc cupit esse cliens.
85
Anche i fori sono adatti agli amori, anche se sembra assurdo, e spesso le passioni sono nate nelle
piazze vivaci, dove il gruppo delle ninfe Appie al tempio marmoreo di Venere sferza l’aria con gli
zampilli d’acqua. Lì spesso il dotto è colto dall’amore e chi si cura degli affari altrui non bada ai
propri: lì spesso mancano le parole anche a chi è facondo e accadono novità e si deve difendere la
propria causa. Venere dal vicino tempio sorride di costui, chi prima era avvocato ora si fa cliente.
I teatri
Le donne eleganti si affollano nei teatri come le api o le formiche, termini classici delle similitudini
letterarie; vengono per vedere, ma soprattutto per essere ammirate e questo è l’ambiente più
favorevole per ogni tipo di incontri, sia per gli amori fugaci che per le opportune conoscenze.
Particolare efficacia ha l’ultimo distico, ma soprattutto l’anafora del verbo spectatum … spectentur;
come non ricordare il leopardiano: la gioventù del loco … e mira ed è mirata e in cor s’allegra.
Sed tu praecipue curvis venare theatris:
haec loca sunt voto fertiliora tuo.
90
Illic invenies quod ames, quod ludere possis,
quodque semel tangas, quodque tenere velis.
Ut redit itque frequens longum formica per agmen,
granifero solitum cum vehit ore cibum,
aut ut apes saltusque suos et olentia nactae
95
pascua per flores et thyma summa volant,
sic ruit ad celebres cultissima femina ludos:
copia iudicium saepe morata meum est.
Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae:
ille locus casti damna pudoris habet.
100
Ma tu devi cercare la tua preda soprattutto nei curvi teatri che sono più fertili per la tua ricerca. Lì
troverai chi puoi amare, chi corteggiare, chi avere per una sola volta, o chi tenere con te per
sempre. Come le formiche che vanno e vengono in lunga fila quando portano in bocca il loro cibo
usuale, il grano, o come le api che nelle balze e nei pascoli profumati volano su fiori e timi, così
corrono le donne truccate ai ludi famosi e sono tante che spesso ero in imbarazzo a scegliere.
Vengono per vedere ed essere ammirate e quel luogo è dannoso al loro onore.
Il circo
Nec te nobilium fugiat certamen equorum;
multa capax populi commoda Circus habet.
Nil opus est digitis, per quos arcana loquaris,
135
59
nec tibi per nutus accipienda nota est:
proximus a domina, nullo prohibente, sedeto,
iunge tuum lateri qua potes usque latus;
et bene, quod cogit, si nolis, linea iungi,
quod tibi tangenda est lege puella loci.
Hic tibi quaeratur socii sermonis origo,
et moveant primos publica verba sonos.
Cuius equi veniant, facito, studiose, requiras:
nec mora, quisquis erit, cui favet illa, fave.
At cum pompa frequens caelestibus ibit eburnis,
tu Veneri dominae plaude favente manu;
utque fit, in gremium pulvis si forte puellae
deciderit, digitis excutiendus erit:
etsi nullus erit pulvis, tamen excute nullum:
quaelibet officio causa sit apta tuo.
Pallia si terra nimium demissa iacebunt,
collige, et inmunda sedulus effer humo;
protinus, officii pretium, patiente puella
contingent oculis crura videnda tuis.
Respice praeterea, post vos quicumque sedebit,
ne premat opposito mollia terga genu.
Parva leves capiunt animos: fuit utile multis
pulvinum facili composuisse manu.
Profuit et tenui ventos movisse tabella,
et cava sub tenerum scamna dedisse pedem.
Hos aditus Circusque novo praebebit amori,
sparsaque sollicito tristis harena foro.
Illa saepe puer Veneris pugnavit harena,
et qui spectavit vulnera, vulnus habet.
Dum loquitur tangitque manum poscitque libellum
et quaerit posito pignore, vincat uter,
saucius ingemuit telumque volatile sensit,
et pars spectati muneris ipse fuit.
140
145
150
155
160
165
170
Val la pena di frequentare anche le corse dei nobili cavalli, perché il circo è capiente e offre molti
vantaggi. Non servono le dita per rivelare segreti, né gesti per accordarsi: siediti vicino alla
donna, nulla te lo impedisce, e avvicina il tuo fianco fin che puoi al suo, e bene è, perché la calca
costringe tutti a star vicini, anche se non vuoi; toccare la donna, questa è la legge del luogo.
Cerca d’iniziare un discorso amichevole e le prime battute siano pure luoghi comuni. Chiedile di
chi sono i cavalli, mostrandoti interessato, e non aver indugi a sostenere il suo favorito. Quando
ci sarà la processione degli dei d’avorio, tu applaudi calorosamente alla dea Venere. Se capita
che casualmente della polvere cada nel grembo della fanciulla, tu la scrollerai via con le dita e se
la polvere non c’è scuotila via lo stesso. Qualsiasi motivo è buono per il tuo scopo. Se la veste
tocca troppo la terra tu pronto sollevala e scuotila via. Subito per premio, consenziente la
fanciulla, potrai scorgerle le gambe. Fai inoltre attenzione che nessuno, seduto dietro di voi, le
spinga le ginocchia nella schiena delicata. Piccolezze conquistano questi animi leggeri ed anche
un cuscino posto con mano esperta è stato utile a molti, come anche farle vento o porre uno
sgabello sotto il delicato piede. Questi mezzi offre il circo ai nuovi amori e la triste arena sparsa
nell’inquieto Foro. Spesso in quell’arena combatté il figlio di Venere, chi guarda le ferite ne è
ferito a sua volta. Mentre le parla, le tocca una mano, le chiede il libretto, e chiede chi ha vinto,
60
una volta scommesso; ferito geme e avverte la freccia veloce, e lui stesso diviene parte dello
spettacolo.
Gli spettacoli e le feste: naumachia e trionfi
Quid, modo cum belli navalis imagine Caesar
Persidas induxit Cecropiasque rates?
Nempe ab utroque mari iuvenes, ab utroque puellae
Venere, atque ingens orbis in Urbe fuit.
Quis non invenit turba, quod amaret, in illa?
Eheu, quam multos advena torsit amor!
Ecce, parat Caesar domito quod defuit orbi
addere: nunc, oriens ultime, noster eris.
175
…
Spectabunt laeti iuvenes mixtaeque puellae,
diffundetque animos omnibus ista dies.
Atque aliqua ex illis cum regum nomina quaeret,
quae loca, qui montes, quaeve ferantur aquae,
omnia responde, nec tantum siqua rogabit;
et quae nescieris, ut bene nota refer.
Hic est Euphrates, praecinctus harundine frontem:
cui coma dependet caerula, Tigris erit.
Hos facito Armenios; haec est Danaëia Persis:
urbs in Achaemeniis vallibus ista fuit.
Ille vel ille, duces; et erunt quae nomina dicas,
si poteris, vere, si minus, apta tamen.
220
225
Che dire quando Cesare fingendo una battaglia portò navi persiane e cecropie? Vennero giovani e
fanciulle da entrambi i mari e tutto il mondo fu a Roma. Chi non trovò qualcuno da amare in quella
turba? Oh, quanti soffrirono per un amore straniero! Ormai Cesare si prepara a darci ciò che
mancava al mondo domato, ora estremo Oriente sarai nostro. ….. Quel giorno lo vedranno giovani
lieti insieme a fanciulle, e aprirà i cuori a tutti. E se qualcuna delle ragazze ti chiederà il nome dei
re, dei luoghi, dei monti e dei fiumi rappresentati nel trionfo, rispondi a tutto, non solo a quello che
ti chiederà, e riferisci con accuratezza anche ciò che non conosci come se ti fosse noto. Questo è
l’Eufrate con la fronte cinta di canne, il Tigri invece ha la chioma cerulea. Dì che quelli sono
Armeni, questa la Persia Danaide, quest’altra una città delle valli achemenie. Questi e quegli
saranno i duci e gli dirai i loro veri nomi, se potrai, o almeno nomi verosimili.
Il banchetto
Dant etiam positis aditum convivia mensis:
est aliquid praeter vina, quod inde petas.
Saepe illic positi teneris adducta lacertis
purpureus Bacchi cornua pressit Amor:
vinaque cum bibulas sparsere Cupidinis alas,
permanet et capto stat gravis ille loco.
Ille quidem pennas velociter excutit udas:
sed tamen et spargi pectus amore nocet.
Vina parant animos faciuntque caloribus aptos:
230
235
61
cura fugit multo diluiturque mero.
Tunc veniunt risus, tum pauper cornua sumit,
tum dolor et curae rugaque frontis abit.
Tunc aperit mentes aevo rarissima nostro
simplicitas, artes excutiente deo.
Illic saepe animos iuvenum rapuere puellae,
et Venus in vinis ignis in igne fuit.
Hic tu fallaci nimium ne crede lucernae:
iudicio formae noxque merumque nocent.
Luce deas caeloque Paris spectavit aperto,
cum dixit Veneri 'vincis utramque, Venus.'
Nocte latent mendae, vitioque ignoscitur omni,
horaque formosam quamlibet illa facit.
Consule de gemmis, de tincta murice lana,
consule de facie corporibusque diem.
240
245
250
Offrono occasioni anche i banchetti con le tavole imbandite. Spesso lì Amore splendente tenne
stretta le corna di Bacco ebbro a mensa con le tenere braccia e quando il vino ha imbevuto le ali di
Cupido resta lì e occupa il luogo preso. Scuote invero velocemente le umide penne, tuttavia il cuore
è colpito dalle gocce. Il vino prepara l’animo e lo rende aperto al trasporto, i pensieri svaniscono e
si sciolgono nel vino. Ecco allora il sorriso ed anche il povero diventa sfrontato, fuggono gli
affanni, i dolori e le rughe dalla fronte. Allora la sincerità, ormai cosa assai rara oggi, apre gli
animi, poiché il dio scaccia i sotterfugi. Lì spesso le fanciulle hanno rapito gli animi dei giovani e
Venere nel vino aggiunge fuoco al fuoco. Lì tu non credere troppo alla lucerna, il vino e la notte
nuocciono alla valutazione della bellezza. Paride giudicò le dee in piena luce e a cielo aperto
quando disse a Venere: “Venere, le vinci entrambi”. Di notte i difetti sfuggono, si perdona ogni
difetto, e il buio rende bella ogni fanciulla. Attendi il giorno per valutare le gemme, per la lana
tinta di porpora, aspetta il giorno per giudicare le forme ed i corpi.
Soggiorno e culti fuori Roma: Baia e Ariccia
Baia, città campana sul golfo di Pozzuoli, era famosa per le sue acque termali ed era località di
villeggiatura alla moda, spesso citata dai poeti, era sede di un tempio di Venere ed uno di Diana.
Il tempio di Diana Nemorensis era situato nel bosco sacro tra il lago di Nemi e la città di Aricia
(Ariccia), la dea favoriva la procreazione e le nascite; il rex Aricinus, il sacerdote della dea,
otteneva tale funzione uccidendo in duello il sacerdote precedente quando ormai era troppo vecchio
e debole per opporsi.
Quid tibi femineos coetus venatibus aptos
enumerem? Numero cedet harena meo.
Quid referam Baias, praetextaque litora Bais,
et quae de calido sulpure fumat aqua?
Hinc aliquis vulnus referens in pectore dixit
'Non haec, ut fama est, unda salubris erat.'
Ecce suburbanae templum nemorale Dianae
partaque per gladios regna nocente manu:
illa, quod est virgo, quod tela Cupidinis odit,
multa dedit populo vulnera, multa dabit.
255
260
A che elencare i luoghi adatti alla caccia delle femmine? Sono meno i granelli di sabbia. Perché
parlare di Baia e delle vicine spiagge e dell’acqua che fuma per i caldi vapori di zolfo? Portando
62
di qui ferite nell’animo si sente spesso qualcuno dire “Quest’acqua non è salubre come vuole la
sua fama”. Ecco anche il tempio suburbano di Diana nel bosco e il regno acquisito con la spada
a mano armata. La dea, poiché è vergine, odia gli strali di Cupido ed ha causato molti dolori alla
gente e molti ne darà.
DENTRO IL PROBLEMA
Latino e scienza
- Cultura e scienza
L’unità tra il Latino e il sapere scientifico è stata artificiosamente spaccata nel noto testo di C.
Snow, Le due culture (Cambridge, 1959), i settori del sapere, così, sono divenuti due: le scienze
umane e quelle della natura. La contrapposizione tra questi due mondi è un falso ideologico perché
la cultura è unica.
La scienza è legata al pensiero, così era nel mondo antico e così accade oggi per esempio nella
fisica quantistica. Gli antichi pensatori erano anche scienziati, il philosophus era anche physicus, e
questo vale non solo per Aristotele, Democrito ed Epicuro, ma anche per Cartesio, Leibniz, Pascal.
Il linguaggio scientifico moderno è tenuto insieme da un sostrato comune che è costituito dal greco
e dal latino, si può dire anzi che i grecismi rendono semanticamente trasparente la comunicazione
scientifica universale.
- Scienza e tecnologia
Diverso invece è il discorso per quanto riguarda la tecnologia. Nel mondo antico non si dava molta
importanza al progresso, non interessava la tecnica, ma il risultato finale. Gli uomini al potere erano
interessati alla tecnologia solo perché opere grandiose potevano essere sfruttate a fine
propagandistico.
Vernant (in “Mito e pensiero presso i Greci” p. 219-226) definisce la tèchne frutto della
consuetudine tradizionale applicata ai bisogni della società con la mediazione del potere
(evergetismo). Il termine technítes (artifex), indica tutta una gamma di professioni legate alla
pratica.
La tecnica non era codificata perché non faceva parte della cultura classica. Addirittura Vitruvio
s’ispirò alla retorica ciceroniana per definire il ruolo di architetto (cfr. E. Romano, La capanna e il
tempio, Palermo 1987 p. 69), e l’architettura è strettamente legata al potere autocratico ed è
documentata in tutto il Mediterraneo e in Oriente: artisti ed artigiani andavano da una parte all’altra
per soddisfare le esigenze dei potenti. Il successo dell’artefice dipendeva dal prestigio del
committente, infatti i maggiori risultati si riscontravano in campo civile e militare e nel periodo
ellenistico diventare “tecnico di corte” procurava onori e ricchezze.
Archimede (Plutarco, Demetrio, 43,5) fu geniale, ma dovette scendere a compromessi con il potere
che lo controllava e lo finanziava e dovette applicare il suo sapere all’ingegneria militare.
- Scienza e potere
Lo scienziato era libero di esercitare il suo ingegno a patto di applicarlo secondo le direttive della
committenza.
Nel mondo romano vigeva il principio dell’utilità dell’opera. Frontino (De aquae ductu, 1.16)
criticava l’architetto a servizio della propaganda dei sovrani ellenistici, perché le costruzioni erano
prive di senso ed ironizzava sull’uso di queste per la luxuria personale; Vitruvio (De arch. X,1,4),
63
fedele servitore del potere imperiale, elogiava la macchina e le innovazioni tecniche, simbolo della
lungimiranza e della magnanimità di Augusto. Altro esempio è quello di Suetonio (Claudio, 20)
che illustra il progetto dell’imperatore Claudio che fece lavorare all’allestimento del canale per
prosciugare il Fucino trentamila operai per undici anni. Era un grande progetto idraulico ed
ingegneristico; non si parla, però, di costi, sia di materiali che di forza lavoro, in quanto importava
solo il risultato.
Talvolta le scelte imperiali frenavano le innovazioni. Per esempio Vespasiano (Suetonio,
Vespasiano, 18) bocciò il progetto di una macchina atta a trasportare grandi colonne, perché era
meglio dare lavoro alle masse dei non abbienti.
Plinio (Naturalis Historia, XXXVI, 195) ricorda che Tiberio mandò a morte l’inventore del vetro
infrangibile perché, se si fosse divulgato, i metalli sarebbero diminuiti di valore.
La fine di Archimede ucciso da un soldato romano (cfr. Plutarco, Marcello, 19,4,6) fu dovuta
all’incomunicabilità tra l’aspetto tecnico-scientifico e il potere, che sfrutta le invenzioni, ma non
può capire il valore delle sue riflessioni teoriche. Il contrasto non era tanto tra Greci e Romani, ma
tra scienza e potere.
Per gli antichi, l’invenzione non scaturiva da un lampo di genio, quanto dalla memoria della
tradizione tecnologica che ispirava la creazione in base all’imitatio-mimesis di modelli già esistenti
(l’invenzione era la reinvenzione). Nella scala dei valori l’artigianato e la tecnologia si
eguagliavano come espressione di manualità. L’importanza di un’invenzione era data dal prestigio
del committente.
Il De re rustica di Columella fu scritto per bloccare la tendenza dei proprietari a non divulgare i
propri segreti, negando agli intellettuali l’accostamento all’utilitas, il trattato era dedicato alle
attività connesse con la gestione della villa, ma usava una prosa elegante.
I manuali non servivano solo a soddisfare il bisogno di sapere di un determinato pubblico, ma anche
a dare alle tecniche una dignità letteraria.
Il sapere tecnico, pur se partecipe dei presupposti applicativi della scienza, difficilmente si
traduceva in sapere colto, ossia “scritto”, a meno che non giungesse a compromessi con il potere,
oppure apparisse agli occhi della gente come sapere di infimo ordine.
Cicerone in De Officiis 2,15 sviluppa il concetto stoico della somma utilità delle tecniche, “senza le
quali non sarebbe possibile la vita umana”. Era lodata quindi l’attività, spregiandone però l’aspetto
prettamente materiale: così l’agricoltura è sempre esaltata, ma non il brutale lavoro dei campi.
Cicerone distingueva gli inventori o i realizzatori dagli artigiani che svolgevano solo attività
manuale e ripetitiva. In seguito gli artigiani ebbero modo di far valere nella società il loro ruolo di
portatori di sollertia ed ingenium come ponte di passaggio tra la manualità e l’elaborazione teorica.
Col passare del tempo a Roma i tecnici compiono una scalata sociale soprattutto entrando nel
campo militare.
Frontino era fiero del suo ufficio di curator aquarum ed esprimeva una valutazione positiva del
lavoro tecnico che veniva accettato dai ceti superiori.
Nel II sec. d.C. il princeps protegge gli studia che sono propedeutici alla scoperta di nuove
macchine. In particolare nel campo della guerra e della poliorcetica ci fu una progressiva
meccanizzazione che divenne tecnica specializzata e fece uso di artifici tecnologici, diffondendo le
macchine d’assedio. Per la sua trattazione sulle macchine da guerra Vitruvio nel X libro attinge agli
scrittori greci, ma integra le notizie con le informazioni orali degli ingegneri romani.
DENTRO IL PROBLEMA
ALCUNI ESEMPI DI ARCHITETTURA IMPERIALE
TRA IL I SECOLO A. C. E IL I SECOLO D. C.
64
AUGUSTO
Teatro di Marcello: situato nel Campo Marzio, iniziato da Cesare e terminato da Augusto, fu
utilizzato nel 17 a.C. per i ludi saeculares; era dedicato al nipote di Augusto, Marcello, morto
prematuramente. La facciata era ricoperta da travertino e si articolava su tre piani con arcate
inquadrate da colonne di ordine dorico e ionico, forse nel terzo piano era chiuso con lesene corinzie.
Poteva contenere circa 20.000 spettatori. Presentava una scena con due aule con absidi e dietro la
scena una grande esedra con due tempietti dedicati alla Pietas ed a Diana.
Mausoleo di Augusto: situato nel Campo Marzio, iniziato nel 29 a. C. in linea con l’influsso dei
sovrani ellenistici, prende come modello il sepolcro di re Mausolo ad Alicarnasso in Caria. Il
basamento di travertino è alto 12 metri e posto intorno ad una sovrastruttura cilindrica il cui
diametro è di m. 87 con 5 muri concentrici in tufo; la cella era al centro di una struttura a piani
sovrapposti, al culmine una statua coronava l’opera. Nelle nicchie della cinta interna della tomba
erano stati sepolti Marcello, Agrippa, Druso maggiore, Lucio e Gaio Cesare e, dopo Augusto, Livia
e Tiberio. Sui due pilastri al lato dell’ingresso dell’edificio erano fissate due tavole bronzee incise
con la biografia di Augusto, proveniente dal tempio dell’imperatore ad Ankara.
Suetonio, Augusto, 100:
Reliquias legerunt primores equestris ordinis, tunicati et discincti pedibusque nudis, ac
Mausoleo condiderunt. Id opus inter Flaminiam viam ripamque Tiberis sexto suo
consulatu exstruxerat circumiectasque silvas et ambulationes in usum populi iam tum
publicarat.
I suoi resti furono raccolti dai maggiorenti dell’ordine equestre, vestiti di tunica, discinti e scalzi
e furono riposti nel Mausoleo. L’aveva costruito lui stesso durante il suo sesto consolato tra la
via Flaminia e la riva del Tevere e aveva già allora aperto al popolo i boschi e le passeggiate
intorno.
Ibidem, 101: Tribus voluminibus, uno mandata de funere suo complexus est, altero indicem rerum
a se gestarum, quem vellet incidi in aeneis tabulis, quae ante Mausoleum statuerentur, tertio
breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique esset, quantum pecuniae in aerario et
fiscis et vectigaliorum residuis.
Aveva dato le sue disposizioni in tre volumi, in uno quelle circa il suo funerale, in un altro
l’elenco delle imprese compiute, che volle incise in lastre di bronzo e collocate davanti al suo
Mausoleo, nel terzo un quadro rapido di tutto l’impero, quanti soldati in servizio e dove, quanti
soldi nelle casse dello stato, in quella imperiale e nei residui da riscuotere delle tasse.
Inserire foto Pantheon
Pantheon: fu costruito da Agrippa tra il 27 e il 25 a.C.; restaurato da Domiziano dopo l’incendio
dell’80 d. C., Adriano fece incidere sul frontone un’iscrizione tra il 118 e il 125 d. C. e lo ricostruì.
Terme di Agrippa: furono edificate tra il 25 e il 19 a.C. e costituivano il più antico edificio
termale pubblico; erano alimentate dall’acquedotto Vergine, restaurate dopo l’incendio dell’80 d.C.
e poi ancora da Adriano. La sala centrale di m. 25 di diametro era ornata da statue famose come
l’Apoxiomenos di Lisippo, accanto vi era un laghetto (stagnum Agrippae) che per mezzo di un
canale, l’Euripo, confluiva nel Tevere.
Historia Augusta, Hadrianus, 19, 10
Romae instauravit Pantheum, saepta, basilicam Neptuni, sacras aedes plurimas, forum Augusti,
lavacrum Agrippae, eaque omnia propriis auctorum nominibus consecravit.
65
CLAUDIO
Gli acquedotti dell’Aniene e dell’Aqua Claudia (52 d.C.) furono edificati sotto Claudio insieme
alla Porta Maggiore per contenere le condutture dei due acquedotti, questa fu poi inglobata nelle
mura aureliane e divenne una porta della città. Era un arco a due fornici sul cui attico passavano le
condutture degli acquedotti. Sulla parte superiore si legge:
CIL. VI, 1258 IMP T CAESAR DIVI F VESPASIANUS AUGUSTUS
PONTIFEX MAXIMUS TRIBUNIC POTESTATE X
IMPERATOR XVII PATER PATRIAE CENSOR COS
VIII AQUAS CURTIAM ET CAERULEAM PERDUCTAS
A DIVO CLAUDIO ET POSTEA A DIVO VESPASIANO
PATRE SUO URBI RESTITUTAS CUM A CAPITE
AQUARUM A SOLO VETUSTATE DILAPSAE ESSENT
NOVA FORMA REDUCENDAS SUA IMPENSA CURAVIT
I FLAVI
Durante il periodo dei Flavi l’architettura tese a rendere al popolo quello che il “tiranno” Nerone
aveva tolto: molti edifici della Domus aurea furono demoliti per far posto a nuove costruzioni. Lo
sviluppo degli elementi curvilinei portò ad un uso frequentissimo della volta a crociera e della
cupola.
VESPASIANO
Spetta a questo imperatore l’ideazione e la costruzione dell’ Anfiteatro Flavio (in Vitruvio, De
arch., V,17 compare per la prima volta il nome di anfiteatro ad indicare l’unione di due teatri, sul
modello di quello di Pompei del 79 d.C.), detto Colosseo, che interpretava la passione dei Romani
per i giochi. Fu preceduto dall’anfiteatro di Statilio Tauro sotto il principato di Augusto. Fu iniziato
sotto Vespasiano sul bacino artificiale della Domus neroniana; Tito lo portò a termine
inaugurandolo nell’80 a. C. con festeggiamenti durati cento giorni. I lavori di completamento (i
decori degli scudi sull’attico ed i sotterranei) giunsero però sino a Domiziano. L’opera è alta circa
50 m., ha un asse maggiore di 188 m. e uno minore di 156. Consta di quattro piani sovrapposti con
arcate e semicolonne tuscaniche al primo piano, ioniche al secondo e corinzie al terzo; al quarto
piano (attico) le arcate sono cieche e sono ornate di lesene corinzie alternate a scudi bronzei. Un
grande velario, sostenuto da pali inseriti nelle mensole del cornicione, riparava gli spettatori dal
sole. Era manovrato da una squadra di marinai della flotta del Miseno. Dalle 80 arcate del piano
terra le scalinate portavano ai vari settori della cavea. Ogni ingresso aveva un numero riportato sul
biglietto dello spettatore; i quattro ingressi principali in corrispondenza degli assi del circo, erano
riservati ai notabili. La tribuna imperiale doveva essere disposta nel lato nord. Il piano dell’arena
era in legno e poggiava sui muri dei sotterranei di servizio in cui erano le armerie, le gabbie per le
belve ed i depositi dei vari macchinari che, come i montacarichi, portavano le fiere nell’arena. Un
corridoio ed una robusta rete separavano gli spettatori dall’arena, coperta da un tavolato ligneo. I
posti erano divisi in cinque settori concentrici e leggi precise fissavano le categorie cui erano
riservati: senatori, cavalieri e via via sino ai posti in alto per le donne. Su alcuni gradini, o sui
settori, sono ancora incisi i nomi delle categorie degli spettatori, o addirittura i nomi dei senatori,
divisi fra clarissimi, spectabiles e illustres. Nel complesso i posti erano circa 50.000. Il Colosseo fu
incendiato e restaurato varie volte, anche a seguito di terremoti, ospitò spettacoli sino al 523 d.C.
con Teodorico.
66
Il Colosseo prese tale nome nell’ottavo secolo in quanto sorgeva al posto di una grande statua che
raffigurava Nerone, opera dello scultore greco Zenodoros e che con la sua altezza quasi eguagliava,
se non addirittura superava, l’anfiteatro. Nel luogo poi occupato dall’arco di Costantino una fontana
conica a forma di meta (il traguardo di un circo, cioè una stele lungo la spina centrale, che
designava il punto in cui si trovava la curva nella pista durante le corse) faceva sgorgare acqua: era
la Meta Sudans, distrutta durante la sistemazione dell’area sotto il fascismo.
Marziale, Liber spectaculorum, II
Hic ubi sidereus propius videt astra colossus …
TITO
Le Terme di Tito furono dedicate nell’80 d.C.; forse furono ricavate dai bagni della Domus aurea.
La pianta ricalca quella tradizionale degli ambienti simmetrici intorno ad una sala centrale. La
descrizione proviene da una pianta del Palladio,.
Marziale, Ep., III, 20, 15
Titine thermis an lavatur Agrippae
an inpudici balneo Tigillini?
DOMIZIANO
La sua residenza fu la Domus Augustana edificata nel 92 d. C. dall’architetto Rabirio sul colle
Palatino; comprendeva una basilica rettangolare a tre navate con un podio da cui l’imperatore
amministrava la giustizia ed un’Aula regia per le cerimonie ufficiali.
Marziale, Ep. VIII, 36
Regia pyramidum, Caesar, miracula ride;
iam tacet Eoum barbara Memphis opus:
pars quota Parrhasiae labor est Mareoticus aulae?
Clarius in toto nil videt orbe dies
…
Haec, Auguste, tamen, quae vertice sidera pulsat,
par domus est caelo sed minor est domino.
L’Arco di Tito, invece non è mai citato dalle fonti antiche. L’iscrizione sull’attico parla di Divo
Tito, l’opera deve essere quindi posteriore alla sua morte avvenuta nell’81 d. C.; la costruzione è
quindi da attribuire a Domiziano. L’arco è ad un solo fornice e rappresenta il trionfo di Vespasiano
e Tito sui Giudei del 71 d. C.. All’interno dell’arco due riquadri riportano uno il corteo trionfale e
l’altro l’avanzare di Tito sulla quadriga retta anche dalla dea Roma, mentre la Vittoria lo incorona.
Al centro della volta sta l’apoteosi dell’imperatore portato in cielo da un’aquila.
CIL VI, 945 - SENATUS POPULUSQUE ROMANUS DIVO TITO
DIVI VESPASIANI F VESPASIANO AUGUSTO
Per lo Stadio di Domiziano (che occupava l’area dell’attuale p.zza Navona in Roma) la fonte è
costituita dal seguente brano di Suetonio:
Suetonio, Domiziano, IV:
67
Spectacula assidue magnifica et sumptuosa edidit non in amphitheatro modo, verum et in circo;
ubi praeter sollemnes bigarum quadrigarumque cursus proelium etiam duplex, equestre ac
pedestre, commisit; at in amphitheatro navale quoque. Nam venationes gladiatoresque et noctibus
ad lychnuchos; nec virorum modo pugnas, sed et feminarum. … Edidit navales pugnas paene
iustarum classium, effosso et circumstructo iuxta Tiberim lacu, atque inter maximos imbres
perspectavit.
DENTRO IL PROBLEMA
LA DOMUS AUREA
L’incendio di Roma del 64 d. C. fornì un pretesto all’imperatore Nerone per costruirsi una dimora
finalmente degna di lui.
L’eccezionalità della grandezza ed il fasto della costruzione divennero proverbiali:
Testi
Suetonio, Nero, 31,1-2
[1] Non in alia re tamen damnosior quam in aedificando domum a Palatio Esquilias usque fecit,
quam primo transitoriam, mox incendio absumptam restitutamque auream nominavit. De cuius
spatio atque cultu suffecerit haec ret<t>ulisse. Vestibulum eius fuit, in quo colossus CXX pedum
staret ipsius effigie; tanta laxitas, ut porticus triplices miliarias haberet; item stagnum maris instar,
circumsaeptum aedificiis ad urbium speciem; rura insuper arvis atque vinetis et pascuis silvisque
varia, cum multitudine omnis generis pecudum ac ferarum. [2] In ceteris partibus cuncta auro lita,
distincta gemmis unionumque conchis erant; cenationes laqueatae tabulis eburneis versatilibus, ut
flores, fistulatis, ut unguenta desuper spargerentur; praecipua cenationum rotunda, quae perpetuo
diebus ac noctibus vice mundi circumageretur; balineae marinis et albulis fluentes aquis. Eius modi
domum cum absolutam dedicaret, hactenus comprobavit, ut se diceret quasi hominem tandem
habitare coepisse.
In null’altro fu tanto dannoso quanto nel costruire, edificò una casa dal Palatino all’Esquilino
che dapprima chiamò transitoria, poi, distrutta da un incendio e rifatta, disse aurea. Sarà
sufficiente dire questo della sua ampiezza e lusso: il vestibolo era tale che vi sorgeva nel mezzo
un colosso alto 120 piedi che rappresentava Nerone, la larghezza era tanta che c’erano tre
porticati lunghi un miglio, v’era uno stagno simile a un mare, cinto da edifici come città, ville
con campagne e vigneti, pascoli e selve, con numerosissimo bestiame e selvaggina. Altrove tutto
era coperto d’oro, con gemme e conchiglie perlifere, sale da pranzo con soffitti in avorio
traforato e girevoli, per potervi far piovere dall’alto fiori e profumi, la sala principale era rotonda
e con un movimento continuo diurno e notturno girava seguendo il moto della Terra; nei bagni
scorreva acqua di mare e albula. Inaugurando una tale dimora, la lodò dicendo che finalmente
iniziava ad abitare in una casa degna di un uomo.
La costruzione copriva un’area di 80 ettari fra i colli Palatino, Velia, Oppio, Esquilino e Celio, tanto
che circolavano a Roma battute di questo tipo:
Suetonio, Nero, 39
Roma domus fiet; Veios migrate, Quirites,
Si non et Veios occupat ista domus.
68
Roma diviene una sola casa, Quiriti migrate a Veio, salvo che questa casa non occupi anche
Veio.
Da Tacito sappiamo il nome degli architetti, il lusso delle decorazioni, gli enormi spazi che
comprendevano addirittura laghi e boschi:
Testi
Tacito, Annales, XV, 42
Ceterum Nero usus est patriae ruinis exstruxitque domum, in qua haud proinde gemmae et aurum
miraculo essent, solita quidem et luxu vulgata, quam arva et stagna et in modum solitudinem hinc
silvae, inde aperta spatia et prospectus, magistris et machinatoribus Severo et Celere, quibus
ingenium et audacia erat etiam, quae natura denegavisset, per artem temptare et viribus principis
inludere.
Inoltre Nerone si servì delle rovine della patria e si costruì una casa in cui non solo destassero
meraviglia oro e gemme, oramai cosa abituale e lusso comune, quanto piuttosto campi e stagni e
da un lato selve solitarie, dall’altro spazi aperti e vedute; architetti e costruttori furono Severo e
Celere, la cui audacia ed il cui ingegno sperimentarono con l’arte quello che la natura aveva
negato e misero in gioco le ricchezze del principe.
Plinio dice addirittura che abbracciava tutta Roma:
Plinio, Naturalis historia, XXXIII, 54
Nero ... et quota pars ea fuit aureae domus ambientis urbem!
Nerone … e che parte fu quella della casa d’oro che circondava la città!
Nel vestibolo si ergeva la colossale statua di Nerone alta 35 metri, opera dello scultore greco
Zenodoro, in cui il princeps era identificato con il dio Sole, come simbolo di una nuova era dell’oro:
Plinio, Naturalis istoria, XXXIV, 45
Zenodorus … Romam accitus a Nerone, ubi destinatum illius principis simulacro colossum fecit
CXIXS pedum in longitudinem, qui dicatus Soli venerationi est damnatis sceleribus illius principis.
Zenodoro fu chiamato a Roma da Nerone e vi fece una colossale statua come simulacro di quel
principe, alta 119 piedi e mezzo, che fu consacrata al dio sole per venerazione a causa delle
esecrate nefandezze di quel principe.
Marziale lamentava che una sola casa occupasse tutta la città:
Marziale, Liber de spectaculis, II
Hic ubi sidereus propius videt astra colossus
et crescunt media pegmata celsa via,
invidiosa feri radiabant atria regis
unaque iam tota stabat in urbe domus;
hic ubi conspicui venerabilis Amphitheatri
erigitur moles, stagna Neronis erant;
hic ubi miramur velocia munera thermas,
abstulerat miseris tecta superbus ager;
Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras,
ultima pars aulae deficientis erat.
5
10
69
Reddita Roma sibi est et sunt te preside, Caesar,
deliciae populi, quae fuerant domini.
Qui, dove un sidereo colosso guarda le stelle più da vicino e in mezzo alla via si alzano le altre
strutture, si distendevano gli atri invidiabili del crudele re ed una sola dimora ormai occupava
l’intera città. Qui, dove si erge la mole veneranda del grande Anfiteatro c’erano gli stagni di
Nerone e qui, dove godiamo il dono rapido delle terme, un prato superbo toglieva ai miseri un
tetto. Dove il portico di Claudio largisce le sue vaste ombre, finiva l’ultima parte del palazzo.
Roma è stata resa a se stessa e sotto la tua tutela, o Cesare, sono del popolo quelle delizie prima
riservate al potente.
Infatti il complesso sopravvisse di poco alla morte dell’imperatore (68 d.C.), distrutto o riutilizzato
per far posto agli edifici dell’età dei Flavi.
Molte statue ornavano l’edificio e Plinio lo ricorda sia per il lusso che per i saccheggi che
l’imperatore non aveva esitato a compiere in Grecia. S’ipotizza che fra queste statue ci fossero
quelle del Galata morente, del Galata suicida e del gruppo del Laocoonte.
Testi
Plinio, Naturalis historia, XXXIV, 84
84 ... Atque ex omnibus, quae rettuli, clarissima quaeque in urbe iam sunt dicata a Vespasiano
principe in templo Pacis aliisque eius operibus, violentia Neronis in urbem convecta et in sellariis
domus aureae disposita.
Tra tutte le statue che ho citato, le più famose oggi sono a Roma, dedicate da Vespasiano nel
Tempio della Pace e negli altri edifici da lui eretti,; furono trasportate a Roma in seguito ai
violenti saccheggi di Nerone ed erano state poste nei saloni della Domus Aurea.
La Domus Aurea era un palazzo tanto odiato che Pisone nel 65 d. C. tramava di uccidervi il
principe:
Tacito, Annales, XV, 52
Melius apud urbem in illa invisa et spoliis civium exstructa domo vel in publico patraturos quod
pro re publica suscepissent.
Sarebbe stato meglio perpetrare quello che avevano deciso per il bene dello stato in città, in
quella odiosa casa costruita con le spoliazioni dei cittadini, oppure in pubblico.
L’abbandono delle terme di Traiano, causato forse dal taglio degli acquedotti del 539 da parte degli
Ostrogoti, segnò l’oblio dei monumenti del colle Oppio. Le rovine della Domus furono riscoperte
alla fine del ‘400 quando i visitatori, calandosi dall’alto del terreno di riporto che aveva occultato i
resti dell’edificio, copiavano i disegni decorativi delle volte detti “grottesche”, in quanto davano
l’impressione di trovarsi nelle grotte.
70
DENTRO IL TESTO
IL SAGGIO TRA VITA PRATICA E VITA CONTEMPLATIVA
Seneca, Epistulae ad Lucilium, VIII, 73
1. Errare mihi videntur qui existimant philosophiae fideliter deditos contumaces esse ac
refractarios, contemptores magistratuum aut regum eorumve per quos publica administrantur. Ex
contrario enim nulli adversus illos gratiores sunt, nec immerito; nullis enim plus praestant quam
quibus frui tranquillo otio licet. 2. Itaque ii quibus multum ad propositum bene vivendi confert
securitas publica necesse est auctorem huius boni ut parentem colant, multo quidem magis quam
illi inquieti et in medio positi, qui multa principibus debent sed multa et imputant, quibus numquam
tam plene occurrere ulla liberalitas potest ut cupiditates illorum, quae crescunt dum implentur,
exsatiet…. 8. …. Adice nunc quod magna et vera bona non sic dividuntur ut exiguum in singulos
cadat: ad unumquemque tota perveniunt. E congiario tantum ferunt homines quantum in capita
promissum est; epulum et visceratio et quidquid aliud manu capitur discedit in partes: at haec
individua bona, pax et libertas, ea tam omnium tota quam singulorum sunt. 9. Cogitat itaque per
quem sibi horum usus fructusque contingat, per quem non ad arma illum nec adservandas vigilias
nec ad tuenda moenia et multiplex belli tributum publica necessitas vocet, agitque gubernatori suo
gratias. Hoc docet philosophia praecipue, bene debere beneficia, bene solvere; interdum autem
solutio est ipsa confessio. 10. Confitebitur ergo multum se debere ei cuius administratione ac
providentia contingit illi pingue otium et arbitrium sui temporis et imperturbata publicis
occupationibus quies.
O Meliboee, deus nobis haec otia fecit; namque erit ille mihi semper deus.
11. Si illa quoque otia multum auctori suo debent quorum munus hoc maximum est,
ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum
ludere quae vellem calamo permisit agresti,
quanti aestimamus hoc otium quod inter deos agitur, quod deos facit? 12. Ita dico, Lucili, et te in
caelum compendiario voco. Solebat Sextius dicere Iovem plus non posse quam bonum virum. Plura
Iuppiter habet quae praestet hominibus, sed inter duos bonos non est melior qui locupletior, non
magis quam inter duos quibus par scientia regendi gubernaculum est meliorem dixeris cui maius
speciosiusque navigium est. 13. Iuppiter quo antecedit virum bonum? Diutius bonus est: sapiens
nihilo se minoris aestimat quod virtutes eius spatio breviore cluduntur.
Mi sembra che sbaglino coloro che credono che chi si dedica alla filosofia con tutto l’animo sia
estraneo e ribelle, disprezzi le magistrature ed i sovrani e coloro attraverso i quali lo stato è
amministrato. Al contrario nessuno è più grato nei loro confronti e giustamente; infatti offrono
la possibilità di usufruire di un tranquillo otium. Perciò coloro ai quali la stabilità di governo
fornisce la possibilità di vivere bene, è necessario che venerino l’autore di questo bene come un
padre, certamente molto di più di quegli uomini ansiosi e agitati che sono molto debitori ai
sovrani, ma gli rimproverano anche molte cose, per i quali nessun atto di liberalità può fornirgli
tanto da saziare i loro desideri che si accrescono mentre si soddisfano. … Aggiungi il fatto che i
grandi e veri beni non si dividono in modo tale che ne cada un po’ in ognuno. Giungono a tutti
in egual misura. Da una distribuzione di cibo gli uomini prendono tanto quanto gli è stato
promesso a testa. I banchetti e la distribuzione di carni e tutto quello che viene elargito, si divide
71
in parti, ma questi beni indivisibili, la pace e la libertà, sono sia di tutti quanto di ogni singolo.
Rifletti perciò attraverso chi il lor uso e il loro risultato si possa realizzare e grazie a chi non si
deve ricorrere alle armi, né a fare i turni di guardia, né a difendere le mura, né a pagare le tasse,
se lo stato è in pericolo. E allora rendi grazie a chi ha nelle mani il timone dello stato. La
filosofia insegna soprattutto questo, ad essere debitore dei benefici ricevuti e a restituirli.
Frattanto il fatto stesso di ammetterlo è una forma di pagamento. Il saggio confesserà dunque di
essere debitore a colui che con una giusta amministrazione gli garantisce grande disponibilità di
tempo libero e una pace non turbata da problemi politici.
“O Melibeo, un dio ci permise questa pace, infatti egli sarà per me sempre un dio”.
Melibeo deve molto all’autore di questa pace, dei cui vantaggi egli gode.
“Egli consentì ai miei buoi di pascolare come vedi e di suonare quello che volessi con l’agreste
zampogna”.
Perché non dovremmo tenere in considerazione quell’otium che c’è tra gli dei, e che ci rende
dei. Così ti dico, o Lucilio, e ti invito ad elevarti al cielo per la via più breve. Sestio soleva dire che
Giove non ha più potere di una persona virtuosa. Giove ha molte cose che può offrire agli
uomini, ma fra due uomini virtuosi non è migliore chi è più ricco, non diversamente che tra due
timonieri abili non è migliore quello che ha una nave più bella. In che cosa Giove supera il
saggio? La sua virtù dura più a lungo. Ma il saggio non si considera inferiore per il fatto che le
sue virtù sono racchiuse in uno spazio di tempo esiguo.
Qui Seneca scagiona i filosofi dall’accusa di essere contemptores magistratuum aut regum,
perché proprio grazie a costoro possono fruire di quell’otium necessario all’esercizio della vita
contemplativa. La securitas pubblica deve essere apprezzata anche da chi non partecipa
direttamente alla vita dello stato. Il saggio lascia la curia e il foro ut ad ampliora secederet. Cosa
sono questi ampliora? Sono gli ideali del sapiens realizzabili in una cosmopoli in cui l’individuo si
senta prima uomo e poi civis. Seneca ormai avanti con gli anni, tornando alla sua formazione in
seno alla setta dei Sesti sceglierà un tipo di vita fuori dallo stato; con Nerone aveva ipotizzato che
il filosofo potesse attuare anche nella vita politica i principi in cui crede, svolgendo una funzione di
educatore; divenire precettore di Nerone significava poter giovare all’umanità. Il filosofo diventa
così un maestro di vita e non un individuo che si pone al servizio dei potenti, diventandone
“cliente” e subendo ogni tipo di angherie. Uno stato giusto garantisce al pace a tutti e sono i sapienti
coloro che sanno cogliere il meglio da questa situazione. Seneca ha reso la vita contemplativa meno
astratta, infatti l’otium serviva per il perfezionamento morale, per lo studio anche in campo
scientifico e per quello che poteva giovare all’umanità; il saggio invece non può essere una guida
politica dal momento che vi ha rinunciato ut ad ampliora secederet.
Vi sono dei beni indiscutibili comuni a tutti, accanto ad essi esistono beni individuali come la pax e
la libertas. Qui il termine pax si svuota di ogni significato politico-propagandistico: la pace è un
bene strumentale, cioè il mezzo che consente sicurezza e libertà, in cui il filosofo può realizzare il
suo ideale di vita. Si ricordi che le Epistole a Lucilio furono scritte quando Seneca si era ritirato
dalla vita politica; si era reso conto dell’impossibilità di una restaurazione degli ideali dell’antica
repubblica e aveva accettato la monarchia così come gliela presentavano gli stoici, vale a dire il
governo di un rex iustus da identificarsi con il sapiens: tutto questo era un’utopia, come
dimostrava l’esperienza con Nerone. La pace permette al sapiente di stare lontano dalle attività
pubbliche e di disporre liberamente del proprio tempo coltivando la propria vita interiore e
mostrando riconoscenza a colui che la rende possibile. In questo contesto si inseriscono i versi della
I Ecloga di Virgilio. Segue il ricordo del maestro Sestio che soleva dire che Iovem plus non posse
quam bonum virum. Il vir bonus può dunque uguagliare Giove e non importa che il dio possegga
più cose e per più tempo, non godrà per questo di una felicità superiore a quella del sapiens. Tale
concetto Seneca lo aveva già espresso. Nel De constantia sapientis si legge: “Sapiens autem vicinus
proximusque deis consistit excepta mortalitate similis deo”. Il sapiente non solo è superiore agli
72
altri uomini, ma persino alla divinità, perché quest’ultima non può che essere buona, mentre il
saggio lo è per sua scelta.
DENTRO IL TESTO
QUANTUM HOMINUM UNUS VENTER EXERCET!
SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM, 95
25. Di boni, quantum hominum unus venter exercet! Quid? Tu illos boletos, voluptarium venenum,
nihil occulti operis iudicas facere, etiam si praesentanei non fuerunt? Quid? Tu illam aestivam
nivem non putas callum iocineribus obducere? Quid? Illa ostrea, inertissimam carnem caeno
saginatam, nihil existimas limosae gravitatis inferre? Quid? Illud sociorum garum, pretiosam
malorum piscium saniem, non credis urere salsa tabe praecordia? Quid? Illa purulenta et quae
tantum non ex ipso igne in os transferuntur iudicas sine noxa in ipsis visceribus extingui? Quam
foedi itaque pestilentesque ructus sunt, quantum fastidium sui exhalantibus crapulam veterem!
Scias putrescere sumpta, non concoqui.
26. Memini fuisse quondam in sermone nobilem patinam in quam quidquid apud lautos solet diem
ducere properans in damnum suum popina congesserat: veneriae spondylique et ostrea ea tenus
circumcisa qua eduntur intervenientibus distinguebantur echini totam destructique sine ullis
ossibus mulli constraverant.
27. Piget esse iam singula: coguntur in unum sapores. In cena fit quod fieri debebat in ventre:
expecto iam ut manducata ponantur. Quantulo autem hoc minus est, testas excerpere atque ossa et
dentium opera cocum fungi? “Gravest luxuriari per singula: omnia semel et in eundem saporem
versa ponantur. Quare ego ad unam rem manum porrigam? Plura veniant simul, multorum
ferculorum ornamenta coeant et cohaereant.
28. Sciant protinus hi qui iactationem ex istis peti et gloriam aiebant non ostendi ista sed
conscientiae dari. Pariter sint quae disponi solent, uno iure perfusa; nihil intersit; ostrea, echini,
spondyli, mulli perturbati concoctique ponantur”. Non esset confusior vomentium cibus.
29. Quomodo ista perplexa sunt, sic ex istis non singulares morbi nascuntur sed inexplicabiles,
diversi, multiformes, adversus quos et medicina armare se coepit multis generibus, multis
observationibus. Idem tibi de philosophia dico.
O dei buoni, quanti uomini mette in movimento un solo ventre!
E che? Pensi che quei funghi, piacevole veleno, non abbiano un loro subdolo effetto, anche se
esso non si manifesta subito?
Non pensi che questa neve consumata d’estate provochi un indurimento del fegato?
Queste ostriche, carne molle ingrassata nel fango non ti trasmetterà niente, secondo te, della sua
limacciosa gravezza?
73
Quel caviale di importazione, prezioso marciume di pesci guasti, non ti brucerà lo stomaco con la
sua salsa poltiglia?
Quei cibi putridi che passano bollenti dai fornelli alla bocca non lasceranno alcuna lesione
spegnendosi nelle tue viscere?
Inoltre che rutti sconci e pestiferi! Che disgusto di sé a sentire esalare l’odore dell’indigestione
del giorno precedente! In costoro il cibo non viene assimilato, ma imputridisce.
Ho sentito parlare di un piatto famoso in cui il cuoco, affrettando la rovina dei convitati, aveva
riuniti tutti i cibi che vengono serviti nei lauti banchetti: conchiglie di ogni specie e ostriche
staccate dal guscio e pronte per essere mangiate erano disposte accanto ai ricci di mare: tordi
disossati e triglie senza lische ricoprivano di uno strato tutto il fondo del piatto.
Ormai non da più gusto mangiare i cibi uno alla volta, si vogliono sentire più sapori riuniti, si fa
a tavola quello che si dovrebbe fare nello stomaco: c’è da aspettarsi che ci imbandiscano i cibi
già masticati. Del resto poco ci manca dal momento che si tolgono gusci a ossa e il cuoco
sostituisce le funzioni dei denti. “E’ fastidioso gustare uno alla volta cibi diversi, formino
un’unica pietanza e si confondano in un unico sapore. Perché dover prendere un cibo alla volta?
Ne vengano portati in tavola molti insieme; si faccia una mescolanza di molte vivande. Chi
afferma che una tale pietanza era preparata solo per il desiderio di originalità, sappia che noi
non vogliamo metterci in mostra, ma provare la nostra cultura gastronomica. Quei cibi che
sogliono imbandirsi separatamente siano mescolati insieme in parti uguali: non ci sia nessuna
differenza, ostriche, ricci, conchiglie, triglie, siano cotti insieme e serviti a tavola”. Il cibo che si
vomita non potrebbe essere più rimescolato. E come queste pietanze sono complicate, così
provocano malattie complesse, diverse, multiformi e, per combatterle, la medicina ha dovuto
fornirsi di molti rimedi e di molte ricette. Così dico della filosofia.
La visione del cibo è qui sottoposta alla lente deformata del moralismo; prima vi è un elenco di
piatti e di ingredienti difficili da reperire e quindi costosi, mangiarne vuol dire far vedere che si
appartiene ad una certa classe sociale e l’unico modo per distinguersi sono i cibi raffinati. E’ lo
stesso spirito che anima il Satyricon: quanto più c’è ignoranza e mancanza di equilibrio, tanto più si
pensa al mangiare eccessivo e ricercato. L’atteggiamento di Seneca è polemico e vuole
contrapporre alla situazione presente - quella dei nuovi ricchi, dei mercanti, di coloro che non
hanno dei valori - la cultura romana, vale a dire quella contadina delle origini e della semplicità,
della rude vita militare. Questo argomento è stato abbondantemente trattato da altri autori, valga per
tutti Orazio, ma a Seneca preme mettere in evidenza come alcuni cibi, che ingannano sia con il loro
aspetto che con il sapore alla lunga siano deleteri; questo serve come pretesto per introdurre la
seconda sequenza del passo preso in esame. Lo scrittore riferisce infatti l’ultima ignobile trovata
dei cuochi, ovviamente spinti dai loro padroni, i quali mescolano i cibi più ricercati per farne una
pietanza irriconoscibile e innominabile. Tale piatto è disgustoso, afferma Seneca, perché non si
riesce a capire ciò che si mangia e quella che doveva essere una ricercatezza diviene invece una
cosa immonda. Qui la descrizione dei cibi e delle vivande sofisticate assume un significato sociale e
politico in una visione estremamente moralistica. L’esaltazione di questo insieme di cibi e sapori è
affidata ad un interlocutore fittizio, l’uomo della folla, che è irretito da ogni tipo di novità. Tutto
questo excursus gastronomico piuttosto enfatico, paradossale e “barocco” serve al filosofo per far
vedere come ciò che è eccessivamente artefatto nasconde qualcosa di vuoto o di dannoso: da
notare che il linguaggio si fa via via più complesso in relazione alla complessità del cibo. Così
avviene per la filosofia: un tempo i concetti erano semplici, le problematiche risolvibili, perché i
74
difetti dell’uomo erano facilmente individuabili, ora non è più così. Anche nel linguaggio è
necessaria la brevità e la concisione che consenta la comprensione da parte di tutti.
DENTRO IL PROBLEMA
IL CIBO COME ECCESSO
Il cibo come eccesso implica sempre una connotazione morale; valgano come esempio le parole di
Epitteto (41): “È segno di stupidità trascorrere gran parte del tempo a occuparsi del proprio
corpo, esercitando i muscoli, mangiando, bevendo, defecando e copulando. Queste cose
andrebbero fatte incidentalmente e si dovrebbe piuttosto dedicare tutta l’attenzione alla mente”.
Teofrasto (Caratteri, 3), presentando una tipologia di persone prive di equilibrio, fa elencare al suo
loquace personaggio tutti i piatti che ha gustato la sera precedente. Plutarco (Mor., 1094C)
disprezza le persone che non ricordano un pasto consumato da poco e si entusiasmano per questo
tipo di piaceri. Nella biografia di Augusto, Suetonio include anche la dieta seguita dall’imperatore,
come riflessione secondaria (Aug. 74-76): “Nel cibo - giacché non potrei certo ometterlo - egli era
oltremodo frugale”. Veniamo a sapere che sbocconcellava piccoli fichi e pane nero durante i suoi
spostamenti in lettiga, che pur avendo dato importanza ai banchetti pubblici a questi però arrivava
in ritardo, dicendo di aver già mangiato.
Trasporre il cibo in forma scritta presentava ovviamente alcune precipue difficoltà. Per quanto gli
autori latini e greci cercassero di evitare ogni contatto con gli aspetti fisici e corporei
dell’alimentazione, resta il fatto che, per quanto riguarda il gusto, l’appetito, la soddisfazione di un
cibo, il vocabolario latino e greco ricorre alla metafora del piacere (cfr. edonè da edys che in greco
vuol dire “dolce” e sapiens, dal verbo sapio che voleva dire in origine che “aveva un buon sapore”;
lo stesso è riscontrabile nell’inglese sweet, “dolce” sia come sostantivo che come aggettivo).
Cicerone nei suoi scritti filosofici, predica sulle antiche virtù del cibo inteso come necessario
corroborante per il corpo, ma quando scrive le epistole dimostra di essere a conoscenza di molti
aspetti della gastronomia che un uomo colto deve possedere (Ad fam., 9, 18, 3 – Ad Att. 13, 52).
Il luogo dove cibo e sporcizia convivevano era la Suburra, descritta da Giovenale (Sat., 5, 105); il
quartiere era lo stomaco di Roma, un po’ come il ventre di Parigi nella descrizione delle Halles in
Victor Hugo. Inoltre il fatto che il quartiere delle taverne fosse così vicino al condotto fognario
della Cloaca Maxima doveva rappresentare un costante monito al carattere transeunte del cibo.
Gli estremi dell’alimentazione romana, cibo frugale e cibo estremamente elaborato,
rappresentavano l’iter del processo di civilizzazione: la natura rustica e frugale del passato era
sovrapposta all’attuale cultura cittadina sofisticata, perciò il contrasto diviene storico e sociale
insieme. La dieta seguita dalle altre razze viene in soccorso alla decadenza alimentare di Roma:
Tacito nel paragrafo 23 della Germania ricordava che i Germani si cibavano di selvaggina, frutta
selvatica e formaggio e sapevano placare il loro appetito senza dover ricorrere a condimenti e a
elaborate preparazioni culinarie. L’espansione romana porta come conseguenza una chiara ostilità
verso i cibi troppo elaborati e abbondanti e altri desideri superflui del corpo, l’ingordigia della gola
si mette in rapporto con quella delle conquiste dei romani o degli arricchiti.
Molti autori, tra cui Plinio (Plinio, Nat. hist. XVII, 27, 220), ricordano come si manipolava la
natura al fine di ottenere animali o ortaggi di grandi dimensioni, si ricorreva poi ad una grande
quantità e varietà di cibi che spesso confondeva artificiosamente i sapori; il termine luxuria si
riferisce contemporaneamente sia alla grandezza fisica, sia al proliferare di cibi ed alla esasperata
75
raffinatezza gastronomica. Plinio ci riferisce di veri e propri “prodigia gastronomici” (Nat. Hist.,
IX, 19, 54). Mentre in Grecia si attuavano scoperte scientifiche, a Roma ci si sbizzarriva con quelle
culinarie.
Eppure nell’Urbe esisteva una cultura del convivio nel suo significato intrinseco di “vivere
insieme”, un corrispondente del simposio del mondo greco. Ricordiamo che dal punto di vista
simbolico, i Saturnalia erano feste importanti, in esse si ribaltava qualsiasi gerarchia sociale e vi
erano alcune variazioni sugli usi alimentari: nel rispetto dello stile ludico della festa, venivano
serviti piatti di cibo finto, fatti di sostanze immangiabili (cfr. Petronio, Sat., 69, 9).
La cena era per i Romani quello che il symposium era per i Greci. La differenza stava nel fatto che il
symposium era una riunione per bere, mentre la cena romana era appesantita da ogni sorta di cibi.
Il momento del banchetto diviene comunque qualcosa di licenzioso e di eccessivo, un esempio di
volgarità portata all’eccesso è la descrizione del banchetto funebre di uno schiavo fatta dal
marmista Abinna alla fine della Cena del Satyricon: in essa vi è la tipica confusione tra ciò che è
umano e ciò che è animale.
Nel convito vi sono spesso allusioni alla sessualità. Nella letteratura conviviale ricorrono giochi di
parole tra sapiens (saggio ma anche saporito) e ius (salsa, sugo di carne, ma anche legge e diritto);
spesso erano solo battute scherzose che però fanno capire una certa avversione del potere e il tono
sprezzante dei moralisti.
Grasso era sinonimo di grossolano, anche nelle opere letterarie; a Roma essere parchi voleva dire
dissociarsi dall’insieme di materialismo e di consumi ostentati: Marziale dice di un ospite
particolarmente arrogante “E’ la tua cena ad essere eloquente, non certo tu”. Cicerone giocando
sul termine ius, che vuol dire anche salsa, scherza con la possibilità di scambiare le lezioni di
retorica con quelle di cucina. Nel Gorgia (cfr. Plat. Gorgia 465d) l’arte retorica e quella culinaria
vengono comparate sulla base del fatto che entrambe si fondano sull’inganno. Nel Moretum il cibo
viene impiegato come metaforico e come reale: macrocosmo e microcosmo sono racchiusi nello
spazio della poesia. La frase e pluribus unum (Moretum,102 – curiosamente divenuto il motto che
si legge sul dollaro statunitense), sottolinea la stravagante commistione di linguaggio comune e
linguaggio aulico; il poeta diventa il villico irsuto e il formaggio una ridicola parodia del cosmo.
Testo
Tacito, Germania, 23
Potui umor ex hordeo aut frumento, in quandam similitudinem vini corruptus: proximi ripae et
vinum mercantur. Cibi simplices, agrestia poma, recens fera, aut lac concretum. Sine apparatu,
sine blandimentis expellunt famem. Adversus sitim non eadem temperantia. Si indulseris ebrietati
suggerendo quantum concupiscunt, haud minus facile vitiis quam armis vincentur.
Umor: si tratta di un liquido ricavato dall’orzo e dal frumento, cioè la birra, l’etimo della quale è
teutonico.
Corruptus vuol dire fermentato. I popoli più vicini alla frontiera del Reno bevono il vino perché
avevano più scambi con i Romani, anche gli esiti nelle lingue anglosassoni del vocabolo “vino”
mostrano il rapporto con Roma. L’uso della cacciagione fresca ci fa capire come non fosse condita
con spezie per evitare che s’imputridisse, come invece facevano i Romani.
Lac concretum: latte rappreso come in Virgilio, Georg. III, 463; non si tratta di formaggio che era
pressoché sconosciuto alle genti barbare. Tacito conclude in maniera come al solito sentenziosa.
Suetonio, Augusto, 74
76
[74] Convivabatur assidue nec umquam nisi recta, non sine magno ordinum hominumque dilectu.
Valerius Messala tradit, neminem umquam libertinorum adhibitum ab eo cenae excepto Mena, sed
asserto in ingenuitatem post proditam Sexti Pompei classem. Ipse scribit, invitasse se quendam, in
cuius villa maneret, qui speculator suus olim fuisset. Convivia nonnumquam et serius inibat et
maturius relinquebat, cum convivae et cenare inciperent, prius quam ille discumberet, et
permanerent digresso eo. Cenam ternis ferculis aut cum abundantissime senis praebebat, ut non
nimio sumptu, ita summa comitate. Nam et ad communionem sermonis tacentis vel summissim
fabulantis provocabat, et aut acroamata et histriones aut etiam triviales ex circo ludios
interponebat ac frequentius aretalogos.
Dava spessissimo conviti e sempre in forma regolare, con accurata scelta delle persone e delle
classi. Narra Valerio Messalla che non ammise mai alle sue cene alcun libertino, tranne Mena,
soltanto però dopo che lo ebbe dichiarato libero cittadino, quando costui gli consegnò la flotta di
Sesto Pompeo. Egli stesso scrive di aver invitato un tale nella cui villa dimorava, che era stato
suo informatore particolare. Spesso entrava a mensa in ritardo e la lasciava più presto degli altri,
sì che i convitati cominciavano a cenare prima che egli venisse e continuavano dopo che egli si
era ritirato. Offriva cene di tre portate o di sei quando voleva molto abbondare, non per ciò di
soverchia spesa, ma con somma giovialità; incitava infatti a partecipare alla conversazione chi
taceva o chi parlava sommessamente, faceva intervenire o musici o attori ed anche ballerini
ordinari del circo e più spesso i cantastorie.
Suetonio, Augusto, 76
[76] Cibi - nam ne haec quidem omiserim - minimi erat atque vulgaris fere. Secundarium panem et
pisciculos minutos et caseum bubulum manu pressum et ficos virides biferas maxime appetebat;
vescebaturque et ante cenam quocumque tempore et loco, quo stomachus desiderasset. Verba ipsius
ex epistulis sunt: "Nos in essedo panem et palmulas gustavimus." Et iterum: "Dum lectica ex regia
domum redeo, panis unciam cum paucis acinis uvae duracinae comedi." Et rursus: "Ne Iudaeus
quidem, mi Tiberi, tam diligenter sabbatis ieiunium servat quam ego hodie servavi, qui in balineo
demum post horam primam noctis duas buccas manducavi prius quam ungui inciperem." Ex hac
inobservantia nonnumquam vel ante initum vel post dimissum convivium solus cenitabat, cum pleno
convivio nihil tangeret.
Quanto ai cibi, infatti non voglio omettere neppure questo, era frugalissimo e di gusti quasi
volgari. Gradiva pane di seconda qualità, pesciolini minuti, cacio vaccino premuto a mano, fichi
freschi biferi; e mangiava anche prima della cena, in qualunque momento e in qualunque luogo
il suo stomaco lo invitasse. Sono parole tratte dalle sue lettere: “Ho mangiato pane e datteri in
vettura”; “Tornando in lettiga dalla Basilica a casa ho mangiato un’oncia di pane con pochi
chicchi di uva duracina; neanche un giudeo osserva i sabati come oggi li ho osservati io, che
soltanto al bagno, dopo la prima ora di notte, ho mangiato due bocconi prima che cominciassero
ad ungermi”. Per effetto di questo disordine, non di rado mangiucchiava da solo, prima di
mettersi a mensa o dopo il convito, mentre durante questo non toccava cibo.
Petronio, Satyricon
66… ci fu servito un pezzo di carne di orsa.
77
69…seguirono poi delle mele cotogne con gli spini confitti intorno, per simulare i ricci di mare,
e ciò sarebbe stato ancora più tollerabile, se una pietanza stupefacente non ci avesse fatto venir
voglia di morire piuttosto che di assaggiarne…
70… è una perla d’uomo, che, se tu vuoi ti fa un pesce da una vulva, un colombo da un pezzo di
lardo, una tortora da un prosciutto, una gallina da un culaccio. Perciò gli ho trovato un nome
che gli si addice bene
Persio, Satire, Proemio 10 – 11
Magister artis ingenique largitor
Venter, negatas artifex sequi voces.
Il ventre è maestro d’arte ed elargitore d’ingegno, sa imitare le voci negate dalla natura.
Platone, Gorgia, 464d:
Socrate: “Nella medicina si è insinuata la gastronomia, e pretende di sapere quali siano i cibi
migliori per il corpo; infatti se un cuoco e un medico dovessero competere davanti ad una giuria di
bambini- o anche di uomini dissennati come bambini- per stabilire chi dei due s’intende di più di
cibi buoni e cattivi, fra il cuoco e il medico sarebbe il medico a morire di fame. E’ questo che
intendo quando parlo di adulazione; e dico che è una cosa brutta perché mira al piacere
disinteressandosi del bene".
465b c d e: “Come dicevo, la gastronomia è un’adulazione travestita da medicina…la cosmesi sta
alla ginnastica come la gastronomia alla medicina; e si potrebbe anche dire che la cosmesi sta alla
ginnastica come la sofistica sta alla legislazione, o che la gastronomia sta alla medicina come la
retorica sta alla giustizia … certo, se non fosse l’anima a governare il corpo, ma il corpo si
governasse da sé, e se non fosse l’anima a tenere distinte la gastronomia e la medicina, ma il corpo
dovesse giudicare in base ai piaceri che prova, allora avrebbe proprio ragione Anassagora: ogni
cosa si confonderebbe insieme, nello stesso calderone, senza più possibilità di distinguere salute,
medicina e gastronomia. Questa è la mia definizione di retorica, l’equivalente nell’anima di ciò che
è la gastronomia per il corpo” .
DENTRO IL PROBLEMA
ASTROLOGIA IN PETRONIO
Il nesso tra i segni zodiacali e i temperamenti individuali è questione che si perde nelle nebbie del
più remoto passato.
C. G. Jung, Tipologia psicologica, 1929
L’astrologia non può essere interpretata solo come un’espressione di dipendenza, ma deve essere
considerata un’ideologia della dipendenza.
T. W. Adorno, Stelle su misura, 1957
L’astrologia in fondo non è per l’appunto null’altro che un feticismo dei nomi proiettato nel futuro.
78
Abi Warburg, Arte e astrologia nel palazzo Schifanoia di Ferrara, 1912
Le stelle sono nostre compagne di viaggio, e la loro apparente immobilità forse dipende da questo:
avanziamo insieme.
L. A. Blanqui, L’eternità attraverso gli astri, 1872
Durante la Cena viene portato a Trimalchione un vassoio che stupisce i commensali per la sua
grandezza e per la singolarità delle pietanze. Nel piatto sono rappresentati i segni dello zodiaco in
modo circolare e sopra ogni segno è posto un cibo che in qualche modo è legato a tali costellazioni.
Trimalchione spiega la nuova portata con il fatto che anche un banchetto deve offrire spunti di
conversazione colta per cui inizia la trattazione astrologica secondo cui ad ogni costellazione dello
zodiaco corrisponde un tipo ed un temperamento umano.
Chiaramente tutta la trattazione viene deformata dal padrone di casa in un’epoca in cui l’astrologia
era considerata una vera e propria religione in una sorta di rapporto tra l’uomo e il suo destino.
Nel 52 d. C. venne approvato un decreto senatoriale con il quale si bandivano gli astrologi dall’
Italia; non era questa una novità: già infatti nel 139 a. C., gli astrologi erano stati espulsi da Roma
con decreto del pretore Cornelio Ispullo, ma l’effetto non era stato ottenuto se Agrippa dovette in
seguito adottare un provvedimento analogo. Gli atteggiamenti di repressione non fecero che
aumentare l’interesse della popolazione per tale disciplina e spesso gli astrologi furono considerati
dei veri e propri martiri; d’altra parte anche gli imperatori vi ricorrevano sovente. Il terreno di
diffusione dell’astrologia fu l’ambiente stoico che subì l’influsso dell’arte dei Caldei secondo cui
ogni evento si compie in base ad una necessità.
Petronio, Satyricon, 35
Laudationem ferculum est insecutum plane non pro expectatione magnum, novitas tamen omnium
convertit oculos. Rotundum enim repositorium duodecim habebat signa in orbe disposita, super
quae proprium convenientemque materiae structor imposuerat cibum: super arietem cicer
arietinum, super taurum bubulae frustum, super geminos testiculos ac rienes, super cancrum
coronam, super leonem ficum Africanam, super virginem steriliculam, super libram stateram in
cuius altera parte scriblita erat, in altera placenta, super scorpionem pisciculum marinum, super
sagittarium oclopetam, super capricornum locustam marinam, super aquarium anserem, super
pisces duos mullos. In medio autem caespes cum herbis excisus favum sustinebat. …
Ai nostri elogi tenne dietro una portata non così grande come ci aspettavamo, ma la cui novità
richiamò gli sguardi di tutti. Un vassoio rotondo recava in giro i dodici segni dello Zodiaco, su
ciascuno dei quali lo scalco aveva disposto una vivanda conveniente al soggetto: sull’Ariete ceci
arietini, sul Toro un tocco di bue, sui Gemelli rognoni e un paio di testicoli, sul Cancro una
corona, sul Leone fichi d’ Africa, sulla Vergine una vulva di troia sterile, sulla Libbra una
stadera con un pasticcio da una parte e una schiacciata dall’altra, sullo Scorpione un pesciolino
di mare, sul Sagittario un gallo selvatico, sul Capricorno un’aragosta, sull’Acquario un’oca, sui
pesci un paio di triglie. Nel centro poi, una zolla di terra con tutte le erbe recava un favo di miele.
Quindi ad ogni segno corrispondeva una pietanza:
ARIETEM cicer arietinum
TAURUM
bubulae frustum
GEMINOS testiculos ac rienes
79
CANCRUM coronam
LEONEM
ficum africanam
VIRGINEM steriliculam ( forse diminutivo di histera)
LIBRAM
stateram , scriblita placenta (tipo di focaccia fatta con il formaggio e senza il miele)
SCORPIONEM
pisciculum marinum
SAGITTARIUM oclopetam ( un animale dall’occhio fisso, che guarda da una parte e dall’altra)
CAPRICORNUM locustam marinam
AQUARIUM anserem
PISCES
duos mullos
Petronio, Satyricon, 39
… Caelus hic, in quo duodecim dii habitant, in totidem se figuras convertit, et modo fit aries.
Itaque quisquis nascitur illo signo, multa pecora habet, multum lanae, caput praeterea durum,
frontem expudoratam, cornum acutum. Plurimi hoc signo scolastici nascuntur et arietilli."
Laudamus urbanitatem mathematici; itaque adiecit: "Deinde totus caelus taurulus fit. Itaque tunc
calcitrosi nascuntur et bubulci et qui se ipsi pascunt. In geminis autem nascuntur bigae et boves et
colei et qui utrosque parietes linunt. In cancro ego natus sum: ideo multis pedibus sto, et in mari et
in terra multa possideo; nam cancer et hoc et illoc quadrat. Et ideo iam dudum nihil super illum
posui, ne genesim meam premerem. In leone cataphagae nascuntur et imperiosi. In virgine mulieres
et fugitivi et compediti; in libra laniones et unguentarii et quicunque aliquid expediunt; in
scorpione venenarii et percussores; in sagittario strabones, qui holera spectant, lardum tollunt; in
capricorno aerumnosi, quibus prae mala sua cornua nascuntur; in aquario copones et cucurbitae;
in piscibus obsonatores et rhetores. Sic orbis vertitur tanquam mola, et semper aliquid mali facit, ut
homines aut nascantur aut pereant."
…Questo cielo, dove stanno i dodici dei, si converte in altrettanti simboli e prima diventa Ariete.
Chi nasce sotto quel segno ha molto bestiame e molta lana, ha la testa dura, faccia tosta e nervo
aguzzo. Nascono sotto questo segno molti letterati e testoni. Lodammo l’arguzia dell’astrologo che
seguitò: poi tutto il cielo diventa Toro. Allora tocca ai musoni, agli zotici e a quelli che si rodono
dentro. In Gemelli nascono le coppie di cavalli, i buoi i testicoli e quelli che tengono i piedi in due
staffe. Sotto il segno del Cancro nacqui io. Perciò distendo assai le branche e possiedo molto in
terra ed in mare, infatti il Cancro è anfibio. Nulla vi ho posto sopra per non schiacciare il mio
oroscopo. In Leone nascono gli scialacquatori e i violenti; in Vergine i bellimbusti, i vigliacchi e
quelli destinati ai ceppi; in Libbra i macellai, i profumieri e quelli che sanno sbrogliarsela; nello
Scorpione gli avvelenatori e gli omicidi; nel Sagittario i guerci, che guardano il cavolo e rubano il
lardo; nel Capricorno i disgraziati a cui crescono in fronte le corna torte; in Acquario gli osti e i
citrulli; nei Pesci i cuochi e i retori. Il mondo gira come una mola e ci fa sempre qualcosa di male,
sia che si nasca o che si muoia…
80
Si è detto che l’astrologia era molto praticata dal popolo e dagli imperatori; l’opera più nota su tale
argomento era quella di Manilio vissuto alla fine del I secolo a. C., che aveva dedicato gli
Astronomica ad Augusto e che considerava tale scienza alla stregua di una religione.
Manilio, Astronomica, II, 432 - 451
His animadversis rebus quae proxima cura?
Noscere tutelas adiectaque numina signis
et quae cuique deo rerum natura dicavit,
cum divina dedit magnis virtutibus ora,
condidit et varias sacro sub nomine vires,
pondus uti rebus persona imponere posset.
Lanigerum Pallas, Taurum Cytherea tuetur,
formosos Phoebus Geminos; Cyllenie, Cancrum,
Iuppiter, et cum matre deum regis ipse Leonem;
spicifera est Virgo Cereris fabricataque Libra
Vulcani; pugnax Mavorti Scorpios haeret;
venantem Diana virum, sed partis equinae,
atque angusta fovet Capricorni sidera Vesta;
e Iovis adverso Iunonis Aquarius astrum est
agnoscitque suos Neptunus in aethere Pisces.
Hinc quoque magna tibi venient momenta futuri,
cum ratio tua per stellas et sidera curret
argumenta petens omni de parte viasque
artis, ut ingenio divina potentia surgat.
Presa coscienza di questi punti, quale sarà il prossimo impegno? Conoscere la protezione degli
astri e le potenze divine che sovrintendono ai segni e quale natura ciascun dio ha attribuito ai
segni, quando le divine sembianze ha posto in base alle grandi virtù e ha posto varie forze sotto un
sacro nome, perché potesse imporre una fisionomia a queste energie. La bestia lanuta protegge
Pallade, il Toro Citera, i bei Gemelli Febo, tu, o Cileno, governi il Cancro, tu, o Giove, insieme con
la madre degli dei, il Leone; la Vergine ha la spiga, insegna di Cerere e la Bilancia è fabbrica di
Vulcano; da Marte dipende il bellicoso Scorpione; l’uomo che caccia, ma con una parte equina,
l’assiste Diana e così pure Vesta protegge le anguste stelle del Capricorno; avverso a Giove,
l’Acquario è la costellazione di Giunone e Nettuno riconosce per suoi i Pesci nel mare. Di qui ti
deriveranno importanti spunti di previsione, quando i tuoi calcoli si indagheranno astri e
costellazioni alla ricerca di indizi da ogni parte e del giusto cammino delle arti, perché cresca nel
tuo spirito la potenza del dio…
Altra opera che tratta l’astrologia e nella quale possiamo rintracciare i segni zodiacali in relazione
alle caratteristiche degli uomini, è l’opera di Firmico Materno. Lo scrittore latino cristiano, vissuto
nel IV secolo d. C., è autore di un ampio trattato di astrologia, Matheseos libri VIII in cui fa
un’apologia dell’ astrologo, come uomo, tra l’altro, di elevata integrità morale.
Nello schema seguente si mettono in relazione i tre testi: quello di Petronio, quello di Manilio ad
esso precedente e quello di Firmico Materno. Nell’analisi comparativa emergono analogie e
81
approfondimenti utili alla comprensione del testo di Petronio (con M. si indica Manilio, con F. M.
Firmico Materno).
ARIES (Pallade)
multa pecora habet (lanigeri gregis est aries M.)
multum lanae (aries in vellera lanis M.)
caput durum
(secondo la melothesia, scienza che trova corrispondenze tra malattie e parti del
corpo, l’ariete è collocato nella testa, la patologia legata a questo segno è il mal di testa)
frontem expudoratam (tantum audere iuvat M.- obstinata fronte F.M.)
cornum acutum
Scholastici (i maestri di retorica, il segno infatti è sotto il controllo di Pallade)
et arietilli (gli alunni? i “capoccioni”?)
TAURUS (Venere)
calcitrosi (scontrosi oppure che si muovono in senso inverso)
bubulci (erunt agricolae et aratores F.M.)
qui se ipsi pascunt (non agunt vitam parasiticam M.)
GEMINI (Apollo)
bigae, boves, colei (coppie di cavalli e buoi, vincolo di amore come iugum)
et qui utrosque parietes linunt (si arrangiano come possono)
CANCER (Mercurio)
sotto questo segno è nato Trimalchione
multis pedibus sto (si allude alle molte zampe e all’arte di arrangiarsi)
in mari et in terra multa possideo (artem lucrorum, vendere, navigat, ingenium sollers M.)
hoc et illoc quadrat (il granchio ha una doppia vita, anche Trimalchione è nato in una condizione
poi si è adattato in un’altra)
LEO (Giove e Cibele)
cataphagae (ghiottoni e scialacquatori)
et imperiosi (sotto questo segno nascono i dominatori e i re)
VIRGO (Cerere)
mulieres (molles viri, muliebrium artium studiis dediti F.M.)
et fugitivi (schiavi fuggitivi)
et compediti (la vergine è rappresentata con i piedi legati, si allude al termine “nodi” con cui si
chiamavano gli equinozi e i solstizi)
LIBRA (Vulcano)
sotto questo segno avviene la fondazione di Roma
laniones (macellai – habebunt actus de mensuriis et ponderibus F.M.)
unguentarii (profumieri)
et quicumque aliquid expediunt (quelli che se la sanno sbrogliare)
SCORPIO (Marte)
nihil fere bonum est in eo signo et magis valet ad faciendum malum quam bonum
venenarii (pugnax Mavorti scorpios haeret M.)
et pecussores (ad neces hominum venena vendentes F. M.)
SAGITTARIUS (Diana)
82
strabones (vitium habebunt in oculo F.M.)
et qui holera spectant lardum tollunt (erit fur, periurus, malivolus, malignus F.M.)
CAPRICORNUS (angusta fovet capricorni siderea Vesta M.)
aerumnosi (dediti ai lavori pesanti e perciò disgraziati)
quibus prae mala sua cornua nascuntur (erunt etiam maximis infelicitatibus demersi F.M.)
AQUARIUS (Giunone)
copones (osti, e tutti i lavori legati all’acqua)
et cucurbitae (zucca o uomo inetto o ubriaconi, pieno di acqua e di vino)
PISCES (Nettuno)
obsonatores (chi prepara cibi elaborati, piscator freneticus)
et rhetores (erit orator, advocatus, affluentia docti sermonis ornatus F.M.)
il binomio poggia sul concetto dell’irretire e dell’adescare in senso concreto e metaforico
L’immagine dell’uomo “zodiacale” si basa sulla medicina astrologica o melothesia, codificata da
Manilio; secondo costui ad ogni parte del corpo era assegnato un determinato segno dello
zodiaco. La salute dipendeva dall’influsso degli astri e le malattie erano curate attraverso la
consultazione delle stelle e delle influenze di quest’ultime.
Inserire foto oroscopo Limbourg
DENTRO IL PROBLEMA
IL SATYRICON DI FELLINI
Il film con la regia e la sceneggiatura di Federico Fellini, viene girato e distribuito nelle sale
cinematografiche nel 1969 e, come dice la locandina dell’epoca, è liberamente tratto dal testo di
Petronio Arbitro.
Siamo in anni molto densi di rinnovamento sociale e culturale, ma il regista vuole riproporre un
“classico”, che ha molto poco di un tipico componimento dell’antichità latina, anzi è piuttosto
un’opera che non esiteremmo a definire anticonformista. Non a caso il film fu rappresentato in
anteprima all’American Square Garden subito dopo un concerto rock cui assistettero diecimila
giovani hippy: la proiezione, come ricorda Fellini stesso in varie interviste, fu entusiasmante;
sembrava che i fotogrammi riflettessero ciò che era accaduto poco prima fra i giovani presenti,
evidentemente il Satyricon aveva trovato il suo contesto, la sua collocazione ed il suo pubblico.
Federico Fellini, come chiarirà lui stesso in una intervista a Grazzini di seguito riportata, decide,
dopo una rilettura durante una convalescenza, di trasferire sullo schermo uno dei testi più
enigmatici del mondo antico, per di più incompleto e lacunoso: proprio questo è il fascino che il
regista trova nel romanzo, il senso del non finito e del mistero che consente il volo della fantasia. In
un’intervista a Moravia, riportata nel luglio del ’69 dalla rivista Vogue, Fellini racconta che per lui
l’opera è la trasposizione di un sogno e che il film si basava su tale aspetto onirico nel passaggio
repentino ed alogico da una scena all’altra, nella deformazione grottesca degli uomini e nella
totale assenza di spazio e tempo.
Il film si apre con una sorta di babele linguistica e un intreccio labirintico di salite in una
pressoché totale oscurità: in questo non-luogo vagano come anime in pena Encolpio, Gitone ed
Ascilto, quasi brancolanti e perduti. Attraverso dissolvenze in nero si passa alle scene successive,
tecnica riscontrabile nel romanzo stesso con le sue cesure ed i repentini cambiamenti addirittura
stilistici (non dimentichiamo la presenza di versi nell’opera petroniana). Nella Cena, Fellini, ma
83
soprattutto il geniale scenografo e costumista Danilo Donati, si sbizzarriscono, creando, più che
personaggi, grottesche figure della fantasia, vicine ad un Inferno dantesco o ad un quadro di
Broegel. La deformazione onirica è qui evidente, soprattutto nella rappresentazione caricaturale
ed ossessiva dei personaggi femminili. Per la Cena, il regista si affidò ad attori presi dalla
strada, in particolare Trimalchione fu interpretato dal gestore di un noto ristorante di Trastevere, in
modo tale che rappresentasse, più che altro, se stesso. Troviamo quindi elementi di realismo fusi, o
piuttosto confusi con tratti fantastici. Trimalchione parla con un forte accento meridionale,
mentre per il doppiaggio delle parti in latino che abbondano nel film, si ricorse ad attori tedeschi in
quanto la loro era una pronuncia scientifica con le consonanti dure, forse più vicina al greco. Fellini
introdusse non poche novità nel testo petroniano, come sempre accade nelle trasposizioni
cinematografiche. Tra le tante si segnala quella del suicidio “stoico” dei due coniugi che ricorda i
brani di Tacito su Petronio stesso e su Seneca e la moglie Paolina. La scena si svolge in
un’atmosfera rarefatta e luminosa in una domus romana in cui tutto è pace e che contrasta con il
caos assordante e agghiacciante che domina gran parte del film.
La scelta di Fellini fu senza dubbio coraggiosa, non solo per l’epoca in cui il film fu proposto, ma
anche perché il pubblico era abituato ai kolossal americani che riproducevano un mondo romano
enfatico e roboante senza alcun supporto scientifico. Era lo stereotipo dell’antica Roma che già
l’opera di Petronio e più ancora la rilettura felliniana contribuirono a sfatare, leggendola come
epoca di angoscia e di paure. Sintomatico è che negli stessi anni un altro grande regista, Pier
Paolo Pasolini, compiva un’operazione analoga partendo da testi classici, per le tragedie greche.
Le parole di Fellini nell’intervista concessa a Grazzini:
Convalescente a Manziana, nella bibliotechina di una pensione, mi capitò in mano Petronio: tornai
a provare una grande emozione. Mi fece pensare alle colonne, alle teste, agli occhi mancanti, ai
nasi spezzati, a tutta la scenografia cemiteriale dell’Appia Antica o in generale ai musei
archeologici. Sparsi frammenti, brandelli riaffioranti di quello che poteva essere anche considerato
un sogno, in gran parte rimosso e dimenticato. Non un’epoca storica filologicamente riscontrabile
sui documenti, positivisticamente accertata, ma una grande galassia onirica, affondata nel buio, fra
lo sfavillio di schegge fluttuanti, galleggianti fino a noi. Mi pare di essere stato sedotto
dall’occasione di ricostruire questo sogno, la sua trasparenza enigmatica, la sua chiarezza
indecifrabile.
DENTRO IL PROBLEMA
I profumi in Petronio e in Marziale
Petronio, Satyricon, 76
Oneravi rursus vinum, lardum, fabam, seplasium, mancipia. Hoc loco Fortunata rem piam fecit:
omne enim aurum suum, omnia vestimenta vendidit et mi centum aureos in manu posuit. Hoc fuit
peculii mei fermentum. Cito fit quod di volunt.
Nel cap. 76 Trimalchione cita il seplasium, dicendo che l’origine della sua fortuna è dovuta al
trasporto di questo profumo venduto a Capua dai seplasarii (profumieri) nella piazza del mercato.
Il profumo era molto usato e considerato un bene di consumo associato alla cura del corpo.
Troviamo anche il termine unguentum, usato prima del bagno e per lavarsi le mani prima di sedersi
a tavola (cfr. cap. 78 unguento perfusus, nel 47 unguento manus lavit); nella sceneggiata
organizzata da Trimalchione per la sua morte, costui si fa portare un profumo che servirà a lavare le
sue ossa (cfr. 77 profer et unguentum et ex illa amphora gostum ex qua iubeo lavari ossa mea).
84
Nel cap. 78 cosparge tutti quelli che sono venuti al suo funerale con del nardo (statim ampullam
nardi aperuit omnesque nos unxit); tale sostanza profumata molto ricercata veniva dall’ India. Nel
cap. 60 troviamo coronae aurae cum alabastris unguenti: si tratta di una specie di apophoreta
legato alla sorte, che ha un valore di ricompensa o premio, i flaconi di alabastro potevano essere
riempiti di oli profumati, come avveniva nelle gare atletiche.
Durante la commissatio, il momento della sera in cui i convitati si dedicano al piacere del bere e del
chiacchierare, gli odori naturali ed artificiali perdono la loro ragione di essere. Qui si inserisce il
ritratto del marmista Abinna ormai ubriaco (cfr. 65 oneratus aliquot coronis et unguento per
frontem in oculos fluente). Tale figura ricorda quella di Alcibiade nel Simposio platonico, quando fa
irruzione, ebbro e coronato di fiori, presso Agatone (Plat., Simposio, 212e-213a), ma una distanza
incolmabile separa l’ateniese, che con grazia onora il talento e la saggezza, dal lapidarius, nato in
Cappadocia, in cui tutto è eccessivo e bestiale. Dunque gli invitati di Trimalchione sono gratificati
di corone e di ampolle preziose, l’ospite ricerca l’inaudito, il mai visto, come nel capitolo 60 in cui
si legge inaudito enim more…unguentum in argentea pelve pedesque recumbentium unxerunt. Una
buona quantità dello stesso profumo egli fa versare nel vaso del vino e nella lucerna (cap. 70), cui
segue il massaggio che ha un valore rigenerante ed afrodisiaco. Da notare la quantità sproporzionata
del profumo che riempie un grande bacino, segno di un lusso ostentato e di una totale indifferenza
alla qualità.
Sull’uso dei profumi non abbiamo molte testimonianze letterarie, ma basta ricordare il carme 13 di
Catullo per capirne l’importanza. Marziale ci riferisce dei profumieri Cosmo e Nicerote:
Marziale, Epigrammi, XII, 65
Formosa Phyllis nocte cum mihi tota
Se praestitisset omnibus modis largam,
Et cogitarem mane quod darem munus,
Utrumne Cosmi, Nicerotis an libram,
An Baeticarum pondus acre lanarum,
An de moneta Caesaris decem flavos:
Amplexa collum basioque tam longo
Blandita, quam sunt nuptiae columbarum,
Rogare coepit Phyllis amphoram vini.
5
La bella Fillide era giaciuta con me per tutta la notte in mille modi diversi; la mattina seguente
pensavo al regalo da farle, o una libbra di profumo di Cosmo o di Nicerote, o una discreta
quantità di lana Andalusa, o dieci monete d’oro dalla zecca di Cesare: ma Fillide, dopo avermi
abbracciato il collo e blandito con un bacio lungo come quelli dei piccioni, ha cominciato a
chiedermi un’anfora di vino.
Per la maggior parte dei casi gli autori antichi hanno commentato negativamente l’utilizzo dei
profumi, considerandoli superflui, anche perché se ne faceva un uso smodato; venivano comunque
usati come mezzo di seduzione, come ci riferisce Giovenale (Sat. VI, 457-473). L’opinione
negativa era accentuata dall’uso eccessivo che ne facevano le prostitute, adoperando oltre tutto un
profumo a buon mercato. Interessante la testimonianza di Plutarco (Moralia, IX, 990b) che rimane
scandalizzato dall’uso dei profumi anche per gli uomini, in quanto si tratta di qualcosa di caro,
inutile e riservato, semmai, alle ragazze. Plinio racconta (Nat. hist. XIII, 22-23) aneddoti sugli
uomini importanti che utilizzavano profumi ed annovera fra questi anche Nerone e Caligola.
85
DENTRO IL TESTO
A Roma non si riesce a dormire
Marziale, Epigrammi, XII, 57
Cur saepe sicci parva rura Nomenti
Laremque villae sordidum petam, quaeris?
Nec cogitandi, Sparse, nec quiescendi
In urbe locus est pauperi. Negant vitam
Ludi magistri mane, nocte pistores,
Aerariorum marculi die toto;
Hinc otiosus sordidam quatit mensam
Neroniana nummularius massa,
Illinc balucis malleator Hispanae
Tritum nitenti fuste verberat saxum;
Nec turba cessat entheata Bellonae,
Nec fasciato naufragus loquax trunco,
A matre doctus nec rogare Iudaeus,
Nec sulphuratae lippus institor mercis.
Numerare pigri damna quis potest somni?
Dicet quot aera verberent manus urbis,
Cum secta Colcho Luna vapulat rhombo.
Tu, Sparse, nescis ista, nec potes scire,
Petilianis delicatus in regnis,
Cui plana summos despicit domus montis,
Et rus in urbe est vinitorque Romanus
Nec in Falerno colle maior autumnus,
Intraque limen latus essedo cursus,
Et in profundo somnus, et quies nullis
Offensa linguis, nec dies nisi admissus.
Nos transeuntis risus excitat turbae,
Et ad cubilest Roma. Taedio fessis
Dormire quotiens libuit, imus ad villam.
5
10
15
20
25
Mi chiedi perchè vado spesso nei poveri campi dell’arida Nomento, nel misero focolare della mia
casa. O Sparso, a Roma un povero non può né pensare né dormire. Di mattina gl’impediscono di
vivere i maestri, di notte i fornai e per tutto il giorno i martelli dei fabbri: da una parte un pigro
cambiavalute fa risuonare sul suo tavolo le monete di Nerone, dall’altra parte un battitore d’oro
spagnolo colpisce la logora moneta con un lucente bastone. Neppure smette di gridare la folla che
esalta Bellona, né il naufrago con il corpo coperto di fasce, né il giudeo che ha appreso dalla
madre a chiedere l’elemosina, né l’ambulante cisposo che vende gli zolfanelli. Chi potrebbe
contare i danni provocati dalla perdita del sonno? Chi conosce quante sono le mani che
percuotono il bronzo a Roma, quando la ruota di Medea colpisce la luna con l’eclisse. Tu, o
Sparso, non sai queste cose, non le puoi sapere perché sei nel regno di Petilio, tu guardi le cime
dei monti dalla tua casa, hai un podere in città ed un vignaiolo romano dove l’autunno dura di
86
più che sul Falerno. Nella tua casa c’è un passaggio largo per i carri e nella parte più interna c’è
il sonno e un silenzio che le lingue non turbano e dove la luce del giorno entra solo se invitata. Le
risate della folla che passa mi svegliano, tutta Roma sta presso il mio letto. Quando stanco del
rumore voglio dormire, me ne vado in campagna.
Marziale spiega all’amico Sparso perché si rechi così spesso nel suo podere di Nomentum, che pure
offre molto poco. Il problema è che a Roma non si riesce a dormire, soprattutto quando si è
costretti a vivere in centro in una casetta misera e non si riesce a trovare un momento di pace per
tutto il rumore che c’è.
Per mettere in luce la povertà del podere il poeta ricorre a tre aggettivi: siccus, parvus e sordidum
in linea con la poesia satirica e di invettiva, vuole rendere la concretezza della sua condizione
misera. Questa viene accentuata dal rivolgersi all’interlocutore, che invece vive fuori città in
tutt’altra situazione. Segue l’elenco di tutti coloro che esercitano attività, per così dire, rumorose tra
cui alcune sono giustificate, come i pistores che lavorano di notte perché il pane deve essere venduto
l’indomani mattina; segue l’immagine del nummularius, il cambiavalute che, tanto per passare il
tempo in attesa di un cliente, maneggia i mucchi di monete che ha sul banco, questo rumore
infastidisce il poeta. Non mancano poi i vari cialtroni e i falsi mendicanti, tra i quali un tale che
esibisce un pezzo di legno facendolo passare per un frammento superstite di una nave naufragata, il
mendicante lo porta al collo come prova della sua sventura. Molti ricorrono poi ad ogni tipo di
sortilegio, alcuni dei quali sono piuttosto “sonori”: a tale proposito Marziale riporta quello secondo
cui per far cessare l’eclissi, segno di cattivo augurio, bisognava far rumore picchiando su recipienti
di rame o altri oggetti di metallo. Rispetto a questa situazione insostenibile vi è la netta
contrapposizione: “tu, Sparse, nescis ista”, l’amico non conosce questi tormenti e non può averne
nemmeno un’idea, vivendo in un luogo lontano dal centro della città. Nella seconda parte
dell’epigramma ai toni concitati e alle descrizioni crudamente realistiche si sostituisce un tono
pacato con l’uso di somnus e quies; gli ultimi versi invece ritornano al tema che ha ispirato il
componimento con una metafora ardita ma efficace “ad cubile est Roma”: è tanto il chiasso che
proviene dal di fuori che al poeta sembra di avere tutta Roma in capo al letto, non resta che ritirarsi
nella casa di campagna ormai stremati.
Roma invivibile e piena di ciarlatani e di chiasso fu narrata anche dal poeta Giovenale,
evidentemente era un tema molto attuale e le lamentele frequenti fornirono spunti ai poeti satirici: un
amico del poeta, tale Umbricio, vuole stabilirsi a Cuma. Ciò rattrista il Nostro che condivide però la
scelta. Tutto è preferibile al caos di Roma e soprattutto ad un luogo tanto pieno di pericoli ed insidie
come la Suburra, dove scoppiano incendi e, cosa ancora più nefasta, non si può sfuggire alle
declamazioni dei poetastri.
Giovenale, Satire, III, 1-9
87
Quamvis digressu veteris confusus amici
laudo tamen, vacuis quod sedem figere Cumis
destinet atque unum civem donare Sibyllae.
Ianua Baiarum est et gratum litus amoeni
secessus. Ego vel Prochytam praepono Suburae;
nam quid tam miserum, tam solum vidimus, ut non
deterius credas horrere incendia, lapsus
tectorum adsiduos ac mille pericula saevae
urbis et Augusto recitantes mense poetas?
5
Anche se la partenza di un vecchio amico mi angoscia, devo approvare la sua decisione di
stabilirsi come un eremita a Cuma e di donare almeno un cittadino alla Sibilla. Cuma, porta di
Baia, è un piacevole approdo, un rifugio delizioso. Poi io alla Suburra preferirei persino Procida.
Si è mai visto un luogo, per quanto misero, desolato, che non sia preferibile al terrore continuo
degli incendi, dei crolli frequenti dei tetti, ai mille pericoli di questa città tremenda, dove nemmeno
in pieno Agosto sfuggi al vociare dei poeti?
DENTRO IL PROBLEMA
ANNIBALE
La figura di Annibale ha sempre affascinato gli storici: stratega abilissimo, tanto che la sua tattica
nella battaglia di Canne è ancora oggetto di studio nelle scuole di guerra, uomo solo, senza figli, né
amori, né amici è un eroe spietato e crudele che fa tremare Roma.
Il suo ritratto è presente anche nelle storie di Nepote e Livio, ma la complessità della personalità del
Cartaginese riceve diverse tinteggiature nel bene e nel male. Per quanto riguarda i difetti una forte
analogia si riscontra in Silio Italico con la narrazione di Livio, mentre per quanto riguarda l’odio
inestinguibile contro i Romani tutti e tre gli autori concordano.
C. Nepote, De viris illustribus,
III De excellentibus ducibus exterarum gentium,
XXIII Hannibal,1-3
1. Hannibal, Hamilcaris filius, Carthaginiensis. Si verum est, quod nemo dubitat, ut populus
Romanus omnes gentes virtute superarit, non est infitiandum Hannibalem tanto praestitisse ceteros
imperatores prudentia, quanto populus Romanus antecedat fortitudine cunctas nationes. 2. Nam
quotienscumque cum eo congressus est in Italia, semper discessit superior. Quod nisi domi civium
suorum invidia debilitatus esset, Romanos videtur superare potuisse. Sed multorum obtrectatio
devicit unius virtutem. 3. Hic autem velut hereditate relictum odium paternum erga Romanos sic
conservavit, ut prius animam quam id deposuerit, qui quidem, cum patria pulsus esset et alienarum
opum indigeret, numquam destiterit animo bellare cum Romanis.
Il cartaginese Annibale era figlio d’Amilcare. Se è vero, cosa di cui nessuno dubita, che il popolo
romano ha superato in valore tutte le genti, non si può negare che Annibale abbia superato tanto
gli altri condottieri in saggezza quanto il popolo romano eccelle in forza su tutti. Infatti, tutte le
volte che Annibale si scontrò in Italia col popolo romano, sempre fu vincitore; se non fosse stato
ostacolato in patria dall’invidia dei suoi concittadini, sembra che avrebbe potuto superare i
Romani. Ma il discredito di molti ebbe la meglio sul valore di uno solo. Conservò l’odio contro i
Romani, trasmessogli dal padre come in eredità, a tal punto che avrebbe abbandonato prima la
88
vita che quest’animosità, lui che certamente bandito dalla patria, bisognoso della protezione degli
altri, non cessò mai di combattere con lo spirito contro i Romani.
Anche un personaggio come Annibale è esaltato perché coerente e teso a realizzare l’unico
scopo della sua vita, la distruzione di Roma e, pur essendo nemico, merita il rispetto, così com’è da
biasimare l’invidia miope dei concittadini.
Livio, Ab Urbe condita, XXI, 4
4. Missus Hannibal in Hispaniam primo statim adventu omnem exercitum in se convertit;
Hamilcarem iuvenem redditum sibi veteres milites credere; eundem vigorem in voltu vimque in
oculis, habitum oris lineamentaque intueri. Dein brevi effecit ut pater in se minimum momentum ad
favorem conciliandum esset. Nunquam ingenium idem ad res diversissimas, parendum atque
imperandum, habilius fuit. Itaque haud facile discerneres utrum imperatori an exercitui carior
esset; neque Hasdrubal alium quemquam praeficere malle ubi quid fortiter ac strenue agendum
esset, neque milites alio duce plus confidere aut audere. Plurimum audaciae ad pericula
capessenda, plurimum consilii inter ipsa pericula erat. Nullo labore aut corpus fatigari aut animus
vinci poterat. Caloris ac frigoris patientia par; cibi potionisque desiderio naturali, non voluptate
modus finitus; vigiliarum somnique nec die nec nocte discriminata tempora; id quod gerendis rebus
superesset quieti datum; ea neque molli strato neque silentio accersita; multi saepe militari sagulo
opertum humi iacentem inter custodias stationesque militum conspexerunt. Vestitus nihil inter
aequales excellens: arma atque equi conspiciebantur. Equitum peditumque idem longe primus erat;
princeps in proelium ibat, ultimus conserto proelio excedebat. Has tantas viri virtutes ingentia vitia
aequabant, inhumana crudelitas, perfidia plus quam Punica, nihil veri, nihil sancti, nullus deum
metus, nullum ius iurandum, nulla religio. Cum hac indole virtutum atque vitiorum triennio sub
Hasdrubale imperatore meruit, nulla re quae agenda videndaque magno futuro duci esset
praetermissa.
Annibale, giunto in Spagna, al suo arrivo portò dalla sua parte tutto l’esercito; i veterani
credevano che addirittura fosse restituito loro Amilcare giovane e in lui videro la stessa forza nel
volto e il piglio negli occhi, la stessa espressione del viso e i lineamenti. In breve tempo egli fece
sì che la somiglianza con il padre fosse il minore dei motivi che gli conciliavano il favore dei
soldati. Mai uno stesso ingegno fu più adatto ad attività opposte, come l’obbedire ed il
comandare. Così non potresti facilmente distinguere se fosse più caro al comandante o
all’esercito; né Asdrubale gli preferiva qualcun altro, quando fosse necessario agire con vigore e
con coraggio, né i soldati erano più pieni di fiducia e d’ardore sotto un altro comandante. Era
pieno d’audacia nell’affrontare i pericoli, e in mezzo a questi sapeva prendere la giusta
decisione. Il corpo e l’animo non potevano essere schiacciati o abbattuti da nessuna fatica.
Sopportava parimenti il caldo e il freddo; nel mangiare e nel bere si regolava non in base al
piacere, ma alla necessità naturale. Le ore delle veglie e del sonno non erano da lui collocate di
giorno o di notte: si concedeva al riposo quando gli avanzava tempo dal servizio, tale riposo non
era su un molle giaciglio e neppure nel silenzio, molti, infatti, lo videro che giaceva sulla nuda
terra coperto da un mantello militare, tra i corpi di guardia e le sentinelle. Nel vestire non
eccelleva rispetto ai suoi coetanei, si distinguevano le sue armi e i suoi cavalli. Era di gran lunga
il primo tra i cavalieri e tra i fanti, per primo attaccava battaglia, per ultimo se n’andava una
volta che il combattimento era finito. Queste sue così grandi virtù erano però bilanciate da
enormi vizi: crudeltà disumana, perfidia più che cartaginese, non aveva nessun rispetto per il
vero, per il sacro, né per gli dei, nessuna fede nel giuramento, nessuno scrupolo religioso. Con
questa natura mista di virtù e di vizi militò per tre anni al comando d’Asdrubale, senza trascurare
mai ciò che un futuro grande condottiero doveva fare ed osservare.
89
Annibale è dipinto in ogni sfumatura, sia nei suoi aspetti esteriori, che in quelli interiori per
enfatizzare le capacità del condottiero nel bene e nel male. Si osservi, ad esempio, tra i suoi vizi una
perfidia plus quam Punica e una mancanza d’ogni remora morale, dopo che erano state attribuite
doti tipicamente “romane” al Cartaginese. La descrizione è quindi precisa e pittorica.
DENTRO IL PROBLEMA
LA SATIRA SESTA DI GIOVENALE
La sesta satira costituisce da sola il secondo dei cinque libri in cui si sogliono dividere le satire. È
dedicata all’amico Ursidio Postumo, che era sul punto di sposarsi: è uno spietato quadro dei
difetti delle donne e dei fastidi del matrimonio. Si può dividere in tre parti:
un proemio con la trattazione delle mitiche età dell’uomo (cfr. vv. 23-24: Omne aliud
crimen mox ferrea protulit aetas: / viderunt primos argentea saecula moechos), l’immagine
della moglie ideale, basata sui concetti di pudicitia e paupertas, ed i consigli a Postumo (vv. 137);
una parte centrale che dà la motivazione ideologica della corruzione dei tempi e della
donna a causa della libido e della luxuria (vv. 38-626);
un epilogo in cui il crescendo culmina con l’immagine della possibile uccisione del marito
da parte della moglie con il veleno, ma, se ciò non riuscisse, addirittura con il ferro; chiude
l’opera la suggestiva immagine di Clitennestra che stigmatizza il pessimismo dell’autore
sull’argomento (vv. 627-661).
Il mito dell’età dell’oro e la presenza della dea Pudicitia in terra sono rievocati come cornice e
premessa del buon tempo antico per le virtù considerate la base della società e della famiglia. La
figura della rustica moglie ideale è quella di una donna tutta intenta ad allevare la prole.
Giovenale, Satira, II, 6, 1 - 10.
Credo Pudicitiam Saturno rege moratam
in terris visamque diu, cum frigida parvas
praeberet spelunca domos ignemque laremque
et pecus et dominos communi clauderet umbra,
silvestrem montana torum cum sterneret uxor
frondibus et culmo vicinarumque ferarum
pellibus, haut similis tibi, Cynthia, nec tibi, cuius
turbavit nitidos extinctus passer ocellos,
sed potanda ferens infantibus ubera magnis
et saepe horridior glandem ructante marito.
5
10
Sono convinto che la Pudicizia avesse dimorato in terra durante il regno di Saturno e vi si fosse
fatta vedere a lungo, quando una gelida caverna offriva un modesto rifugio e ospitava sotto una
comune ombra il focolare, il Lare, le bestie ed i padroni, quando una moglie montanara
preparava un letto rozzo con fronde e paglia e con le pelli delle bestie vicine, non certo simile a te
Cinzia, né a te i cui begli occhi turbò il passero morto, ma offrendo i seni da succhiare ai robusti
figli e spesso più sciatta del marito che ruttava per le ghiande.
Le due dee sorelle, la Pudicizia e la Giustizia (la vergine Astrea), finirono per fuggire dal mondo
già durante il regno di Giove.
90
Multa Pudicitiae veteris vestigia forsan
aut aliqua exstiterint et sub Iove, sed Iove nondum
barbato, nondum Graecis iurare paratis
per caput alterius, cum furem nemo timeret
caulibus ac pomis et aperto viveret horto.
Paulatim deinde ad superos Astraea recessit
hac comite, atque duae pariter fugere sorores.
15
20
Forse molti segni dell’antica Pudicizia almeno in parte rimasero sotto il regno di Giove, ma di un
Giove ancor fanciullo, quando i Greci ancora non erano pronti a giurare sul capo altrui, quando
nessuno temeva il ladro per i cavoli ed i pomi e viveva con il recinto dell’orto spalancato. A poco
a poco la Giustizia poi si rifugiò fra gli dei con la Pudicizia come compagna e le due sorelle
fuggirono insieme.
Postumo vuole sposarsi per i vantaggi della legge Iulia (la Lex Iulia de maritandis ordinibus era
la prima delle leggi di Augusto in favore del matrimonio per il risanamento dei costumi, sanciva
l’obbligo del matrimonio; per essa solo se si avevano figli si poteva avere il diritto di ereditare) e
quindi ora antiquis uxor de moribus illi quaeritur. Che mai gli passa per la testa? Sarebbe meglio il
suicidio, oppure cercare le grazie di un fanciullo.
… Uxorem, Postume, ducis?
Dic qua Tisiphone, quibus exagitere colubris ?
Ferre potes dominam salvis tot restibus ullam,
cum pateant altae caligantesque fenestrae,
cum tibi vicinum se praebeat Aemilius pons?
Aut si de multis nullus placet exitus, illud
nonne putas melius, quod tecum pusio dormit?
Pusio, qui noctu non litigat, exigit a te
nulla iacens illic munuscula, nec queritur quod
et lateri parcas nec quantum iussit anheles.
Sed placet Ursidio lex Iulia: tollere dulcem
cogitat heredem, cariturus turture magno
mullorumque iubis et captatore macello.
Quid fieri non posse putes, si iungitur ulla
Ursidio? Si moechorum notissimus olim
stulta maritali iam porrigit ora capistro,
quem totiens texit perituri cista Latini?
30
35
40
Ti vuoi sposare, Postumo? Dimmi quale Tisifone, o quali serpenti ti sconvolgon la mente? Puoi
sopportare una padrona con tante corde disponibili per impiccarsi, quando ci sono tante finestre
alte e vertiginose, quando ti è così vicino il ponte Emilio? Se fra tutte queste soluzioni nessuna ti
piace, non pensi sia meglio se fai dormire con te un fanciullo che di notte non litiga, che non
pretende regali per il fatto di giacerti vicino, che non si lamenta se ti risparmi i fianchi e se non ti
affanni dietro a ciò che ordina? Ma ad Ursidio piace la legge Iulia: già pensa di sollevare fra le
braccia un dolce erede, rinunciando alle grosse tortore, alle triglie barbute e al mercato che lo
seduce. Pensi che ciò non possa accadere se qualcuna sposa Ursidio? Se un notissimo adultero di
una volta ormai porge la stolta testa al capestro matrimoniale, lui che tante volte si nascose nella
cesta di Latino perchè era nei guai?
Eppia ha lasciato il marito senatore ed i figli per correre dietro ad un gladiatore.
91
Nupta senatori comitata est Eppia ludum
ad Pharon et Nilum famosaque moenia Lagi
prodigia et mores urbis damnante Canopo.
Inmemor illa domus et coniugis atque sororis
85
nil patriae indulsit, plorantisque improba natos
utque magis stupeas ludos Paridemque reliquit.
Sed quamquam in magnis opibus plumaque paterna
et segmentatis dormisset parvula cunis,
contempsit pelagus; famam contempserat olim,
90
cuius apud molles minima est iactura cathedras.
Tyrrhenos igitur fluctus lateque sonantem
pertulit Ionium constanti pectore, quamvis
mutandum totiens esset mare. Iusta pericli
si ratio est et honesta, timent pavidoque gelantur
95
pectore nec tremulis possunt insistere plantis:
fortem animum praestant rebus quas turpiter audent.
Si iubeat coniunx, durum est conscendere navem,
tunc sentina gravis, tunc summus vertitur aer:
quae moechum sequitur, stomacho valet. Illa maritum 100
convomit, haec inter nautas et prandet et errat
per puppem et duros gaudet tractare rudentis.
Qua tamen exarsit forma, qua capta iuventa
Eppia? Quid vidit propter quod ludia dici
sustinuit? Nam Sergiolus iam radere guttur
105
coeperat et secto requiem sperare lacerto;
praeterea multa in facie deformia, sicut
attritus galea mediisque in naribus ingens
gibbus et acre malum semper stillantis ocelli.
Sed gladiator erat. Facit hoc illos Hyacinthos;
110
hoc pueris patriaeque, hoc praetulit illa sorori
atque viro. Ferrum est quod amant. Hic Sergius idem
accepta rude coepisset Veiiento videri.
Moglie di un senatore Eppia seguì una squadra di gladiatori sino a Faro, al Nilo ed alle
famigerate mura della città di Lago, pur condannando la stessa Canopo le prodigiose
scostumatezze di Roma. Immemore della casa, del marito e della sorella nulla concesse alla
patria e abbandonò, snaturata, i figli piangenti e, per il tuo stupore, anche l’attore Paride ed i
giochi. Sebbene da piccola avesse dormito fra le ricchezze e le piume del padre ed in culle
intarsiate, disprezzò i pericoli del mare; già da tempo del resto aveva disprezzato la sua
reputazione, che però nei salotti eleganti è cosa da poco. Quindi affrontò le onde del Tirreno e lo
Ionio urlante con animo fermo, sebbene spesso si dovesse cambiare mare. Di fronte ad un
pericolo se la causa è onesta hanno paura e si gela loro il cuore nel petto e non possono stare in
piedi; mostrano invece un animo indomito nelle cose vergognose. Se lo ordina il marito è faticoso
imbarcarsi, la sentina è fastidiosa, il cielo gira tutt’intorno. Chi segue l’amante invece ha uno
stomaco forte. Quella vomita addosso al marito, questa mangia fra i marinai, gira per la nave e
gode a toccare le ruvide gomene. Ma Eppia si è innamorata di una bellezza, di un giovanotto?
Che ha visto di tanto attraente da sopportare di essere detta “la gladiatora”? Infatti il suo
Sergiolino si cominciava a radere per l’età, sperava nella pensione per il braccio rotto; del resto
parecchi erano i difetti nel volto, l’escoriazione per l’elmo, un porro nel naso e un occhio malato
che colava di continuo. Ma era un gladiatore, perciò era bello come Giacinto e questo ella
92
antepose alla patria, ai figli, alla sorella ed al marito. Ama la spada, ma una volta che Sergio
avrà ricevuto il bastone comincerà a somigliare al marito Veiento.
Altro celebre esempio è Messalina, la moglie dell’imperatore Claudio.
Quid privata domus, quid fecerit Eppia, curas?
Respice rivales divorum, Claudius audi
quae tulerit. Dormire virum cum senserat uxor,
sumere nocturnos meretrix Augusta cucullos
ausa Palatino et tegetem praeferre cubili
linquebat comite ancilla non amplius una.
Sed nigrum flavo crinem abscondente galero
intravit calidum veteri centone lupanar
et cellam vacuam atque suam; tunc nuda papillis
prostitit auratis titulum mentita Lyciscae
ostenditque tuum, generose Britannice, ventrem.
Excepit blanda intrantis atque aera poposcit.
Continueque iacens cunctorum absorbuit ictus.
Mox lenone suas iam dimittente puellas
tristis abit, et quod potuit tamen ultima cellam
clausit, adhuc ardens rigidae tentigine volvae,
et lassata viris necdum satiata recessit,
obscurisque genis turpis fumoque lucernae
foeda lupanaris tulit ad pulvinar odorem.
115
120
125
130
Non preoccuparti delle case private, di quello che fece Eppia, guarda ai rivali degli dei, ascolta
cosa sopportò Claudio. Quando la moglie capiva che il marito si era addormentato, l’Augusta
meretrice osava indossare un cappuccio notturno e preferire una stuoia al letto imperiale e se ne
andava accompagnata da una sola ancella. Nascondeva i neri capelli con una parrucca bionda
ed entrava in un lupanare riparato da una vecchia tenda e in una cameretta solo per lei. Allora
nuda, sotto lo pseudonimo di Licisca, con le mammelle indorate, si prostituiva e mostrava il
ventre che ti portò, o nobile Britannico. Accoglieva con moine i clienti e chiedeva il denaro.
Giaceva in continuazione, sostenendo l’impeto di ognuno. E quando il lenone licenziava le sue
ragazze, afflitta se ne andava, chiudeva per ultima la stanzetta, almeno quello lo ha ottenuto,
ancora ardente per la tensione del rigido utero, e, stanca dei maschi, ma non ancora sazia, si
ritirava e turpe, con gli occhi pesti e sozza del fumo della lucerna, portava l’odore del lupanare al
talamo.
Segue la descrizione della suocera, origine di tutti i mali!
Desperanda tibi salva concordia socru.
Illa docet spoliis nudi gaudere mariti,
Illa docet missis a corruptore tabellis
nil rude nec simplex rescribere, decipit illa
custodes aut aere domat. Tum corpore sano
advocat Archigenen onerosaque pallia iactat,
abditus interea latet et secretus adulter
inpatiensque morae silet et praeputia ducit.
Scilicet expectas ut tradat mater honestos
atque alios mores quam quos habet? Utile porro
235
240
93
filiolam turpi vetulae producere turpem.
Non puoi sperare nella concordia se c’è la suocera! È lei che insegna a godere delle spoglie del
marito ridotto sul lastrico, lei insegna a rispondere a tono ai biglietti dell’amante, lei inganna i
custodi o li corrompe. Pur stando benissimo chiama il medico Archigene e getta via le coperte
eccessive, intanto l’adultero sta nascosto in un canto e, impaziente dell’indugio, sta zitto e arde.
Davvero credi che la madre le trasmetta costumi onesti, diversi dai suoi? Del resto è utile per una
vecchia corrotta allevare una figlia simile a lei.
La conclusione è sconsolata:
Semper habet lites alternaque iurgia lectus
in quo nupta iacet; minimum dormitur in illo.
268
Il letto dove giace la sposa accoglie sempre liti e insulti reciproci; lì si dorme pochissimo!
Il buon tempo antico era diverso:
Unde haec monstra tamen vel quo de fonte requiris?
Praestabat castas humilis fortuna Latinas
quondam, nec vitiis contingi parva sinebant
tecta labor somnique breves et vellere Tusco
vexatae duraeque manus ac proximus urbi
Hannibal et stantes Collina turre mariti.
Nunc patimur longae pacis mala, saevior armis
luxuria incubuit victumque ulciscitur orbem.
290
Chiedi da dove vengano questi eccessi o da che fonte? Una volta l’umile condizione rendeva
caste le donne latine e il lavoro, i sonni brevi e le mani dure e segnate dalla lana etrusca non
permettevano che le piccole case fossero contaminate dai vizi ed anche Annibale vicino a Roma e
i mariti che vigilavano sulla torre Collina. Ora soffriamo i mali di una lunga pace e la lussuria,
peggiore delle guerre, imperversa e il mondo sottomesso si vendica.
I misteri della Bona Dea, riservati solo alle donne, si erano tramutati spesso in orge; Livio in
XXXIX, 8-19 ricorda i Baccanali del 168 a. C. che provocarono uno scandalo famoso, tanto che il
culto fu vietato con un senatus consultum.
Nota bonae secreta deae, cum tibia lumbos
incitat et cornu pariter vinoque feruntur
attonitae crinemque rotant ululantque Priapi
maenades. O quantus tunc illis mentibus ardor
concubitus, quae vox saltante libidine, quantus
ille meri veteris per crura madentia torrens!
315
…
tunc prurigo morae inpatiens, tum femina simplex
327
Sono noti i riti segreti della Bona Dea, quando il flauto eccita i lombi e le menadi di Priapo
invasate sono travolte sia dal vino che dal corno e roteano i capelli ed ululano. O che sfrenato
desiderio allora quelle menti hanno di giacersi, che voce esaltata dalla libidine, che quantità di
puro vino vecchio bagna loro le gambe! … Allora la libidine non sopporta attesa, allora la
donna si rivela qual è !
94
Famosa esclamazione di fronte alla lussuria che imperversa !
“Pone seram, prohibe!” Sed quis custodiet ipsos
custodes? Cauta est, et ab illis incipit uxor.
347
“Tienila chiusa, dille di no!” Ma chi custodirà gli stessi custodi? La fanciulla è furba e proprio
da questi comincia.
Tra le tipologie di donne vi è l’intellettuale:
Illa tamen gravior, quae cum discumbere coepit
laudat Vergilium, periturae ignoscit Elissae,
committit vates et comparat, inde Maronem
atque alia parte in trutina suspendit Homerum.
435
È però ancor più fastidiosa quella che appena si siede loda Virgilio, comprende Elissa in punto di
morte, raffronta e compara i poeti, quindi mette su un piatto della bilancia Marone e sull’altra
Omero.
C’è quella che ama i gioielli:
Nil non permittit mulier sibi, turpe putat nil,
cum viridis gemmas collo circumdedit et cum
auribus extentis magnos commisit elenchos.
Intolerabilius nihil est quam femina dives.
460
Nulla si nega, nulla reputa turpe una donna quando si mette al collo verdi gemme e affida ai lobi
tesi delle orecchie grosse perle. Nulla è più insopportabile di una donna ricca.
Nessuna vuole più partorire:
Hae tamen et partus subeunt discrimen et omnis
nutricis tolerant fortuna urguente labores,
sed iacet aurato vix ulla puerpera lecto.
594
Queste tuttavia affrontano la prova del parto e sopportano tutte le fatiche dell’allevare per
necessità di condizione, ma sui letti dorati non giace più quasi nessuna partoriente.
Il quadro finale è fosco, non solo si evoca Clitennestra, ma anche le Danaidi (citate col nome di
Belidi), Erifile e l’antidoto per il veleno che rese famoso Mitridate:
Occurrent multae tibi Belides atque Eriphylae
mane, Clytemestram nullus non vicus habebit.
Hoc tantum refert, quod Tyndaris illa bipennem
insulsam et fatuam dextra laevaque tenebat;
at nunc res agitur tenui pulmone rubetae,
sed tamen et ferro, si praegustarit Atrides
Pontica ter victi cautus medicamina regis.
655
660
95
Di mattina incontri molte Belidi ed Erifile, ogni vicolo ha la sua Clitennestra. Ma ascolta: la
Tindaride teneva con le due mani una bipenne stolta e volgare, ora invece l’affare si gestisce con
un piccolo polmone di rospo, ma non si esclude il ferro, se l’Atride prudente ha preso il
medicinale pontico del re tre volte vinto.
DENTRO IL PROBLEMA
LA DONNA TRA PROCREAZIONE E MISOGINIA
La donna, o meglio la matrona, nel mondo romano era vista in un’ottica tipicamente maschilista:
la sua funzione più importante era quella di essere mater, cioè di procreare figli per lo stato, poi di
filare la lana, di essere pudica e casalinga, e fedele al suo uomo. Queste prerogative spesso
l’hanno posta sotto una luce particolare, ora come “utero in affitto” ai vari personaggi che
necessitavano di prole, ora come lanifica, come domiseda ed univira.
I poeti satirici, da Lucilio a Orazio da Marziale a Persio e Giovenale, hanno trattato la donna come
oggetto preferito per criticare la società nuova che aveva perso i valori del buon tempo antico e,
quindi, come esempio di corruzione di costumi. La tradizione cristiana ha spesso interpretato e
rivissuto l’antica misoginia pagana.
Lucilio, Satire, Fr. 678 Marx:
Homines ipsi hanc sibi molestiam ultro atque aerumnam offerunt,
ducunt uxores, producunt quibus haec faciant liberos.
Gli uomini si procurano da soli fastidi e disgrazie, prendono moglie, fanno nascere figli per darsi
queste angosce.
Metello Numidico, censore nel 131 a. C., pronunciò un’orazione che riassume il pensiero romano
sulle donne: sì al matrimonio solo perché lo stato ha bisogno di figli.
Aulo Gellio, Noctes Atticae, I, 6
Verba ex oratione Metelli Numidici, quam dixit in censura ad populum, cum eum ad uxores
ducendas adhortaretur; eaque oratio quam ob causam reprehensa et quo contra modo defensa sit.
I. Multis et eruditis viris audientibus legebatur oratio Metelli Numidici, gravis ac diserti viri, quam
in censura dixit ad populum de ducendis uxoribus, cum eum ad matrimonia capessenda hortaretur.
II. In ea oratione ita scriptum fuit: "Si sine uxore possemus, Quirites, omnes ea molestia
careremus; set quoniam ita natura tradidit, ut nec cum illis satis commode, nec sine illis uno modo
vivi possit, saluti perpetuae potius quam brevi voluptati consulendum est."
Metello Numidico, durante la sua censura, pronunciò un famoso discorso al popolo per
convincerlo a prender moglie; quel discorso fu biasimato, ma anche difeso.
I. Di fronte ad un uditorio scelto e colto si leggeva l’orazione di Metello Numidico, uomo serio ed
erudito, che pronunciò al popolo durante la sua censura in relazione ai matrimoni, affinché lo si
esortasse a preder moglie. II. Così scrisse in quel discorso: “Se potessimo fare a meno delle
mogli, o Quiriti, ci priveremmo di una molestia. Ma poiché la natura ha così disposto che non si
può vivere abbastanza bene con esse, né senza di esse, bisogna pensare più al benessere futuro
che ad un breve piacere.
96
Varrone, Menippeae in Aulo Gellio, Noctes Atticae, I, 17, 4
IV. Secundum hanc sententiam M. quoque Varro in satura Menippea, quam de officio mariti
scripsit: "Vitium" inquit "uxoris aut tollendum aut ferendum est. Qui tollit vitium, uxorem
commodiorem praestat; qui fert, sese meliorem facit."
Di questo parere è anche M. Varrone nella satira menippea che scrisse sul dovere del marito: “Il
difetto della moglie o va tolto o lo si sopporta. Chi lo toglie rende la moglie più gradevole, chi lo
sopporta migliora se stesso”.
Ovidio, Ars amatoria, I, 281-2
Parcior in nobis nec tam furiosa libido:
legitimum finem flamma virilis habet.
Più fievole in noi e non così forte è la libidine: l’ardore maschile ha un confine consono.
Ovidio, Ars amatoria, I, 341-2
Omnia feminea sunt ista libidine mota;
acrior est nostra, plusque furoris habet.
Tutto ciò è mosso dalla libidine femminile, è più forte della nostra ed
ha maggior furia.
Ovidio, Metamorfosi, III, 318 - 321
Forte Iovem memorant diffusum nectare curas
seposuisse graves vacuaque agitasse remissos
cum Iunone iocos et « Maior vestra profecto est
quam, quae contigit maribus », dixisse, « voluptas ».
Si ricorda che per caso Giove, inebriato per il nettare, tralasciasse le gravi cure e con Giunone
oziosa riprendesse i giochi trascurati e dicesse: “Voi avete maggior godimento di quello concesso
ai maschi”.
La tradizione cattolica riprende molto della misoginia pagana.
Tertulliano, De cultu feminarum, I, 2
I.2 Vivit sententia Dei super sexum istum in hoc saeculo: vivat et reatus necesse est. Tu es diaboli
ianua; tu es arboris illius resignatrix; tu es divinae legis prima desertrix; tu es quae eum suasisti,
quem diabolus aggredi non valuit; tu imaginem Dei, hominem, tam facile elisisti; propter tuum
meritum, id est mortem, etiam filius Dei mori habuit: et adornari tibi in mente est super pelliceas
tuas tunicas?
E’ attuale la condanna divina sulle donne in questo tempo: è attuale e deve essere reato. Tu sei la
porta del diavolo, la violatrice di quell’albero, la prima trasgreditrice della sua legge, tu
persuadesti colui che il diavolo non riuscì a persuadere, tu ingannasti facilmente l’uomo,
immagine di Dio, per causa tua, cioè per la morte, anche il figlio di Dio, dovè morire: e tu pensi
di ornarti anche di pellicce?
97
Ben delineato è il concetto di S. Paolo sul reciproco rispetto nel matrimonio.
San Paolo, Ai Corinzi, I, 7, 3
Uxori vir debitum reddat, similiter autem et uxor viro. Mulier sui corporis potestatem non habet,
sed vir. Similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet, sed mulier. Nolite fraudare invicem,
nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi; et iterum revertimini in id ipsum, ne tentet vos
satanas propter incontinentiam vestram.
Il marito renda alla moglie il debito coniugale, e allo stesso modo la moglie al marito. Non è la
moglie che ha potere sul proprio corpo, ma il marito; ugualmente non è il marito ad avere potere
sul proprio corpo, ma la moglie. Non defraudatevi a vicenda, se non di comune accordo
temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera e per stare poi di nuovo insieme, perché Satana
non vi tenti per la vostra incontinenza.
Dante segue la tradizione scolastica e non ha dubbi sulla bontà della Firenze antica, perché fondata
sulla modestia delle donne e la povertà.
Dante, Paradiso, XV, 97 - 102
Fiorenza dentro della cerchia antica,
ond’ella toglie ancora e terza e nona,
si stava in pace, sobria e pudica.
Non avea catenella, non corona,
non gonne contigiate, non cintura
che fosse a veder più che la persona.
Lussuria e ricchezza sono danni sociali comuni alla Roma antica ed alla Firenze moderna.
ibidem, XV, 107 - 108.
non v’era giunto ancor Sardanapalo
a mostrar ciò che ‘n camera si puote.
ibidem, XV,113 - 114
………... e venir dallo specchio
la donna sua sanza ‘l viso pinto
ibidem, XV,116 - 117.
esser contenti a la pelle scoperta
e le sue donne al fuso ed al pennecchio.
L’usanza della donna di dedicarsi ad allevare i figli, alla casa ed alla tessitura ricorda molto da
vicino le caratteristiche della matrona romana.
Dante, Paradiso, XV,121 - 129.
L’una vegghiava a studio della culla,
e, consolando, usava l’idioma
che prima i padri e le madri trastulla;
l’altra, traendo a la rocca la chioma,
favoleggiava con la sua famiglia
d’i Troiani, di Fiesole e di Roma.
Saria tenuta allor tal meraviglia
una Cianghella, un Lapo Saltarello,
98
qual or saria Cincinnato e Corniglia.
DENTRO IL PROBLEMA
Excursus sulla retorica nel mondo antico
Le origini
Le origini della retorica si sogliono ricercare nella Magna Grecia del V secolo a. C. nelle figure di
Corace e Tisia, o meglio, come dice Cicerone (Brutus XII, 46), la pratica era comunque in uso in
Sicilia, ma questi due personaggi la teorizzarono. Secondo Platone (Phaedro, 267a) l’arte di Tisia si
basava sul fatto che il verosimile è da stimarsi molto più del vero: la retorica doveva studiare, come
ars, le tecniche di dimostrazione della verosimiglianza di una tesi.
La scuola pitagorica invece si fondava sulla seduzione della parola che ha un valore psicagogico e
si basava sul modo conveniente di argomentare per ciascuna persona in una determinata circostanza
(polytropia); nei discorsi Pitagora faceva frequente ricorso all’antitesi. Per Parmenide il mondo
della verità riguarda il ragionamento scientifico, la parola è invece utilizzata nel mondo della doxa;
la retorica con la sua funzione psicagogica è spesso legata anche alla medicina, in quanto entrambe
hanno un valore terapeutico, e Pitagora vi inseriva anche la musica. Sempre all’ambito pitagorico
possiamo far risalire la teoria del kairòs: la giustizia non è ciecamente uguale per tutti, ma legata al
kairòs, cioè ad ogni particolare circostanza e persona; la retorica si serve del momento opportuno,
quindi ha un impiego sociale. Un’evoluzione del senso della retorica si ha con Protagora che le
attribuisce più un valore semantico che uno moralistico, ritenendo che la forza della parola sia
quella di rendere potente il discorso meno valido. In base alla testimonianza di Diogene Laerzio
(IX, 51) Protagora sosteneva che intorno ad ogni argomento vi sono discorsi reciprocamente
opposti, da cui il titolo dell’opera Antilogie.
Gorgia
Il primo teorizzatore di un’arte retorica come disciplina autonoma fu Gorgia, nel cui pensiero si
possono individuare due problematiche: quella della persuasione che trascina l’azione e quella
dell’illusione poetica. Il concetto di poesia come apàthe, cioè come inganno, è connessa con il
concetto magico-estetico dell’“incantesimo” poetico di stampo pitagorico (Gorgia era stato
discepolo di Empedocle, a sua volta legato all’ambiente pitagorico). A differenza dei pitagorici,
secondo cui la poesia guarisce anima e corpo, Gorgia vuole evidenziare il meraviglioso inganno
della parola poetica, che può guarire o dare una “dolce malattia”. Per quanto riguarda invece la
persuasione in ambito retorico, non si parla di nessuna malia, ma è necessario essere bene aderenti
alla realtà; mentre la poesia fa credere in ciò che non esiste, la persuasione fa credere che le cose
siano diverse da quello che sono, a seconda delle intenzioni dell’oratore: il logos ha comunque una
forza psigagogica (cfr. Encomio di Elena, 8-9). Sappiamo che la tecnica retorica di Gorgia si
fondava sull’antitesi e che per lui (secondo la testimonianza di Platone in Gorgia 453a) la retorica è
creatrice di convincimento e non di insegnamento. Fondamentale era poi il kairòs, cioè
l’opportunità adattata al tipo di ascoltatore secondo i fini del retore.
Platone
Le opere platoniche Ippia maggiore e Ippia minore si aprono con la descrizione del grande successo
ottenuto dai retori e dai sofisti e, tra coloro che praticarono queste tecniche, è inserito anche
Socrate: il primo problema che Platone volle impostare è quello del rapporto tra retorica e filosofia.
99
Nell’Eutidemo la retorica è considerata come un’abilità pratica alla quale si concede un’affinità
con la magia e gli incantesimi. Nel Gorgia si insiste sul fatto che la retorica non è una scienza né
una vera arte, bensì una pratica che non si fonda sulla verità, ma sulla doxa, il suo carattere
empirico non è comunque da sottovalutare. Nel Gorgia il filosofo sostiene altresì che, mentre la
dialettica è un’arte della discussione che coinvolge forma e contenuto, la retorica è puramente
formale, tende solo a persuadere senza curarsi dei contenuti, fa parte di quella che Platone chiama
kolacheia, cioè una mistificazione che si adatta sia al corpo che all’anima: il filosofo quindi rifiuta
la retorica, ma al contempo nutre un interesse per questa abilità, essa non è un’arte ma richiede, per
chi la pratica, una notevole capacità. L’ultima parte del Fedro è dedicata alla retorica, qui Platone
non polemizza in generale contro di essa, ma contro quella apparente: vi è una falsa retorica che fa
mostra di sapere ciò che non si sa, ed una autentica che sa ciò che esprime e si affida alla dialettica;
ogni discorso non può prescindere dall’analisi e dalla sintesi, una volta acquisita la tecnica della
dialettica i discorsi diventano utili e giovano; la natura della retorica risulta quindi essenzialmente
sociale ed è impossibile esercitarla senza un’adeguata conoscenza della psiche umana. Si ribadisce
il concetto di potere psicagogico della retorica, ma comunque, sia quest’ultima sia la poetica, non
sono delle technai, la poetica è una sorta di divina mania. Potremmo dire che la “mania divina” è il
dover essere della poesia, come la dialettica è il dover essere della retorica. Tale dialettica è dialogo
e consiste nell’interrogare e nel rispondere, è quindi un’attività legata al reale.
Aristotele
Il pensiero del filosofo è espresso nei tre libri Sulla retorica. La vera retorica, come primo punto,
deve essere tecnica rigorosa dell’argomentare, perciò compito dell’oratore è quello di dimostrare
l’esistenza o meno di una cosa o un accadimento attraverso un’argomentazione probativa che
permetta di arrivare ad una conclusione razionale. La retorica non può sostenere tesi contrarie e
deve partire da una premessa veritiera, si giunge quindi alla tecnica del sillogismo detto entimema.
Tre sono i fattori fondamentali di ogni discorso: colui che parla, l’argomento di cui si parla, la
persona a cui ci si rivolge; tre sono quindi i generi retorici legati ai tre momenti fondamentali:
deliberativo, rivolto al futuro; giudiziario, che accusa o difende, rivolto al passato; quello
epidittico che loda o biasima ed è rivolto al presente. L’abile retore deve possedere anche una
capacità emozionale, che miri a rendere credibile il discorso: saggezza, virtù e benevolenza
costituiscono l’ethos del perfetto oratore. Egli deve suscitare negli ascoltatori il pathos che
coinvolge la parte irrazionale dell’essere umano. Con l’introduzione dell’irrazionale Aristotele si
ricongiunge alle prime scuole della retorica greca che avevano individuato la psicagogia come
elemento fondamentale. Nel proemio del I libro della Retorica, il filosofo sostiene che “il compito
della retorica non è di persuadere, ma di scorgere intorno a ciascun argomento gli argomenti
persuasivi”. Nel secondo libro si individua di nuovo un rapporto stretto tra retorica e poetica e la
passione diventa essa stessa techne. Infine nel terzo libro si tratta della teoria dell’elocuzione che si
basa su metafora, antitesi e vigore. La prima è l’elemento più importante che accomuna la poesia
alla retorica, l’antitesi avvicina invece al sillogismo. Infine, per quanto riguarda il problema del
rapporto con l’etica, Aristotele afferma che la retorica è più vicina alle scienze morali e politiche
rispetto alla poesia; mediante la persuasione la retorica può intervenire sulle sensazioni di piacere e
dispiacere dell’uomo.
DENTRO IL PROBLEMA
La Scuola a Roma
100
La scuola del periodo repubblicano è essenzialmente basata sull’educazione familiare impartita dal
padre e fondata sulla trasmissione dei valori tradizionali di una società agricola; basilare è lo
scrivere e far di conto. La figura che emerge in questo campo è quella di Catone, che aveva scritto
opere non pervenuteci sull’educazione, come ci dice Quintiliano, delineando la figura di un uomo
ideale, onesto ed esperto oratore, il vir bonus dicendi peritus (Inst. or. XII, 1, 1).
Col passare del tempo e l’espandersi delle conquiste il quadro educativo si arricchisce
dell’esperienza culturale greca. Cosa dovessero studiare i fanciulli romani si può capire da Plauto:
esercizi fisici, lettura e punizioni per gli errori.
Plauto, Bacchides III, 420-434
Sed tu, qui pro tam corrupto dicis causam filio,
eademne erat haec disciplina tibi, cum tu adulescens eras?
Nego tibi hoc annis viginti fuisse primis copiae,
digitum longe a paedagogo pedem ut efferres aedibus.
Ante solem exorientem nisi in palaestram veneras,
gymnasi praefecto haud mediocris poenas penderes.
Id quom optigerat, hoc etiam ad malum accersebatur malum:
et discipulus et magister perhibebantur improbi.
Ibi cursu luctando hasta disco pugilatu pila
saliendo sese exercebant magis quam scorto aut saviis:
ibi suam aetatem extendebant, non in latebrosis locis.
Inde de hippodromo et palaestra ubi revenisses domum,
cincticulo praecinctus in sella apud magistrum adsideres:
cum librum legeres, si unam peccavisses syllabam,
fieret corium tam maculosum quam est nutricis pallium.
Ma tu che difendi sempre un figlio così depravato, hai avuto la stessa educazione quando eri
fanciullo? Non credo che prima di vent’anni potevi allontanarti di un dito dal maestro, mettendo
piede fuori casa. Se non ti presentavi in palestra prima del sorgere del sole, rischiavi un castigo
non lieve dal maestro di ginnastica. E a chi toccava ciò, un altro male si aggiungeva al primo:
maestro e alunno si rovinavano la reputazione. Lì ci si rompeva la schiena con la corsa, la lotta,
il giavellotto, il disco, il pugilato, la palla, il salto, più che con i baci o le donnine: lì si cresceva,
non nei lupanari! E quando tornavi a casa da lì, ippodromo o palestra che fosse, ti sedevi su uno
sgabello di fronte al maestro con uno straccetto sui fianchi: quando leggevi un libro, se sbagliavi
anche una sola sillaba, la pelle ti diventava così piena di lividi come le macchie del grembiule
della nutrice.
La scuola elementare (ludus) va dai sette ai dodici anni, l’educazione è impartita da un litterator o
ludi magister, spesso anche liberto, che insegna la lettura ed il calcolo. L’alunno seduto, scrive su
una tavoletta (tabella) spalmata di cera con uno stilo di legno (talora di bronzo o di avorio),
incidendo lettere dell’alfabeto o giocando con modellini in avorio e poi leggendo e sillabando le
parole per copiarle.
Quintiliano, Institutio oratoria, I, 1, 24-26
… Neque enim mihi illud saltem placet, quod fieri in plurimis video, ut litterarum nomina et
contextum prius quam formas parvoli discant. 25. Obstat hoc agnitioni earum, non intendentibus
mox animum ad ipsos ductus dum antecedentem memoriam secuntur. Quae causa est
praecipientibus ut, etiam cum satis adfixisse eas pueris recto illo quo primum scribi solent contextu
videntur, retro agant rursus et varia permutatione turbent, donec litteras qui instituuntur facie
101
norint, non ordine: quapropter optime sicut hominum pariter et habitus et nomina edocebuntur. 26.
Sed quod in litteris obest in syllabis non nocebit. Non excludo autem id quod est notum irritandae
ad discendum infantiae gratia, eburneas etiam litterarum formas in lusum offerre, vel si quid aliud
quo magis illa aetas gaudeat inveniri potest quod tractare intueri nominare iucundum sit.
Né del resto mi piace quello che accade spesso, che i bambini imparino nomi e collocazione delle
lettere prima delle loro forme. Ciò è di ostacolo al loro apprendimento, perché non volgono
l’animo subito allo stesso contorno, ma seguono il ricordo di ciò che hanno appreso prima.
Questo è il motivo per cui gli insegnanti, anche quando sembra che hanno fatto imparare ai
fanciulli le lettere in quello stesso ordine in cui sogliono essere scritte, le riprendono a rovescio e
le confondono in vari modi, finché i discepoli le riconoscono dall’aspetto, non dall’ordine. Per
cui impareranno figure e nomi benissimo, come si fa con le persone. Ma quello che è di ostacolo
nelle lettere, non lo è nelle sillabe. Del resto non escludo quello che è stato escogitato per
stimolare ad apprendere i fanciulli, cioè di proporre per gioco anche lettere in avorio, o
quant’altro si può immaginare, per attrarre quell’età, che sia gradevole a toccare, guardare e
denominare.
L’insegnamento è essenzialmente orale, va dall’alba al tramonto e dura da novembre a giugno. I
castighi sono molto frequenti (cfr. Orazio in Epist, II, 1, 70 definisce il maestro plagosus), impartiti
con la bacchetta (ferula) sulla mano o la frusta (scutica) sulla schiena.
La scuola media è tenuta dal grammaticus per i ragazzi dai 12 ai 14 anni e verte soprattutto sulla
grammatica e sulla letteratura, per lo più esercitandosi su testi di autori latini (in specie l’Odysia di
Livio Andronico), letti e spiegati (enarratio) con analisi e commento.
Cicerone, De oratore I, 42, 187
Omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quondam fuerunt; ut in musicis
numeri et voces et modi; in geometria lineamenta, formae, intervalla, magnitudines; in astrologia
caeli conversio, ortus, obitus motusque siderum; in grammaticis poetarum pertractatio, historiarum
cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus; in hac denique ipsa ratione dicendi
excogitare, ornare, disponere, meminisse, agere, ignota quondam omnibus et diffusa late
videbantur.
Tutto ciò che ora è definito nelle dottrine, una volta fu disperso e separato, come nella musica i
ritmi, i toni, le melodie; nella geometria le linee, le figure, gli spazi, le grandezze; nell’astronomia
la rotazione del cielo, il sorgere, il tramontare ed i moti delle stelle; nella grammatica
l’interpretazione dei poeti, la conoscenza della storia, l’interpretazione delle parole, il tono della
pronuncia; in questa stessa arte del dire l’ornare, il disporre, la memoria, l’azione una volta
sembravano cose ignote e sconnesse.
La scuola di retorica è l’ultima fase di questo curricolo, Cicerone e Suetonio ne danno ampia
illustrazione; il rhetor o magister dicendi fornisce modelli e cerca di sviluppare la capacità
declamatoria mediante tesi che, col tempo, si fissano nelle suasoriae e nelle controversiae: le prime
sono esercizi letterari, le seconde cause fittizie civili o penali. L’insegnante in genere è greco e il
modello diffuso ormai è quello di tale cultura, come testimonia Cicerone in De oratore, III, 34, 137:
nam ut virtutes a nostris, sic doctrinae sunt ab illis (Graecis) petenda.
Cicerone nelle opere retoriche traccia un quadro completo della figura del perfetto uomo politico
romano, ormai partecipe dell’egemonia culturale greca: il suo oratore è un personaggio colto, che sa
usare il mezzo tecnico retorico, ed ha familiarità con la filosofia, per impostare le grandi tesi di
dibattito in cui inserire le particolari situazioni oggetto di discussione.
102
Ultimo grande esempio di progetto culturale educativo lo fornisce Quintiliano con la sua Institutio
oratoria.
Nei secoli dell’impero, infatti, la popolazione in Roma è aumentata (nel II secolo si arriverà intorno
al milione) e conseguentemente anche la diffusione di lettori e di libri, in papiri o in codici di
pergamena; la zona dei librai è il quartiere dell’Argiletum. Lo stato s’interessa maggiormente di
scuole e Quintiliano ha la prima cattedra di retorica a spese dello stato sotto Domiziano, infatti S.
Girolamo nel Chronicon ci dice: Quintilianus ex Hispania Calagurritanus prima Romae publicam
scolam et salarium e fisco accepit et claruit. In lui notiamo non solo un’interessante esposizione
sulla linea ciceroniana della formazione dell’oratore e del curricolo d’istruzione, ma anche un
forte interesse per la psicologia dell’alunno e per il metodo d’insegnamento progressivo ed
efficace che il maestro doveva adottare.
Certo per i comuni maestri il compenso deve essere stato sempre assai scarso e le lamentele molte,
come testimoniano Orazio e Giovenale.
Orazio, Satira, I, VI, 75
….. in Flavi ludum ….. magni
quo pueri magnis e centurionibus orti
laevo suspensi loculos tabulamque lacerto
ibant octonos referentes idibus aeris….
….. alla scuola di Flavio, dove andavano gli altezzosi figli dei superbi centurioni, con la borsa e
le tavolette sospese al braccio sinistro, portando allo scadere delle Idi gli otto pezzi di bronzo.
Giovenale, Satira, VII, 158 – 168
‹Mercedem appellas? quid enim scio?› ‹Culpa docentis
scilicet arguitur, quod laevae parte mamillae
nil salit Arcadico iuveni, cuius mihi sexta
quaque die miserum dirus caput Hannibal inplet,
quidquid id est de quo deliberat, an petat urbem
a Cannis, an post nimbos et fulmina cautus
circumagat madidas a tempestate cohortes.
Quantum vis stipulare et protinus accipe: quid do
ut totiens illum pater audiat?› Haec alii sex
vel plures uno conclamant ore sophistae
et veras agitant lites raptore relicto.
160
165
“Chiedi di essere pagato? E cosa ho imparato?” “Si vede bene che la colpa è del maestro, dato
che al giovane campagnolo nulla balla sotto la parte sinistra del petto, lui che ogni sei giorni mi
riempie la testa col suo crudele Annibale, che comunque deve decidere se marciare su Roma da
Canne, o se dopo il temporale ed i fulmini debba tenere lontane le sue coorti fradice per il
diluvio. Fissa quello che vuoi e prenditelo: quanto ti devo dare perché il padre se lo stia a sentire
altrettante volte?” Questo gridavano ad una voce una mezza dozzina o più di maestri e
minacciavano cause vere, lasciati da parte gli esercizi sui seduttori.
Del resto l’abbassamento del livello culturale e la superficialità imperante nelle scuole sono
denunciati da Petronio all’inizio del Satyricon e da Tacito nel Dialogus de oratoribus e la
diffusione di maestri libertini, sostenuti dalla burocrazia imperiale in espansione, non migliorerà
certo le cose neanche nel III e IV secolo d. C..
103
DENTRO IL PROBLEMA
L’IMPERIALISMO ROMANO VISTO DAI BARBARI:
I DISCORSI DI CALGACO, ARMINIO E CRITOGNATO
Tacito, Agricola, 30-32
Il discorso di Calgaco
XXX. Quotiens causas belli et necessitatem nostram intueor, magnus mihi animus est hodiernum
diem consensumque vestrum initium libertatis toti Britanniae fore. Nam et universi servitutis
expertes et nullae ultra terrae ac ne mare quidem securum, imminente nobis classe Romana. Ita
proelium atque arma, quae fortibus honesta, eadem etiam ignavis tutissima sunt. … Sed nulla iam
ultra gens, nihil nisi fluctus et saxa, et infestiores Romani, quorum superbiam frustra per
obsequium et modestiam effugeris. Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, iam
et mare scrutantur: si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi; quos non Oriens, non
Occidens satiaverit. Soli omnium opes atque inopiam pari adfectu concupiscunt. Auferre trucidare
rapere falsis nominibus imperium, atque, ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. XXXI. Liberos
cuique ac propinquos suos natura carissimos esse voluit: hi per dilectus alibi servituri auferuntur:
coniuges sororesque etiam si hostilem libidinem effugiant, nomine amicorum atque hospitum
polluuntur. Bona fortunaeque in tributum, ager atque annus in frumentum, corpora ipsa ac manus
silvis ac paludibus emuniendis inter verbera ac contumelias conteruntur. Nata servituti mancipia
semel veneunt, atque ultro a dominis aluntur: Britannia servitutem suam cotidie emit, cotidie
pascit. Ac sicut in familia recentissimus quisque servorum etiam conservis ludibrio est, sic in hoc
orbis terrarum vetere famulatu novi nos et viles in excidium petimur. Neque enim arva nobis aut
metalla aut portus sunt, quibus exercendis reservemur. Virtus porro ac ferocia subiectorum ingrata
imperantibus; et longinquitas ac secretum ipsum quo tutius, eo suspectius. Ita sublata spe veniae
tandem sumite animum, tam quibus salus quam quibus gloria carissima est. … XXXII. An eandem
Romanis in bello virtutem quam in pace lasciviam adesse creditis? Nostris illi dissensionibus ac
discordiis clari vitia hostium in gloriam exercitus sui vertunt.
Quando considero le cause della guerra e ciò di cui abbiamo bisogno, mi sento sempre più sicuro
che la vostra concordia odierna segnerà l’inizio della libertà per tutta la Britannia. Infatti voi
tutti, qui, non avete mai subito la servitù, né ci sono per voi altre terre, mentre neanche il mare è
sicuro per la minaccia della flotta romana. Per tanto la lotta e le armi, che sono i mezzi più nobili
per i forti, sono anche quelli più sicuri per i vili. … Ma ormai non resta altro popolo, nulla se
non flutti e scogli ed i Romani sempre più pericolosi, la cui tracotanza non si può evitare con
l’ossequio e la sottomissione. Rapinatori del mondo intero, poiché avendo devastato tutto gli
mancarono altre terre, ora scrutano anche il mare. Se il nemico è ricco sono esosi, se è povero
altezzosi, non li ha saziati né l’Oriente né l’Occidente. Bramano per sé soli con pari desiderio le
ricchezze di tutti e la miseria. Il rubare, il trucidare, il rapire lo chiamano con falso nome impero
e dove hanno fatto deserto lo dicono pace. Figli e parenti sono a ciascuno per natura diletti: gli
uni ci sono sottratti dal servizio militare in altre terre, le mogli e le sorelle, anche se riescono a
sfuggire alla libidine del nemico, sono contaminate dal pretesto dell’amicizia e dell’ospitalità. I
beni e le fortune finiscono in tributi, i campi ed i raccolti per fornire il frumento; ci consumiamo
i corpi e le mani tra percosse ed insulti per costruire fortificazioni tra selve e paludi. Gli schiavi
nati in servitù sono venduti una sola volta e sono per di più nutriti dal padrone: la Britannia ogni
giorno compra la sua servitù, ogni giorno l’alimenta. E come in una famiglia di servi gli ultimi
venuti sono di scherno agli altri, così noi, vecchia famiglia di schiavi del mondo, siamo gli ultimi
venuti e per di più spregevoli e siamo oggetto di sterminio. Del resto non abbiamo campi, miniere
104
o porti per i quali essere risparmiati per lavorare. Il valore e la fierezza dei sottomessi sono
sgraditi ai dominatori e la lontananza e l’isolamento sono tanto più sospetti quanto più sicuri.
Per cui abbandonata ogni speranza di indulgenza, fatevi animo, come a coloro cui è carissima
sia la salvezza che la gloria. ... Credete forse che i Romani abbiano lo stesso valore in guerra
quanta lascivia in pace? Costoro si giovano delle nostre discordie e liti e volgono a favore della
loro gloria militare gli errori dei nemici.
Siamo nell’83 d. C., i Britanni, avendo ritrovato la concordia tra le varie tribù a causa del
pericolo incombente, si apprestano ad affrontare i Romani presso il monte Graupio (l’attuale
catena dei monti Grampiani in Scozia). Tacito fa parlare uno dei notabili, Calgaco, capo dei
Calcedoni, facendo pronunciare a lui quelle accuse che venivano mosse all’imperialismo romano.
Al discorso del Britanno, i cui toni toccano il vertice dell’arte retorica nella famosa espressione
raptores orbis ….. atque, ubi solitudinem faciunt, pacem appellant, seguirà quello di Agricola, che
usa toni non meno drammatici ed efficaci: come per i Britanni la sola speranza è la vittoria, così per
un esercito di occupazione et vota virtusque in aperto, omniaque prona victoribus, atque eadem
victis adversa.
Il potere romano per il Nostro si fonda sulle antiche virtù e sull’esercito, pilastro dell’impero;
l’imperialismo è la molla della sopravvivenza delle istituzioni e la guerra di conquista ne è il
mezzo. L’efficacia psicologica dei discorsi dei grandi generali romani è il modo con cui lo storico
spiega le cause degli eventi e lumeggia gli aspetti, anche contrastanti, della storia. Per darci
obiettivamente il quadro delle diverse situazioni egli mette a confronto due punti di vista, quello
romano e quello barbarico. La storia tacitiana è opus oratorium maxime ed egli è il sublime artista
della drammaticità degli eventi.
Il concetto della giustificazione della pax romana con il pretesto della civilizzazione dei popoli
barbari, ma che nasconde lo sfruttamento del territorio e degli uomini, è presente anche nel discorso
di Arminio.
Tacito, Annales, II, 15
Il discorso di Arminio
Orationem ducis secutus militum ardor, signumque pugnae datum. Nec Arminius aut ceteri
Germanorum proceres omittebant suos quisque testari, hos esse Romanos Variani exercitus
fugacissimos qui ne bellum tolerarent, seditionem induerint; quorum pars onusta vulneribus terga,
pars fluctibus et procellis fractos artus infensis rursum hostibus, adversis dis obiciant, nulla boni
spe. Classem quippe et avia Oceani quaesita ne quis venientibus occurreret, ne pulsos premeret:
sed ubi miscuerint manus, inane victis ventorum remorumve subsidium. Meminissent modo
avaritiae, crudelitatis, superbiae: aliod sibi reliquum quam tenere libertatem aut mori ante
servitium?
Il discorso di Germanico infiamma i soldati romani e si dà il segnale della battaglia. Né Arminio
o gli altri capi germani trascuravano di ricordare ai loro che questi erano i Romani fuggiaschi
dell’esercito di Varo che per non sopportare la guerra si erano ribellati, le schiene di parte di loro
erano coperte di ferite, molti avevano le ossa rotte da flutti e tempeste e dovevano affrontare di
nuovo nemici agguerriti e divinità ostili. Cercavano rifugio nella flotta e nell’Oceano sconfinato
perché nulla soccorreva chi veniva, né opprimeva i fuggiaschi: ma venuti alle mani sarebbe stato
inutile l’aiuto del vento o dei remi. Ci si ricordasse solo dell’avidità, della crudeltà, della
superbia: non restava loro altro che la libertà o la morte prima di divenire schiavi?
105
La trattazione degli eventi, siamo intorno al 16 d. C., è di tipo psicologico e le cause sono
cercate nell'animo umano; da vero storico Tacito nei discorsi cerca di esprimere l'obiettività, anche
se è costretto talora a modificarli o ad ipotizzare che siano così come li riporta. La tecnica narrativa
procede sempre illuminando gli aspetti di entrambe le parti, quella dei Romani come quella dei
barbari: così nel II libro degli Annali che narra le conquiste romane durante l’impero di Tiberio, il
discorso del capo germanico Arminio, che rievoca la sconfitta di Varo nella selva di Teutoburgo
all’epoca di Augusto (9 d. C.), è preceduta dal discorso del generale romano Germanico (Ann., II,
14). Lo storico sostiene la guerra di conquista, ma non è inumano e se esalta le stragi di
Germanico contro i Cherusci di Arminio, lo fa solo perché si tratta della vendetta di Teutoburgo: nei
Germani vede la forza che fu degli antichi romani e li teme.
Un utile paragone può esser fatto con il famoso ed efferato discorso di Critognato, un nobile degli
Arverni, nella città di Alesia, stretta d’assedio dai Romani e ormai stremata.
Cesare, De bello Gallico, VII, 77
Il discorso di Critognato
At ei, qui Alesiae obsidebantur praeterita die, qua auxilia suorum exspectaverant, consumpto omni
frumento, inscii quid in Aeduis gereretur, concilio coacto de exitu suarum fortunarum consultabant.
Ac variis dictis sententiis, quarum pars deditionem, pars, dum vires suppeterent, eruptionem
censebat, non praetereunda oratio Critognati videtur propter eius singularem et nefariam
crudelitatem. Hic summo in Arvernis ortus loco et magnae habitus auctoritatis, "Nihil," inquit, "de
eorum sententia dicturus sum, qui turpissimam servitutem deditionis nomine appellant, neque hos
habendos civium loco neque ad consilium adhibendos censeo. Cum his mihi res sit, qui eruptionem
probant; quorum in consilio omnium vestrum consensu pristinae residere virtutis memoria videtur.
Animi est ista mollitia, non virtus, paulisper inopiam ferre non posse. Qui se ultro morti offerant
facilius reperiuntur quam qui dolorem patienter ferant. Atque ego hanc sententiam probarem
(tantum apud me dignitas potest), si nullam praeterquam vitae nostrae iacturam fieri viderem: sed
in consilio capiendo omnem Galliam respiciamus, quam ad nostrum auxilium concitavimus. Quid
hominum milibus LXXX uno loco interfectis propinquis consanguineisque nostris animi fore
existimatis, si paene in ipsis cadaveribus proelio decertare cogentur? Nolite hos vestro auxilio
exspoliare, qui vestrae salutis causa suum periculum neglexerunt, nec stultitia ac temeritate vestra
aut animi imbecillitate omnem Galliam prosternere et perpetuae servituti subicere. An, quod ad
diem non venerunt, de eorum fide constantiaque dubitatis? Quid ergo? Romanos in illis ulterioribus
munitionibus animine causa cotidie exerceri putatis? Si illorum nuntiis confirmari non potestis
omni aditu praesaepto, his utimini testibus appropinquare eorum adventum; cuius rei timore
exterriti diem noctemque in opere versantur. Quid ergo mei consili est? Facere, quod nostri
maiores nequaquam pari bello Cimbrorum Teutonumque fecerunt; qui in oppida compulsi ac simili
inopia subacti eorum corporibus qui aetate ad bellum inutiles videbantur vitam toleraverunt neque
se hostibus tradiderunt. Cuius rei si exemplum non haberemus, tamen libertatis causa institui et
posteris prodi pulcherrimum iudicarem. Nam quid illi simile bello fuit? Depopulata Gallia Cimbri
magnaque illata calamitate finibus quidem nostris aliquando excesserunt atque alias terras
petierunt; iura, leges, agros, libertatem nobis reliquerunt. Romani vero quid petunt aliud aut quid
volunt, nisi invidia adducti, quos fama nobiles potentesque bello cognoverunt, horum in agris
civitatibusque considere atque his aeternam iniungere servitutem? Neque enim ulla alia condicione
bella gesserunt. Quod si ea quae in longinquis nationibus geruntur ignoratis, respicite finitimam
Galliam, quae in provinciam redacta iure et legibus commutatis securibus subiecta perpetua
premitur servitute."
Gli assediati di Alesia, passato invano il giorno in cui aspettavano aiuti, finito tutto il frumento,
ignari di cosa accadesse fra gli Edui, radunato il consiglio consideravano la loro situazione. Tra
106
le varie opinioni espresse circa l’opportunità della resa o di un’irruzione finché c’erano le forze,
è degno di essere riferito il discorso di Critognato per la sua singolare e nefasta crudeltà. Costui
era un nobile degli Arverni di grande autorità. Ecco il discorso: “Tralascio di rispondere a chi
parla di resa per celare una vergognosa schiavitù, penso che costoro non siano degni di essere
fra i cittadini, né di sedere in consiglio. Mi par degno discutere invece con coloro che
propugnano l’irruzione. In questa idea per consenso di tutti voi mi sembra permanere il ricordo
del precedente valore. È viltà, non valore, a poco a poco non poter sopportare l’indigenza. È più
facile trovare chi si offra spontaneamente alla morte che chi sopporti pazientemente il dolore. Io
appoggerei questa soluzione (tanto valore ha per me l’onore) se non vedessi esserci altra
sventura che quella della nostra vita: ma nel prendere questa decisione dobbiamo tenere presente
la Gallia tutta che abbiamo chiamato in nostro aiuto.
Cosa credete che penseranno i nostri consanguinei e parenti, essendo caduti in un solo luogo
ottanta mila uomini, se saranno costretti a combattere sugli stessi cadaveri? Non vogliate privarli
del vostro aiuto, essi hanno trascurato il pericolo per salvarvi, né vogliate sottomettere e
prosternare tutta la Gallia alla servitù per la vostra stoltezza, incoscienza o debolezza d’animo. O
dubitate della lealtà e della risolutezza degli alleati, perché non sono giunti per tempo a
soccorrerci? Forse credete che i Romani lavorino quotidianamente per diletto nel costruire tante
fortificazioni per esercitarsi? Se non potete avere conferma dai messaggi che sono sempre
intercettati, il fatto che ormai essi si avvicinano capiamolo da questi recenti eventi: il loro timore
spinge i Romani atterriti a lavorare senza posa notte e giorno. Cosa propongo quindi? Fare
quello che in una guerra meno crudele di questa con i Cimbri ed i Teutoni fecero i nostri
antenati, che stretti d’assedio e sottoposti ad una simile scarsezza di mezzi, si sostentarono con le
carni di coloro che erano inabili per l’età a combattere, ma non si arresero. Anche se non
avessimo un tale precedente, direi che sarebbe opportuno fornirlo ora per amore della libertà e
per tramandare ai posteri un nobile esempio. Che affinità esiste tra le due guerre? I Cimbri, una
volta saccheggiata la Gallia e fatte grandi devastazioni, infine abbandonarono i nostri confini in
cerca di altre terre; ci hanno lasciato il diritto, le leggi, i campi e la libertà. I Romani invece non
cercano forse altro che, spinti da emulazione, di stabilirsi nei territori e nelle città di chi era
famoso per nobiltà e per potenza guerriera e imporre a costoro un’eterna schiavitù? Non hanno
mai fatto guerre per altri scopi. Se poi non sapete cosa hanno fatto in terre lontane, guardate la
vicina Gallia, che ridotta a provincia, mutate leggi e diritti, sottoposta al potere, è oppressa da
perpetua schiavitù”.
Cesare concede un insolito spazio al discorso del capo degli Arverni, ma gli preme mettere a
confronto le diverse ragioni dei popoli. La vittoria su Alesia corona la sua conquista e con un
tocco di abile retorica sul topos della libertas ingigantisce i fatti e conferisce al tutto un tono
drammatico: la comprensione storica del patriottismo dei Galli, spinto fino al cannibalismo per non
arrendersi e sopravvivere gli assediati, fa contrasto con le ragioni superiori della civiltà portata da
Roma.
Tacito, Agr., 30-32
Il discorso di Calgaco
Raptores orbis … atque, ubi
solitudinem faciunt, pacem
appellant
Tacito, Ann., II, 15
Il discorso di Arminio
Hos esse Romanos Variani
exercitus fugacissimos qui ne
bellum tolerarent, seditionem
induerint; quorum pars onusta
vulneribus terga, pars fluctibus
et procellis fractos artus
infensis rursum hostibus,
adversis dis obiciant, nulla boni
Cesare, De bello Gall., VII, 77
Il discorso di Critognato
Quid ergo mei consili est?
Facere, quod nostri maiores
nequaquam pari bello
Cimbrorum Teutonumque
fecerunt; qui in oppida
compulsi ac simili inopia
subacti eorum corporibus qui
aetate ad bellum inutiles
107
spe.
Contro l’imperialismo romano e Ansia di vendetta dei Romani
la necessità delle guerre di
per la presenza dello spettro
conquista.
della sconfitta di Teutoburgo.
videbantur vitam toleraverunt
neque se hostibus tradiderunt.
Romani vero quid petunt aliud
aut quid volunt, nisi invidia
adducti, quos fama nobiles
potentesque bello cognoverunt,
horum in agris civitatibusque
considere atque his aeternam
iniungere servitutem?
Il patriottismo dei Galli spinto
fino all’eccesso della ferinità.
DENTRO IL PROBLEMA
LA TRADUZIONE DI MARINETTI DELLA GERMANIA DI TACITO
Alla fine degli anni venti l’Istituto Editoriale Italiano con sede a Milano si fece promotore della
pubblicazione di una collana di classici latini, che, nelle intenzioni del suo ideatore e direttore
Ettore Romagnoli, avesse anche carattere divulgativo e propagandistico, pur conservando il
carattere elitario dello studio delle lingue antiche. “La letteratura latina ha carattere universale:
essa ha offerto modelli ed impulsi spirituali a tutto il mondo civile”, così esordisce nella prefazione
alla collana il grande antichista.
La veste editoriale è particolarmente curata, i volumetti di piccole dimensioni sono rilegati in pelle
nera e stupendamente decorati all’interno da fregi di Duilio Cambellotti. Inoltre l’edizione presenta
il testo in lingua ed a fronte la traduzione, affidata ad illustri studiosi. A Filippo Tommaso
Martinetti fu dato il compito di tradurre La Germania di Tacito, opera che in quegli anni si prestava
a vari tipi di lettura. Perché il futurista Martinetti accetta di tradurre tale opera? La risposta la
fornisce lo scrittore stesso nella doverosa premessa:
Alla proposta ho risposto affermativamente … perché la nostra passione futurista per la sintesi ci
permette di gustare ancora Tacito senza essere soffocati dalla ripugnante polvere del passato;
perché Tacito, maestro di concisione sintesi e intensificazione verbale è molto più futurista dei
maggiori scrittori moderni; perché la visione imperiale della Germania fissata da Tacito è tuttora
politicamente istruttiva ed ammonitrice; perché venga dimostrata l’assurdità dell’insegnamento
scolastico del Latino, basato su traduzioni scialbe, errate e su cretinissime spiegazioni di professori
abbrutiti, tarli di testi e di teste.
La traduzione di Marinetti risulta molto fedele al testo latino, il che dimostra che l’autore si era
adeguatamente documentato e che era scrupoloso nella sua attività, nonostante le parole polemiche
ed alquanto irridenti della premessa.
Lo stesso volumetto presenta in appendice il discorso di Atto Vannucci Di Tacito della sua vita e
delle sue opere.
Inserire foto Germania Marinetti-Cambellotti
DENTRO IL PROBLEMA
108
IL GENERE EPISTOLARE: UN’ANALISI COMPARATIVA
Si esaminano tre tipi di epistole: Cicerone Ad familiares 14,8 – Plinio Epistole I, 14 – Seneca
Epistole morali a Lucilio I,1.
Cicerone Ad familiares 14, 8
M.T.C.s.p.d. Terentiae
Si vales bene est; ego valeo. Valetudinem tuam velim cures diligentissime. Nam mihi et scriptum et
nuntiatum est, te in febrim subito incidisse. Quod celeriter me fecisti de caesaris litteris certiorem,
fecisti mihi gratum. Item posthac, si quid opus erit, si quid acciderit novi, facies ut sciam. Cura ut
valeas. Vale. D. IV Nonas Iun.
Marco Tullio Cicerone saluta molto Terenzia
Se sei in buona salute, è cosa buona; io sto bene. Vorrei che avessi a cuore la tua salute con
grande attenzione. Infatti mi è stato scritto e riferito che ti sei improvvisamente ammalata. Mi hai
fatto cosa grata perché mi hai informato alla svelta delle lettere di Cesare. Allo stesso modo, in
futuro, se ci sarà bisogno di qualcosa, se accadrà qualcosa di nuovo, fai in modo che io lo sappia.
Abbi riguardo di te. Addio. Data il 2 giugno.
Nota le allitterazioni (vales...valeo...valitudinem... velim),
l’uso dei superlativi (stile più colloquiale),
l’uso dei verbi impersonali (scriptum et nuntiatum est),
l’uso dell’anafora si (ali)quid… si (ali)quid + il genitivo partitivo,
i termini del sermo familiaris come in febrim incidisse,
velim è congiuntivo ottativo più cures al congiuntivo (cfr. sotto in Plinio: rogo cures).
Plinio, Epistole I, 24
C. Plinius Baebio Hispano suo s.
Tranquillus contubernalis meus vult emere agellum, quem venditare amicus tuus dicitur. (2) Rogo
cures, quanti aequum est emat; ita enim delectabit emisse. Nam mala emptio semper ingrata, eo
maxime quod exprobrare stultitiam domino videtur. (3) In hoc autem agello, si modo arriserit
pretium, Tranquilli mei stomachum multa sollicitant, vicinitas urbis, opportunitas viae, mediocritas
villae, modus ruris, qui avocet magis quam distringat. (4) Scholasticis porro dominis, ut hic est,
sufficit abunde tantum soli, ut relevare caput, reficere oculos, reptare per limitem unamque
semitam terere omnesque viteculas suas nosse et numerare arbusculas possint. Haec tibi exposui,
quo magis scires, quantum esset ille mihi ego tibi debiturus, si praediolum istud, quod
commendatur his dotibus, tam salubriter emerit ut emptionis eum non paeniteat. Vale.
Gaio Plinio saluta il suo Bebio Ispano
Tranquillo, mio compagno, vuole comprare un campicello che si dice che un tuo amico abbia
posto in vendita. Cerca di fare in modo che lo paghi un giusto prezzo. Così infatti si compiacerà
d’averlo comprato. Infatti un cattivo affare è sempre sgradito, soprattutto per il fatto che sembra
dimostrare la stoltezza del padrone. Quindi in questo campicello, se il prezzo sarà accattivante,
molti elementi stuzzicano il mio Tranquillo: la vicinanza alla città, la facilità di comunicazione,
la dimensione giusta della casa, la tipologia del terreno, che attira più che impegnare. Per un
proprietario anche letterato, come lui, basta di gran lunga tanto terreno da poter distrarre la
mente, riposare gli occhi, girovagare nei suoi confini e camminare sempre sullo stesso sentiero;
109
conoscere ogni più piccola vite e contare gli arbusti. Ti ho detto queste cose affinché tu sappia
quanta gratitudine egli mi dovrà e quanta io a te, se comprerà questo poderetto, che si
raccomanda per tali vantaggi, a condizioni così favorevoli che non si penta dell’acquisto. Sta
bene.
Nota:
Tranquillus: si tratta dello storico Suetonio.
Dicitur: costruzione personale.
Rogo più congiuntivo cures più congiuntivo emat: serie di completive.
Vicinitas urbis … si elencano tutte le caratteristiche di una villa ed i suoi vantaggi.
I termini vicinitas, opportunitas, mediocritas, modus sono tipici di un modo di vivere misurato,
necessario agli scholasticis dominis.
Per descrivere i vantaggi dell’otium, Plinio usa verbi con allitterazione: relevare, reficere, reptare.
La serie di pronomi ille, mihi, ego, tibi indica l’uso del sermo familiaris, ma anche di uno stile
retorico.
Seneca, Epistole Morali a Lucilio I, 1
Seneca Lucilio suo salutem
[1] Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus quod adhuc aut auferebatur aut subripiebatur aut
excidebat collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo: quaedam tempora eripiuntur nobis,
quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima tamen est iactura quae perneglegentiam fit.
Et si volueris attendere, magna pars vitae elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota
vita aliud agentibus. [2] Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui
intellegat se cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius iam
praeterit; quidquid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes
horas complectere; sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris. [3] Dum
differtur vita transcurrit. Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est.
Seneca saluta il suo Lucilio.
Fai così, o mio Lucilio, dedicati al perfezionamento del tuo essere, e il tempo che sino ad ora o ti
veniva sottratto, o ti era rubato, o ti sfuggiva, raccoglilo istante per istante e custodiscilo
gelosamente. Convinciti che è così come scrivo: alcuni momenti ci vengono strappati, altri portati
via, altri ancora scorrono via. Tuttavia è una sciagura assai grave ciò che avviene a causa della
nostra negligenza e, se vorrai riflettere, gran parte della nostra vita scivola via nell’agir male,
una grandissima parte nel non agire affatto, tutta la vita nel fare altro. Dammi l’esempio di
qualcuno che dia giusto valore al tempo, che valorizzi la propria giornata, che abbia la
percezione di morire giorno dopo giorno. In ciò infatti siamo in errore, che guardiamo la morte
da lunga distanza: gran parte del tempo è già passato, tutta l’età che resta è in mano della morte.
Comportati, o mio Lucilio, come scrivi: vivi intensamente tutti i momenti della tua giornata. Così
avverrà che sarai meno condizionato dal futuro, se t’impegni nel presente. Mentre s’indugia, la
vita passa. Tutto, o Lucilio, dipende dagli altri, solo il tempo è nostro.
Nota le seguenti caratteristiche:
la presenza di domande retoriche per dimostrare una tesi filosofica,
il climax ascendente con variatio stilistica (auferebatur aut subripiebatur aut excidebat: i primi due
i verbi sono di forma passiva, il terzo è all’attivo),
l’uso dell’imperativo e del vocativo (mi Lucili),
la preferenza per l’ipotassi,
la prolessi in hoc quod …,
il linguaggio è retorico al fine di persuadere.
110
ANALISI COMPARATIVA DELLE TRE EPISTOLE
Parti della lettera
Destinatario
Cicerone
Terenzia
Plinio
Bebio Ispanico
Seneca
Lucilio
Saluti
S.D.
S.D.
S.D.
Exordium
Notizie sulla sua salute o su Notizie sulla sua salute o su Può mancare, spesso è una
(in dativo, cui epistula missa est)
quella del destinatario
quella del destinatario
domanda retorica per porre il
problema della riflessione
Corpus centrale
Congedo
Argomento dell’epistola
Vale
Argomento per esaltare la
Serie di riflessioni
propria capacità di
filosofiche: la forma
mediazione
epistolare è un pretesto
Vale
Vale
Cura ut valeas
Data
È essenziale
Non compare
Non compare
Luogo
È essenziale
Non sempre compare
Non compare
Proclo, uno scrittore del I sec. d. C., individuava quarantuno tipologie di epistole ed affermava
che era un genere molto diffuso.
Nel mondo greco (in Platone, in Epicuro) la caratteristica dell’epistola doveva essere la brevità e
l’intimità. Cicerone invece si definiva “longior quam vellem”, infatti il suo epistolario era
caratterizzato da un ininterrotto flusso autobiografico, come bene intese Leopardi che nello
Zibaldone scrisse che era una “intima e recondita sorgente della storia dei suoi tempi”.
L’autobiografismo è ancora più evidente in Plinio, che voleva ripercorrere l’iter ciceroniano, anche
se percepiva i propri limiti e la profonda differenza con quell’ideale, come scriveva infatti
nell’Epistola IX, 2. Seneca giungeva al genere epistolare dopo un percorso diverso: la lettera era un
mezzo idoneo per stabilire un contatto con l’interlocutore. La chiave di lettura è filosofica.
L’epistola di Cicerone, quindi, è scritta per dare o avere delle informazioni, di conseguenza il suo
stile è colloquiale ed essenziale, vicino al sermo familiaris; l’autore è pienamente inserito nella
realtà socio-politica e consapevole dell’importanza degli avvenimenti in un momento critico per la
repubblica. Ogni minima informazione circa i protagonisti della politica del tempo può rivelarsi
interessante. Come si evince dallo schema è importante la data, il destinatario (la moglie Terenzia
funge da legame con Roma durante la sua assenza; la lettera era scritta dal campo di Pompeo ed è
del 2 luglio del 48 a.C.): l’epistola è di tipo informativo.
D’altro tono è l’epistola di Plinio, in cui l’autore si limita a raccomandare l’amico, forte della sua
posizione sociale. Non c’è nessuna presa di posizione politica, in quanto la situazione a Roma è
tranquilla per l’equilibrio instaurato dal princeps. Il linguaggio è piuttosto ricercato in quanto la
lettera è composta per essere pubblicata, ma è sempre legato ad un aspetto concreto: l’autore si
mostra al di sopra dei problemi quotidiani e vuole dispensare consigli dall’alto della sua posizione.
L’epistola è di tipo letterario.
L’epistola di Seneca, invece, non è condizionata dal destinatario, che diviene un alter ego
dell’autore, fornendo lo spunto per considerazioni filosofiche, a volte piuttosto involute, di natura
morale. Lo stile è ipotattico con uso di figure retoriche. L’epistola è di tipo filosofico.
111
DENTRO IL PROBLEMA
PLUTARCO: LE VITE PARALLELE
Plutarco nacque a Cheronea in Beozia nel 50 d.C. e vi morì verso il 120 d. C.. Studiò ad Atene la
filosofia platonica cui restò legato per tutta la vita. Viaggiò molto e soggiornò a Roma. Ottenne la
cittadinanza romana sotto Traiano. Scrisse in greco molte opere, di cui ci è giunta solo una parte:
quelle filosofiche, raggruppate sotto il titolo di Moralia, e le famose Vite parallele, così dette perché
pongono a confronto la biografia di un personaggio greco ed uno romano; un giudizio comparativo
conclude il paragone.
La vita di Cesare è posta in parallelo con quella di Alessandro Magno. Il brano che segue narra la
morte di Cesare e si può opportunamente confrontare con il testo di Suetonio, Caes., 82, sopra
riportato.
Plutarco, Cesare, LXVI
Sedutosi, respinse le loro suppliche; ma poiché insistevano violentemente si irritava verso
ciascuno, allora Tullio Cimbro, afferrata la toga con entrambe le mani, la tirò via dal collo, era il
segnale dell’azione. Casca per primo lo ferì con la spada alla gola, ma il colpo non fu né grave, né
mortale, com’è verosimile essendo quello che osò per primo dare il via ad un sì grave fatto,
cosicché Cesare, rivoltatosi, afferrava la spada e la teneva ferma. Nello stesso tempo egli colpito
disse in latino: “Scelleratissimo Casca, che fai?” e l’omicida, in greco, verso il fratello: “Aiuto,
fratello!” Avvenuto ciò, i senatori che non partecipavano alla congiura rimasero dapprima
immobili, poi pieni di terrore e di paura non furono capaci né di fuggire, né di aiutare Cesare, ma
neppure ebbero il coraggio di proferire parola. Invece quelli che si erano preparati all’omicidio,
sguainando la spada, lo circondarono in modo che egli da qualunque punto si rivolgesse, si trovava
un’arma sul volto e sugli occhi e quello, come una fiera assalita, era colpito dalle mani di tutti;
perché era necessario che tutti partecipassero a quell’uccisione e ne gioissero. Perciò anche Bruto
gl’inferse un colpo nell’inguine. Alcuni raccontano che egli per difendersi dai molteplici assalitori,
si spostava qua e là, gridando; ma quando vide che anche Bruto aveva sguainato la spada, si coprì
la testa con la toga e si lasciò andare, spinto a caso, o per volontà degli uccisori, sul piedistallo
della statua di Pompeo, che rimase tinta di molto sangue. Sembrava così che Pompeo presiedesse
alla vendetta sul suo nemico, steso ai suoi piedi, agonizzante per i numerosi colpi inferti. Infatti si
dice che fosse colpito ventitré volte e che anche gli altri si ferirono fra di loro, mentre rivolgevano
tanti colpi contro un solo corpo.
DENTRO IL PROBLEMA
IL ROMANZO GRECO
Nella Storia Vera Luciano, autore del II secolo d. C., esordisce con un paragone secondo cui, come
gli atleti ogni tanto devono rilassarsi per rinvigorirsi e riposare i muscoli, così anche lo studioso
deve talvolta leggere qualcosa che lo distenda, per poi potersi dedicare di nuovo alle attività
impegnative della mente. Esisteva quindi una letteratura “minore” che oggi chiameremmo “di
evasione”. In Grecia questo genere era ignorato dagli uomini di cultura, ma il fatto che ci rimangano
parecchi componimenti, i cosiddetti romanzi, ci fa capire che godeva di un certo successo. Le
componenti essenziali del romanzo greco sono l’amore e l’avventura che rimarranno costanti come
112
ingredienti principali del genere. La vicenda è abbastanza scontata: un lui ed una lei s’incontrano
casualmente ed altrettanto accidentalmente s’innamorano: l’uomo è sempre bello e soprattutto
valoroso e coraggioso, lei è bellissima e tutti la desiderano, la sue doti sono l’onestà, la purezza e la
fedeltà. I due presto vengono separati per una serie di eventi che spesso risultano poco credibili e
macchinosi: questa è un po’ la caratteristica del genere, non si tratta di vicende vere, semmai
verosimili. Nonostante tutte le avversità il lieto fine è garantito ed il Fato, come motore unico della
vicenda in cui gli dei sono completamente assenti, ha deciso finalmente la loro riunificazione. La
trama è quindi molto semplice, ma le descrizioni, soprattutto quelle di ambienti irreali e favolosi
collocati al di fuori dello spazio e del tempo, sono estremamente varie e ricche di particolari.
I testi conservati risalgono al periodo imperiale, ma già durante l’Ellenismo tale genere dovette
essere diffuso. Per quanto riguarda gli antecedenti del romanzo, o per meglio dire le fonti, possiamo
pensare in primis all’Odissea, con i resoconti di avventure e di viaggi e con il lieto fine che
corrisponde al nòstos e al ritorno in patria dell’eroe per ricongiungersi con la moglie. Tra le fonti
non bisogna dimenticare le digressioni novellistiche di Erodoto e di altri storici, nonché la tragedia e
la commedia in cui il fato regola le vicende dei protagonisti. I romanzi sono, quindi, indice di un
desiderio di evasione in un’epoca in cui la vita politica e militare non impegnano più; il cittadino,
ormai relegato a suddito, non riconoscendosi in una realtà che è sempre più vasta, è portato a
sognare mondi e storie impossibili. Tali romanzi non sono affatto collocabili nello spazio e nel
tempo, i mondi ed i paesaggi descritti appartengono alla fantasia e invano cercheremmo
l’autobiografismo dell’autore, o qualche indizio di introspezione dei personaggi. Il loro mondo si
risolve nell’agire ed essi sono semplicemente delle “maschere”, dei prototipi di tipi umani. Si è
detto che il mondo degli dei è completamente assente dal romanzo, sostituito dalla Tyche che è
sovrana, come era già evidente nelle tragedie euripidee. La civiltà che fa da sfondo alle vicende
narrate è quella orientale e persiana, comunque lontana da quella del lettore e perciò misteriosa e
affascinante. In questo sfondo si muovono i tòpoi della commedia greca nuova: viaggi soprattutto
per mare perché più pericolosi ed insidiosi, naufragi, rapimenti, morti presunte e falsi suicidi; alla
fine vi è il riconoscimento e lo scioglimento di tutte le peripezie. Da una parte sono i buoni,
dall’altra i malvagi, senza alcuna connotazione psicologica, l’amore, spesso vero elemento
risolutore della vicenda, nasce con un colpo di fulmine e non è frutto di evoluzione o rielaborazione
di sentimenti, è solo una bella favola.
Strutturalmente la composizione fa uso di descrizioni, dialoghi e monologhi e dell’inserimento di
digressioni novellistiche per creare una sorta di romanzo nel romanzo; il linguaggio si adegua
all’effetto “sorpresa” ed ai colpi di scena che si susseguono nel complesso intrigo.
I romanzi che ci sono giunti sono:
Il romanzo di Cherea e Calliroe di Caritone (I secolo d. C.);
Le avventure di Leucippe e Clitofonte di Achille Tazio (fine II secolo d. C.);
La storia pastorale di Dafni e Cloe di Longo Sofista (fine II, inizio III secolo d. C.);
Le storie etiopiche di Teagene e Cariclea di Eliodoro (inizio III secolo d. C.).
Opportuno è invece attuare un confronto tra il Romanzo greco e quello latino al fine di evidenziarne
analogie e differenze.
I due romanzi che ci sono giunti in lingua latina sono il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di
Apuleio, opere diverse fra loro, scritte in epoche differenti, ma nelle quali possiamo enucleare
elementi comuni, come ad esempio il fatto di essere narrate in prima persona, cosa che ne mette in
luce il carattere autobiografico. Gli autori-protagonisti sono perfettamente inseriti nell’epoca in cui
vivono e nella quale si trovano a fare scelte ed esprimere pareri. Infatti nel romanzo latino la
situazione sociale e culturale è perfettamente individuabile, perchè questo è il desiderio dell’autore
che vuole esprimere un punto di vista sui propri tempi; il contesto è quindi riconoscibile,
minuziosamente descritto e spesso oggetto di riflessione critica. Tale genere non è quindi di pura
evasione e le situazioni paradossali ed umoristiche rivelano spesso amarezza e sarcasmo.
Nel romanzo in lingua latina la vicenda è spesso pretesto per indicare la scelta dell’autore e il suo
stile di vita improntato alla filosofia, l’avventura è solo marginale perchè emerga l’idea dell’autore:
113
si arriva, nel caso di Apuleio, ad un’iniziazione misterica che giustifica tutta la narrazione
rocambolesca precedente. I protagonisti dei due romanzi, Encolpio e Lucio, sono alla ricerca di uno
stile di vita in un mondo privo di certezze: per raggiungere una sorta di accettabile equilibrio
devono scendere i gradini dell’esistenza, le loro avventure sono giustificate dall’esito del loro
vagabondare.
DENTRO IL PROBLEMA
IL CULTO DI ISIDE
Iside era una divinità egizia, sposa del fratello Osiride (dio del Nilo) ucciso dal fratello Seth.
Secondo il mito, Iside riunì le parti del corpo di lui, riportandolo in vita (come racconta Plutarco nel
trattato Su Iside ed Osiride). Quando Osiride fu identificato con il dio Sole, Iside divenne la dea
della Luna, considerata una divinità associata alla magia ed all'oltretomba. Nel sincretismo tipico
della religione romana Iside venne assimilata a molte divinità femminili locali, quali Cibele,
Demetra e Cerere e molti templi furono innalzati in suo onore. Durante il periodo dell'impero il
culto di Iside si contraddistinse per la fastosità delle processioni e delle celebrazioni. Le
sacerdotesse della dea vestivano solitamente di lino bianco e si adornavano di fiori.
Il culto di Iside, oltre ai riti quotidiani che prevedevano un'invocazione mattutina al sole e un
sacrificio pomeridiano in cui veniva adorata l'acqua sacra del Nilo, era celebrato durante due feste:
la prima era detta "la navigazione di Iside", ed è raccontata da Apuleio nelle Metamorfosi in
occasione della festa della dea a Corinto.
Apuleio, Metamorfosi, XI, 1
Circa primam ferme noctis vigiliam experrectus pavore subito, video praemicantis lunae
candore nimio completum orbem commodum marinis emergentem fluctibus; [2] nanctusque opacae
noctis silentiosa secreta, certus etiam summatem deam praecipua maiestate pollere resque prorsus
humanas ipsius regi providentia, nec tantum pecuina et ferina, verum inanima etiam divino eius
luminis numinisque nutu vegetari, ipsa etiam corpora terra caelo marique nunc incrementis
consequenter augeri, nunc detrimentis obsequenter imminui, [3] fato scilicet iam meis tot tantisque
cladibus satiato et spem salutis, licet tardam, subministrante augustum specimen deae praesentis
statui deprecari; [4] confestimque discussa pigra quiete <laetus et> alacer exurgo meque protinus
purificandi studio marino lavacro trado septiesque summerso fluctibus capite, quod eum numerum
praecipue religionibus aptissimum divinus ille Pythagoras prodidit, [laetus et alacer] deam
praepotentem lacrimoso vultu sic adprecabar.
1 [1]
Mi svegliai all’improvviso spaventato verso le prime ore della notte, il disco rotondo della luna
brillava di un candore abbagliante, sorgendo dalle onde del mare; preso dai misteriosi silenzi
della notte buia, ero certo che la nobile dea imperava col suo potere e governava le cose umane e
non solo gli animali domestici e selvaggi, ma anche le cose inanimate ricevevano dalla sua luce
114
e dal suo potere la forza, e gli stessi corpi celesti, marini e terrestri crescevano e diminuivano al
suo volere. Poiché il destino sembrava smettere di perseguitarmi e mi offriva una seppur tarda
speranza di salvezza, decisi di pregare l’augusta benignità della dea e, scossa di dosso la pigrizia,
lieto e deciso mi alzai, m’immersi nel mare e mi purificai sette volte nei flutti immergendovi la
testa, come il divino Pitagora consiglia in quanto tale numero è adatto ai riti, quindi levai una
preghiera alla dea potentissima con volto lacrimoso.
ibidem XI, 3 – 4
3 [1] Ad istum modum fusis precibus et adstructis miseris lamentationibus rursus mihi marcentem
animum in eodem illo cubili sopor circumfusus oppressit. [2] Necdum satis conixeram, et ecce
pelago medio venerandos diis etiam vultus attollens emergit divina facies; ac dehinc paulatim toto
corpore perlucidum simulacrum excusso pelago ante me constitisse visum est. … [4] Iam primum
crines uberrimi prolixique et sensim intorti per divina colla passive dispersi molliter defluebant.
Corona multiformis variis floribus sublimem destrinxerat verticem, cuius media quidem super
frontem plana rutunditas in modum speculi vel immo argumentum lunae candidum lumen emicabat,
[5] dextra laevaque sulcis insurgentium viperarum cohibita, spicis etiam Cerialibus desuper
porrectis conspicua. Tunica multicolor, bysso tenui pertexta, nunc albo candore lucida, nunc
croceo flore lutea, nunc roseo rubore flammida et, quae longe longeque etiam meum confutabat
optutum, palla nigerrima splendescens atro nitore, quae circumcirca remeans et sub dexterum latus
ad umerum laevum recurrens umbonis vicem deiecta parte laciniae multiplici contabulatione
dependula ad ultimas oras nodulis fimbriarum decoriter confluctuabat. 4 [1] Per intextam
extremitatem et in ipsa eius planitie stellae dispersae coruscabant earumque media semenstris luna
flammeos spirabat ignes. Quaqua tamen insignis illius pallae perfluebat ambitus, individuo nexu
corona totis floribus totisque constructa pomis adhaerebat. Iam gestamina longe diversa. [2] Nam
dextra quidem ferebat aereum crepitaculum, cuius per angustam lamminam in modum baltei
recurvatam traiectae mediae paucae virgulae, crispante brachio trigeminos iactus, reddebant
argutum sonorem. [3] Laevae vero cymbium dependebat aureum, cuius ansulae, qua parte
conspicua est, insurgebat aspis caput extollens arduum cervicibus late tumescentibus. Pedes
ambroseos tegebant soleae palmae victricis foliis intextae.
Così invocai la dea e lamentai la mia sorte, e di nuovo l’animo stanco fu oppresso dal sonno
nello stesso luogo. Dormivo da poco quando dal mare emerse una forma divina che mostrava un
volto venerabile anche per gli dei. A poco a poco mi sembrò che il corpo luminoso emergendo
completamente dall’acqua si fermasse vicino a me. ... I capelli erano lunghi, fluenti e sparsi
intorno al collo delicatamente. Una corona con fiori multiformi le ornava la testa, nel mezzo
sulla fronte splendeva un tondo a forma di specchio, anzi una candida luce di luna, ai lati era
adorna di vipere che si ergevano e si aggiungevano spighe di frumento sporgenti. La copriva una
tunica di bisso multicolore, ora bianca splendente, ora gialla come il croco, ora fiammante di
rosso; inoltre mi confondeva la mente un mantello di un nero splendente che le girava intorno e
passandole sotto il braccio destro, arrivava alla spalla sinistra con un ricco panneggio. Le frange
pendevano svolazzanti in maniera elegante. Per tutta la veste splendevano stelle sparse e una
luna piena nel mezzo dardeggiava rossi bagliori. Tutt’intorno il bordo del bellissimo manto aveva
una continua corona di fiori e frutta. C’erano ornamenti diversissimi. Nella mano destra portava
un sonaglio d’oro (il sistro) con una lamina sottile curva a mo’ di scudo e con alcune verghette
per traverso che mandavano un suono squillante quando scuoteva tre volte il braccio. Dalla
sinistra le pendeva un vaso d’oro a forma di barca, dal cui manico si ergeva un aspide con la
testa eretta e gonfia. Le coprivano i piedi profumati d’ambrosia dei sandali intessuti con foglie di
palma vincitrice.
ibidem XI, 13
115
At sacerdos, ut reapse cognoscere potui, nocturni commonefactus oraculi miratusque
congruentiam mandati muneris, confestim restitit et ultro porrecta dextera ob os ipsum meum
coronam exhibuit. [2] Tunc ego trepidans, adsiduo pulsu micanti corde, coronam, quae rosis
amoenis intexta fulgurabat, avido ore susceptam cupidus promissi devoravi. [3] Nec me fefellit
caeleste promissum: protinus mihi delabitur deformis et ferina facies. [4] Ac primo quidem squalens
pilus defluit, ac dehinc cutis crassa tenuatur, venter obesus residet, pedum plantae per ungulas in
digitos exeunt, manus non iam pedes sunt, [5] sed in erecta porriguntur officia, cervix procera
cohibetur, os et caput rutundatur, aures enormes repetunt pristinam parvitatem, dentes saxei
redeunt ad humanam minutiem, et, quae me potissimum cruciabat ante, cauda nusquam! …..
[1]
Il sacerdote, come seppi, avvisato da un sogno e stupito dell’esattezza dell’informazione, si fermò
e con la destra mi porse la corona alla bocca. Allora io, tremante e col cuore in gola, divorai la
corona, fulgida di rose in fiore, con avidità, desideroso della promessa. La divina profezia non
m’ingannò: subito mi scomparve la forma bestiale. Dapprima cadde il pelo, poi si assottigliò la
pelle spessa, il ventre prominente rientrò, le piante dei piedi divennero dita, le zampe anteriori
divennero mani utili per nobili azioni, il lungo collo si accorciò, il capo e la bocca divennero
tondi, le grandi orecchie ripresero la dimensione originale, le zanne divennero denti umani,
infine sparì la coda, che prima mi tormentava moltissimo.
ibidem XI, 16
Inter haec et festorum votorum tumultum paulatim progressi iam ripam maris proximamus
atque ad ipsum illum locum quo pridie meus stabulaverat asinus pervenimus. [6] Ibi deum
simulacris rite dispositis navem faberrime factam picturis miris Aegyptiorum circumsecus
variegatam summus sacerdos taeda lucida et ovo et sulpure, sollemnissimas preces de casto
praefatus ore, quam purissime purificatam deae nuncupavit dedicavitque. [7] Huius felicis alvei
nitens carbasus litteras [votum] <auro> intextas progerebat: eae litterae votum instaurabant de
novi commeatus prospera navigatione. ….. [9] Tunc cuncti populi tam religiosi quam profani vannos
onustas aromatis et huiusce modi suppliciis certatim congerunt et insuper fluctus libant intritum
lacte confectum, donec muneribus largis et devotionibus faustis completa navis, absoluta strophiis
ancoralibus, peculiari serenoque flatu pelago redderetur.
….. [5]
Nel frattempo, fra il tumulto della festa, giungemmo alla riva del mare e al luogo dove io da
asino mi ero riposato. Lì vennero disposti i simulacri degli dei sulla nave fatta a regola d’arte,
adorna d’egregie pitture egizie e il sommo sacerdote la purificò con una fiaccola splendente, un
uovo e dello zolfo e la offrì e la dedicò alla dea, con preghiere solennissime dette con pura bocca.
La vela nitida di questa fortunata nave portava una scritta d’oro in voto per augurare una
prospera navigazione ai futuri commerci. ... Allora tutti, sia profani che iniziati, fecero a gara a
portare setacci ripieni d’aromi e d’altre offerte e libarono sui flutti focacce intrise di latte finché
la nave, ricca di doni e di fauste offerte, fu liberata dalle gomene che la trattenevano e fu lasciata
al mare con vento propizio.
In questo brano Apuleio si riferisce alla festa del navigium Isidis, celebrata a Roma il cinque marzo.
Era una festa legata al mare e consisteva essenzialmente nel consacrare alla dea una nave che poi si
spingeva in acqua; la processione si recava dal tempio alla spiaggia, dove aveva luogo la sacra
cerimonia. La dea egizia, che simboleggiava la forza produttrice della natura, era considerata la
dispensatrice del latte all'umanità nascente e alla presenza del popolo si facevano libagioni.
116
La seconda festa, detta Isia, era celebrata dal 13 al 16 novembre e commemorava il ritrovamento
del corpo di Osiride.
Spesso il culto di Iside era misterico, cioè veniva celebrato da fedeli iniziati ai suoi misteri in
segreto, e specie nel periodo imperiale ebbe grande successo perché rispondeva al bisogno di
misticismo, tipico dei culti orientali ed alle esigenze spirituali ignote alla religione ufficiale.
Il brusco risveglio di Lucio nel cuore della notte, con cui si apre l'ultimo libro delle Metamorfosi,
descrive la purificazione rituale e la preghiera alla Luna in un clima mistico: Lucio riprenderà forma
umana mangiando un cespo di rose recato da un sacerdote nella processione in onore di Iside,
secondo quanto la stessa dea gli aveva prescritto quando gli apparve sulla spiaggia. Grato alla dea,
Lucio si fa iniziare al culto di Iside a Corinto e, stabilitosi a Roma per volere di Osiride, si dedica a
patrocinare le cause nel foro.
La vicenda del protagonista è la denuncia della violenza in cui Lucio-asino s’imbatte. La sua
metamorfosi in asino è una sorta di espiazione: l’uomo ha la colpa di voler conoscere e solo dopo
aver scontato la sua arroganza si può salvare, convertendosi e diventando sacerdote del culto di
Iside.
Nel terzo capitolo del libro XI è narrata l’epifania di Iside in maniera molto dettagliata e ricorda da
vicino alcune rappresentazioni iconografiche della Madonna, soprattutto dell’Immacolata, segno
che il cristianesimo rielaborò le immagini pagane.
DENTRO IL PROBLEMA
IL NUOVO TESTAMENTO
Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri scritti in greco (ad eccezione della redazione
originaria di quello di Matteo che era in aramaico, poi tradotto in greco) e narrano la vita e la
predicazione di Gesù di Nazareth. Il termine “nuovo” indica il nuovo patto stabilito da Dio con gli
uomini per mezzo di Gesù Cristo.
I Vangeli sono quattro, tre sinottici (cioè che seguono lo stesso scema cronologico – narrativo
della vita di Gesù): quelli di Matteo, Marco e Luca, mentre quello di Giovanni ha un’impostazione
teologica ed identifica Dio con il Lògos (ragione e parola).
Luca, oltre al Vangelo, scrisse anche gli Atti degli Apostoli, in cui narra la storia delle prime
comunità cristiane e abbraccia un periodo di tempo che va dall’ascensione di Cristo all’arrivo a
Roma di Paolo.
Le Lettere di San Paolo sono degli scritti inviati dal santo a varie comunità cristiane in risposta ad
esigenze organizzative o a temi teologici, insieme a regole relative al comportamento quotidiano dei
fedeli. Tali scritti sono documenti che testimoniano la genesi del cristianesimo ai suoi albori. Sono
composte dalla lettera ai Tessalonicesi, ai Galati, ai Corinzi (due), ai Romani, ai Filippesi, a
Filemone, ai Colossesi, agli Efesini e le lettere pastorali, due a Timoteo e una a Tito.
La Lettera agli Ebrei potrebbe essere un'antica omelia rivolta a cristiani di origine ebraica tentati
di ritornare alle istituzioni giudaiche; si dubita della paternità paolina. L'autore conosceva molto
bene i rituali ebraici, le Scritture di Israele e le loro tecniche interpretative.
Le altre lettere sono dette cattoliche, perché indirizzate non alla comunità cristiana di una città
particolare, ma a tutte le chiese, o più semplicemente perché non hanno precisato il destinatario.
117
Esse sono le due Lettere di Pietro, la Lettera di Giacomo, la Lettera di Giuda e le tre cosiddette
Lettere di Giovanni.
L'Apocalisse di Giovanni chiude il Nuovo Testamento, trattando temi desunti dalle profezie
veterotestamentarie reinterpretate e utilizzate alla luce della fede in Cristo e del suo trionfo finale.
Tra Antico e Nuovo Testamento c’è sicuramente continuità: il Nuovo Testamento porta a
compimento l’Antico e si fonda sull’evento della Resurrezione di Gesù Cristo. La conversione al
Nuovo Testamento si realizza quando si comprende e si crede che con Gesù si è aperto il tempo
finale nella storia della salvezza. Il passaggio al Nuovo Testamento richiede un salto di fede, perché
occorre riconoscere che la morte di Gesù in croce, la più vergognosa ed impura, è il segreto usato
da Dio per confondere i sapienti. Fondandosi su una situazione privilegiata, di chi ha veduto e
ascoltato, l’attività propria dell’evangelista è la testimonianza diffusa mediante il kèrygma, cioè la
predicazione. Testimonianza è fedeltà a un’esperienza e coraggio per annunciarla; kèrygma è
irruzione, espansione, potenza, notorietà: è la grande novità contenuta nei Vangeli. Intorno all’anno
70 d.C. Marco compose in greco il primo Vangelo, probabilmente sotto la spinta di più di una
motivazione: perché andavano scomparendo i testimoni, per riequilibrare l’accentuazione a-storica
data da Paolo all’annuncio cristiano, perché era necessario mettere in guardia da travisamenti
storico-dottrinali e perché si andavano diffondendo degli apocrifi. E’ opinione molto diffusa che
Marco sia stato il primo evangelista, anche se l’affermazione non è documentabile con certezza. Il
lavoro fu comunque quello di raccogliere in un’unica narrazione il materiale frammentario della
tradizione, fatto di episodi separati. I Vangeli, ad eccezione di quello di Giovanni, seguono una
narrazione sinottica. Dentro tale schema ogni evangelista ha disposto i vari episodi, facendosi
guidare dalla sua sensibilità di credente e di catechista, sottolineando ciò che gli era più congeniale
o ciò che era più urgente per i suoi lettori, operando piccoli adattamenti, aggiungendo episodi che
non erano conosciuti agli altri evangelisti, congiungendo con piccole frasi di sutura una narrazione
all’altra. Gli evangelisti sono, dunque, veri autori, tanto dal punto di vista letterario che dal punto di
vista teologico. I Vangeli sono però fonti storiche non primarie, dal momento che i materiali in
essi raccolti non derivano solo da testimoni diretti. Per questo un giudizio sul loro valore storico
non può essere adeguato se non si tiene conto di ciò che l’evangelista ha messo di suo, sia dal punto
di vista stilistico-letterario, sia dal punto di vista teologico. La storia di Gesù è comunque reale: egli
si era circondato di testimoni e aveva dato un insegnamento rimasto nella loro memoria. Del resto
va ricordato che i maestri giudaici utilizzavano delle tecniche mnemoniche e va anche tenuta
presente la grande capacità degli antichi di memorizzare e di trasmettere oralmente le loro
tradizioni. Evangelisti e testimoni oculari costituiscono una linea continua, anche se non diretta, di
trasmissione che risale fino a Gesù come figura storica e che quindi è storicamente attendibile.
DENTRO IL PROBLEMA
LE ERESIE
Combattute dai grandi scrittori cristiani detti Padri della Chiesa, le eresie sorsero all’inizio negli
stessi ambienti giudaici, poi con il II secolo si svilupparono anche in ambiente pagano come
accadde per lo Gnosticismo (dal greco gnosi, conoscenza approfondita), tentativo di dare al
cristianesimo una complessa dignità filosofico-religiosa; fu dapprima una semplice corrente
all’interno della Chiesa, poi ne stravolse gli immutabili principi di fede. I suoi seguaci furono
scomunicati dai papi Igino ed Aniceto. Fu merito di Tertulliano, strenuo difensore della tradizione
apostolica, se con i trattati Adversus Marcionem, Adversus Valentinianos, Adversus Hermogenem
la gnosi fu definitivamente sconfitta.
118
Il Montanismo affermava la superiorità dei profeti sul clero istituzionale e dava molto spazio alla
partecipazione delle donne ai riti. Sosteneva l’imminente avvento della parusìa, suggerita, forse,
dall'Apocalisse. Di conseguenza il comportamento dei montanisti era estremamente severo e
intollerante di qualsiasi concessione alle esigenze del corpo. Anche Tertulliano negli ultimi anni
della sua vita fu attratto da tale eresia.
Altra eresia diffusa dal I al IV secolo fu il Docetismo, una dottrina il cui nome deriva dal verbo
greco dokéin (sembrare). La caratteristica di questa eresia consisteva nel negare che Cristo incarnato
avesse la natura umana, con la conseguente negazione della sofferenza durante la passione e la
morte. L’eresia fu combattuta fra gli altri, da Tertulliano e S. Agostino.
Tra il II e il III secolo sarà il dogma della Trinità ad essere messo in discussione sino ad arrivare
all’Arianesimo. Ario era un prete alessandrino che sosteneva che il Figlio non è consustanziale al
Padre, ma è subordinato a Lui. Si diffuse specialmente in Oriente fra i Goti; nel IV secolo si mise in
discussione la divinità del Verbo (Logos), subordinando anche questo al Padre. Coloro che
s’impegnarono con dei trattati contro questa eresia, furono S. Ilario di Poitiers con il De Trinitate in
12 libri e Contra Constantium; S. Ambrogio con il De fide, De Spiritu sancto, De Incarnatione,
composti per desiderio dell’imperatore Graziano, e S. Agostino con il Contra sermonem
Arianorum. L’Arianesimo fu condannato nel primo concilio di Nicea del 325 da papa Silvestro.
In Oriente si riaccenderà nel V secolo il problema cristologico con i Nestoriani che negavano
l’unità della persona di Cristo, attribuendogli due distinte nature, quella umana e quella divina;
prendevano il nome da Nestorio, teologo di Antiochia e vescovo di Costantinopoli; l’eresia fu
condannata dal concilio di Efeso del 431. Per reagire ad eresie del tipo di quella nestoriana, i
Monofisiti equivocavano sulla natura del Figlio. Il monaco Eutiche di Costantinopoli formulò l’idea
che in Cristo fosse presente la sola natura divina (mone physis, una natura), da cui derivò il nome
dell’eresia. Fu condannata dal concilio di Calcedonia del 451.
In Occidente nel V secolo invece si disputava sul problema della Grazia con i Donatiani (dal
monaco Donato, vescovo di Cartagine) ed i Pelagiani (dal nome del monaco Pelagio), combattuti
da S. Agostino e S. Girolamo che scrissero varie opere soprattutto contro la dottrina di Pelagio che
negava la Grazia divina, identificandola con il libero arbitrio. I Donatiani invece sostenevano che i
sacramenti non erano validi di per sé, ma a seconda del sacerdote che li somministrava.
L’ultimo movimento contro cui la patristica si impegnò fu quello iconoclasta (dal greco eikòn
immagine e klào rompo, distruttore d’immagini), verificatosi nella Chiesa bizantina del secolo VIII.
L’imperatore Leone III l’Isaurico nel 726 proibì la presenza nelle chiese delle immagini sacre,
anche di Cristo e della Madonna. Ci fu una violenta reazione anche da parte dei monaci, che causò
non pochi morti in nome della fede. L’eresia fu condannata nel secondo concilio di Nicea del 787.
DENTRO IL PROBLEMA
LA LETTERATURA APOLOGETICA
in greco significa parlo in mia difesa; gli obiettivi degli apologisti, i cui massimi
esponenti furono Giustino e Tertulliano, erano, infatti, prevalentemente i seguenti: denunciare gli
119
abusi dello Stato romano imputato di discriminare ingiustamente la religione cristiana; confutare le
accuse, spesso infamanti, indirizzate contro i cristiani; attaccare la stessa religione pagana,
rendendone evidenti le incongruenze e le assurdità.
Spesso, tuttavia, gli aspetti difensivi si mescolano ad atteggiamenti più propriamente fideistici,
perché la nuova religione, fondandosi su un messaggio di redenzione universale, implica l’annuncio
della fede cristiana presso coloro che ancora non credono. L’esigenza di conquistare nuovi fedeli e
diffondere il messaggio cristiano, insieme alla necessità di difendere l’ortodossia della fede dal suo
interno, confutando le eresie nascenti, determinano l’impegno dei primi intellettuali cristiani, nel
divulgare, attraverso gli scritti, il loro pensiero.
E’ da ricordare che la letteratura cristiana in lingua latina si manifesta dopo quella in lingua greca,
probabilmente perché il Cristianesimo si diffonde inizialmente in ambienti ellenizzati e solo più
tardi conquista l’Occidente. Anche la lingua ufficiale della Chiesa inizialmente è il greco. Solo
successivamente, intorno al II secolo, cominciano ad apparire le prime manifestazioni letterarie in
lingua latina di scrittori della provincia d’Africa, probabilmente perché qui il greco aveva avuto una
scarsa penetrazione ed il latino si era imposto come lingua ufficiale dell’impero, determinando così
il suo utilizzo anche all’interno della comunità cristiana.
Per più di un secolo, l’apologetica costituì l’espressione più alta della letteratura latina cristiana con
esiti diversificati. Passiamo, così, dall’apertura conciliante di Minucio Felice ai toni aspri e
intolleranti di Tertulliano, a quelli sarcastici e aggressivi di Arnobio, o a quelli di stampo più
squisitamente dottrinale di Lattanzio. Diverse sono anche le tipologie letterarie utilizzate: dal
dialogo filosofico alla lettera, al trattato, senza dimenticare gli scritti in versi. Anche lo stile è
diversificato: dai toni baroccheggianti e strepitosi di Tertulliano si arriva a quelli ciceroniani di
Minucio Felice e di Lattanzio.
DENTRO IL TESTO
Tertulliano, Apologeticum IV, 3 - 9
Sed quoniam: il nesso avversativo esprime il passaggio dalla parte introduttiva del capitolo, in cui
l’autore sostiene con foga di voler controbattere le accuse mosse contro i cristiani, alla confutazione
della legittimità delle procedure adottate nei processi.
Cum ... consistam vobiscum: il periodo è formato da una causale (quoniam. . . obstruitur) da cui
dipende una concessiva (cum ... occurrit veritas nostra), che regge a sua volta una consecutiva (ut
... dicatur) seguita da un’infinitiva (retractandum esse) e un’altra consecutiva (aut ... praeferatur);
la proposizione principale è posta in fondo (de legibus...consistam). Il neutro plurale omnia si
riferisce a tutte le accuse formulate contro i cristiani. Veritas è la verità della fede esplicitata nei
comportamenti dei cristiani. Ingratis è aggettivo sostantivato.
Ut ... tutoribus legum: Tertulliano si rivolge ai magistrati della provincia d’Africa, che avevano
poteri giurisdizionali ed amministrativi e presiedevano all’applicazione delle leggi. Essi non
potevano, di conseguenza, formulare o riformulare le leggi, ma potevano usare la loro influenza
presso l’imperatore, o esercitare un potere discrezionale, che veniva loro concesso per evitare che si
infierisse contro i cristiani.
Iam primum: ha inizio la lunga requisitoria di Tertulliano che parla a nome dei cristiani privati del
diritto di replica nei processi.
120
Cum praescribitis: il cristianesimo è considerato, fino dall’età di Nerone, non una religione
legittima (religio licita), ma un’illecita superstizione (superstitio illicita) e quindi soggetta, per
legge, a condanna.
Vim profitemini ... licere: Tertulliano sostiene che il diritto di esistere viene negato ai cristiani
unicamente perché i Romani non vogliono concederlo, non perché non debba essere concesso.
Ex arce dominationem: l’espressione latina significa “dominio da una rocca”, forse è una locuzione
per dire “dominare dall’alto”, dal proprio castello, come avviene per il tiranno.
Quodsi ... bene fit: il periodo, retoricamente complesso, risulta così composto: quodsi (= et si hoc)
ideo noluistis licere è la protasi del periodo ipotetico della realtà da cui dipende la proposizione
causale quia ... licere; sine dubio id non debet licere è l’apodosi del periodo ipotetico, da cui
dipende la proposizione relativa quod male fit; et utique … licere è apodosi coordinata alla
precedente, da cui dipende la relativa quod bene fit, in antitesi rispetto alla precedente (quod male
fit).
Si bonum invenero … iure prohiberet?: Si invenero è la protasi di un periodo ipotetico della realtà,
da cui dipende l’infinitiva bonum esse; quod… prohibuit è espansione relativa; nonne… potest:
l’interrogativa diretta è l’apodosi del periodo ipotetico introdotta dalla particella nonne che
presuppone una risposta orientata positivamente; (hoc) quod ... prohiberet: la relativa costituisce
l’apodosi di un periodo ipotetico dell’irrealtà, del quale la protasi è si malum esset. Il periodo è tutto
centrato sull’opposizione bene/male. Da rilevare l’insistenza sul concetto di proibizione, scandita
dal poliptoto prohibuit/prohibere/prohiberet.
Si lex … ruit: periodo ipotetico di primo tipo. Se dunque, argomenta Tertulliano, la legge è opera
dell’uomo non solo è suscettibile di errore, ma può essere mutata. Il termine lex, che ricorre più
volte nel testo, appartiene, analogamente a ius, praeiudico, praeiudicium al lessico giudiziario.
Miramini … in reprobanda?: l’interrogativa retorica, non introdotta da alcuna particella, è propria
del discorso forense in cui è sufficiente la sola intonazione della voce per conferire efficacia alla
domanda; in lege condenda e in reprobanda formano un parallelismo con antitesi; resipuisse …
reprobanda è allitterazione. L’uso di un verbo che indica stato d’animo (miror), l’insistenza sul
concetto di errore (erravit/errare) e l’accostamento miror/homo in apertura del periodo,
sottolineano efficacemente l’idea di imperfezione delle leggi umane.
Non enim … iudicarit!: altra interrogativa retorica. Emendatae è participio attributivo di leges.
Semetipso è forma pronominale rinforzata.
Nonne ... ruspatis et caeditis: Tertulliano procede nell’argomentazione tramite il ricorso ad un
periodare ampio e ad effetto che coinvolge emotivamente l’ascoltatore. Experimentis ... antiquitatis
è ablativo assoluto. Nel testo è presente, accanto alla metafora dell’esperienza che rischiara le
tenebre, quella della scure che si abbatte sulle leggi per sfrondarle: novis... securibus et caeditis.
L’iperbato (novis … securitis) e l’addensarsi di immagini conferiscono al discorso una particolare
intensità espressiva; rescriptorum et edictorum: i rescritti sono ordinanze dell’imperatore a privati,
o a pubblici funzionari, in risposta ad interrogazioni su questioni di dubbia interpretazione nella
pratica quotidiana. Gli editti sono decreti rivolti a governatori delle province, in relazione ai modi di
amministrare i territori loro assegnati in giurisdizione.
Nonne ... exclusit?: a conferma di leggi abrogate o modificate, in quanto inutili o contrarie alla
giustizia, l’autore fornisce due esempi, dilatando il suo ragionamento per riprendere poi, in modo
121
serrato, il filo del discorso. Primo esempio: la lex Papia Poppea del 9 d. C. impediva al vedovo di
ereditare dal coniuge scomparso, in mancanza di figli. Settimio Severo aveva apportato alcune
modifiche a questa legge, perché non fosse in contraddizione con la lex Iulia de maritandis
ordinibus, adeguandone i limiti di età.
Sed … erasa est … quam effundere: il secondo esempio è tratto dall’antico diritto romano che
poneva il debitore insolvente in balia del creditore che poteva ucciderlo o venderlo come schiavo.
La lex Petelia del 326 a. C. aveva attenuato la crudeltà di questa legge, commutando la pena di
morte in una nota di infamia (in pudoris notam capitis poena conversa est): con la confisca dei beni
si preferì che il sangue inondasse per la vergogna il viso dell’uomo piuttosto che fosse sparso.
DENTRO IL PROBLEMA
Il problema del tradurre
Per conoscere i testi di una lingua che non è la nostra si deve ricorrere alla traduzione: travagli e
ripensamenti si alternano e siamo consapevoli che il testo che ne verrà fuori sarà “altro”, cioè
diverso da quello di partenza. Si cerca d’interpretare per ritrovare l'intenzione del testo: il problema
principale è come ottenere fedeltà.
Già Cicerone (Libellus de optimo genere oratorum V, 14) e Orazio (Ars poetica 38-62)
raccomandavano di non tradurre verbum pro verbo. S. Girolamo (Epistola LVII, 5 Ad
Pammachium) consiglia di rendere verbum e verbo per i testi sacri e sensum exprimere de sensu
negli altri casi.
In latino translatio ha il senso di “cambiamento, trasporto”, solo in Seneca appare come “versione
da una lingua all’altra”; traducere significa “condurre oltre” e il passaggio di senso al “tradurre”
sembra sia dovuto ad un’erronea interpretazione di Leonardo Bruni di un passo di Gellio (Noct. Att.
I, 18): “Vocabulum graecum vetus traductum in linguam Romanam”, in cui s’intendeva parlare del
“trapianto” della parola greca nella lingua romana.
Oggi il problema, nota Umberto Eco in un suo saggio3, è particolarmente sentito per i fenomeni
della globalizzazione e per l'espansione dell'informatica e dei suoi modelli di traduzione artificiale.
Nella traduzione meccanica tradurre è dare l'equivalenza di significato, gli omonimi, mentre i
sinonimi esprimono concetti diversi. La traduzione automatica, che ricalca i meccanismi del
cervello (cibernetica), si presta abbastanza bene per la letteratura scientifica, mentre ben altre sono
le esigenze del tradurre poesia, filosofia o testi sacri.
Solo la traduzione poteva garantire che l'uomo moderno non fosse privo della saggezza del passato
e la storia del pensiero occidentale coincide con quella della traduzione, basti pensare al Nuovo
Testamento di Erasmo (1516) e alla Bibbia di Lutero (1522-34): la letteratura dipende dalla
traduzione, noi possediamo la civiltà perché abbiamo imparato a tradurre e ciò implica lo studio dei
problemi del linguaggio.
Si può sostenere che tradurre sia impossibile, ma negare la traduzione significherebbe negare il
linguaggio. Purtroppo nessuna duplicazione è perfetta, ma ciò che c’interessa è il grado di fedeltà:
serve un compromesso di buon senso tra gli estremi, tenendo presente non solo il manuale
linguistico, ma anche uno di antropologia culturale per dare un'ipotesi interpretativa sui livelli di
senso da privilegiare.
Le diverse sostanze dell'espressione e del contenuto, ovvero i diversi livelli, devono essere
evidenziati: nella poesia, per esempio, è l'espressione che detta le leggi al contenuto, considerando
inoltre che le frasi idiomatiche o i modi di dire non andrebbero tradotti letteralmente, ma scegliendo
3
U. Eco, Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, MI 2003
122
l'equivalente nella lingua d'arrivo. Si può concludere che la traduzione ottimale deve permettere di
mantenere la maggiore reversibilità possibile. Omero si può tradurre in prosa, in base al criterio che
l'epica dei suoi tempi equivale alla nostra prosa narrativa, secondo la funzione del testo (cfr.
l’epistola a Pammachio sopra riportata).
Tradurre è interpretare, ma un'interpretazione non è sempre una traduzione, l'interpretazione può
dare di più o di meno rispetto al testo-fonte. Il significato da esprimere, come dice Umberto Eco,
deve quindi essere negoziato e, per bene che vada, traducendo si dice “quasi la stessa cosa”.
George Steiner, in un ponderoso volume sull’argomento4, preferisce intendere la traduzione non
come questione a sé, ma come un caso particolare del rapporto di comunicazione: l’esecuzione è
un’interpretazione e tra due esecuzioni c’è una variazione non solo formale, cioè di linguaggio, ma
di sostanza.
La poesia, comunque, è forse impossibile da tradurre, sicuramente è più difficile da rendere di ogni
altro testo per una serie di costrizioni che vincolano il contenuto: per ciò spesso si punta al
rifacimento radicale, cioè a un vistoso esempio di licenza interpretativa non reversibile.
È interessante notare, inoltre, come una traduzione segua le caratteristiche proprie di una lingua:
rispetto alle altre l’inglese necessita di meno parole e meno righe, il tedesco di più righe e meno
parole (per i suoi lunghi composti), l’italiano ed il francese si equivalgono, se il testo inglese è di
una pagina, le altre lingue dovranno utilizzare anche la successiva.
Del resto l’“interpretazione” nel campo delle arti non è “traduzione” e il regista non è il traduttore,
ma si firma come autore di un nuovo film; in quest’ultimo caso cambia la materia. Definiremmo
adattamenti o trasmutazioni le versioni dei romanzi in film o in testi teatrali, delle favole in balletti,
delle musiche classiche in cartoni animati, ma tutto ciò va distinto dalle traduzioni propriamente
dette.
In conclusione possiamo affermare con tranquillità che la “fedeltà” non porta ad un’unica
traduzione, ma è importante tenere ben fermo il principio che tradurre sia sempre possibile, se
s’interpreta il testo cercandone il senso profondo.
4
G. Steiner, After Babel, London, Oxford U.P. 1975
123