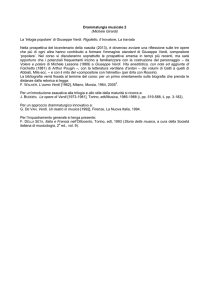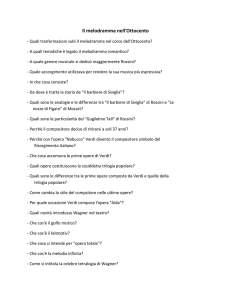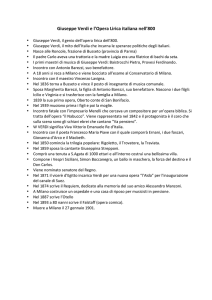UTE
Anno 2012/2013
IL PERCORSO UMANO E ARTISTICO
DI GIUSEPPE VERDI
Programma (per punti sintetici)
1. Il Romanticismo italiano e il melodramma
2. Le fasi evolutive del melodramma verdiano:
I) I sentimenti “corali” (Nabucco)
II) Lo studio dei “temperamenti” individuali della personalità umana
(Ernani, Attila)
III) Il processo interiore del personaggio (Rigoletto, Traviata)
IV) L’esperienza sociale dei rapporti umani (Don Carlo, Aida,
Simon Boccanegra)
V) Dal dramma alla tragedia e alla commedia (Otello, Falstaff)
PARTE I
IL MELODRAMMA
1. Definizione di “opera” e “melodramma”
Il vocabolo “opera” (dal latino opus/opera = lavoro), come il suo sinonimo “melodramma” (dal
greco melos = melodia, canto, e drama = azione scenica) indica la rappresentazione scenica di
un’azione in cui i personaggi si esprimono mediante il canto.
Perché un’opera sia considerata tale non è sufficiente che un testo drammatico sia accompagnato
dalla musica. Più arti concorrono alla formazione di un melodramma: la poesia, la musica (nelle
varie espressioni di canto solistico e corale e dall’orchestra), la scenografia (arti figurative e
architettura), la recitazione, la pantomima, la danza.
È del tutto gratuito indicare come “precedenti storici” dell’opera tutte quelle forme miste di parola e
musica che all’opera stessa furono precedenti solo nel tempo ma non nell’intenzione: Dramma
Liturgico, Sacra Rappresentazione, Intermedi etc. . L’opera nacque quando si ebbe la coscienza di
voler creare quella forma di rappresentazione melodrammatica.
(da Dizionario della musica e dei musicisti, ed. UTET, 1984)
2. Le origini del melodramma
Il melodramma è creazione prettamente e tipicamente italiana. Esso nacque a Firenze,
attraverso i tentativi e gli esperimenti d’un cenacolo di umanisti e di cultori d’arte che si riunivano
dapprima in casa di Giovanni Bardi conte di Vernio, poi, dopo il 1592, quando questi si trasferì a
Roma, in casa di Jacopo Corsi, dove convenivano il poeta Ottavio Rinuccini, il trattatista Gerolamo
Mei, i musicisti e cantori Jacopo Peri e Giulio Caccini, e il compositore Emilio de Cavalieri. Questi
artisti, letterati, musicisti e dilettanti, muovevano da un atteggiamento polemico verso il
contrappunto a più voci, imperante nella musica cinquecentesca, e si proponevano di ripristinare
l’antica tragedia greca, studiandosi di ricreare e far rivivere nel canto, non più polifonico, ma
monodico, non più a parecchie voci, ma a una sola voce accompagnata da strumenti, quella che,
secondo il loro concetto, doveva essere stata la declamazione praticata dai poeti e dagli attori
greci: qualcosa di mezzo fra la parola detta e la parola cantata, un’elevazione del discorso parlato
a un’enfasi canora che, nei momenti di maggiore intensità emotiva, si dilata in vero canto; ciò che
Giulio Caccini chiama appunto con felice espressione “in armonia favellare”. (…).
Il merito innegabile dei Cameratisti fiorentini sta nell’aver dato a tutti gli elementi entrati nel
quadro del melodramma una forma organica ed unitaria che rimase come modello del genere.
(…) Lo stato di transizione dal madrigale al dramma con musica, può cogliersi con molta
evidenza nella commedia madrigalesca, tipo l’Amfiparnaso di Orazio Vecchi, eseguito a Modena
probabilmente nel 1594 e stampato a Venezia tre anni dopo. Si tratta d’una piccola commedia in
cui il dialogo dei personaggi che sono quelli della commedia dell’arte e svolgono una breve azione
senza scene è affidato alle voci del coro che si esprimono nel consueto stile madrigalistico proprio
dell’epoca, con mezzi e procedimenti che sono quelli del madrigale drammatico. La trasformazione
che si andava compiendo è qui evidente. Il personaggio prossimo ad emergere dal seno della
massa corale, non se ne stacca ancora interamente. La caratterizzazione individuale si afferma
come esigenza, ma non assume ancora lineamenti definiti, non acquista una fisionomia.
E questa è l’opera dei Cameratisti fiorentini, che della voce emergente dal complesso corale,
ma tuttora anonima e impersonale, fanno una vera persona drammatica, senziente, agente,
soffrente; le danno un carattere, una coscienza, un’autonomia, un nome: Dafne, Orfeo, Euridice;
trasformano insomma la voce del coro (soprano, contralto, tenore, basso), a cui era affidata la
parte del personaggio, in creatura indipendente ed attiva che in sé incarna e raffigura la parte
stessa, trasfondendole il palpito della vita. (…) la Camerata Fiorentina non fece in sostanza che
fissare ed integrare in un’azione scenica concreta, elementi musicali e drammatici che già si erano
singolarmente determinati.
2
Si deve tuttavia agli esperimenti di casa Bardi e di casa Corsi se poté vincersi l’abitudine di
considerare come classica soltanto la musica polifonica, e se poté farsi strada il concetto
dell’attore unico, del personaggio dotato d’una vita individuale e inconfondibile, di passioni, di
affetti, d’una sensibilità, d’una espressione, anelante nella gioia o nel dolore, soggiacente al caso o
al destino. Per poco che si rifletta, si comprenderà tutta l’enorme importanza di questa
trasformazione. Era un nuovo mondo che entrava nella musica: il mondo della personalità, che
usciva dallo sfondo neutro del canto corale, e si profilava nettamente, con tratti decisi. Era
l’individuo sostituito alla collettività, il trionfo della melodia, del canto espressivo o, come dissero i
fiorentini stessi, del “recitar cantando”.
(ANTONIO CAPRI - Il Melodramma dalle origini ai nostri giorni, Ed. Guanda, 1938)
3. Gli elementi costitutivi del melodramma
Il melodramma consta di due elementi musicali distinti che sono il RECITATIVO e l’ARIA:
RECITATIVO: in esso i personaggi adottano uno stile di canto tendente a riprodurre con una
recitazione intonata la naturalezza e la flessibilità della lingua parlata; il recitativo si distingue in:
a) recitativo libero (o secco), in cui la voce è sostenuta dal solo basso continuo (generalmente il
clavicembalo);
b) recitativo accompagnato (o obbligato, o strumentato), di carattere più disteso o arioso, nel quale
alla voce si uniscono gli strumenti o più spesso l’intera orchestra.
In entrambi i casi il recitativo ha sempre la funzione di stabilire il legame fra i vari momenti
dell’intreccio della vicenda.
ARIA: si tratta di un brano per voce solista, articolato in diverse parti e con accompagnamento
strumentale. Generalmente in forma tripartita A-B-A1 col “da capo”, cioè la ripetizione (A1) della
prima parte (A), liberamente variata dall’esecutore. In termini di esperienza interiore l’aria
costituisce il momento in cui i personaggi esprimono liricamente il sentimento che nasce e fiorisce
per propria forza espansiva dalla risoluzione di un nodo drammatico, dal superamento di una
situazione critica, dalla tensione all’elevazione dello spirito o semplicemente dall’esigenza di
conoscere e obiettivare il proprio sentimento. Nel corso dei secoli, in aderenza al modificarsi delle
esigenze espressive, da queste due forme fondamentali ne nascono delle altre.
Romanza: ha praticamente la stessa forma dell’aria (termine usato nell’Ottocento)
Arioso: brano con andamento melodico intermedio fra quello dell’aria, di cui possiede l’espansione
lirica, e quello del recitativo, di cui conserva il ritmo della parola.
Es. da ORFEO (Claudio Monteverdi), Atto II, “Tu se’ morta”
Es. da ANDREA CHENIER (Umberto Giordano), Atto I, “Un dì all’azzurro spazio”
Cavatina: è un’aria in una o due parti senza ripresa “da capo”, preceduta spesso dal recitativo.
Adottata nel Settecento, più spesso nell’Ottocento, in particolare per presentare un personaggio
alla sua prima entrata in scena (“aria di sortita”), può avere un andamento cantabile o vivace:
Es. da IL TROVATORE (Giuseppe Verdi), Atto I, “Tacea la notte placida” (cantabile)
Es. da IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Gioacchino Rossini), Atto I, “Largo al factotum” (vivace)
Cabaletta: breve aria di movimento vivace, talvolta con variazioni, di solito collocata a conclusione
di una scena o di un concertato, introduce direttamente nell’azione. È un momento di particolare
accensione espressiva in cui confluiscono in sintesi i sentimenti precedentemente emersi.
Es. da IL TROVATORE (Giuseppe Verdi), Atto III, “Di quella pira”
(da Dizionario della musica e dei musicisti, ed. UTET, 1984)
Tre sono gli elementi fondamentali della forma melodramma: la musica strumentale, il canto
e l’azione scenica (…). Ci sono però altri elementi di non secondaria importanza. Innanzitutto la
scenografia, che cura l’ambiente, la cui influenza è determinante sul comportamento umano e
nello stesso tempo ne è un riflesso; la coreografia, che coordina i movimenti dell’individuo e delle
masse corali e delle comparse; i costumi, che contribuiscono essenzialmente al tratteggio di ogni
individualità; inoltre non trascurabili sono tutti quei fattori che concorrono a realizzare l’atmosfera
3
ambientale, come le luci e i rumori; infine la regia, coordinamento creativo di tutti questi elementi,
che devono essere rappresentati in modo unitario.
La musica, a sua volta, assume forme diversissime, dal canto individuale a quello corale, che si
possono dispiegare in recitativi, arie, duetti, quartetti, cori e altro ancora; quella puramente
strumentale può assumere la forma di un intermezzo, di preludio, interludio, ouverture. C’è infine la
parola, ma non si deve cercare nel libretto il senso poetico, né soffermarsi su assurdità logiche
come il “sentir l’orma dei passi spietati” (BALLO IN MASCHERA, di Giuseppe Verdi): la parola infatti ha
solo un valore evocativo drammatico e deve fondersi in perfetta unità con la musica. (…).
Il melodramma va quindi realizzato come perfetto equilibrio di tutti questi elementi, perché
sia comunicativo di un’esperienza.
(GABRIELLA GOGLIO/CORRADO SETTI – Intendere la musica, Ed. Lampi di stampa, 2011)
Una verità della quale pochi hanno tenuto conto è che il melodramma è una forma unitaria.
Né potrebbe essere diversamente perché ogni forma d’arte è tale solo in quanto gli elementi che
ad essa concorrono si risolvono nell’unità integrale che è il suo fine. Il dualismo di parole e musica
è solo apparente. La parola è suono ed anch’essa è, come suono, elemento di musica.
(GUIDO PANNAIN - La vita del linguaggio musicale, Ed. Curci, 1956)
5. L’esperienza estetica del melodramma
Quando i moribondi cantano a piena voce o i personaggi pensano ad alta voce senza essere
uditi dagli altri o più linee melodiche si intrecciano confondendo le singole voci, la mente giudica
facilmente di trovarsi di fronte a una forma assurda, paradossale e ridicola di verismo. Se invece
riusciamo a vivere la forma dall’interno, non solo scopriamo che tutti questi elementi non devono
avere senso in se stessi bensì come rappresentazione simbolica, ma intendiamo anche che la
complessità della forma è espressione di un’altra realtà interiore: quella dei sentimenti e delle
passioni che l’uomo vive quando entra nel rapporto. Il musicista contempla e ricompone sul piano
estetico l’azione umana mossa dalla sfera psicologica, con i suoi circuiti emotivi, sentimentali,
passionali, fino al generarsi del dramma.
Occorre però precisare che il dramma non è insito nell’azione in sé, ma è la visione che
scaturisce dal voler conoscere, da un piano più elevato e distaccato, le cause psicologiche che
nell’azione coinvolgono e trascinano l’uomo: il dramma e la conseguente catarsi – cioè la
purificazione dopo la liberazione – si generano dunque in chi osserva per conoscere il processo
universale della dinamica delle passioni umane (l’artista e noi).
Per questo le vicende del melodramma sono sempre simboliche e fungono da supporto alla
rappresentazione di tale dinamica; anche i personaggi non hanno mai un valore fisico, ma sono
l’incarnazione di qualità umane campite nella loro tipicità. Ne consegue che l’antico Egitto di Aida,
come la Parigi di Violetta o il misterioso Oriente di Turandot, non sono che uno spazio mitico
esistente solo nell’interiorità dell’Uomo; e le vicende scelte trascendono sempre il momento storico
per rappresentarsi come eterna storia umana e hanno significato in quanto creano le condizioni al
costituirsi dei rapporti e dei contrasti tra i personaggi, nei quali si accendono e si consumano le
passioni. E poiché la conoscenza estetica fa contemplare fino in fondo la personalità umana, i
sentimenti del melodramma, come la gelosia di Otello o l’amore di Violetta o l’odio di Rigoletto,
sono totali, vissuti su tutti i piani fino alle estreme conseguenze.
Ascoltando il melodramma, non ci si deve dunque preoccupare di creare un nesso logico tra
le varie azioni o di ritrovare un senso veristico in esse: si deve invece superare la ben più ardua
difficoltà di penetrare nel suo valore simbolico e stare di fronte al manifestarsi, in modo
spietatamente evidente, del mondo delle passioni psicologiche, che abitualmente non amiamo
guardare.
(GOGLIO/SETTI, op. cit.)
4
PARTE II
DAI SENTIMENTI CORALI
ALLO STUDIO DEI TEMPERAMENTI INDIVIDUALI
1. Cenni biografici essenziali
La nascita e i primi studi. GIUSEPPE VERDI nasce a Roncole di Busseto (Parma), il 10 ottobre 1813
da Carlo e Luigia Uttini. Fin da bambino mostra una forte attitudine per la musica e riceve i primi
insegnamenti dall’organista della chiesa di Busseto; qualche anno più tardi, Antonio Barezzi, un
ricco commerciante del luogo, fermamente convinto del talento del giovane, lo aiuta pagandogli gli
studi. Nel 1832 Verdi si reca a Milano, per frequentare il locale Conservatorio, al quale però non
viene ammesso. Nel 1836 sposa Margherita Barezzi, figlia del suo benefattore, con la quale si
trasferisce a Milano; dalla loro unione nascono due figli.
Gli esordi. Nel 1839, dopo molti tentativi falliti, Verdi riesce finalmente a far rappresentare la sua
prima opera alla Scala: OBERTO, CONTE DI SAN BONIFACIO, che ha un discreto successo. Il giovane
maestro viene però colpito da una gravissima tragedia familiare: la morte improvvisa della moglie e
dei due figli. Solo, prostrato dal dolore, anche avvilito per il fiasco dell’opera buffa (UN GIORNO DI
REGNO), composta su commissione dell’impresario della Scala, Merelli, medita di rinunciare per
sempre alla musica. Ma proprio il Merelli lo convince a non abbandonare la lirica, proponendogli di
musicare NABUCCO: offerta che, dopo molte resistenze, Verdi accetta. L’opera va in scena nel
marzo 1842 ed è accolta trionfalmente. Con Nabucco inizia la fortuna di Verdi.
Gli “anni di galera”. Dopo Nabucco, per un decennio, Verdi scrive mediamente un'opera all'anno (I
LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA, LA BATTAGLIA DI LEGNANO, I DUE FOSCARI, ATTILA, ERNANI E
MACBETH le più famose). Tali opere giovanili hanno immediato successo, ma Verdi è costretto a un
lavoro massacrante: per questo egli chiama questo periodo della propria vita "gli anni di galera".
La trilogia popolare. Con RIGOLETTO (1851), Verdi si impone come il massimo operista italiano del
suo tempo. Rigoletto è seguito da altri due capolavori, IL TROVATORE e LA TRAVIATA, che formano
con esso la cosiddetta "trilogia popolare", perché conosciuti da tutto il grande pubblico.
Il ritorno a Sant'Agata. Proprio in quegli anni Verdi, ormai ricco e famoso, pensa di tornare a vivere
nella sua campagna: perciò, nel 1848, acquista la villa di Sant'Agata, e va a vivervi insieme alla
sua nuova compagna, la cantante Giuseppina Strepponi, che sposerà nel 1859.
Gli anni della maturità. Gli anni successivi sono difficili per Verdi, perché il mondo musicale e il
gusto del pubblico stanno cambiando. Le opere più famose di questo periodo sono Un ballo in
maschera (1859), La forza del destino (1862), Don Carlos (1867) e il rifacimento di Simon
Boccanegra (1881). Tale periodo di maturazione umana e artistica giunge al massimo punto con
Aida, opera commissionata dal kedivè d'Egitto e andata in scena la vigilia di Natale del 1871, in
occasione dei festeggiamenti per l’apertura del Canale di Suez. Dopo Aida, Verdi decide di ritirarsi
a vita privata. Inizia così il periodo del grande silenzio, interrotto solo dalla Messa di Requiem
(1874), scritta per il primo anniversario della morte di Alessandro Manzoni.
Gli ultimi capolavori. È Arrigo Boito, giovane musicista che era stato un suo grande avversario e
critico, a convincerlo a comporre altre due opere, le ultime della sua lunga carriera: Otello (1887) e
Falstaff (1893), due capolavori assoluti. Verdi trascorre gli ultimi anni tra Sant'Agata e Milano. Nel
1897 muore l’adorata moglie Giuseppina, lasciandolo solo nell’avanzata vecchiaia. Nel 1899 egli
compra un terreno alla periferia di Milano e vi fa costruire un grande edificio, che diviene la Casa di
Riposo per i Musicisti. Nel suo testamento nomina erede universale delle sue grandi ricchezze una
cugina, Maria, che fin da bambina era vissuta in casa Verdi, considerata come una vera figlia.
La morte. Verdi muore a Milano, dove era solito trascorrere l’inverno, in una suite al Grand Hotel et
De Milan, il 27 gennaio 1901, a 87 anni. Il Maestro lasciò precise istruzioni per i suoi funerali, da
svolgersi all'alba o al tramonto, in forma strettamente privata: le ultime volontà del compositore
vennero rispettate, ma non meno di centomila persone seguirono in silenzio il feretro.
5
2. Gli esordi
Di solito, l’artista muove i primi passi nel cerchio magico dell’esperienza altrui e rassoda
quella che si suol chiamare la tecnica per poter passare il limite di quel cerchio, oltre il quale starà
appunto il libero mondo della sua personale esperienza. Nel Verdi invece il procedimento è
inverso: parte dalla rude e sommaria nozione che ha degli uomini e delle cose e, senza valersi di
aiuti estranei, scruta e fruga in se stesso e in ogni sua opera dice con i mezzi naturali a
disposizione ciò che gli sembra essenziale.
L’eccesso di una certa ruvidità umana nuoce al Verdi nella creazione delle prime opere?
(…). Verdi, col suo impeto sano e gagliardo, travolge i limiti fra vita e arte: non sa, non può ancora
conoscerli. Il suo mondo vero è quello delle arie, dei rondò, delle romanze, cabalette, quartetti,
terzetti, cori e concertati. Qualcuno ha detto e vorrà ripetere, ch’entro la forma frusta e consunta di
questi schemi convenzionali il Verdi versa la piena tumultuante dei suoi affetti, ma per la
mancanza di una sua “tecnica” personale l’opera d’arte riesce insufficiente. Errore questo, da cui
occorre liberarsi per sempre: la tecnica sommaria dei primi drammi s’adegua perfettamente, è
tutt’uno anzi con la foga, indistinta e indiscriminata, di quell’acceso mondo romantico di odii e di
vendette proiettati su personaggi storici o pseudo tali che possiamo prendere sul serio soltanto
perché il Verdi, oltre la goffaggine e l’inconsistenza dei loro manichini, ha rivelato in musica
qualcosa del loro animo.
Si afferma così in breve ora nella coscienza degli ascoltatori la figura non soltanto di un
operista ma di un drammaturgo.(…) In apparenza Verdi si comporta di fronte al libretto nel modo
più tradizionale: a parte gli indugi più o meno lunghi della scelta, egli lo accetta come un dato
iniziale, come il punto di partenza del suo processo creatore. Ma non lo accetta passivamente: con
una tenacia senza limiti agisce incessantemente sulle possibilità drammatiche dell’azione e
sottopone il poeta ad una specie di martellamento, non per renderlo docile all’estro dei suoi
desideri, ma interprete consapevole della propria, ancora inespressa concezione.
(LUIGI RONGA - Arte e gusto nella musica, Ed. Ricciardi, 1956)
Come necessariamente doveva riscontrarsi nell’opera di un artista che svolse un’attività di
oltre mezzo secolo e che mai volle straniarsi dalle necessità storiche culturali (…), vi sono in Verdi
fasi di transizione, momenti di incertezza e di oscillazione, indizi, talvolta fugaci, tal’altra più
profondi e durevoli, di assimilazioni, di perplessità, di tutta una vita interiore trepida e occulta, nella
quale si preparano e maturano quelle trasformazioni che, non solo non sminuiscono la grandezza
della personalità verdiana, ma costituiscono anzi uno dei suoi aspetti più interessanti e
commoventi, più insospettati e gloriosi.
Il concetto del genio, inteso come qualcosa di aprioristico, di miracoloso, di un dono che
l’uomo riceverebbe dal cielo, è mitico e utopistico. (…) il genio è ben altro. Esso non è mai fatto,
ma sempre in fieri; non può cedere alla tentazione di volgersi indietro e di ascoltare le sirene del
passato, ma deve continuamente concentrare tutte le forze e tutte le facoltà nell’anelito verso il
futuro (…). Ciò che nel genio vi ha d’innato è la forza, che si manifesta come attitudine e
comprensività, come assimilazione e selezione e, acquistando, crea; conservando, rinnova.
Questa forza si manifesta in Verdi fino dalle prime opere. È un irresistibile impulso tragico,
un’energia scultorea che, in pochi tratti, sa plasmare un carattere, accentuare un sentimento o una
passione fino al più alto grado di intensità, rivelando una gagliarda fibra drammatica, una potenza
creativa che spezza ogni inciampo, annulla ogni formula di convenzione, va dritta all’anima dei
personaggi, al cuore dell’azione. Molte di queste caratteristiche si riscontrano già nel Nabucco. (…)
In alcune pagine alita quella ispirazione melodica calda e palpitante che infiammò i petti e gli animi
degli italiani, ponendo loro nel cuore un nuovo desiderio di libertà.
Tuttavia, questa ripercussione dei canti verdiani sul sentimento patriottico e popolare, non
era il conseguimento di un risultato che il compositore mirasse ad ottenere coi mezzi dell’arte,
l’attuazione di un programma civile e politico effettuata per il tramite della musica; ma l’espressione
spontanea, immediata, naturale di un artista che, esprimendo se stesso, esprimeva il suo popolo;
era l’anima del Risorgimento italiano che trovava una voce alle proprie speranze, alle proprie
ansie, al presagio del dolore e delle vittorie.
(A. CAPRI - Musica e musicisti d’Europa, Ed. Hoepli, 1931)
6
E l’istinto si fa vivo sempre di più, e sempre più asseconda il suo moto interiore. Questo
istinto, artisticamente, si riversa nel Nabucco, nei Lombardi e nell’Ernani, dove troviamo la grande
voce corale verdiana e l’ardore di un uomo che viveva in sé le varie passioni degli uomini (…).
Dentro di sé, sentiva molteplici aspirazioni che dovevano però prendere forma; sentiva una
specie di tormento, e, per far sì che questo scomparisse, doveva respirare una boccata d’aria
nuova che doveva essere diversa da quella respirata nel comporre Oberto e Un giorno di regno.
La rivelazione di tutta questa sua agitazione interiore, Verdi la espresse in queste sue parole che
descrivono un preciso stato d’animo dopo che Merelli gli aveva messo a forza, nella tasca della
giacca, il libretto del Nabucco: “Strada facendo mi sentivo indosso una specie di malessere
indefinibile, una tristezza somma, un’ambascia che mi gonfiava il cuore!... Mi rincasai e con un
gesto quasi violento, gettai il manoscritto sul tavolo, fermandomici ritto in piedi davanti. Il fascicolo
cadendo sul tavolo stesso si era aperto: senza saper come i miei occhi fissano la pagina che stava
a me dinnanzi, e mi si affaccia questo verso: Va’ pensiero sull’ali dorate”.
È una storia che tutti sanno, ma che abbiamo riportato sia perché si tratta di parole dello
stesso Verdi, sia perché queste ci dimostrano come, dopo il primo esperimento (Oberto), gli iniziali
dolori e la prima sconfitta, l’anima di Verdi, l’istinto di Verdi, si ridestino. “Un malessere indefinito”,
“una tristezza somma”, “un’ambascia che gonfiava il cuore”: sono sentimenti che tutti conosciamo
(…). In Verdi questo istinto chiarisce ogni cosa. Ha trascorso delle settimane d’inferno, forse si è
abbandonato alla disperazione, ma ora la parte più sana del suo essere, quella del contadino non
tarato, quella dell’uomo rude che ha un animo che vibra, prende il sopravvento. È un canto
sconosciuto quello che gli sgorga istintivamente, che l’ispirazione gli detta. “Va’ pensiero sull’ali
dorate” è un canto suo.(…).
(MARIO RINALDI - Gli “anni di galera” di G. Verdi, Ed. Volpe, 1969)
La storia che tutti i biografi si compiacciono di ripetere - la subitanea ispirazione alla vista
casuale del coro degli Ebrei in schiavitù - vera o non vera, rappresenta bene in quali privilegiate
circostanze sia nato questo Nabucco (1842), forte delle forze compresse di una giovinezza ormai
matura, già liberata dalla titubanza della prima prova, ma ricondotta ad una sorta di verginità
dall’astensione volontaria e dalla puntigliosa castità artistica di oltre un anno. Non ci stupiscono le
cure con cui Verdi finì quest’opera e che ne fanno appunto il più equilibrato organismo artistico da
lui creato fino al Rigoletto: l’esito del Nabucco, in quel momento, voleva dire la consacrazione
definitiva o l’irrevocabile condanna; dopo due anni d’inerte miseria spirituale, tra lo sterile lavoro
delle lezioni e l’ozio di una vita interdetta ai grandi sogni, era la salvezza e la fede, oppure il
definitivo naufragio nel mare della mediocrità e dei falliti.
Il libretto piacque a Verdi, perché andava incontro alla sua passione per la lettura dei testi
sacri; d’altronde la fortuna dei primi anni di Verdi fu la semplice verginità di quel suo mondo
contadino e incolto da cui poté accostarsi in buona fede con ammirazione e stupore al mondo
fantastico e spesso strampalato del melodramma. (…) Verdi impiantò l’opera su alcuni grandi temi,
prevalentemente corali, saldamente connessi nella sinfonia, che sono come i colori principali di
questo vasto affresco: in essi si pongono i temi del contrasto fondamentale dell’azione, che non è
tanto di passioni e d’individui, quanto di popoli e di fedi. Due popoli sono in lotta, l’oppressore e il
vinto, gli Assiri e gli Ebrei, ed attraverso le masse corali parlano un linguaggio pieno di dignità,
quale raramente si ritroverà ancora nei cori verdiani.
(M. MILA - L’arte di Verdi, Ed. Einaudi, 1980)
Come uomo è conscio che la vita è dolore; e tuttavia sa che non deve cedere ai colpi della
sventura. Ma lo sa perché, come artista, ha trovato una soluzione al dolore, l’unica: esprimerlo. Gli
urti, le contraddizioni, le avversità della vita e più ancora l’affrettarsi della vita incontro alla morte,
generano il conflitto, cioè il dramma. Dal contrasto, che è il dramma, sorge l’amaro sapore che è il
condimento quotidiano della nostra esistenza: il dolore. Allora si presenta la necessità del canto,
della espressione intensa, che, comunicando, sia testimonianza d’una accettazione che di per sé è
salvezza e liberazione. Tale ci appare la poetica e la moralità dell’arte verdiana, tale la ragione
della sua profonda “umanità”. (…)
Poesia del dolore. È questo il segno sotto il quale nasce l’arte di Giuseppe Verdi. (…)
7
Oggi le immagini del coro “Va pensiero”, nei decasillabi di Temistocle Solera, possono anche
sembrare ingenuamente barocche; ma quando Verdi (com’egli stesso narrò), costretto a viva forza
dal Merelli a portarsi a casa il libretto del Nabucco, gettò il manoscritto sul tavolo, quasi con rabbia,
e lo vide aprirsi alla pagina che portava il verso fatidico, fu come se il segreto della vita gli si fosse
rivelato improvviso. Allora il gran groppo del dolore gli si sciolse nell’animo, e fluì in un’ondata di
canto. Giuseppe Verdi aveva “trovato”. Aveva forse ripensato ai contadini della sua pianura
emiliana che, curvi sotto il sole, con la schiena spezzata dalla fatica, risolvevano di quando in
quando la sofferenza mediante la poesia di un canto nostalgico.(…) Di qui il valore “religioso” di
alcune melodie verdiane; di qui il loro valore etico, che consentì a un intero popolo oppresso e
anelante alla liberazione di riconoscersi in esse.
(TEODORO CELLI - Poesia del dolore (in G. Verdi), Ed. La Scala, 1951)
3. Gli “anni di galera”
La locuzione “anni di galera” viene da una celebre lettera di Verdi alla contessa Maffei, del
12 maggio 1858: “Dal Nabucco in poi non ho avuto, si può dire, un’ora di quiete. Sedici anni di
galera!!”. Queste parole sono diventate una formula per designare quel periodo che comincia dopo
l’Emani e giunge fino alle soglie della grande triade popolare costituita da Rigoletto (1851),
Trovatore e Traviata (1853).
(M. MILA - La giovinezza di Verdi, Ed. E.R.I., 1974)
Nell’Emani troviamo Verdi alla base dove si incurva l’arco che descriverà la sua potenza
drammatica. Siamo in presenza d’una svolta nella sua concezione teatrale. Nelle opinioni e nelle
consuetudini melodrammatiche dell’epoca, si trattava di uno spostamento dal tipo d’opera corale e
collettiva a grande spettacolo di cui Rossini aveva fissato le norme col Mosè, per accostarsi al
fremente individualismo drammatico di Bellini e Donizetti: opera e personaggi, anziché opera di
masse. (…) Verdi qui inizia una serie di “studi di carattere” che lo metteranno in grado, in meno di
dieci anni, di scolpire i personaggi di Rigoletto, di Azucena, di Violetta. A distanza di più di un
secolo è difficile rendersi conto di quel che significò questo mutamente.
(…) Il contatto di Verdi con i suoi soggetti, in quest’epoca, avviene come in una furia di
devastazione. Ogni sfondo, sociale o storico, ogni traccia d’ambiente scompare dietro i
personaggi, i quali vengono proiettati in primi piani implacabili sotto un getto di luce artificiale
accecante. Come per Alfieri, la musa tragica del giovane Verdi è la semplificazione, la nudità
lineare, l’annientamento di tutti i fronzoli e di tutti gli orpelli, a favore di una selvaggia, sommaria
efficienza drammatica.
(M. MILA - Verdi, Ed. Rizzoli – 2000)
Emani è situato, nella carriera artistica, in un momento particolare, tra l’impulso iniziale e la
sofferenza lavorativa di un periodo che l’angoscerà non poco. Ne consegue che, dopo Emani,
Verdi cercò qualche cosa di nuovo che lo allontanasse da determinate formule, desideroso di
chiarire meglio - ma all’inizio fu un’illusione - la sua posizione di artista di teatro. Questa ricerca la
effettuò, a volte inconsciamente, a volte meditatamente, durante gli “anni di galera”, periodo in cui
la sua anima non spaziò libera, in verità, ma si contrasse per essere ossequiente a una riflessione
interiore che sentiva più istintivamente che volutamente.
(…) Uomo ordinato per natura, va in cerca di un sistemazione che lo soddisfi e non lo faccia
stare in continue apprensioni; artista dotato come pochi, va in cerca di una formazione culturale
che gli dia la possibilità di dare corpo ai suoi fantasmi artistici. Tutto da fare nel suo animo e nel
suo cervello, perché era nato dal nulla, e perciò necessaria appariva una formazione di base che
egli cercava più col suo istinto che non attraverso consigli, più con le sue possibilità naturali che
non attraverso la cultura dei libri. Il fare da sé costa fatica e, infatti, numerosi furono i dubbi, i
ripensamenti, le autocritiche, le disillusioni, i rimproveri. Tutto ciò, però, non lo abbatteva poiché
dentro di sé vibrava una sicurezza meravigliosa e una forza viva che lo guidavano anche là dove
affrontava serie difficoltà.
8
(…) Partito da zero, dopo aver appreso quella grammatica che gli era necessaria, dopo aver
riflettuto su quanto gli sembrava più logico, dopo aver avuto qualche contatto con la vita umana e
professionale, raggiunse determinati stati d’animo che gli presentarono con chiarezza alcune
possibilità artistiche che egli maturò via via, e che lo portarono a scegliere il suo linguaggio
musicale o quei “climi” che gli parvero necessari per la creazione del suo linguaggio operistico.
Linguaggi e climi che mutarono a mano a mano che la sua esperienza cresceva, via via che
l’iniziale istinto diventava convinzione operante.
(…) Le opere del “Verdi minore” sono comprese negli “anni di galera”, ma va tenuto presente
che questa “galera” deve essere considerata come un fatto non esterno, ma interno, vale a dire
proprio dell’animo del compositore. (…) Problema d’arte che nasce da un’ansia di vita, desiderio di
raggiungere la sua formazione, in virtù di un’esperienza che veniva considerata e curata anno per
anno, anche se agli inizi tutto appare dominato da una forza d’urto di cui non si trova uguale in altri
compositori, escluso Wagner.
(…) Se nel primo periodo impiega circa quattro anni per comporre cinque opere, nel periodo
oscuro impiega meno di quattro anni e tre mesi per comporne nove. Che vuol dire ciò? Vuol dire
che in Verdi era accaduto qualche cosa che lo portava al nervosismo e alla insoddisfazione, vuol
dire che gli ideali perseguiti erano tormentati da vari affanni, che qualche cosa stava accadendo
nella ricerca di un’opera che lo accontentasse, vuol dire che Verdi lavorava e mutava soggetto a
seconda di quello che sentiva vibrare dentro di sé.
(M. RINALDI, op. cit.)
“Attila” è la nona opera di Verdi e risale al 1846. Il compositore contava trentatré anni e fu
allora che Rossini gli riconobbe quella “natura selvaggia” che tanto lo colpì, aggiungendo che il
giovane compositore dimostrava grande potenza nell’espressione delle passioni. Era precisamente
quello che Verdi tentava. (…) Si era veramente innamorato di un soggetto che gli dava la
possibilità di mettere in scena la figura del “flagello di Dio”, di un barbaro che si arresta alla vista
della Croce e dinanzi alla figura di Leone I. “Bel soggetto - andava ripetendo al Solera e al Piave un soggetto stupendo”. (…) E poi c’era la speciale figura del protagonista, arso dalla sadica gioia
della distruzione, reso superbo dalle vittorie, torturato dall’intimo desiderio di possedere la figlia del
signore di Aquileia, colpito dalla sognata scena dell’incontro col pontefice. (…) Ed ecco che Verdi
presenta un Attila eroico e nobile nello stesso tempo, che gli dà la possibilità di puntare l’attenzione
su un solo personaggio, anzi possiamo dire su due personaggi, in quanto anche Odabella, qua e
là, tenta di superare per importanza il protagonista. Ma Attila resta, comunque, l’incarnazione di
una figura eroica che Verdi si è forgiata nel suo intimo.
(M. RINALDI, op. cit.)
Nei “Due Foscari”, in “Attila” e nei “Masnadieri” aveva cercato le sue “tinte” ma ora bisognava
andare più in profondità, bisognava studiare attentamente i moti dell’animo e dare ad essi lo
sfondo, l’ambiente e il clima necessario.
(…) Ora, (siamo nel 1849 al tempo della composizione di “Luisa Miller”) ancor meno di
prima, ammetteva che il pubblico, a teatro, dovesse “divertirsi”; ma che riviva un po’ quello che ha
sofferto l’artista, questo pubblico, e vedrà di che razza di “divertimento” si tratta. (…) Più che logica
la reazione di Verdi che per dieci anni si era martirizzato a indagare e a trovare una soluzione ai
suoi problemi. Chi si vuole “divertire” - questo è il suo concetto - vada a uno spettacolo comico,
perché l’opera non è adatta ai superficiali.
(…) Verdi, dunque, tende a mettere in rilievo il personaggio e anche, con maggiore ardore, il
protagonista. Cura tutti i passaggi delle sue opere, tutti i rapporti tra un personaggio e l’altro, tra
una scena e l’altra, perché la sua aspirazione è quella di giungere a un equilibrio ideale. E allora
studia gli accenti dei versi, le inflessioni delle parole, convinto com’è che tutto è importante
nell’opera in musica così come ora la concepisce. “Quanto studio richiede”, diceva, “la creazione di
un’opera”, e questo studio ora se lo imponeva esigendolo, però, anche dai direttori, dagli esecutori,
dai realizzatori e anche, perché no?, dal pubblico.
(…) Verdi ha iniziato una nuova strada che lo porterà lontano: non siamo infatti troppo
distanti, col tempo, dalla popolare trilogia - la quale rappresenta una assoluta novità nel continuo
progredire della sua arte - che lo affermerà in modo definitivo in tutto il mondo.
(M. RINALDI, op. cit.)
9
PARTE III
IL PROCESSO INTERIORE DEL PERSONAGGIO
1. La nuova concezione drammatica nelle opere della“trilogia”
Verdi doveva lottare con le consuetudini della librettistica ottocentesca, ricettacolo di tutte le
assurdità, e che non sempre l’intenso sentimento umano e la potenza drammatica del suo
temperamento poteva redimere e compensare.
La prima volta che a questo egli perviene quasi interamente è nel Rigoletto. In quest’opera,
ciò che vi ha di enfatico e di truculento nelle turgide stilizzazioni victorughiane, è mitigato e
umanizzato per virtù della musica, che ingentilisce il pianto, abbella il dolore, conferisce profondità
e intensità di vibrazioni alla commozione e al sentimento. I personaggi sono ancora di stampo
popolare, fusi in un sol blocco psicologico, tutti immediatezza istintiva di impeti subitanei,
elementarità di vita interiore. Ma questa vita è più ricca, più varia ed espressa con tocchi squisiti
che nulla più può obliterare. Amore, dolore, odio, furore, tenerezza filiale e paterna, casto tremore
della giovine anima femminile turbata dall’ardore presago della nascente passione; tutti questi e
molti altri affetti e sentimenti Verdi sa incomparabilmente tradurre ed esprimere, facendo risuonare
tutte le corde di un’orchestra poetica non prima udita.
(…) Il Rigoletto, la Traviata, il Trovatore sono le opere di un arista che si è ripiegato su sé
stesso, che ha cercato nella propria coscienza il principio e la ragione dell’esistenza, che ha
meditato e medita sui grandi problemi della vita, ed è riuscito a cogliere e a fondere nel fuoco della
propria virtù creatrice gli interessi e i motivi del mondo morale, a penetrare nel cuore dell’uomo e
ad ascoltarne le voci arcane e rivelatrici. (…)
Una riprova di questa altezza di concezione, di questa profondità di visione umana e
spirituale, ci è fornita dalla predilezione di Verdi per la poesia shakespiriana, ch’egli lesse e rilesse
durante tutta la sua vita.
(ANTONIO CAPRI - Musica e musicisti d’Europa, Ed. Hoepli, 1931)
Di eccezionale importanza appare un’affermazione di Verdi uscito, ormai, dagli “anni di
galera”. In un momento di serenità e di sicurezza il maestro scrive in una lettera: “Mi possono
benissimo mancar le forze per arrivare dove io voglio, ma io so quello che voglio”. Si tratta di un
linguaggio nuovo per lui che aveva espresso tanti dubbi e che non era ancora riuscito a dimostrare
con chiarezza le sue intenzioni. Un linguaggio nuovo, più franco e ottimista. Affermare “io so quello
che voglio”, per un uomo della sua tempra e del suo carattere (…) vuol dire che ormai vede con
chiarezza l’opera, la trama e i personaggi, che considerava a fondo i sentimenti di questi,
sentimenti che non erano impersonali, ma che caratterizzavano quella figura o quel protagonista.
Atteggiamenti, dunque, deliberati, non più incerti e sopratutto non più generalizzati.
Finora aveva lavorato per saggiarsi, ma già aveva fatto delle conquiste. Ora però ha
raggiunto la maturazione piena del suo pensiero, il discernimento completo delle azioni da mettere
in musica: giunge infatti al Rigoletto. (…)
Insistiamo nel dire che non è certo il caso di parlare di una nuova maniera o di un nuovo
stile, (...) ma di nuovo linguaggio si può parlare nel senso che Verdi coglie i personaggi non
soltanto dal lato teatrale e drammatico, ma soprattutto dal lato musicale. Una poetica nuova che
affascina tutti, e infatti Rigoletto, il Trovatore e la Traviata appaiono come il culmine dell’arte
verdiana, almeno fino al 1853.
Tutto questo è accaduto - già lo sappiamo - perché Verdi ha saputo meditare, ha saputo
attendere fino a che la sua coscienza di uomo e di artista non si era maturata, fino a che non
“vedeva” le trame e i personaggi, così come aveva in animo di vederli. (...) Desidera soggetti e
forme nuove, ma - era già accaduto e accadeva ancora - un poeta che potesse dargli tutto ciò non
c’era, o per lo meno non lo conosceva. Senza timori nette in scena un gobbo (Rigoletto), tra la
meraviglia di tutti musica “un soggetto dell’epoca” (La Traviata) che suscita discussioni per “mille
grossi scrupoli”. Una donna dalla dubbia morale, ma capace di esternare alti sentimenti: in
10
precedenza non l’avrebbe accolta, e lo dichiarò palesemente. Ora sa che i personaggi si
trasfigurano nella musica e tenta quello che non ha mai tentato. Non gli importa se la gente
chiacchiera e se i critici palesano i loro dubbi. Egli vuole giungere a “quel” sentimento e nessuno
può impedirglielo. (…).
Il nuovo colore che sorge da un’opera come Rigoletto - Verdi, in verità, parla di “tinta” - da un
dramma come quello della Traviata (si pensi anche solo al primo atto), prende vita dal nuovo
valore che si dà alla parola, all’individuato sentimento del personaggio. Bisognava penetrare in
esso ed anche lasciarsi trasportare da esso. Verdi vi è penetrato e si è lasciato trasportare, sicuro
di ricavarne qualche cosa di inatteso e di estremamente efficace.
(MARIO RINALDI - Gli “anni di galera” di G. Verdi, Ed. Volpe, 1969)
Attraverso le prove che vanno dai Due Foscari (1844) al Rigoletto (1851), l’esperienza del
compositore matura, e con essa crescono le esigenze. (…) Ciò che maggiormente lo appassiona è
la novità dei caratteri e delle situazioni che gli è indispensabile perché possa rinnovare anche la
propria ispirazione e la propria tecnica, fra loro interdipendenti. Si noti che un anno prima di
Rigoletto egli giudicava il Nabucco oramai quale “un’opera vecchia, stravecchia, fuori di moda e da
mettere fra gli invalidi”, ed erano passati appena otto anni! Nel soggetto di Rigoletto, che la
censura veneta accusava di “ributtante immoralità e oscena trivialità”, egli trova pane pei suoi
denti: un gobbo in scena e un cadavere in un sacco! Altro che il corno di Silva! “Temono l’effetto? scrive - Ma mi si permetta dire, perché ne vogliono sapere in questo più di me? Chi può fare da
Maestro?”. Non è dunque più l’uomo che accetti suggerimenti o osservazioni; è sicuro di sé; nulla
è fatto da lui a caso: “dico francamente -aggiunge - che le mie note, o belle o brutte che siano, non
le scrivo a caso, e procuro sempre di darvi un carattere”. Sa quel che fa: “Ho ideato il Rigoletto afferma - senz’arie, senza finali, con una filza interminabile di duetti, perché così ero convinto”.
(GINO RONCAGLIA - Galleria verdiana, Ed. Curci, 1959)
Ed ecco come Verdi lavora. Il maestro medita a lungo il soggetto, l’argomento: la moglie, con
una punta di presa in giro, scriverà che “rumina” il libretto. Quando esce da quel periodo di
meditazione in cui non ha scritto assolutamente nulla, l’opera è già compiuta, anzi Verdi ha
bisogno di scriverla in gran fretta perché, raggiunta la concezione dell’opera, l’esecuzione
materiale si riduce a un fatto meccanico e deve essere affrettata il più possibile; altrimenti ci sono i
ripensamenti, i dubbi, e l’opera nasce, (son sempre sue parole), “a mosaico”, il che è la negazione
dell’opera come la intende lui, Verdi, così costruttivo da distruggere perfino quel mosaico, in fondo
più apparente che reale, costituito dallo schema a forma chiusa. (…)
Di qui la vertiginosa rapidità con cui Verdi compone le sue opere, come anche viene
documentata dalle prime stesure degli spartiti verdiani: il Gatti ci informa che il Rigoletto fu scritto
per intero in un sol getto, e, si noti, su un rigo solo, indice anche questo della concezione
eminentemente vocale dell’opera verdiana; per il Verdi, una volta fissata la parte vocale, che è
l’essenziale, la vocalità porterà con sé, necessario e insostituibile, un certo e solo
accompagnamento: è noto che a Verdi bastavano pochi giorni, a volte meno di una settimana, per
la strumentazione completa dell’opera, che egli in genere eseguiva solo quando erano già
cominciate le prove al pianoforte. Anche i pentimenti e le correzioni sono scarsi: una volta intuita la
concezione generale, l’opera si compone quasi da sé, per intrinseca necessità, e basterà eseguire
così come la “situazione” richiede, così come “ditta dentro”: il famoso preludio all’ultimo atto de La
Traviata, ci informa sempre il Gatti, uscì di getto dalla penna del maestro, non porta una
correzione, e fu concepito, nella sua lirica essenzialità, così come è eseguito tuttora.
(PALMIRO PINAGLI - Romanticismo verdiano, Ed. Vallecchi, 1967)
Attraverso la temporanea frammentazione individuale di questi studi di carattere (…) si vien
costituendo l’unità organica del mondo morale verdiano. Nella triade Rigoletto, Trovatore e
Traviata essa è un fatto compiuto. La tipica vicenda morale verdiana si presenta qui completa in
tutta la sua coerenza di radicata concezione del mondo, e con un peso, un valore di messaggio
umano non inferiore a quello del mito della rinuncia e della redenzione d’amore elaborato da
Wagner.
11
Ma la meraviglia è che qui, in Verdi, una coerente concezione morale si è formata
unicamente nella pratica musicale, senza bisogno di migliaia di pagine di teorizzamenti sull’opera e
il dramma (…). La musica da sola ha creato la vicenda verdiana tipo, in cui si riflette un ordine
morale di immanente coerenza, una concezione della vita di sperimentata saggezza: l’eroe,
snaturato dall’unilateralità morbosa di maligne passioni, o reso abbietto da qualche inumana
imposizione del destino o dal peso d’ingiuste convenzioni sociali, riacquista attraverso l’esperienza
dell’amore e del dolore il retaggio della comune umanità.
Questo schema di vicenda morale che si potrebbe definire della riacquistata umanità, si
ripete nei tre capolavori senz’ombra di partito preso o di preconcetto programmatico, con la stessa
spontaneità inconsapevole con cui la natura ripete sempre uguale il disegno d’un guscio di
conchiglia, o i fiocchi d’una nevicata asciutta rifanno tutti in un modo la stessa stella a sei punte.
Rigoletto non è una creatura umana al suo apparire: è un trastullo, un cane ammaestrato,
che ridiventa uomo nell’amore per la figlia. Azucena è chiusa nella volontà di vendetta come in una
rigida armatura, che si scioglierà al contatto del dolore, dell’affetto materno. Violetta, coi suoi folli
gorgheggi di usignolo meccanico, si presenta come un simbolo astratto del piacere, della disperata
volontà di gioire; ma nell’amore e nel sacrificio il suo canto ritrova la verità delle lacrime umane. Il
canto è sempre il catalizzatore che scioglie la rigidità innaturale dell’ostinazione perversa e
restituisce il personaggio alla condizione della sua natura umana. “Ebben, io piango”: sono le
parole in cui si flette, giunta al vertice, la disperazione forsennata di Rigoletto, e lo scheletro
burattinesco del buffone si accascia in un empito di dolorante umanità.
Questa intuizione morale, che la verità dell’uomo, la sua sostanza, stia nella capacità di
amare e di soffrire, viene fermata nei tre capolavori popolari con quella schematicità frettolosa ed
esclusiva che è propria di tutte le scoperte, di tutte le verità che esplodendo nell’animo di un artista
ne impegnano momentaneamente tutte le facoltà. Nell’ispirazione del Rigoletto, del Trovatore e
della Traviata non c’è posto per altro che non sia la figura dei protagonisti (...). Questa vicenda tipo
della drammaturgia verdiana - un essere snaturato da avversità del destino o da furiose passioni,
che recupera la comune umanità attraverso la prova dell’amore e del dolore - questa vicenda tipo
viene proiettata in primo piano sotto un getto di luce violentissima e abbagliante, che si concentra
tutta sul protagonista.
Ritirare la luce dalle altre parti del dramma per proiettarla tutta sul personaggio principale è
una necessità biologica di questa fase dell’arte verdiana. Le convenzioni melodrammatiche
vengono perciò, non solo accettate, ma esasperate, e creano intorno al protagonista dell’opera un
vuoto irreale e metafisico, nel quale esso, investito da un getto di luce spietata, proietta
lunghissime ombre fantomatiche. Gli altri personaggi, l’ambiente storico o sociale, lo sfondo della
vicenda, insomma, tutto ciò, viene ignorato o trascurato, nell’ansia di portare in primo piano la
parabola psicologica del protagonista.
(M. MILA - Verdi, Ed. Rizzoli, 2000)
2. Rigoletto
Nel Rigoletto la struttura è assai complessa, la strumentazione ben nutrita e pittoresca (si
vedano il preludio, il temporale, l’ultima scena) l’intreccio delle parti ardito e nuovo, e i più disparati
contrasti espressi, talora simultaneamente, con vivezza di tinte e di ritmi (vedasi il quartetto
dell’ultimo atto). Inoltre tutti i caratteri sono scolpiti con michelangiolesca vigoria, con dantesca
rapidità di tocchi, ciò lo si deve alla potenzialità drammatica e passionale delle melodie, che però
non perdono mai un istante la loro simmetrica quadratura e la loro purezza, e alla novità e varietà
dei ritmi incisivi e pieni di vita.
Rigoletto, Gilda, Sparafucile, il Duca, Maddalena: tutti hanno un loro colore particolare, una
loro personale atmosfera. È la prima volta che questa individuazione dei “tipi” avviene con tanta
pienezza e luminosità in Verdi. Perfino Monterone è figura significativa e vigorosamente scolpita
nelle sue poche battute. (...)
Si vorrebbe da alcuni fare una colpa a Verdi dell’essersi ancora servito in quest’opera di
accompagnamenti e moti orchestrali un po’ primitivi e invecchiati; ma occorre tener presente che
(…) se ancora ricompaiono forme schematiche di armonie e di accompagnamenti, non importa: la
melodia è tale che basta da sola a scolpire caratteri e situazioni con quella potente verità non
materiale ma tutta ideale e profondamente poetica propria dello Shakespeare e del Buonarroti!
12
E questa forza drammatica del canto nel Rigoletto è somma. (...) Victor Hugo, autore di “Le
Roi s’amuse” da cui era stato preso il libretto dell’opera di Verdi (…) per molto tempo si rifiutò di
assistere ad una rappresentazione dell’opera. Soltanto in uno degli ultimi anni di sua vita vi si
lasciò condurre. L’illustre uomo “ascoltò con attenzione la musica, dando qualche segno di
approvazione (…) ma dopo il quartetto, che ascoltò nervosamente, Victor Hugo si alzò di scatto ed
esclamò: “Insuperabile! Meraviglioso! Semplicemente meraviglioso!”. Ma subito dopo, non
volendosi dare per vinto, sedendosi di nuovo, soggiunse: “Se potessi anch’io, ne’ miei drammi, far
parlare contemporaneamente quattro personaggi in modo tale che il pubblico ne percepisse le
parole ed i diversi sentimenti, otterrei un effetto uguale a questo”(...).
Non passerò sotto silenzio un’altra pagina importantissima e alla quale pure il pubblico
presta in generale poca attenzione: il preludio. Esso è impostato tutto sugli squilli fatidici della
maledizione, i quali appaiono dapprima lenti e pallidi come fantasmi, indi incalzano e
ingigantiscono rapidamente fino ad esplodere in una successione spasmodica di singhiozzi che a
poco a poco si affievoliscono e terminano in un ultimo e lungo gemito. Il tema della maledizione
riappare ancora fosco e pauroso, ma ora, dopo la seconda ripresa, si muta istantaneamente in una
forma di risoluzione energica e scultorea che sale e si arresta in un ultimo grido; due note basse e
ruvide troncano la visione dolorosa e terribile: il dramma è compiuto. Così, in poche linee questo
preludio sintetizza meravigliosamente con beethoveniana grandezza tutta l’azione che appresso
dee svolgersi: nulla di più grande e di più semplice! E con quale nitidezza si stacca dietro questa
specie di velario tragico, la gaiezza signorile e fatua insieme delle musiche festose fra le quali si
culla la spensierata sensualità del Duca.
(GINO RONCAGLIA - Giuseppe Verdi, Ed. Perrella, 1914)
2. La Traviata
Se oggi stentiamo tanto a comprendere l’insuccesso iniziale dell’opera, la colpa è in parte
anche nostra; educati alla musica di Traviata e a tanta altra che ne è venuta dopo, noi riusciamo
solo con estrema difficoltà a renderci conto del valore rivoluzionario che ebbe quest’opera nella
storia del melodramma ottocentesco italiano e del senso quasi di sgomento che dovette produrre
nei primi interpreti e spettatori. Basterebbe ripensare al finale del primo atto, quando, dopo la festa
e l’incontro con Alfredo, Violetta rimane sola e, riandando con la memoria a quell’incontro,
incomincia ad avvertire la futilità della sua vita e va ripetendo le frasi amorose di Alfredo. Poi, con
uno degli scatti tipici dei personaggi verdiani, la donna di mondo riaffiora e cerca di riprendere il
controllo di se stessa: il trapasso, psicologicamente, è curato in maniera fittissima; per descrivere
l’aridità ostentata di quel cuore di donna, Verdi riprende tutti i mezzi soliti del vecchio melodramma,
i trilli virtuosistici (questo è il tipico “pezzo forte” della prima donna), che qui ricompaiono asserviti
ad una funzionalità espressiva; ma l’animo nuovo contrasta con l’animo vecchio e le diverse
passioni combattono così violentemente nell’animo del personaggio che a Verdi non basta più una
voce sola, gli occorrono due voci, due motivi diversi, quello arido e trillante della Violetta che fu, e
quello tenero della Violetta appassionata che ormai sta sbocciando: quasi evocato da Violetta
stessa, fuori scena il tenore riprende la frase amorosa del duetto: i due motivi, le due voci
contrastano, gareggiano fra di loro. Verdi non è un autore del ’900: sulla prima battuta del tenore,
lo spartito precisa che Alfredo è “sotto il balcone”; ma qui il personaggio non è Alfredo: la voce di
Alfredo è l’altra voce dell’animo di Violetta, la voce nuova che, in una sorta, direi quasi, di
monologo interno, le ricorda quell’incontro e le ripete quelle frasi che la donna non vorrebbe
ascoltare. L’atto, con una eccezionale abilità di costruzione drammatica, finisce qui, senza
risolvere il problema della redenzione di Violetta, senza risolvere quale dei due motivi ottenga la
vittoria, e creando musicalmente un aggancio fortissimo fra il primo atto e i successivi. Ricorrendo
alla voce del tenore per descrivere quanto è nell’animo della donna, Verdi ha anticipato, per pura
forza d’ispirazione, un effetto artistico che, con una tecnica narrativa più avanzata, ricomparirà
soltanto nei primi del ’900. Allora eravamo nel 1853.
(P. PINAGLI, op. cit.)
Se il Tristano e Isotta di Wagner è il poema della passione morbosa, come quella che fu
generata dalla potenza di un filtro incantato, la Traviata di Verdi è il poema del dolore e dell’amore
sano e limpido come essi appaiono nella loro essenza naturale. Mentre in Tristano e Isotta la
13
redenzione è soltanto nella morte, ne la Traviata invece è l’amore, il quale suscita la grande opera
di redenzione che la morte illumina e santifica. Nell’opera wagneriana tutto l’amore è colpa e
spasimo irresistibile, l’ansia dell’attesa è tormento crudele, soltanto la morte è gioia e liberazione.
Nell’opera di Verdi al contrario l’amore è gioia e purificazione, ma dolore è la rinunzia che accelera
la morte e che però rende ancor più alta la redenzione. E la morte che per tutto il dramma incombe
come un oscuro fato sul fragile corpo della protagonista, mentre amaramente infrange una dolce
esistenza, mentre distrugge un vago sogno di felicità, pure avvolge di un’aureola più radiosa
l’anima della donna redenta pel sacrificio sublime d’amore.
(G. RONCAGLIA, op. cit.)
2. L’evoluzione del linguaggio musicale nelle opere della “trilogia”
Nessun dubbio che l’ispirazione di Verdi sia essenzialmente melodica, nel senso più italiano
della parola; la voce umana è il medium dei suoi pensieri musicali, presentati sempre sotto forma
di una lineare e singola melodia; nessun dubbio che questa forma musicale sia artisticamente
legittima e capace d’espressione sentimentale tanto quanto la polifonia di una grande orchestra.
Le più toccanti espressioni d’umanità che Verdi trovò nella Traviata, nel Rigoletto, sono di questo
genere. In questi casi di felice ispirazione l’orchestra perde il suo peso di cosa morta e inutile: o si
limita a sostenere la melodia con un tremolo degli archi, oppure qualche volta anche il deprecato
accompagnamento a chitarra, retrocesso in secondo piano dalla bellezza della melodia, compie
con discrezione il suo modesto ufficio ritmico e costruttivo.
Ma spesso nelle arie veramente ispirate, anche nelle opere giovanili, si rivela un
irrobustimento della sostanza musicale, una partecipazione spontanea e necessaria dell’orchestra:
canto e accompagnamento vengono concepiti insieme, l’orchestra risponde alla voce, la sorregge,
completa la frase musicale (…).
(M. MILA - L’arte di Verdi, Ed. Einaudi, 1980)
Verdi che, come afferma spesso nelle lettere, ricerca sopratutto la verità del cuore, delle
passioni, dei caratteri, era portato a riflettere che un personaggio si svolge, si cambia, si matura
non attraverso episodi più o meno lunghi, ma per un trapasso continuo. (…) La grande rivoluzione
attuata da Verdi nel melodramma italiano assume, stilisticamente, questo aspetto: la creazione di
un mezzo nuovo di stile, lo spostamento dell’attenzione, esclusiva prima sulle parti cantabili, anche
sulle possibilità espressive del recitativo. L’avvento del declamato melodico (…) significa che
l’opera deve nascere come un tutto organico, in cui la poesia circoli in ogni sua parte; porta con sé
un potenziamento del lato drammatico e narrativo dell’azione scenica, in cui non sono più soltanto i
pezzi vagamente effusivi e lirici ad essere sottolineati; segna sopratutto un cambiamento
fondamentale nel gusto, per cui, ad una costruzione geometrica dell’opera intesa come armonica
distribuzione di pezzi, una distribuzione che torna, per così dire, sempre su sé stessa, succede
una costruzione lineare del melodramma, in continuo crescendo, dove i motivi di contenuto, che
sono subito proposti, tendono a svolgersi rapidamente e si affrettano a una conclusione, in genere
rapidissima, nella quale quei motivi trovano la loro sintesi e l’opera intera il suo momento più
propriamente catartico.
(P. PINAGLI, op. cit.)
Verdi non cerca mai il nuovo per il nuovo (…): abbiamo rilevato l’attenzione del maestro a
risolvere l’aria nell’organicità del dramma, attribuendole una specifica funzione narrativa; ma
ancora si potrebbe osservare il nuovo significato assunto in Verdi dalla cabaletta, che era
tradizionalmente diventata quasi soltanto un pezzo virtuosistico. Nell’opera verdiana la cabaletta si
pone nel momento in cui il personaggio, vittima di una situazione, improvvisamente decide di
ribellarsi a quella situazione e di reagire: in quel punto decisivo dello svolgimento psicologico del
personaggio e di tutta la costruzione drammatica, il maestro punta al massimo sul vivace
movimento in allegro e travolge il virtuosismo del pezzo, che diviene episodio necessario della
narrazione drammatica, così da non essere più riconoscibile come cabaletta.
(P. PINAGLI, op. cit.)
14
PARTE IV
L’ESPERIENZA SOCIALE DEI RAPPORTI UMANI
1. L’ampliamento della visione drammatica dopo la “trilogia”
Dalla Traviata all’Aida si compie nell’opera verdiana una ininterrotta evoluzione, con alterne
vicende di geniali divinazioni e di ritorni verso il passato. Verdi non abbandona mai definitivamente
le forme tradizionali del melodramma, ma alacremente si adopera per rammodernarle e adattarle
alle mutevoli esigenze del tempo. È però innegabile che, nelle opere di questo periodo, Verdi non
ritrova che a intervalli la continuità e la vena di ispirazione che anima di inesausta giovinezza i
capolavori scritti dal 1851 al 1853. Si sente che egli anela a una superiore conciliazione della
tradizione e del progresso, a una fusione degli elementi originari della sua natura con quelli via via
acquisiti o di possibile acquisizione; ma si sente anche che questa conciliazione e fusione vengono
ostacolate e impedite da varie ragioni provenienti, in parte, dalla sua preparazione culturale ancora
insufficiente, in parte dalla inadeguata materia poetica e librettistica, che non offriva al compositore
le prospettive d’arte e le possibilità di realizzazione drammatica da lui intuite e vagheggiate.
Abbiamo un artista che vorrebbe dare alla sua nazione un’arte scaturita dal popolo, dalla sua
storia, dal suo gusto, dalle sue tendenze più native e spontanee e, tuttavia, consona ai portati della
modernità, degna di assurgere a un valore e a un significato universali; un artista, che vuol essere
nazionale e moderno, esprimere se stesso come voce dell’umanità e plasmare, al tempo stesso,
un’espressione esteticamente e psicologicamente congrua al momento storico.
A tale scopo Verdi scruta, interroga e si interroga, cerca in sé e intorno a sé, mira
continuamente ad estendere e ad allargare le proprie cognizioni, ad assimilare i risultati della
cultura. Ma, all’appagamento di questi bisogni spirituali e artistici l’Italia era allora un terreno
impervio, che non presentava risorse, non offriva incentivi, non agevolava in alcun modo il
cammino di chi volesse percorrere vie intentate. (…) In musica [questa mediocrità] aveva nome
melodia italiana, designazione che includeva ed implicava il dispregio dei valori costruttivi
dell’opera musicale, l’imperizia tecnica dei musicisti, la loro ignoranza di ogni severa disciplina e
tradizione, e una incultura che rasentava talvolta l’analfabetismo, onde non era raro il caso di udire
compositori di musica vantarsi, come il Mercadante, di non aver mai aperto un libro in tutta la loro
vita. Non deve quindi far meraviglia se, dovendo lottare contro questo stato di inerzia, di
incomprensione, di disinteresse per i più alti problemi dell’arte che in quel tempo ricevevano
altrove, e segnatamente in Germania, un impulso a magnifici svolgimenti e ad applicazioni
grandiose, il genio di Verdi abbia dovuto lungamente travagliarsi per porsi a livello della cultura
europea e trovare espressioni ad essa adeguate e corrispondenti.
(A. CAPRI - Musica e musicisti d’Europa dal 1830 al 1930, Ed. Hoepli, 1931)
Il dramma che finora era proceduto, secondo l’uso caro a Verdi, serrato nel cerchio dei
protagonisti, tende ad ampliarsi, ad investire di sé la natura, gli uomini tutti, che vengono colti nelle
loro occupazioni quotidiane di pescatori, contadini, pastori: la loro vita interferisce con quella dei
protagonisti, questi cercano di staccarsi dal loro limitato cerchio di passioni per immergersi in
un’umanità più ampia e comprensiva. Il dramma verdiano che finora procedeva unilaterale e
lineare, con inesorabile, alfieriano rigore, vuol rimpolpare il proprio solido scheletro e scendere fra
la folla di creature umane: Verdi sente ormai in sé tanta forza da poter fare a meno di scolpire le
proprie creature con allucinante insistenza sullo sfondo neutro delle convenzioni melodrammatiche
facendo il vuoto intorno a loro per ottenerne maggior risalto e facilità d’illusione. Dopo le grandi
prove ultimamente vinte egli sente di avere ormai raggiunto il suo ideale melodrammatico:
“Inventare il vero”; ora si tratta di portarlo ad un’ampiezza shakespeariana: non solo inventare la
verità di pochi personaggi essenziali, che nella sua allucinata limitazione risente ancora di
palcoscenico, di esperimento artistico, ma inventare anche la verità universale di tutto ciò che li
circonda (…).
15
L’uomo nuovo verdiano supera la limitazione che Mazzini deplorava nell’individualità
dell’opera lirica del suo tempo: l’essere cioè “ristretta all’impressione degli affetti isolati che vi
s’incontrano”. Il che voleva dire, in sostanza, assenza del dramma, disgregazione dell’opera in
episodi lirici per sé stanti, circoscritti per lo più in forme chiuse tradizionali. Nella concezione
drammatica di Verdi, gli “affetti isolati” si organizzano in un sistema morale e si inseriscono in un
ordine concreto di vita civile, sia per piegarvisi, sia per ribellarsi. Il personaggio verdiano stabilisce
dei rapporti - non importa se di collaborazione o di lotta - con il mondo storicamente determinato
che gli sta intorno. Gli “affetti isolati” si coordinano nella coerenza di un carattere e creano il
personaggio; i personaggi si inseriscono nella continuità di un dramma.
(M. MILA - L’arte di Verdi, Ed. Einaudi, 1980)
2. Simon Boccanegra
Col 1880 maturò la decisione di Verdi di riesaminare col Boito il dramma del Boccanegra,fino
a giungere alla famosa sua lettera al Ricordi (20 Novembre) che segnò la capitolazione. Lettera
veramente rivelatrice, sia per la mirabile intuizione del completamento del libretto sotto l’aspetto
politico, sia per la definizione dei personaggi. Per il protagonista Simone si richiedono ora calma,
compostezza, autorità scenica; ruolo, si afferma, mille volte più difficile di quello di Rigoletto,
perché qui “la parte è fatta, e con un po’ di voce e di anima si può cavarsela bene”, mentre “nel
Boccanegra la voce e l’animo non bastano”. E con ciò Verdi sottolineava la nuova concezione del
dramma musicale che non esauriva il suo compito nella pura vocalità e quindi nella “parte già
fatta”. Anche per Fiesco occorreva sì una voce profonda, sensibile nelle corde basse, ma
corredata di “qualche cosa di inesorabile, di profetico, di sepolcrale”. Se stilisticamente Verdi non
programmava manifesti di sorta, anzi si manteneva cautamente nel solco della tradizione
dichiarando: “io non ho tanto orrore delle cabalette”, nel suggerire il rifacimento del vecchio libretto
egli ci appare come il grande drammaturgo ispirato che individua il punto morto del dramma, trova
la soluzione attingendo alla propria memoria, e la offre al poeta perché la sviluppi scenicamente.
Con piglio napoleonico l’operista ha rivissuto il momento “politico” del grande doge nel suo
tentativo di arginare le vendette contro i guelfi in nome di una fattiva pace fra i genovesi, e lo
segnala con incisiva semplicità. (…)
(...) Che Verdi puntasse decisamente sul dramma musicale, e cioè sul graduale abbandono
dei pezzi chiusi della tradizione melodrammatica nostrana, se n’erano ben accorti i contemporanei.
In fondo si trattava di perseguire l’attesa unità drammatica smussando le “cadenze” di frattura fra
un pezzo musicale e l’altro, per incastellare i vari momenti lirici in nuove strutture, più aperte e
logicamente connesse fra loro, che garantissero il continuo fluire dell’azione. (…)
Ora in questa delicata posizione critica verdiana non è tanto da scorgere l’aggiornamento
linguistico ispirato ai moduli tecnici d’oltr’alpe, quanto il maturare nell’artista di una nuova
coscienza che ha superato l’angusta e convenzionale etichetta dell’apostolo della libertà politica
nazionale. Il suo spirito spazia in un orizzonte europeo perché Verdi è un uomo europeo: e come
tale la concezione artistica dell’eroe romantico dovette far presa sulla fortissima sua moralità. (...)
Una simile rivalutazione dell’eroe protagonista, che staccava il Boccanegra dal passionale
lirismo del Gutierrez per elevarlo a una linearità drammatica shakespeariana, trovò il suo
coronamento nel nuovissimo finale del primo atto con la gigantesca scena del senato. Il grande
momento suggerito ora dal colpo d’ala del genio di Verdi, valse anche a equilibrare tutta l’episodica
vicenda dell’opera, e a definire il volto drammatico non soltanto di Simone, ma pure di Fiesco e di
Paolo (…) Col gennaio 1881 Verdi aveva dunque dotato il Boccanegra di una grande pagina che,
equilibrando di riverbero tutta l’articolazione del dramma, recava il vanto di grosse conquiste di
tecnica e d’arte; in essa il Maestro aveva posto di fronte e designato a protagonisti dell’opera il
doge e il popolo: la stessa concezione drammatica che, qualche anno prima, aveva illuminato la
fantasia di Mussorgskij nel Boris Godunov. (...)
Osservata e ripensata dal Maestro a tanti anni di distanza dalla prima veneziana, la figura
del protagonista dominatore del dramma, nel suo triplice aspetto di padre, di uomo di Stato e di
sognatore politico, raggiunge, di volta in volta, una indimenticabile modellatura e una perentoria
immanenza storica, sia per espressione musicale sia per evidenza drammatica.
(GUGLIELMO BARBLAN - Programma di sala “La Scala”, 1973)
16
Il “Simone Boccanegra” nel complesso del teatro musicale verdiano sta fra le opere che si
usa definire “difficili” e “problematiche”, oppure con termini più recenti “sperimentali”. Opere che
caddero alla prima esecuzione pubblica, si rialzarono ma non abbastanza da divenire popolari;
opere che probabilmente popolari non lo diventeranno mai, ma che verranno sempre interrogate
con nuova lena per i fermenti che portano in sé, e nella sensazione che qualche cosa della loro
essenza sia sfuggito sotto il rovello formale, rimosso il quale si può trovare la chiave per riscattare
tutta l’opera. (...)
Il primo a tornarci su fu lo stesso Verdi; questa esigenza di novità era avvertita sul piano dei
contenuti drammatici e qui voleva dire attenuamento della visione onnidrammatica a favore di
nuovi interessi storici, sociali, politici; scivolamento in secondo piano dell’intreccio amoroso, spina
dorsale di tutto il melodramma della prima metà del secolo (…); infine, attenuamento, sospensione
del giudizio morale che pesa sui personaggi: in altre parole, non più una serie di buoni e cattivi
separati da una linea inequivocabile, ma affiorare di figure dall’esponente morale complesso,
davanti alle quali il giudizio del compositore e del pubblico resta sospeso: il capolavoro in questo
senso sarà il Filippo II nel “Don Carlos”, contesto di elementi positivi e negativi in modo
inestricabile, ma già nel “Simone” ad esempio con il personaggio di Fiesco, offre esempi di questa
nuova dimensione psicologica.
(…) La posizione centrale che il Boccanegra occupa è resa chiara, soprattutto nella versione
rifatta, del taglio radicale di quel cordone ombelicale che, da sempre, teneva l’opera italiana legata
alla festa, aristocratica o popolare che fosse: feste e balli sono estromessi persino dalla cornice
dell’opera. Naturalmente, muovere alla conquista di tutto ciò, sul terreno scivoloso e instabile del
melodramma, dominato dall’attivismo, dalla fretta e dalle leggi di una concorrenza senza scrupoli,
voleva dire esporre il nuovo lavoro a duri contraccolpi; il primo rischio era quello dell’insuccesso,
verificatosi puntualmente nel “Boccanegra”; un altro, causa in buona misura del primo, la
provvisorietà, in certi casi l’irrazionalità estrema o la confusione della vicenda drammatica. (...)
Vera “testa” del corpo dell’opera, per riprendere l’immagine dello stesso Verdi, è il
Boccanegra, erede e precursore di quelle figure di vegliardi che campeggiano in tutto il teatro
verdiano da Nabucodonosor a Filippo II; patriarcali figure che il destino mette al timone del potere
e del quale virilmente accettano tutto il peso, ben sapendo “di che lacrime e sangue” grondi lo
scettro di chi regna.
(GIORGIO PESTELLI - Programma di sala “La Fenice”, 1970)
3. Don Carlo
L’Escurial e Filippo II di Spagna erano rimasti impressi nel ricordo di Verdi fin dall’inverno
1863, quando il Maestro, nella maturità dei 50 anni, si era recato a Madrid per la messa in scena
de “La forza del destino”, e aveva allora compiuto la visita d’obbligo alla grandiosa costruzione
nella desolata Sierra Guadarrama. Di questa visita aveva riferito all’Arrivabene confessando
francamente che l’Escorial gli era apparso “un ammasso di marmi” privo di buon gusto nonostante
le grandi ricchezze in esso custodite; e concludeva, “è severo, terribile come il feroce sovrano che
l’ha costruito”. Quando Verdi stigmatizzava così il re spagnolo, quasi immedesimandolo con
l’imponente e solitario edificio da lui voluto, l’ombra di Don Carlo gli era vicina da circa 13 anni: da
quando cioè nell’agosto 1850 era stato pregato da Alphonse Royer e Gustave Vaez di comporre
un “capolavoro” per l’Opera, ed era stato proposto come soggetto il Don Carlos di Schiller. (…)
L’attenta lettura del dramma tanto congeniale, la doverosa necessità di ampliare la partitura
in cinque lunghi atti che venivano a consentire una lievitazione scenica in approfondite indagini
psicologiche, portarono Verdi a maturare i nuovi personaggi in una prospettiva musicale ben più
elaborata del solito. Non più l’assoluta definizione umana di protagonisti fissati in dimensioni
musicali decise e globali, dove le arie e i brani d’assieme rischiaravano e sbalzavano gli eroi
dell’azione in scorci scenici dominati dall’amore o dall’odio, dal sacrificio o dal peccato,
dall’innocenza o dal delitto, dalla purezza o dalla corruzione; e dove gli episodi procedevano in
fretta attraverso illuminazioni e catastrofi. Ora i personaggi vivono in angosciosi chiaroscuri
musicali e in luci crepuscolari che non sono indice di dubbi creativi ma che ci offrono un risolto
problema di storie d’anime (…).
Questi elementi stilistici cui ho accennato non restarono puri mezzi di rinnovamento tecnico,
anzi, quasi per incanto, conversero a creare quel “clima spagnolo” che mai abbandona il procedere
17
del dramma; e con ciò intendo riferirmi non tanto allo spagnolismo di ritmi e colori popolareschi che
possono incidentalmente aver influito dall’esterno, quanto a quella manifestazione tragica del
mistero della vita che mai sembra distaccarsi dall’anima spagnola, e che nell’opera non
abbandona i molti protagonisti del dramma. Verdi, insomma, colse e potenziò quasi magicamente
nel vasto e possente suo affresco musicale, la Spagna imperiale e fanatica alimentata da
misteriose forze segrete a un tempo mistiche e crudeli; e mise a confronto, e musicalmente
espresse nella serie dei duetti famosi e mirabili, le antinomie spirituali di fermenti insurrezionali e di
oppressione inquisitoriale, di violenza dell’assolutismo e di aspirazioni alla libertà del pensiero, di
indomabili fierezze nazionalistiche e di superiori realtà umane, di religiosa unità e di orgoglio
crudele. Per virtù di genio egli fece coincidere con il canto delle sue creature quel fluttuare fra la
vita e la morte che, secondo quanto ci ha tramandato la grande cultura spagnola, è retaggio
morale di quel popolo (...)
Figura dominatrice del Don Carlo verdiano è Filippo II. Come nell’infante gli ideali di libertà
non riescono a sopire il tormento di un amore impossibile, così nel re, che dovrebbe agire contro il
figlio soltanto in ossequio alla ragion di stato, in realtà - come la musica ci svela - il movente è la
gelosia. (…) Dallo sconforto per l’amore deluso, dal sentimento della solitudine che accompagna la
gloria dei potenti, dal sospetto dell’agguato costante, dal segreto tormento della gelosia di Filippo,
nasce il monologo: “Ella giammai m’amò”, dove la finzione teatrale si annulla nella verità
dell’angoscia dell’uomo solo di fronte al pensiero della morte. Tutto concorre in questa pagina
eccelsa e immortale a rendere la commozione gelida dei silenzi vivi. Le toccanti acciaccature che
ostinatamente risuonano in orchestra come remoti richiami, il canto bellissimo e struggente del
violoncello, l’ansiosa e mossa lamentevole insistenza dei violini, c’introducono nel mistero di
conflitti interiori che Verdi scavò a fondo e affidò al canto, nudo e libero, come un alato e irripetibile
messaggio umano.
Forse fu l’infallibile senso del teatro a suggerire a Verdi di anticipare l’incontro, o meglio lo
scontro, fra Filippo e il Grande Inquisitore - che in Schiller avviene alla fine del dramma -,
ponendolo subito dopo la meditazione notturna, quasi ad accentuare la sconfitta del re; ch’è poi la
totale sconfitta morale d’ogni assolutismo. L’ingresso dell’Inquisitore è annunciato da un tema
tenebroso (affidato a tre fagotti, un controfagotto, violoncelli e contrabbassi, e punteggiato da
accordi di tre tromboni) che sembra scaturire dal profondo; e nel suo ossessivo ripetersi a mo’ di
lugubre pedale, reca in sé il minaccioso incedere d’una irreparabile catastrofe. In questa
schermaglia tragica, vero duello di giganti, la parola risalta precisa e netta pur avvolta in una
concretezza musicale fra le più dense e intense: e in tanta mutevolezza o incertezza psicologica
dei protagonisti, alla figura del Grande Inquisitore Verdi dette il taglio sicuro d’una schiacciante
coerenza, sicura e immobile, inclemente e inumana; vera incarnazione del terrore controriformista
che annulla le titubanze psicologiche e gli spiragli umani che in Filippo tentano aprire un varco
nella crudeltà della ragion di stato. (...)
Verdi ebbe il sospetto che la mancata popolarità del Don Carlo fosse dovuta alla sua
lunghezza imposta dalle norme del gusto francese: ma si trattò d’un equivoco, perché nonostante i
due rimaneggiamenti dell’83 e dell’87 l’opera seguitò a non vincere totalmente il riserbo dei
pubblici. Fu creduta e detta prolissa quest’opera immensa e carica di futuro, solo perché i
personaggi non si presentavano di colpo definiti in compiutezza immediata, ma richiedevano
dall’ascoltatore l’attenzione che esigono le vaste descrizioni interiori dei grandi romanzi. Fu pigrizia
d’ascolto, o insofferenza a seriamente meditare, o difficoltà di comprensione, a nascondere ai più per tanti anni- i tesori di questa fatica unica, di questa vittoriosa lotta di Verdi con Verdi, di questo
dono offerto alla civiltà di un nuovo dramma musicale italiano. Oggi le mirabili e sofferte reticenze
di quest’opera che non ha eguali, ci sorprendono e ci commuovono forse ancor più che non la
perfezione assoluta dei capolavori a noi più familiari.
(G. BARBLAN - Programma di sala “La Scala”, 1954)
Don Carlo rappresenta nell’evoluzione del pensiero e dell’arte verdiani il tentativo più lucido e
consapevole di proporre attraverso il melodramma, in una sintesi di singolare complessità
drammaturgica e di denso spessore significativo, una visione globale della vita e della storia
offrendone insieme la chiave d’interpretazione ideologica. Don Carlo è l’affermazione della libertà
di sentire, di pensare e di agire, riconosciuta come diritto naturale e inalienabile di ogni individuo e
di ogni popolo. È, in certa misura, una sacra rappresentazione, che quei principi proclama
18
esibendo la fenomenologia conseguente alla loro inumana negazione: è l’evocazione di un mondo
in disfacimento sotto lo smagliante decoro delle sue apparenze, l’immagine di una società che
soffoca e si sgretola perché conculcata nei suoi diritti naturali, nelle sue organiche ragioni vitali.
L’opera nacque dopo lunghissima, segreta gestazione - attraverso la mediazione del Don
Carlos di Schiller - come una meditazione su temi di fondamentale rilievo umano. Ma il suo segno
non è - come in Schiller - quello dell’utopia, bensì quello del realismo: del quale si fa garante la
oggettiva globalità del quadro evocato, la ricercata ed esibita interdipendenza tra le parti
dell’universo che il teatro è chiamato a riflettere. Così i destini dei protagonisti, scrutati nelle pieghe
più riposte delle loro anime, si intersecano con avvenimenti storici grandiosi e questi, a loro volta,
nello scontro drammatico di principi universali - rivelano le loro dolenti motivazioni occulte, il nodo
di forze oscure che ne determinano il corso: il tutto in un’intricata connessione di piani, di motivi, di
temi dotati di straordinaria tensione ideale ed emotiva, che elevano la scena melodrammatica - pur
non negandone l’immediata evidenza popolare - a incisiva metafora della realtà, i suoi personaggi
e le vicende ad emblemi di forze sentite e indicate come tuttavia vive e operanti nella situazione
storica contemporanea.
(…) L’eccezionale ricchezza degli elementi tematici conseguenti a questa esplicita ricerca di
totalità espressiva, fa di Don Carlo un’opera che rifugge da una prospettiva di lettura univocamente
e rigidamente orientata. La sua struttura è unitaria, ma policentrica; i punti di osservazione da cui
porsi per afferrarne con un sol colpo d’occhio la complessa sostanza sono vari, e ogni angolazione
permette acquisizioni nuove. La somma delle prospettive possibili offre una visione estremamente
densa, frastagliata e se vogliamo anche contraddittoria, assai più complessa rispetto al taglio
tradizionalmente riduttivo e convenzionale del melodramma.
(FRANCESCO DEGRADA - Programma di sala “La Scala”, 1978)
4. Aida
Aida non è un’opera di tutto riposo, la cui valutazione si sia ormai cristallizzata in un giudizio
definitivo. Nonostante la sua enorme popolarità Aida è un’opera che si interroga ancora, e ad ogni
ripresa importante ci si va con l’animo aperto alla possibilità di verificare le proprie opinioni, di cui
non si è sicurissimi. Aida! Per quanta parte dei grandi pubblici d’opera non si racchiude in queste
quattro lettere il segreto della massima potenza verdiana, di quella sua arte elementare e
barbarica, tutta scorci violenti e chiaroscuri, che più d’ogni altra sa destare nel cuore dei popoli
l’entusiasmo. (...)
Se ritorniamo a quello che avevamo definito come il particolare atteggiamento drammatico
dell’ispirazione, cioè la capacità di impersonare nella soggettività lirica sentimentale un mondo
apparentemente esteriore di caratteri e di tipi umani, vediamo Verdi giunto a un tale grado di
evidenza, a tanta vastità di risonanze psicologiche e soprattutto ad una tale cosciente chiarezza di
concezione, che le sue creazioni non hanno più bisogno di nessuna illustrazione. Ogni
convenzione è sparita: l’umanità dei suoi personaggi non soffre più restrizioni di alcun genere,
poiché è giunta a quel grado miracoloso di universalità a cui sa giungere il cosiddetto verismo,
quando, spogliatesi d’ogni carattere polemico di scuola o di maniera o di programma artistico,
diventa semplicemente verità.
(M. MILA - Il melodramma di Verdi, Ed. Feltrinelli, 1960)
Perché il soggetto proposto da Du Locle entusiasmò subito Verdi, sì da convincerlo a
riprendere la penna dopo i tre anni di relativa inattività seguiti al “Don Carlos”? Perché vi trovò la
“tinta” com’egli diceva. Con questo termine di “tinta” a lui caro, Verdi non voleva certo significare
ciò che comunemente vien detto “colore locale”, pretesto per il musicista di modesti compiti
illustrativi e non di autentica creazione artistica. La “tinta”, che il compositore aveva sempre
cercato nei soggetti da svolgere nelle proprie opere, era per lui il segno caratteristico atto ogni
volta ad offrire un centro di gravità alle forze dell’ispirazione. In tal senso, la “tinta” si identifica con
quella “idea-una” che, nel suo pensiero, come abbiamo visto, doveva costituire nell’opera
l’elemento coordinatore di tutte le forze in atto. Nel caso dell’ “Aida”, è vero, il movimento della
tragedia si accompagna in parte all’evocazione di fondo di un’atmosfera “ambientale” (…) Però il
centro, l’ “ubi consistam” della tragedia musicale finisce anche qui con l’identificarsi nel dramma di
19
passioni, di. sentimenti, di realtà umane, insomma. Ed è il dramma la cui peculiarità, e diciamo
pure la “tinta”, risiede nel groviglio di odio-amore che coinvolge in una spirale di tragica fatalità il
volere e l’anima dei suoi quattro personaggi.
(…) L’importante è considerare l’opera nel quadro del mondo poetico di Verdi, del processo
lucido e cosciente dell’evoluzione di esso. Pur nell’accennata mobilità di inflessioni e di
articolazioni, ad esempio, il canto vocale di “Aida” è sempre, come non potrebbe non essere, di
pretta impronta verdiana e ciò, innanzitutto, per la sua disponibilità alla frase spiegata, al volo lirico,
tanto che l’opera, come ben si sa, non manca di accogliere nel suo contesto, con la celebre
romanza di Radames “Celeste Aida”, poniamo, con l’incantevole idillio-notturno sopranile “O patria
mia, mai più ti rivedrò”, esempi di quei “pezzi chiusi” che, staccati dall’opera, fanno le spese,
ahimè, dei cosidetti “concerti operistici”. Ma, com’è tendenza sempre viva nella musica di Verdi e
più che mai dirompente in “Aida”, non è detto che le più alte temperature espressive siano
raggiunte solo attraverso gli spiegamenti e voli del frammento “lirico”. Forse anzi, sotto questo
profilo, la maggior forza del dramma musicale risiede nella sua struttura di base che, sul piano
vocale è decisamente a livello di recitativo-declamato-arioso ma tale, per la stretta aderenza ai
moti del flusso drammatico, da sfuggire, di caso in caso, alla possibilità di preciso inquadramento
nell’uno o nell’altro tipo di canto.
(M. BRUNI - Programma di sala “La Fenice”, 1970)
L’Aida si pone come il coronamento delle acquisizioni di quegli anni, come l’opera della
musica avanti tutto. (...) In questa fase dello svolgimento artistico verdiano, il mondo affettivo del
maestro si è ancora arricchito, si è fatto ancor più vario e complesso: basterà ripensare
all’introduzione del terzo atto dell’opera, a quel tanto di misterico che la caratterizza, in
un’atmosfera sempre drammaticamente tesa, ma più rarefatta, in cui, senza nessuna concessione
di fondo a quella nuova temperie storica che si veniva preparando, (...) è pur evidente che il
Maestro non è rimasto del tutto insensibile a quel mutamento del gusto che veniva maturando, lo
ha avvertito, e, senza infrangere la propria tematica, il proprio fondamentale equilibrio d’arte, ha
pure accolto nel suo contenuto anche qualche tema di quel momento nuovo: toni e motivi di un
Verdi finora sconosciuto, ai quali forse proprio il soggetto esotico dell’opera, quel mitico mondo
egiziano, ha permesso di affiorare. (...)
Le novità strutturali di Aida si presentano subito evidentissime. L’opera è caratterizzata da
una larga presenza di scene di massa, cori e balletti, che certo non hanno nulla a che fare con il
dramma intimo dei personaggi principali: Verdi sembra qui essere venuto meno a quella esigenza
di rigida essenzialità e stringatezza narrativa, propria del suo teatro; e tuttavia, prima di trascurare
quegli episodi come puramente decorativi ed estranei all’ispirazione centrale di Aida, sarà forse il
caso di ricercare quale essenzialità nuova il Maestro possa aver perseguito, o, più semplicemente,
quale funzione possano avere assunto quegli episodi nella nuova compagine strutturale del
dramma. (...)
Il Maestro aveva sempre avvertito con un certo fastidio il problema dei ballabili come
imposizione di consuetudini teatrali soprattutto francesi, ed in sostanza perché l’inserimento dei
balletti riusciva contrario alla sua concezione del dramma. (...) Per Aida non è così: questo giudizio
prescinde completamente dal valore intrinseco di quei passi musicali in sé considerati; a me preme
soltanto rilevare che, mentre possiamo idealmente eliminare i balletti del Macbeth e del Don Carlos
(che poi, in effetti, vengono frequentemente soppressi nelle rappresentazioni senza pregiudizio
alcuno dell’impianto strutturale dell’opera), questo non sarebbe più assolutamente possibile per
l’Aida. (...) Nell’Aida la funzione delle scene di massa appare diversa: in tutti questi episodi, le
vicende dei personaggi principali si arrestano nel senso che quei personaggi non cantano e non
agiscono, ma il dramma più vero, il dramma proposto dalla musica, continua necessariamente
anche in quelle pagine, caratterizzate da una situazione musicalmente sempre chiarissima. I
protagonisti del dramma intimo, Aida e Amonasro, Amneris e Radamès, si presentano ancora,
certamente, come i cardini su cui poggia la costruzione drammatica, ma non più, recisamente,
come gli unici cardini: lo sfondo prende un rilievo insolito, si mescola con le vicende dei
personaggi, si pone accanto a quelle vicende quasi come più ampio riscontro, più vasto orizzonte
di vicende più grandi e di più generali passioni, riuscendo finalmente a quella fusione tra i piani
diversi che era rimasta ancora intenzionale in tanta parte della produzione precedente.
(P. PINAGLI - Romanticismo verdiano, Ed. Vallecchi, 1967)
20
5. Il linguaggio musicale dopo Traviata
Coll’arricchirsi in vastità e in profondità di risonanza del mondo melodrammatico verdiano,
durante il secondo periodo di maturazione e di studio che va dal 1853 al 1870 circa, si pone e
risolve il problema di una più ricca e completa espressione musicale. La semplice umanità di
Rigoletto, Traviata, cede il posto a nuove esperienze spirituali: gli orizzonti del mondo verdiano si
allargano, lo stesso contegno del compositore di fronte ai suoi drammi va leggermente
modificandosi. (...) L’intreccio verdiano non ha più l’uniformità di un tempo. (...)
Tutto questo stato di cose richiede di per sé una più ampia gamma d’espressione musicale.
Si aggiunge la maggiore raffinatezza artistica e intellettuale di Verdi che si apre, sia pure con
intima irriducibile diffidenza, alle nuove teorie melodrammatiche che oltr’alpe Riccardo Wagner, in
Italia il Boito e il Faccio agitano con molto clamore. Anch’egli comincia a parlare, con un certo
impaccio, di “dramma scenico musicale” che deve essere compreso nell’interezza del suo
organismo e non come un mosaico di pezzi felici, ma chiusi. Per questo scopo bisogna riformare
ancora il canto, riformarlo sulla via indicata dai pezzi più belli di Rigoletto e Traviata, dove esso si
atteggia a fluente e libero discorso, scioltamente ondeggiante fra opposti stati d’animo anziché
immobile e inquadrato nella rigida forma e nell’immutabile atmosfera sentimentale di un’aria.
D’altra parte a queste non rinunciare quando siano opportune, ma trovare il modo di conciliarle con
il quadro musicale senza bruschi trapassi, senza soluzione di continuità nel tessuto dell’opera.
Quindi da un lato elevare il recitativo a un declamato sempre arioso e cantabile, almeno in
potenza, dall’altro smussare gli spigoli troppo netti delle forme chiuse. L’elemento che può fare
tutto questo, creare il substrato musicale su cui le voci procedano liberamente, è l’orchestra;
nell’orchestra ancora trovano più facilmente luogo le sfumature espressive con cui la sensibilità
verdiana ogni giorno più delicata ed attenta reagisce a contatto del dramma. Proprio all’orchestra,
alla sinfonia, vanno in quegli anni le cure e gli entusiasmi dei giovani e dei novatori, l’arte tedesca
passa la frontiera e viene accolta con amore e ammirazione anche fra noi. Verdi, riluttante, strenuo
e cocciuto nell’asserzione del suo giudizio sulla vocalità come espressione di musica nazionale,
sente suo malgrado gli effetti di questo movimento: la sua attenzione per la strumentazione si
affina, le risorse espressive della sua orchestra si acuiscono, ma poi, soprattutto egli acquista il
senso della scrittura strumentale. (...)
L’orchestra che tante volte pareva sacrificata, secondo l’espressione di Wagner, ad una
parte di gigantesca chitarra, e spesso pareva riuscir d’imbarazzo al compositore, partecipa ora
fecondamente alla vita dell’opera. L’idea musicale di Verdi, migliorata sotto tutti gli aspetti, nasce
ora non soltanto sotto forma di pura monodica vocalità, ma complessa e ricca, completa solo nella
collaborazione di canto e orchestra. (...)
In questo modo Verdi si avvia a trovare il tessuto musicale su cui distendere da capo a fondo
l’ordito dell’opera; il brusco distacco fra arie, cabalette, cavatine da un lato e recitativi dall’altro, si
attenua: in un’opera che è quasi tutta un cantabile, le forme chiuse non emergono più con
sfacciata preminenza. L’orchestra riacquista i suoi diritti e crea assieme alla voce l’idea musicale,
non solo predomina nei dialoghi spezzati e di per sé scarsamente lirici, suggerendo con richiami
tematici o con espressive armonie la particolare situazione drammatica che a quelle parole
apparentemente insignificanti dà peso e vita, ma qualche volta proprio l’orchestra è chiamata a
fare da unica protagonista musicale della scena. (...)
L’evoluzione musicale procede di pari passo con quella spirituale. (…) Verdi predilige ora
brevi cellule tematiche, spesso orchestrali, certo indipendenti dal verso, dalle quali ha imparato a
spremere ogni possibilità (…). La melodia di Verdi non ci prende più, come un tempo, dall’esterno,
come una forza travolgente e entusiasmante, ma si insinua in noi molto più profondamente, con la
malia di un fascino più sottile e più duraturo, risvegliando nuovi echi della nostra sensibilità,
giungendo ai più riposti recessi dell’animo. Il declamato espressivo della “lirica” impressionistica e
di tanta parte dell’opera moderna, è già completo e perfetto in alcuni passi del Don Carlos, là dove
esso è veramente necessario per esprimere sensazioni tortuose e strane di anime deboli e malate.
(M. MILA - II melodramma di Verdi, Ed. Feltrinelli, 1960)
21
PARTE V
DAL DRAMMA ALLA “TRAGEDIA” E ALLA “COMMEDIA”
1. Il “grande silenzio” dopo Aida
Sul periodo che va dall’Aida all’Otello, i critici sogliono tirare un frego, come quello che, non
offrendo alcun segno tangibile dell’attività del Maestro, sembra non possa recare elementi
significativi e contributi interessanti alla piena comprensione della sua personalità. Il solo fatto che
da tutti si suol rilevare è l’amicizia fra Verdi e il Boito, che si strinse e si approfondì appunto in
questi anni; comunemente additata come la sorgente unica del nuovo orientamento verdiano. Né
si vuole certo negare o sminuire l’importanza di questo incontro. Se in gioventù Boito aveva potuto
mostrare verso Verdi una certa insofferenza e antipatia, proveniente da una raffinatezza estetica e
spirituale che si sentiva urtata dalla forza, talvolta un po’ rude, di certi atteggiamenti verdiani,
quando lo conobbe alcuni anni più tardi sentì subito tutta la potenza della sua natura geniale, e si
prodigò con generosa dedizione di se stesso e con amore perché nulla di quella forza andasse
perduto. (...). Da Boito Verdi ricevette, certo, impulsi fecondi ad esplorare molti campi che fino
allora gli erano rimasti ignoti, e a ripercorrerne altri al lume di altri criteri; e, soprattutto, egli ebbe
da lui quei libretti da lungo tempo vagheggiati, che gli consentirono di assurgere a più alte sfere
nella realizzazione del dramma musicale.
Ma fatta questa constatazione e ammessa questa influenza, bisogna subito aggiungere che
il motivo più profondo dell’evoluzione verdiana deve ricercarsi nello spirito stesso di Verdi, nella
sua sensibilità, nella sua ansia di perfezione, nella sua irrequietezza. Sebbene egli mantenesse il
più austero riserbo, e non consentisse ad alcuno di penetrare nel santuario della sua anima e della
sua arte, si può senza esagerazione affermare che il periodo 1874-1887 segna per lui una vera e
propria crisi artistica; o meglio una successione di crisi, con alternative di ricerche febbrili e di
dubbi fecondi, di assimilazioni laboriose e di meditazioni assidue, di indagine culturale e di
esplorazione interiore. Tutto lo prova; tutto lo attesta: le lunghe esitazioni, i timori, le ritrosie che
Verdi mostra a intraprendere la composizione di Otello; la profonda trasformazione che il
melodramma verdiano subisce nella sua generale struttura; i meravigliosi progressi tecnici che,
subordinati alle finalità superiori della creazione, generano pagine orchestrali d’una potenza
descrittiva veramente shakespiriana, come quella dell’uragano onde l’opera s’inizia; e infine i
dubbi, che negli anni di Otello e di Falstaff assalivano talvolta il Maestro sul valore e la durabilità
delle sue opere; dubbi di un artista che, avendo sentito la necessità di uniformarsi alle esigenze del
tempo, e avendo trovato in sé le forze necessarie a questa rinnovazione, guarda alle sue passate
conquiste come a tappe da lui definitivamente superate, e sente palpitare in sé i gemi di nuovi
mondi. (...) Si comprende così il travaglio di questi anni; e si comprende la sua riluttanza a
riprendere la composizione, vinta specialmente dalle vigili e premurose istanze di Boito, che meglio
d’ogni altro intuiva dove Verdi poteva arrivare (…).
(ANTONIO. CAPRI - Musica e musicisti d’Europa, Ed. Hoepli, 1931)
2. Verdi, Wagner, Shakespeare
Il maggior problema che deve essersi presentato a Verdi, nel periodo di cui si discorre, fu
senza dubbio quello del wagnerismo, che allora invadeva tutta Europa (…). Per Verdi, questo
problema dovette assumere una particolare importanza giacché, nel suo caso, non si trattava
soltanto di perpetrare una intelligente assimilazione dei procedimenti di cui Wagner aveva
arricchita la tecnica costruttiva e strumentale, ma si trattava soprattutto di stabilire fino a qual punto
i concetti estetici che stavano a fondamento della riforma wagneriana del melodramma avessero
valore universale e fossero conciliabili con le caratteristiche e le esigenze dell’arte nostra.
(A. CAPRI, op. cit.)
22
Con Otello il Maestro entra nell’ultima fase della sua rivoluzione musicale. Egli aveva
incominciato portando nel melodramma dei caratteri di violenza melodica e di impeto passionale
ancora sconosciuti. Poi tentò di superare la forma conquistata; e dopo una serie di prove (…)
afferma con Aida una decisiva rivoluzione melodica. Ma lontano, quasi sperduto, era rimasto nel
Macbeth un altro insigne tentativo: la creazione di un recitativo melodicamente commosso e più
vivamente drammatico. E con Otello e Falstaff è precisamente la rivoluzione del recitativo che ha il
sopravvento. La melodia naturalmente e liberamente si spezza e si dissolve in un declamato
melodicamente intensivo e drammatico, che però nulla ha a che vedere con la melopèa
wagneriana. Anzi, è bene notarlo, le rivoluzione verdiane condussero a una forma musicale del
tutto differente da quella di Wagner, e pur tuttavia di pari importanza estetica.
La musica di Otello e Falstaff è strettamente connessa con tutta la precedente arte musicale
italiana, e soltanto con l’italiana. (...) Verdi considerò l’opera wagneriana, ma non ne prese che
degli insegnamenti puramente esteriori che riguardano la struttura dell’opera, non la forma della
melodia. Un punto di partenza comune c’era già prima che il nostro Maestro potesse venire a
conoscenza delle opere di Wagner, ed era questo: la musica drammatica dover nascere dal
linguaggio appassionato. Se qualche insegnamento Verdi trasse dall’arte wagneriana forse fu
quello di rendere ancor più profonda e libera questa genesi; insegnamento che del resto il Wagner
stesso aveva ripreso da Gluck e questi dalla nostra “Camerata Fiorentina” del 1600. (...)
Il temperamento artistico verdiano, violento ed ardente, la tragicità profonda di certi suoi
scatti, l’austerità solenne e umanamente religiosa del suo estro melodico, tutto lo portava presso
l’arte di Guglielmo Shakespeare. Nel grande poeta inglese egli ritrovava completamente se stesso.
Era in entrambi il medesimo impeto tragico, la medesima concezione della vita e un’identica
idealità d’arte. Balenava nel loro spirito la stessa fiamma; il Fato parlava in loro con lo stesso
tremendo grido, li possedeva con uguale furore, con la stessa demoniaca potenza.
(…) Questo shakespearianismo di Giuseppe Verdi fu quello che lo salvò dal wagnerismo.
Infatti tra la mentalità di Riccardo Wagner e quella di Shakespeare c’è un abisso. Wagner è
sempre un mistico; il problema religioso, la concezione trascendentale è sempre in fondo ad ogni
suo dramma e in ogni suo motivo musicale. Nel gran tragico inglese vi è invece un profondo
umanesimo, centuplicato sì nella sua forza vitale, portato ad una estrema potenza espressiva,
cosicché i personaggi non sono quasi più che il simbolo della loro passione personificata, ma
passione sempre e profondamente umana. Questo medesimo spirito anima la musica di Giuseppe
Verdi, musica fatta di tragica ma pura umanità, a volte terribile come un versetto apocalittico, come
un monito di profeta, ma giammai mistica o ascetica, e quindi sempre lontana dall’arte di Wagner.
(GINO RONCAGLIA - Giuseppe Verdi, Ed. Perrella,1914)
3. Otello
Nell’Otello, il contenuto e la fisionomia dell’arte verdiana non possono dirsi sostanzialmente
mutati. È sempre la stessa interiorità, martellata e travagliata, dell’ispirazione; la stessa
concentrazione d’umanità che si sprigiona negli accenti della melodia, ora serena ed estatica, ora
ardente e dolorosa, ora trepida di passionalità tremebonda; è sempre lo stesso vigore scultoreo dei
recitativi, che tracciano possenti rilievi, contrasti subitanei e inattesi; ma è, insieme, un’architettura
più vasta e complessa del dramma, una cura mirabile di ogni dettaglio, un’armonizzazione più
elaborata e raffinata e, segnatamente, un’orchestrazione infinitamente più ricca e possente, che
non si limita mai a un mero ufficio d’accompagnamento ma in ogni momento dell’azione partecipa
intensamente al dramma e si fa interprete delle passioni, delle situazioni e dei caratteri. (…)
Per ciò che si riferisce essenzialmente all’invenzione musicale (…) si può senz’altro asserire
che Verdi è sino ad oggi il solo musicista il quale, accostandosi a Shakespeare, non solo non l’ha
in alcun modo menomato, ma ci ha dato tutta la misura della sua grandezza, potenziandone e
intensificandone l’espressione. Alcuni tratti e alcune effusioni liriche, come il monologo di Otello al
terzo atto e la mesta e pavida trepidazione di Desdemona nel quarto, toccano veramente il
sublime.
Tutta l’ultima scena è d’una sovrana bellezza. L’urto del vento alla porta della camera, la
preghiera di Desdemona, l’entrata di Otello, col formidabile inciso dei contrabbassi, tutto concorre
a creare un’atmosfera in cui è il presagio della catastrofe imminente ed incombente, ed è insieme
un’aura soave e solenne, che stupendamente si precisa e si dilata nell’ultimo canto di Otello, in cui
23
il dolore sembra culminare in una trasfigurazione suprema e liberatrice. Anche l’amore di Otello è
poeticamente cantato in tutte le sue gradazioni, nella ingenuità quasi fanciullesca dei suoi ardori
sensuali, nelle sue vicende di felicità e di strazio, negli scoppi or violenti or disperati di gelosia. (...)
La grandezza di Jago sta tutta nel monologo della sua coscienza. È una grandezza tutta
interiore e psicologica. Jago è il male come volere individuale e come destino; è la fatalità del male
radicata nella natura umana. Esteriorizzare questa bieca perversità, fissarla in atteggiamenti
plastici, configurarla scenicamente, tradurla in accenti musicali appropriati e significativi,
equivaleva a darle un modo d’esistenza e di estrinsecazione troppo diverso da quello nel quale e
per il quale era stata concepita.
(…) Jago con la faccia da galantuomo: ecco l’aspetto che Verdi ha colto e rappresentato più
efficacemente. L’opera lenta e perfida, con cui il malvagio traditore insinua il sospetto nel cuore
ingenuamente credulo di Otello, trova nel declamato verdiano accenti ed atteggiamenti
efficacissimi di evidenza e perspicuità. Ma il carattere di Jago ha anche un aspetto terribile. Egli,
come dice Verdi stesso, è l’umanità guardata sotto la specie del male, della perversità. “Io non
sono che un critico”, esclama Jago; e un critico, in questo caso, significa un capovolgitore di tutti i
valori morali, che fa della coscienza un deserto gelido e tremendo, un vuoto tenebroso ove
regnano la morte e il nulla. Queste due parole si trovano infatti nel Credo del secondo atto.
(A. CAPRI, op. cit.)
Se ancora nel 1883 Verdi confidava al Ricordi: “Non ho scritto nulla di questo Jago, o meglio
Otello, e non so cosa farò in seguito”, nei tre successivi anni quello che a tutti appariva come un
miracolo si avverò. Boito si era totalmente votato alla causa del Maestro: “Saprò lavorare per Lei,
io che non so lavorare per me”, gli aveva scritto, e mantenne la promessa rifacendo il libretto
secondo quello che gli veniva richiesto lasciando Verdi arbitro di qualsiasi mutamento, in quanto
“la ragione musicale è quella che deve decidere”. (…)
Con il chiarificarsi e il definirsi della traccia poetica attraverso un libretto fra i più elaborati e
coerenti che conosciamo, e nel quale, per ovvie esigenze, le figure shakespeariane si
raggrumavano in tratti spiccioli riprendendo dal testo originale soltanto rare essenziali espansioni,
nasceva di pari passo la nuova vita musicale del dramma. (…)
Jago era al centro del pensiero e delle preoccupazioni del Maestro e trasferendosi dalla
tragedia originaria nel dramma in musica boitiano-verdiano, veniva compendiandosi tutto nella
personificazione del male. (…) Dopo i rapidi scorci che sommariamente lo illuminano nel primo
atto, ne sorprendiamo la psicologica identificazione nel secondo e nel terzo atto (nei quali egli è
protagonista) attraverso le sottili esortazioni rivolte a Cassio: “Non ti crucciar” e “Or t’è aperta la via
di salvazione”, prima che esploda la veemenza del Credo: nelle melliflue insinuazioni che
suscitano in Otello la improvvisa reazione dei primi e già cocenti sospetti e nel viscido strisciare del
cromatico “Temete, signor, la gelosia”. E ancora - dopo che l’onesto alfiere ha come insufflato
nell’orecchio di Otello il terribile ritornello: “Vigilate” - sostiamo nell’ascolto, sempre “a mezza voce”,
e della calunniosa istigazione: “Avvinti vederli forse?” e del racconto del falso sogno che, sotto
l’ingenua movenza di una ninna-nanna, nasconde la raffinata perfidia del canto di Jago. (...)
Contro la sottigliezza sfuggente tutta a fior di labbra di Jago, si erge la elementarietà eroica
di Otello. Dominatore solenne e terribile sul nemico e sulla furia del mare, la sua voce copre ogni
clangore col sicuro squillo dell’ “Esultate” nella mirabile pagina sinfonico-corale che apre e subito
arroventa il dramma. (...) Ancora una volta dominatore imperioso sul tumulto delle passioni
scatenate fino al sangue, e sul vociare della folla ubriaca, egli prorompe nel fermo grido di
“Abbasso le spade”, che placa la perfetta costruzione dello smodato baccanale. E dopo questo
colpo di scena di incisivo effetto, eccolo farsi amante tenero e semplice. Qui al pulsar del sangue
nel fremito della passione, Verdi ha preferito un calmo sentimento d’amore che, nella notte,
udiamo espandersi nell’immensità del creato, e vivere nel mormorio dei ricordi reciproci per
culminare nella romantica invocazione alla morte, e venarsi infine, con la richiesta del bacio, di un
brivido sensuale che subito si trasfonde nella contemplazione dell’infinito.
Ma le virtù eroiche che la musica del primo atto a fondo incide, rapidamente crollano nel
maturar del dramma. (...) Nella prima parte del terzo atto la psicologia di Otello tocca i vertici. (...)
La sua grandezza crolla. Una cromatica discesa degli archi che si adagia sul ritmo di funebre
presagio introduce il lamento dell’eroe schiantato dal morso della gelosia. Verità e poesia si
fondono nella mirabile pagina del monologo: “Dio! mi potevi scagliar”, dove l’anima del
24
protagonista ci appare a nudo attraverso tocchi altissimi che portano lo smarrimento, la
concitazione, la rassegnazione, la ferocia a espressioni di universale respiro. (...)
Dileguatasi la figura di Jago, Otello è ormai solo di fronte alla sua vittima: la cupa e torbida
frase dei contrabbassi lo introduce, al quarto atto, quasi furtivamente nella stanza della sposa, il
tema del bacio d’amore lo annunzia a Desdemona. Nessun ricordo passato arresterà la mano
omicida nell’incalzar del dialogo stringente. Poi, compiuto il misfatto, davanti alla scoperta verità,
nel canto che conclude il dramma Verdi ci svela infine l’anima del suo Otello: che è tutta credulità
generosa di una creatura eroica incapace di comprendere quanto di subdolo può albergare nella
ragione umana. Il condottiero invitto è ora un fanciullo smarrito che inutilmente implora colei che
non può più ascoltarlo. Dall’orchestra sale il malioso tema del bacio troppo tardi invocato. (...)
Desdemona fa ascoltare la sua voce soltanto dopo che Otello le ha rivolto il sereno canto
d’amore. Anch’essa, come lo sposo, è musicalmente pervasa da un sentimento superiore e quasi
pacata nella fervida rievocazione dell’entusiasmo e della pietà che fecero fiorire in lei l’estatico
affetto. Personaggio che ripete nel canto la casta fermezza della Desdemona shakespeariana,
essa ora si affianca degnamente alla statura dell’eroe con la sua femminilità. Nell’atto secondo e
terzo essa diviene figura passiva e indifesa, come la volle Shakespeare, come la designò il nome
(“dusdàimon” - nata sotto cattiva stella) e come la mantenne Verdi. I suoi lenti riflessi aggiungono
inopportunità all’ingenuità, sì che il suo canto permane madrigalesco in difesa di Cassio anche
quando Otello tuona nell’esplodere della gelosia. (...) Solo nel quarto atto Desdemona grandeggia,
sublime, attraverso toni che forse neppure l’eroina di Shakespeare conobbe. Essa è ora conscia di
quanto accade, e confida la propria paura ad Emilia che è l’unico carattere coraggioso ben
disegnato nei suoi rari tratti. Il peso della tragedia, che negli altri momenti attenuava la consistenza
umana della dolce sposa, la innalza qui a statura immensa e indimenticabile. L’innocenza acquista
la sua corporeità musicale, e il sentimento d’amore che ascoltammo, alato e puro, librarsi nella
notte sul mare, guida ora la creatura sul fatale sentiero della morte. Soffusa d’immacolata
malinconia risuona nel nostro animo l’estrema Canzone del salice come imperitura eco dell’eroina
verdiana.
“Otello è. Il gran sogno s’è fatto realtà... Oramai l’Otello di Shakespeare possiede il suo
commento, e questo lo ha fatto Lei”: così scriveva, con incondizionata ammirazione, Boito a Verdi
nel dicembre 1886 non molte settimane prima che l’opera ottenesse l’entusiastico battesimo della
Scala il 5 febbraio 1887. Verdi, come sempre, interrogava, e non senza una punta di scetticismo,
l’opera sua; e questa volta per indagare di quanto avesse “sbagliato” rispetto a Shakespeare.
(...) A distoglierlo dal cruccio che l’ideale di una sempre più alta perfezione alimentava, era
intervenuto l’amico Boito il quale, due anni dopo il varo dell’opera, così gli scriveva: “.S’è detto di
Lei dopo l’Otello: ‘è impossibile finir meglio!’...”. Ma nella stessa lettera, proseguendo in una sua
preveggente e decisa intenzione, aveva insinuato al settantaseienne Maestro - con la sottile
maniera di un Jago - l’ardito miraggio: “C’è un modo solo di finir meglio che coll’Otello ed è di finir
vittoriosamente col Falstaff!”.
(GUGLIELMO BARBLAN - Programma di sala Teatro alla Scala, 1959/60)
4. Falstaff
Dall’Otello al Falstaff è un intervallo di sei anni (1887-1893); e sono anni di conquistata
serenità, di supremo equilibrio interiore.
Il Falstaff è opera perfetta, ed è insieme l’espressione di una saggezza superiore. È lo
sguardo limpido, pacato, chiaroveggente che uno spirito fatto esperto e consapevole di tutte le
miserie terrene, dei vizi e delle debolezze umane, getta sul mondo contemplato da una zona di
calma luminosa, ove più non aleggiano le nubi delle tempeste passionali. Ma questa riposta
filosofia non è adombrata in simboli e in allegorie più o meno chiaramente decifrabili, sebbene
espressa direttamente e immediatamente, come esperienza di vita. La significazione ideale che
per noi assume la rappresentazione dei caratteri e delle vicende loro, costituisce altresì la bellezza
organica dell’opera, e altro non è che un riflesso e una vibrazione del suo contenuto universale,
spirituale, cosmico, che si propaga e si compie in noi, nell’intimità della nostra coscienza. Verdi,
come il Goethe del secondo Faust, raggiunge quel supremo grado di spiritualizzazione per cui le
cose vengono guardate e, al tempo stesso, penetrate più profondamente da una luce che ci
mostra gli opposti aspetti della vita: il tragico e il comico, il sublime e il plebeo, l’ideale e le
25
truccature e degradazioni ch’esso subisce inevitabilmente nei contatti e nelle mescolanze della
realtà. Ma tutto ciò, senza amarezza di sarcasmo o crudezza di satira, con umore e bonomia, con
un aureo sorriso che avvolge, affina, purifica tutti gli aspetti più laidi e grottescamente caricaturali
del vizio: dov’è il maggiore segreto dell’umorismo. L’ironia germoglia e fiorisce senza aculei e
senza veleni, circonfusa e aureolata d’una bontà fatta di benigno compatimento, di non confessato
ma palese amore, di fraterna pietà per le debolezze e le colpe del cuore umano. (...)
Il Falstaff è lavoro d’intarsio e di cesello. In quest’opera, fin dalle prime battute, siamo gettati
nel vivo dell’azione. Verdi non adotta neppure qui la forma del leitmotiv, com’e usato da Wagner;
ma inventa, con piena libertà d’imprevedibili movimenti, incisi e frammenti musicali atti a
caratterizzare la fisionomia dei personaggi, a rilevarne e individuarne l’azione, a fissarne
plasticamente gli atteggiamenti. Tutto vi è agile, fresco, scorrevole; tutto concorre a procurare un
godimento sereno e indisturbato (...).
Far vibrare tante corde senza compromettere l’unità del disegno; anzi, far servire questa
gamma ricchissima d’accenti e di trapassi a ricondurci continuamente al motivo principale; trovare
per ogni carattere, per ogni situazione, per ogni affetto e sentimento l’espressione adeguata,
afferrante, evidente, e colorirla con effetti strumentali nuovi e inaspettati, pur serbando nella trama
orchestrale una mirabile trasparenza e levità di tocchi e sfumature; far echeggiare nella spigliata
giocondità della burla la nota idillica di un amore pieno di vezzi e di gentilezza, e porvi a sfondo la
misteriosa serenità del paesaggio notturno; immaginare i più vari, i più ingegnosi movimenti ritmici,
le combinazioni armoniche più nuove e inattese, gli impasti timbrici più adatti a rendere le
gradazioni e i passaggi psicologici, la fervida espansività di quel mondo comico, pieno di sorprese
e di contrasti (…) tale è il miracolo che Verdi ha compiuto all’età di ottant’anni, dando all’Italia una
delle opere più perfette che mai mente umana abbia saputo concepire e realizzare.
Fino a pochi anni or sono non si era compreso il valore di quest’opera. Al suo primo apparire
essa non aveva ottenuto che un successo di stima; e, in seguito, fu generalmente ritenuta opera di
affievolimento senile. Oggi soltanto si comincia a valutarne esattamente il valore estetico e la
portata storica. Verdi vi aveva raggiunto il più mirabile equilibrio fra la tradizione e il progresso, fra
la propria originalità, incomparabilmente approfondita e fecondata, e le libere e ininterrotte
acquisizioni culturali. Vincendo il peso degli anni, levandosi al di sopra del tempo, al di sopra della
vita stessa, contemplando il mondo dalle supreme altezza dell’arte e del pensiero (…).
(A. CAPRI, op. cit.)
Ci vorrebbe un volume per illustrare quale fenomeno straordinario di maturazione, spirituale
e tecnica, avvenga in Verdi durante la lunga pausa di raccoglimento che precede ognuna delle
ultime due opere. Maturazione, e non trasformazione, perché il vecchio Adamo resta pur sempre lì,
presente nell’uomo nuovo, e se ne riconoscono i tratti agevolmente, se pure con segno mutato,
con altro significato ed altra espressione. A ben guardare, i casi in cui si articola la vicenda del
Falstaff sono ancora affini a quelli consueti del melodramma verdiano e fanno perno su quella
passione che è la molla di quasi tutte le loro trame: la gelosia. Soltanto che qui essa è vista sotto
l’angolo di una favolosa saggezza senile, che tutti i casi della vita avvolge in una serena
comprensione: come se il vario spettacolo degli affanni umani fosse visto non dall’interno, con
partecipazione appassionata, ma da un’altezza immensa, o con un cannocchiale rovesciato, sì che
la stessa piccolezza dei protagonisti produce un effetto comico. “Tutto nel mondo è burla...”. Ed
allora hai, invece della matta gelosia d’Otello, il monologo delle corna, questo microcosmo comico
della drammaturgia verdiana. L’ampiezza del campo di visuale permette di cogliere nell’operato dei
personaggi relazioni e ragioni riposte ch’essi stessi ignorano: i fili segreti onde son tirati questi
burattini tanto orgogliosi del loro libero arbitrio. L’umorismo, pieno di compassione intenerita e
bonaria, sta appunto nella possibilità di stabilire le proporzioni fra l’egocentrica gesticolazione dei
piccoli uomini e l’impassibile, inconturbata armonia del Tutto, dove i loro smisurati affanni, le
tragedie e le catastrofi non si percepiscono che come il palpito regolare e sommesso della vita.
A questa maturazione interiore corrisponde, parallela, la maturazione dell’artista. (...) Ma solo
apparentemente si tratta di sue distinti discorsi: in realtà i due fenomeni - maturazione interiore
dell’uomo e trasformazione del linguaggio musicale - sono una cosa sola, sono il dritto e il rovescio
d’un medesimo tessuto.
(M. MILA - “L’alto traguardo” da: Giuseppe Verdi, Ed. La Scala)
26
Bevitore, truffatore, millantatore, traditore, vigliacco; ma il tutto registrato su un fondo di
pigrizia. Falstaff non è un vizioso “attivo”: è una sorta di naturale collettore dei cattivi istinti
dell’uomo, abbandonati alla loro forza di gravità. Questo significano la sua grassezza, la sua
pancia: un’accumulazione di debolezze, di rese; quali forse, prese una per una, ogni uomo
potrebbe commettere. Scrive Gabriele Baldini: “In Falstaff non v’è nulla di demoniaco (…)
insomma, non si sospetta neppure di lontano l’empietà metafisica di Jago, un personaggio nel
quale Shakespeare ha voluto non tanto rappresentare, quanto identificare le forze annientatrici del
demonio annidato in noi. Ed è per questo che Jago è così ‘astratto’ e Falstaff così ‘concreto’, e che
il suo ‘errore’ appare così quotidiano, quello medesimo, insomma, per il quale c’è in serbo una
quotidiana remissione”.
(…) Che la tumultuosa, disordinata, screanzata sceneggiatura di Shakespeare divenisse
nelle mani di Boito un modello di raziocinio, di limpidezza, di ritmo scenico, non può essere stimato
soltanto un caso di abilità tecnica, “librettistica”. La riduzione dei personaggi, la radiosa
semplificazione dell’azione, costringendo ogni elemento alla prestabilita perfezione d’un gioco
impeccabile, trasformarono anche il contenuto della farsa originale, smussandone contrasti e
dislivelli, dissolvendone anche le violenze plebee a umoresca gentilezza. Si pensi, soprattutto, a
Falstaff medesimo; nessun vizio del quale è visto con disprezzo, ma tutti con indulgenza, con un
sorriso. Egli è soltanto una gradazione possibile della debolezza umana, di cui la vicenda fornisce
altri esempi, altre varianti: e sempre senza sostanziale condanna. La conclusione è che tutto nel
mondo è burla; vale a dire: il turno di essere messo allo specchio del ridicolo verrà prima o poi per
ciascuno. E chi è senza peccato scagli la prima pietra.
(…) Il realtà il Falstaff è opera tipicamente senile, cioè espressione dell’animo d’un uomo
che, giunto al traguardo di un’esistenza lunga e operosissima, si volge indietro a contemplarla con
malinconico, seppur sereno distacco. Tutto nel Falstaff è attutito come in una maturata operazione
della memoria, tutto addolcito e come visto dietro un velo. Ancora nell’Otello, Verdi partecipava alle
passioni dei suoi personaggi da pari a pari, sul loro piano; nel Falstaff gli amori di Fenton e
Nannetta sono visti dall’occhio intenerito di un nonno, la burla della mascherata sfuma nella reverie
romantica e tutto il resto è ammesso solo sotto il filtro dell’ironia.
(FEDELE D’AMICO - Programma di sala Teatro Verdi di Trieste, 1967/68)
5. Il linguaggio musicale dell’ultimo Verdi
Ultima tappa di sutura fra un capolavoro e l’altro, il Boccanegra è l’antiporta da cui dovrà
incedere il dramma di Otello (…). Forse il colloquio più intimo con il drammaturgo che sopra ogni
altro aveva amato fin dalla giovinezza, non resta senza conseguenze nella tecnica di Otello:
rispetto ad Aida, infatti, la partitura del nuovo lavoro risulta ancor più parca ed essenziale nell’uso
dei mezzi. (...)
Il musicista stesso soggiace al dramma e certe necessità di struttura tecnica sono facilmente
dimenticate quando l’urgere della situazione lo richieda: e sono spesso momenti che il Verdi di
vent’anni prima avrebbe certo rivestito di esuberante coltre melodica. Si segua passo per passo
Jago nella mendace sua opera di viltà nei duetti con Otello, per convincersene; talvolta il suo dire è
accentuato da una semplice nota, quasi un parlato. Si rilegga il monologo di Otello “Dio! mi potevi
scagliar” per restare stupefatti di come si sia potuto costruire una pagina di tale potenza di
sconfortante squallore muovendo la voce su due sole note, rispettivamente tonica e dominante
nella desolante tonalità di la bem. minore. Si osservi, nel concertato finale del terzo atto, mentre
una dozzina di voci cantano ognuna secondo un proprio sentimento, come Jago sostenga la sua
parte non cantando bensì quasi parlando all’orecchio di Otello. E contro tali situazioni si pensi
invece alla vena melodica che trabocca liricamente ora nelle effusioni amorose del protagonista,
ora nell’avvampare della rabbia nel duetto del secondo finale; e che si fa trasparente nel canto
femminile fino a spiritualizzarsi nella “Canzone del salice” o nell’ “Ave Maria”, per raggiungere i
fremiti di sublime commozione nella scena della morte di Otello. Poesia e verità drammatica
illuminano dunque la vetta raggiunta dalla nuova melodia verdiana: melodia che non è d’obbligo
che sia unicamente affidata alla voce umana ma può, per virtù d’artista, esprimersi anche nel canto
degli strumenti: e basterebbe per tutti l’ampio recitativo dei contrabbassi che annuncia la
minacciosa ultima entrata di Otello.
27
(…) La individuazione di questo mezzo tecnico diviene addirittura temeraria nei confronti di
Falstaff. L’atto di purificazione ultima è concluso: al contatto con le “vere” figure di Shakespeare
ogni peso è fugato; la retorica del cantar grasso, l’enfasi del gesto magniloquente, il sanguigno
apostrofare di prime donne e di tenori, sono ormai ricordi che appartengono al passato. Il teatro
non gioca su esteriori risorse ad effetto, ma sulla immediata compenetrazione della intuizione e
della realizzazione tecnica: una tecnica che ha perduto ogni materialità; che si è fatta cristallina e
trasparente come un diamante; che rinnova il prodigio di divenire tutta atto espressivo, come era
accaduto con Mozart. (…)
Qui non riesci più a demarcare i confini fra la parte vocale e quella strumentale; tanto le voci
si scostano da un lirismo fine a se stesso, e tanto gli strumenti sono compenetrati dallo spirito del
canto. La tecnica vocale ha subìto una svolta decisiva, e soggiace alle leggi ritmiche di un libero e
variato discorrere, di un parlato colorito dalla musica solo per quel tanto che basta ad articolare la
frase nell’ambito della declamazione sonora (…)
Alla radicale concezione di una tecnica atta ad esprimere la nuova commedia musicale,
aggiunge il suo valido contributo la strumentazione. (…) Gli archi ed i legni restano i commentatori
agilissimi, attivi e spiritosi della pulsante vita ritmica dell’opera, e ne accompagnano con effetti
quasi visivi il mimico svolgimento. Il fagotto, ad esempio, si prodiga in tutta la sua grottesca
facondia per i commenti ironici; mentre i corni, riprendendo un vezzo già usato da Mozart,
sottolineano le allusioni alla infedeltà coniugale. (...)
(G. BARBLAN - “La Tecnica” da: Giuseppe Verdi, Ed. La Scala)
6. L’eredità verdiana
Verdi è il grande poeta dell’anima popolare, perché è artista grande che non teme di adottare
le forme elementari e comuni del sentimento e dell’espressione, avendo la forza di riplasmarle e
trasfigurarle; ma che, appunto per questo, non si limita a una mera rielaborazione, e tende a un
continuo affinamento e potenziamento dei mezzi espressivi. Per questo duplice carattere
dell’opera verdiana, profondamente radicata agli strati più genuini dell’anima nazionale e, insieme,
squisitamente artistica e progressiva, essa non si esaurisce in una formula, non si conclude in una
esperienza definitiva, ma si mantiene in perenne divenire, restando legata a doppio nodo alla
tradizione italiana, di cui rende la più alta testimonianza, e alimentandosi alla sorgente delle
maggiori correnti della cultura europea. (…)
Verdi non ebbe scuola o maniera; fu inimitabile e in sé concluso. Come Beethoven, egli non
ebbe procedimenti e schemi che si possano ripetere ed imitare; non ebbe una tecnica costruttiva di
cui ci si possa appropriare il meccanismo. Per potersi chiamare verdiani non vi è altra via che
essere intensamente, compiutamente se stessi; sviluppare fino alle ultime conseguenze tutta la
propria personalità, rendere attive e feconde tutte le proprie possibilità interiori.
(A. CAPRI, op. cit.)
Innovare nel profondo rispettando l’antico: ecco il segreto che consentì a Verdi di cogliere fra
i settantacinque e gli ottant’anni il fiore più squisito dell’arte sua: fiore di saggezza, di gusto,
d’ironia, di serena bontà, sbocciato al vertice dell’anima e della vita. Così si conclude il ciclo
stupendo dell’arte verdiana. E ancora una volta egli aveva obbedito alla prima, alla suprema, alla
più inderogabile legge dell’arte sua: essere vero, essere umano. (…)
Verdi, che sempre aveva cercato le ragioni e le finalità dell’arte nel cuore umano, esplorando
la vita individuale e collettiva, varia nei sentimenti, opposta nelle tendenze, sfrenata negli odi e
negli amori, ma finalmente ansiosa di pace e di bontà, conclude la sua attività creatrice con l’aureo
sorriso dell’anima rasserenata in una visione pacata, dopo i tumulti passionali, dopo i fremiti e
gl’impeti della lotta e della vigilia. (…) Egli aveva piena coscienza che il Falstaff era e doveva
rimanere il suo congedo definitivo dall’arte. (…) Fra le pagine della partitura autografa del Falstaff,
conservata nell’archivio di casa Ricordi, si è ritrovato un biglietto di Verdi su cui erano scritte
queste parole: “Tutto è finito! Cammina per la tua via fin che puoi, divertente tipo di briccone,
eternamente vero, sotto maschera diversa, in ogni tempo, in ogni luogo, va... va... Cammina...
cammina... Addio!”.
(A. CAPRI - II melodramma dalle origini ai nostri giorni, Ed. Guanda, 1938)
28
BIBLIOGRAFIA
OPERE DI CONSULTAZIONE:
AA. VV.
AA. VV.
Capri Antonio
Capri Antonio
Dahlhaus Carl
Degrada Francesco
Leibowitz René
Lindenberger H
Mila Massimo
Pannain Guido
Pannain Guido
Pannain Guido
Parente Alfredo
Roncaglia Gino
Schurè Edouard
Valle Nicola
Storia dell’Opera
Il melodramma italiano nell’Ottocento
II melodramma dalle origini ai nostri giorni
Musica e musicisti d’Europa
Il realismo musicale
Il palazzo incantato
Storia dell’opera
L’opera lirica
L’esperienza musicale e l’estetica
La vita del linguaggio musicale
L’opera e le opere
L’Ottocento musicale italiano
La musica e le arti
Invito all’opera
Storia del dramma musicale
Origini del melodramma
UTET
Einaudi
Guanda
Hoepli
Il Mulino
Discanto
Garzanti
Il Mulino
Einaudi
Curci
Curci
Curci
Laterza
Tarantola
Bottega di Poesia
Ausonia
LA VITA E L’OPERA DI GIUSEPPE VERDI
Abbiati Franco
Baldini Gabriele
Budden Julian
Casini Claudio
Gatti Carlo
Mila Massimo
Mila Massimo
Mula Orazio
Oberdorfer Aldo
Pinagli Palmiro
Rinaldi Mario
Rinaldi Mario
Giuseppe Verdi
Abitare la battaglia
Le opere di Verdi
Verdi
Verdi
I costumi della Traviata
Verdi
Giuseppe Verdi
Giuseppe Verdi: autobiografia dalle lettere
Romanticismo verdiano
Gli “anni di galera” di Giuseppe Verdi
Le opere di Giuseppe Verdi
Ricordi
Garzanti
E.D.T.
Rusconi
Mondadori
Rizzoli
Rzzoli
Il Mulino
Rizzoli
Vallecchi
Volpe
Olschki
___________________________
29