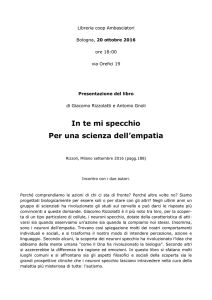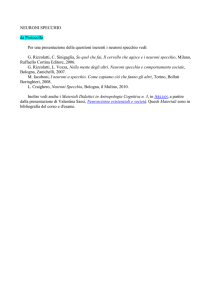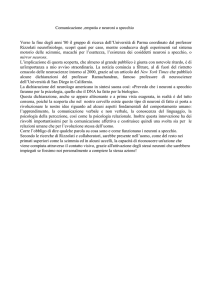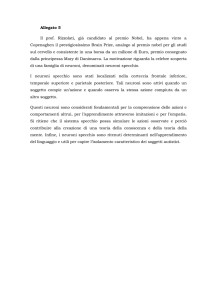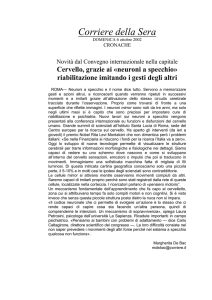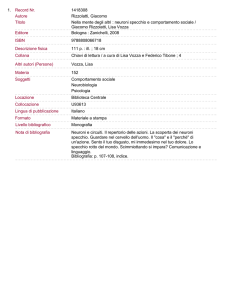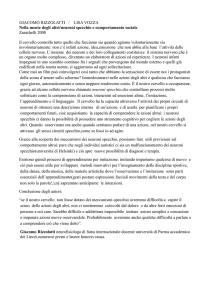attualità
Le possibili basi neurobiologiche
dell’apprendimento maieutico
I neuroni specchio come innovativa scoperta alla
base, forse, del comportamento umano
Fabrizio Lertora *
D
a diversi anni ormai i
processi di conoscenza del
cervello e delle implicazioni
che tali scoperte possono avere
rispetto al resto del patrimonio del
nostro sapere, sono sempre più alla
portata di tutti e l’attenzione da
parte di un pubblico di non addetti
ai lavori è sempre più consistente.
In tal senso, tra le diverse
interessanti scoperte nell’ambito
della neurologia, un posto di
notevole rilievo spetta certamente a
quella, ad opera di due
neuroscienziati dell’Università di
Parma, Giacomo Rizzolatti e
Vittorio Gallese, dei cosiddetti
“neuroni specchio”.
Questa categoria di neuroni
presenta la caratteristica di attivarsi
quando si osserva un proprio simile
compiere una certa azione,
attivazione del tutto simile a quella
che avverrebbe se fosse lo stesso
soggetto osservatore a compiere
quella stessa identica attività. Ad
esempio, se una scimmia afferra un
oggetto, nella scimmia osservatrice
si attivano quelli stessi circuiti
neuronali che, nella corteccia
premotoria, potrebbero predisporre
i neuroni della corteccia motoria a
compiere effettivamente
quell’azione. Dopo la scoperta, per
altro casuale, di tale meccanismo
nelle scimmie, si è notato che tali
neuroni sono presenti e attivi anche
nella nostra specie: quando infatti
osserviamo un nostro simile
compiere una certa azione si
attivano nel nostro cervello le
stesse cellule che entrano in
funzione quando siamo noi stessi a
compiere quel gesto. E’
interessante notare che la presenza
dei “neuroni specchio” non è
limitata esclusivamente all’area
25
motoria, ma sembra interessare
anche altre aree, tanto da arrivare a
parlare più propriamente di un
“sistema di neuroni specchio”, che
si presenta quindi, a livello
neurologico, come struttura base ai
fini dell’apprendimento attraverso
l’osservazione. Questa scoperta si è
rilevata, nelle parole stesse dei suoi
scopritori, come una tappa
fondamentale per la comprensione
di come ci relazioniamo con il
mondo, di come impariamo a
conoscerlo e a rappresentarcelo:
“questo contributo delle
neuroscienze può essere
importante nel suscitare nuove
riflessioni in ambito etico, politico
ed economico. Perché ha messo in
luce come la reciprocità che ci lega
all’altro sia una nostra condizione
naturale, pre-verbale e prerazionale” (Vittorio Gallese).
SINTONIZZAZIONE PERFETTA
Di fatto, a partire dalla semplice
visione di un modo di fare, il nostro
cervello è come se simulasse
internamente tale modalità, non in
maniera astratta, per così dire
immaginativa, ma producendo
esattamente lo stesso tipo di
attività neurale registrabile nel
momento stesso in cui fosse
effettivamente impegnato a
svolgerla. Sotto un certo profilo
non c’è differenza quindi tra il fatto
che siamo noi a compiere una
determinata azione o
semplicemente osserviamo
compierla da un nostro simile. In tal
senso tale predisposizione appare
quale capacità di sintonizzarsi
rispetto a chi ci sta di fronte e di
mutuo apprendimento cablato a
livello neuronale. Da subito
l’interesse dei ricercatori, sulla scia
di tali osservazioni, si è mosso
anche verso le componenti più
emotive, per così dire, del nostro
essere e del nostro essere in
relazione: ci si è posti cioè la
domanda se tale meccanismo di
rispecchiamento valesse anche nel
caso di vissuti emotivi. Gli
esperimenti in proposito paiono
dimostrare, in effetti, che se l’altro
prova piacere o dolore nel fare una
certa cosa, anche in tal caso nel
nostro cervello si attivano gli stessi
neuroni che si attiverebbero se
anche noi stessimo provando le
medesime emozioni e sentimenti. A
partire da ciò e anche a causa della
grande attenzione, a livello di mass
media, che ormai circonda la
ricerca nell’ambito delle
neuroscienze, da subito questa
scoperta è stata vista soprattutto
come la “prova” neurofisiologica
del sentimento dell’ “empatia” e in
tal senso ha stimolato un vasto
Neuroni specchio
CONFLITTI
attualità
dibattito in proposito. La scoperta
dei neuroni specchio pare
rafforzare, infatti, l’idea di una
natura umana intrinsecamente
relazionale, vale a dire di una
predisposizione naturale e
strutturale verso la relazione,
sinteticamente e significativamente
racchiusa nelle parole stesse di uno
degli scopritori: “non è possibile
pensare un io senza un noi”. In
questa frase di Giacomo Rizzolatti
sembra riecheggiare e fondare a
livello neurofisiologico il paradigma
dialogico e relazionale di Martin
Buber (1).
Appare evidente come tale
scoperta e la riflessione che ne è
seguita abbia immediata
importanza anche in una
prospettiva pedagogica; la capacità
di entrare in relazione, di
cooperare, di utilizzare strategie di
auto apprendimento e di mutuo
insegnamento, non è qualcosa che
deve essere imparato ma al
contrario rappresenta una
competenza naturalmente cablata
all’interno delle strutture e dei
processi che, a livello neuronale,
guidano e sostengono il nostro
sviluppo. In tale direzione
condizioni e scelte metodologiche
quali ad esempio la didattica
dialogica, la maieutica socratica, il
cooperative learning appaiono, alla
luce di tale scoperta, elementi
fondati di una ricerca verso una
maggior efficacia dell’impresa
dell’insegnare e dell’apprendere.
Al centro della riflessione si pone il
rapporto tra osservazione,
immaginazione e azione e di
conseguenza lo stretto intreccio tra
mente e corpo nei processi di
apprendimento. Proprio il corpo
pare ritrovare, in tal senso, la sua
funzione di strumento
fondamentale per comprendere ed
apprendere. La relazione corporea
e la sperimentazione sensoriale
appaiono modalità privilegiate,
come già ebbe a dimostrare la
Montessori, per imparare. Fu
proprio Maria Montessori infatti a
sottolineare l’importanza di un
coinvolgimento “corporeo e
motorio” (e non esclusivamente
cognitivo) del bambino nell’ambito
del proprio processo educativo.
Con la sua metafora della “mente
CONFLITTI
assorbente”, in un
certo senso,
anticipava e
teorizzava, a
nostro parere, se
pur in forma
metaforica, molti
tra i meccanismi
che il sistema dei
neuroni specchio
ha
neurologicamente
dimostrato:
l’apprendimento
infatti potremmo
dire che prende
forma grazie ad una sorta di
“immersione”, in primo luogo
mediata dal nostro corpo, nella
realtà e in particolare nella realtà
della relazione con l’altro.
MAIEUTICA E
NEURONI SPECCHIO
Sulla base di questa dotazione
naturalmente relazionale, la
capacità di entrare in relazione, di
cooperare, di apprendere attraverso
situazioni di reciprocità, non è
qualcosa che si acquista nel tempo,
ma la cifra costituente l’umano.
Appare possibile ritrovare tracce
neuronali alla base di fenomeni
squisitamente maieutici, alla base di
pratiche e di condizioni fondanti
una possibile genesi maieutica dello
sviluppo. Il sistema dei neuroni
specchio pare quindi costituire la
dotazione necessaria, anche se
certamente non sufficiente, per
costruire e dare significato a
relazioni di vicinanza, di mutuo
insegnamento, di attivazione
reciproca. In altre parole il
background fisiologico
fondamentale per poter, se
intenzionati a farlo, realizzare, per
dirla con Dolci, strutture maieutiche
efficaci di evoluzione(2).
A tale proposito mi pare
importante però, in chiusura,
evidenziare il rischio che ancora
una volta prevalga, sulle ali
dell’entusiasmo e dell’ingenua
illusione di un facile accesso ai
complessi percorsi della coscienza,
un approccio per così dire
“riduzionista”, che intende stabilire
un rapporto lineare e nesso diretto
di causa-effetto tra meccanismi
Neuroni specchio
neuronali e comportamento
umano. Tale relazione diretta è ben
lungi dal poter essere affermata e
provata e troppo poco ancora
sappiamo, nonostante gli enormi
progressi degli ultimi decenni, sul
sistema più complesso dell’Universo
qual è il nostro cervello. Anche il
problema di come è possibile
apprendere non sfugge a tale
riflessione; i risultati delle
neuroscienze, in particolare le
scoperte relative al sistema dei
neuroni specchio, si presentano
come fondamentali ma il
manifestarsi della nostra
conoscenza, così come il realizzarsi
dell’apprendimento, appaiono
fenomeni la cui comprensione
richiede presumibilmente ancora
molto tempo e che necessita di
sempre maggiori sforzi di sinergia
tra le tante discipline in essa
coinvolte.
NOTE
1) Martin Buber, Il principio dialogico, San
Paolo Edizioni, 1993
2) Danilo Dolci, La struttura maieutica e
l’evolverci, La nuova Italia 1996
PER SAPERNE DI PIÙ
Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia, So
quel che fai, Raffaello Cortina, 2007
Giacomo Rizzolatti, Lisa Vozza, Nella mente
degli altri.Neuroni specchio e
comportamento sociale, Zanichelli, 2007
Iacoboni Marco, I neuroni specchio. Come
capiamo ciò che fanno gli altri, Bollati
Boringhieri, 2008
* ingegnere, formatore per il CPP. E-mail:
[email protected]
26