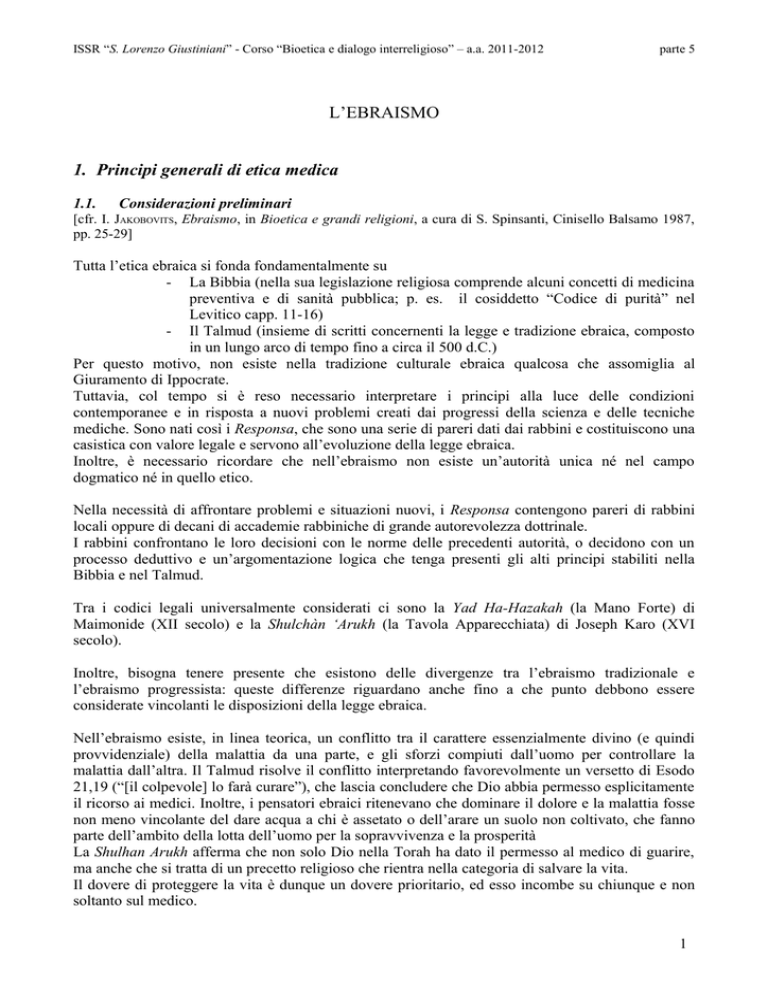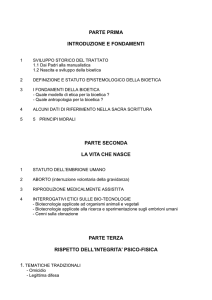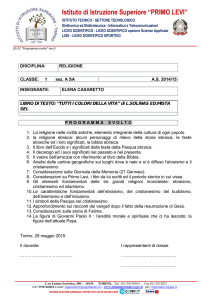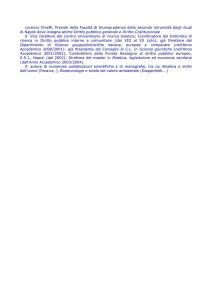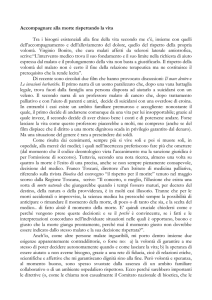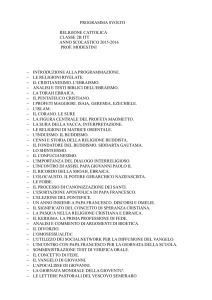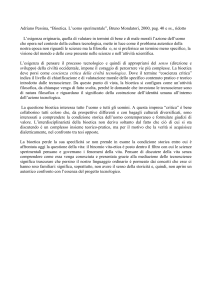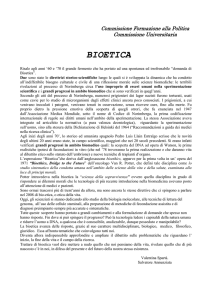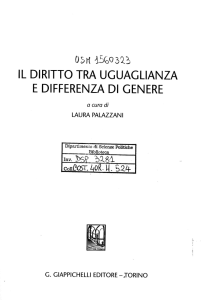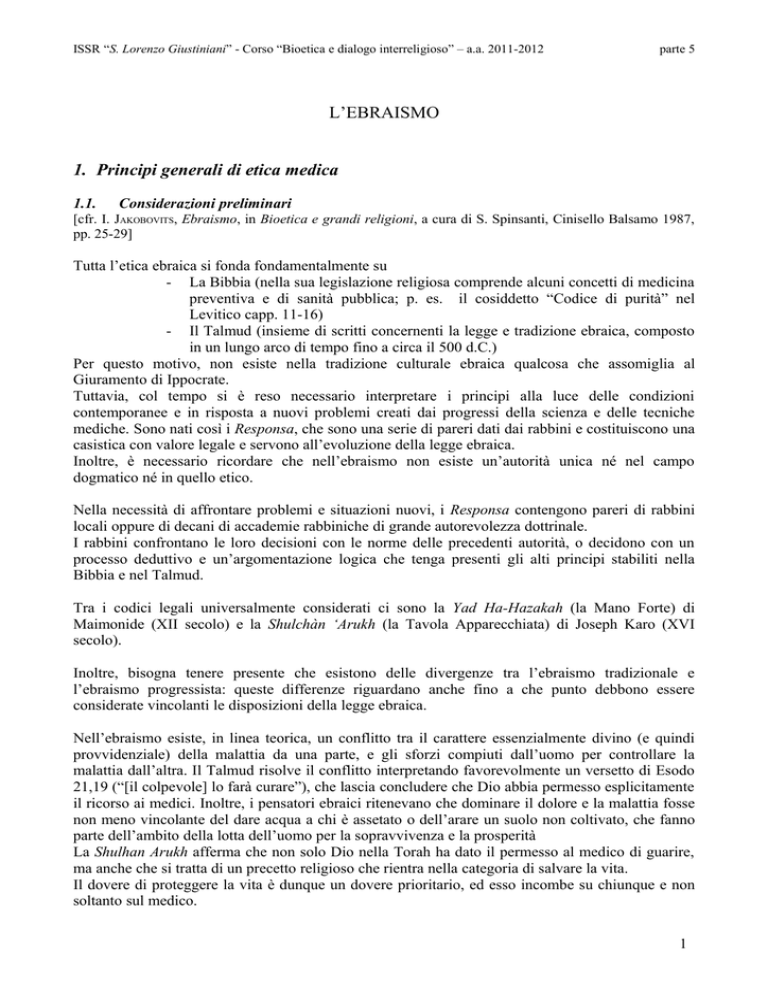
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
L’EBRAISMO
1. Principi generali di etica medica
1.1.
Considerazioni preliminari
[cfr. I. JAKOBOVITS, Ebraismo, in Bioetica e grandi religioni, a cura di S. Spinsanti, Cinisello Balsamo 1987,
pp. 25-29]
Tutta l’etica ebraica si fonda fondamentalmente su
- La Bibbia (nella sua legislazione religiosa comprende alcuni concetti di medicina
preventiva e di sanità pubblica; p. es. il cosiddetto “Codice di purità” nel
Levitico capp. 11-16)
- Il Talmud (insieme di scritti concernenti la legge e tradizione ebraica, composto
in un lungo arco di tempo fino a circa il 500 d.C.)
Per questo motivo, non esiste nella tradizione culturale ebraica qualcosa che assomiglia al
Giuramento di Ippocrate.
Tuttavia, col tempo si è reso necessario interpretare i principi alla luce delle condizioni
contemporanee e in risposta a nuovi problemi creati dai progressi della scienza e delle tecniche
mediche. Sono nati così i Responsa, che sono una serie di pareri dati dai rabbini e costituiscono una
casistica con valore legale e servono all’evoluzione della legge ebraica.
Inoltre, è necessario ricordare che nell’ebraismo non esiste un’autorità unica né nel campo
dogmatico né in quello etico.
Nella necessità di affrontare problemi e situazioni nuovi, i Responsa contengono pareri di rabbini
locali oppure di decani di accademie rabbiniche di grande autorevolezza dottrinale.
I rabbini confrontano le loro decisioni con le norme delle precedenti autorità, o decidono con un
processo deduttivo e un’argomentazione logica che tenga presenti gli alti principi stabiliti nella
Bibbia e nel Talmud.
Tra i codici legali universalmente considerati ci sono la Yad Ha-Hazakah (la Mano Forte) di
Maimonide (XII secolo) e la Shulchàn ‘Arukh (la Tavola Apparecchiata) di Joseph Karo (XVI
secolo).
Inoltre, bisogna tenere presente che esistono delle divergenze tra l’ebraismo tradizionale e
l’ebraismo progressista: queste differenze riguardano anche fino a che punto debbono essere
considerate vincolanti le disposizioni della legge ebraica.
Nell’ebraismo esiste, in linea teorica, un conflitto tra il carattere essenzialmente divino (e quindi
provvidenziale) della malattia da una parte, e gli sforzi compiuti dall’uomo per controllare la
malattia dall’altra. Il Talmud risolve il conflitto interpretando favorevolmente un versetto di Esodo
21,19 (“[il colpevole] lo farà curare”), che lascia concludere che Dio abbia permesso esplicitamente
il ricorso ai medici. Inoltre, i pensatori ebraici ritenevano che dominare il dolore e la malattia fosse
non meno vincolante del dare acqua a chi è assetato o dell’arare un suolo non coltivato, che fanno
parte dell’ambito della lotta dell’uomo per la sopravvivenza e la prosperità
La Shulhan Arukh afferma che non solo Dio nella Torah ha dato il permesso al medico di guarire,
ma anche che si tratta di un precetto religioso che rientra nella categoria di salvare la vita.
Il dovere di proteggere la vita è dunque un dovere prioritario, ed esso incombe su chiunque e non
soltanto sul medico.
1
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
Da ciò discende la regola generale secondo al quale tutte le leggi religiose vengono
automaticamente sospese quando esista un qualche rischio per la vita, anche se remoto. Le sole
eccezioni sono le tre trasgressioni cardinali: l’idolatria, l’immoralità (p.es. incesto e adulterio) e
l’assassinio.
La santità della vita ha una connotazione molto particolare nella legge ebraica. Ogni vita umana è
considerata di valore infinito e assoluto. Su questo principio, i rabbini elaborano un’interessante
argomentazione logica desunta dalla matematica. In matematica, infatti, l’infinito non può essere
aumentato con una moltiplicazione né diminuito con una divisione; perciò una vita mentalmente o
fisicamente handicappata, per quanto limitata, non vale meno di una vita piena e sana. E, per lo
stesso motivo, una persona ha assolutamente lo stesso valore di un milione di persone.
Anche se l’ebraismo si interessa ad alleviare il dolore umano, spesso anche a costo di modificare le
sue più sacre prescrizioni, ciò che non può in ogni caso essere permesso è ottenere il sollievo dal
dolore a costo della vita stessa.
Quindi, ogni autorizzazione di eutanasia non può far altro che sminuire il valore della vita,
rendendo in genere contingente la sua protezione di fronte a considerazioni di opportunità, oppure
di maggiore e minore merito.
In base all’analogia dell’infinito, che non può essere accresciuto con una moltiplicazione, tale
principio viene poi esteso al fatto di salvare un qualsiasi numero di vite, deliberatamente, al prezzo
di una sola vita. Per usare la spiegazione del Talmud: se cento persone innocenti fossero prese in
ostaggio e se le loro vite fossero risparmiate soltanto se essi consegnassero uno di loro
all’oppressore perché sia messo a morte, essi non devono cedere quella vita, anche se ciò salvasse la
vita degli altri.
1.2.
L’etica medica ebraica
[cfr. R. DI SEGNI, Il punto di vista ebraico su aborto, contraccezione fecondazione artificiale, in Religioni e
Bioetica. Un confronto sugli inizi della vita, a cura di L. Biagi e R. Pegoraro, Gregoriana, Padova 1997, pp.
283-293]1.
Premesse sul ragionamento etico-giuridico nella società ebraica.
1. Fonte di riferimento essenziale di qualsiasi importazione etica e di comportamento è la Bibbia.
Tuttavia, la Bibbia non è considerata soltanto un libro che si apre e si legge, e cui ci si ispira, ma
un libro che dal punto di vista della norma, dell’applicazione giuridica, deve passare attraverso
una mediazione, una lettura, un filtro. Il filtro è rappresentato dalla tradizione chiamata secondo
la tradizione classica “tradizione orale” o “Torah orale”.
La Torah orale, dopo il primo codice, la Mishnàh, redatto nel II secolo dell’era volgare, ha avuto
ulteriori sviluppi interpretativi e attuativi espressi in due grandi opere, cioè il Talmud di
Gerusalemme e il Talmud babilonese, ultimati intorno al V secolo dell’era volgare. Queste
opere non hanno però modificato la legge: l’hanno esposta, l’hanno sviluppata. All’inizio di
questo millennio sono cominciate delle opere di compilazione, con le quali la redazione
precedente è stata organizzata in maniera più razionale.
Quindi ora esiste una serie di codici di leggi ebraiche.
Inoltre, con la distruzione dello Stato ebraico e, quindi, la perdita di un centro politico della
comunità ebraica, è venuta a mancare l’autorità unica che stabiliva le leggi per la comunità e la
dispersione geografica ha imposto una differente scelta giuridica. Oggi ci si riferisce ai codici
principali, cioè il codice di Maimonide e il codice detto dello Shulchàn ‘Arukh, che è stato
1
Riccardo Di Segni è Rabbino Capo della Comunità ebraica di Roma.
2
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
scritto nel XVI secolo. Però non tutti gli argomenti sono affrontati in questi codici, né in essi si
trova sempre un’opinione concorde.
Un ebreo che si trova di fronte a un problema ha l’obbligo di sottoporlo all’autorità rabbinica
competente per territorio (che può essere un tribunale o un singolo dotto molto rispettato), la
quale emette un responso che coinvolge di diritto solo le comunità che accettano quella autorità
e non le altre nel mondo.
Quindi, la struttura giuridica con cui da secoli si forma la legge ebraica, è essenzialmente
dispersa, basata sulla letteratura responsoria.
2. Il rapporto della tradizione rabbinica con la scienza. È legittimo l’uso della scienza? È legittima
la medicina? Tali domande nascono in un mondo religioso nel quale si immagina che la realtà
sia dominata dalla volontà divina.
Uno dei paragoni possibili, ricavato da un’antica parabola, è quello di un contadino che si sente
male e chiede ai maestri che incontra per le strade di Gerusalemme che cosa deve fare. E i
maestri gli dicono: “Prendi queste medicine e compi queste azioni”. “Ma come – replica – non è
la volontà di Dio, che io stia male?”. “Ma tu – gli domandano – se hai un albero infestato da
parassiti o un’erba che sta morendo, cosa fai?”. Risponde: “Compio determinate azioni”. E i
maestri: “Ma non è la volontà di Dio che l’albero sia infestato da parassiti e che l’erba stia
morendo? Chi ti autorizza?”. Secondo questo paragone, il corpo umano è come una pianta che
ha bisogno di essere curata.
Vi è nella tradizione ebraica un atteggiamento estremamente positivo ed aperto rispetto al
progresso scientifico e tecnologico: ovviamente va usato con correttezza, con cautela etica, ma
non vi sono obiezioni di principio ad esso, anzi, è vero il contrario.
[…]
Non esiste nemmeno una distinzione tra ciò che potrebbe essere “naturale” e “non naturale” (il
concetto stesso di “natura” è estraneo all’ebraico biblico, che lo sostituisce con quello di
“creato”). L’uomo è considerato come un collaboratore del Creatore nel controllo, nel
mantenimento e nel miglioramento del creato. Pertanto, in linea di massima, non vi è
un’opposizione di principio all’uso di tecniche nuove per risolvere dei problemi che affliggono
l’uomo.
2.
La vita nascente e l’aborto
2.1. Questioni generali relative alla generazione
[cfr. I. JAKOBOVITS, Ebraismo, in Bioetica e grandi religioni, a cura di S. Spinsanti, Cinisello Balsamo 1987,
pp. 34-38]
Tutti i problemi legati alla generazione della vita cadono sotto il precetto positivo della
procreazione. Perciò, in mancanza di un’indicazione medica valida, pratiche contrarie alla
procreazione come l’aborto, la sterilizzazione e la contraccezione rappresentano sicuramente dei
metodi intrinsecamente immorali. Il motivo risiede nel fatto che vengono giudicate come un rifiuto
deliberato di partecipare con il Creatore alla propagazione della specie.
A questo proposito, l’ebraismo si riferisce al dovere di “essere fecondi e di moltiplicarsi” (Gen
1,28). Perciò è considerato un delitto (in quanto una trasgressione a un precetto positivo) astenersi
dal matrimonio, o dai rapporti coniugali nell’ambito del matrimonio, non meno che evitare o
interrompere la gravidanza.
Nei testi antichi l’aborto non è menzionato, sebbene venisse ampiamente praticato.
Anche il controllo delle nascite con tecniche contraccettive è citato solo occasionalmente nella
condanna di Onan. D’altra parte, gli Ebrei erano l’unica nazione del mondo antico a bandire
l’evirazione degli uomini, come pure degli animali.
3
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
Il Talmud ammette l’uso di strumenti contraccettivi in circostanze del tutto particolari (donne
minorenni, in stato di gravidanza o allattamento, al fine di evitare ogni rischio alla loro vita o a
quella del feto, come conseguenza di un concepimento in tali circostanze).
Ogni relazione sessuale prematrimoniale o extramatrimoniale è assolutamente vietata.
A suo modo, il Talmud (Hagigah 15a) ammette il caso di fecondazione artificiale - peraltro
accidentale (afferma che una vergine non avrebbe perso il suo stato se si fosse trovata in stato di
gravidanza immergendosi in acque precedentemente rese fertili da un uomo). In base a questo
passo, i Responsa più recenti sostengono che il concepimento senza amplesso di una donna sposata,
anche se il donatore di sperma è un parente prossimo, non costituisce adulterio o incesto. Tuttavia
numerosi giudizi rabbinici sono unanimi nel condannare assolutamente tale pratica come
incompatibile con la santità del matrimonio e come minaccia per il tessuto morale della società.
Inoltre, viene condannata perché di fatto riduce la procreazione umana a metodi di “allevamento”
degli animali.
La vita è inviolabile dalla nascita alla morte.
Ma questo principio riceve una formulazione diversa quando si tratta della vita prima della nascita.
Il valore infinito della vita comincia soltanto con la nascita, che viene definita legalmente nel
momento in cui la testa o la parte più grande del corpo del bambino emerge dal canale vaginale.
Fino a quel momento il bambino gode di alcuni diritti sacrosanti che non possono essere violati,
salvo per motivi medici gravissimi.
Ma il diritto alla vita del nascituro è nettamente inferiore a quello della madre, perciò, in caso di
conflitto morale tra di loro, è obbligatorio sacrificare il bambino non ancora nato, se non esiste altro
modo per salvare la madre.
2.2. L’aborto
2.2.1. Il parere di Riccardo Di Segni
[cfr. R. DI SEGNI, Il punto di vista ebraico su aborto, contraccezione fecondazione artificiale, in Religioni e
Bioetica. Un confronto sugli inizi della vita, a cura di L. Biagi e R. Pegoraro, Gregoriana, Padova 1997, pp.
286-290].
Dai più remoti tempi biblici, la riproduzione dell’uomo è stata considerata come un atto positivo e
dovuto, e la fecondità come una benedizione, come l’aver figli un segno della grazia divina;
parallelamente la sterilità e la perdita dei figli sono stati considerati come una maledizione.
È comunque essenziale il riferimento ad un brano dell’Esodo (21,22-23), che tradotto dalla
originale versione ebraica dice: «Nel caso in cui alcuni uomini litighino, e colpiscano una donna
incinta, e i suoi figli ne escano, e non vi sia sciagura, [il colpevole] sarà punito nella misura stabilita
dal marito della donna, e pagherà l’ammenda davanti ai giudici; ma se vi sarà una sciagura, farai
pagare vita per vita». L’interpretazione di questo brano è molto complicata, e le possibili diverse
deduzioni sono alla base di un’antica divergenza giuridica (e oggi si direbbe anche “bioetica”) tra
ebraismo e cristianesimo. L’ebraismo rabbinico ha sempre spiegato l’espressione “e non vi sia una
sciagura” come riferita alla madre; nel senso che se la madre non muore, il danno consistente nella
interruzione della gravidanza e nella perdita del prodotto del concepimento è punibile solo con una
pena pecuniaria. Secondo questa interpretazione, in sostanza, il feto non gode di una tutela
personale pari a quella di un essere vivente completo. Diversa è stata la lettura cristiana del brano,
che deriva non dalla versione biblica originaria, ma dalla tradizione greca dei Settanta. Qui, al posto
dell’ebraica “sciagura” compare stranamente un termine totalmente diverso, “forma”, che ribalta
tutto il senso del discorso, che ora viene riferito al feto, su cui si introduce una distinzione: se il feto
4
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
esce, e non ha forma, il danno è punibile con un’ammenda; ma se invece il feto è formato, la sua
morte è considerata come la soppressione di una vita vera e propria, e come tale punibile.
[…]
Nel diritto ebraico rabbinico sono rimasti i segni di queste discussioni, ed in particolare, è stato
posto il termine di quaranta giorni di gravidanza, prima del quale, secondo l’espressione antica, il
feto è ancora “semplice acqua”. Il dato, per quanto ovviamente controvertibile alla luce delle recenti
acquisizioni biologiche, consente tuttavia qualche spazio giuridico di maggiore libertà nei casi in
cui si impone la necessità di un intervento.
Il sistema giuridico rabbinico ha mantenuto infatti l’assunto fondamentale secondo il quale il feto
non è considerato ancora un essere umano a tutti gli effetti, per cui la sua soppressione non è
considerata un omicidio; questo ovviamente non significa che sia consentito sopprimere il feto, ma
apre la strada ad una serie di importanti distinzioni e considerazioni.
È fondamentale a tale riguardo un antico articolo giuridico che afferma: «Quando una donna è in
difficoltà di parto è consentito tagliare il feto nel ventre materno, ed estrarlo a pezzi, perché la vita
della madre ha la precedenza sulla vita del feto» (Mishnà Ohalot 7,6). Se invece il feto ha visto
almeno in parte la luce non è più consentito sopprimerlo, perché da quel momento è un essere
umano a tutti gli effetti. Il principio fu ufficialmente codificato nel Medioevo da Maimonide (che
era medico), con l’aggiunta di una spiegazione, per cui l’intervento di soppressione del feto è lecito
per un principio di legittima difesa, in quanto questi attenta alla vita della madre.
[…]
Fermo restando il principio della relativa minore dignità di essere umano del feto, e della liceità
della sua soppressione nel caso in cui la madre è in pericolo di vita, tutti gli altri problemi restano al
vaglio delle autorità rabbiniche che di volta in volta ne sono investite, con una ventaglio di opinioni
che va dal massimo rigore a posizioni di apertura.
[…]
[In conclusione] al di là delle sottili distinzioni della legge, è sempre dominante il concetto espresso
nello Zohar, il testo principale della mistica ebraica, per il quale l’esecuzione di un aborto equivale
a “distruggere la costruzione del Signore”.
2.2.2. Il parere di Amos Luzzatto
[Cfr. A. LUZZATTO, Fine della vita: un punto di vista ebraico, in Alla fine della vita: religioni e bioetica, a
cura di S. Morandini e R. Pegoraro, Gregoriana, Padova 2003, pp. 183-184 e 191-195]2.
Il problema dell’aborto ha diviso per primo nella nostra società i seguaci di due orientamenti: da un
lato, coloro che stabilivano l’inizio della vita individuale nell’uomo al momento della riformazione
del patrimonio cromosomico completo dopo la meiosi che, nel gamete maschile e in quello
femminile, l’aveva ridotto alla metà; dall’altro vi erano coloro che ritardavano questo inizio al
momento in cui l’organismo fosse stato capace di vita autonoma. A questa seconda concezione fa
riscontro, nell’Ebraismo, il concetto di ben qeyama, che significa, appunto, “vitale”, un termine
usato dal commentatore Rashi trattando di Esodo 21,12, che impone la pena di morte per colui che
uccide un essere umano. Il grande commentatore specifica che la pena non si applica a colui che fa
morire un ‘ubbar (nella lingua ebraica ‘ubbar indica tanto l’embrione che il feto; nefel indica un
aborto indipendentemente dall’età della gravidanza).
La concezione di Rashi è tratta dal Talmud (v. Sanhedrin 84b e Niddà 44b, Midrash Mekhilta 4).
Dal punto di vista giuridico, la “vita” individuale comincerebbe dal momento in cui essa è
certamente autonoma; e per questo bisognerebbe attendere l’uscita di gran parte della testa fetale nel
momento del parto, al punto da giustificare in certi casi, nella fase precedente a questa, il sacrifico
del feto per salvare la vita della madre (eyn dochin nefesh mi-pney nefesh: non si preferisca una vita
per un’altra; in questo caso, a una vita non ancora garantita si preferisce una vita già manifesta). La
2
Amos Luzzatto è stato Presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche d’Italia.
5
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
casistica e i distinguo sono abbondanti, ma non è questo il nostro argomento; a noi interessa il
problema metodologico. Di fronte alla mancanza di un criterio biologico pubblicamente
riconoscibile da qualsiasi osservatore per riconoscere che “la vita” ha già avuto inizio, e dovendo
comunque convenire per un criterio arbitrario, alla definizione dogmatica se ne preferisce una
giuridica.
[…]
Ciò che è vita in potenza può essere già considerata vita in atto? […] Al vivente, che è una minaccia
potenziale per la vita di un altro vivente, può essere tolta la vita?
[…]
Se è vero che non sappiamo che cosa sia in sé la vita ma, al massimo, quali caratteristiche
elementari permettano a un vivente cosciente di riconoscere la vita (propria o altrui), dobbiamo
ammettere che la vita “in potenza” non è altro che la presenza di alcune di queste caratteristiche,
che sono necessarie ma non sufficienti per questo riconoscimento.
Questa caratteristiche ci dicono che, in presenza di opportune condizioni ed entro un determinato
tempo, a queste caratteristiche se ne assoceranno altre, che, nel loro insieme, saranno “sufficienti”.
L’uovo fecondato ha già un metabolismo e cresce, ma non è autonomo, non può generare. Il feto
può già sentire stimoli, pare che possa persino giocare. Dal punto di vista ebraico, il primo precetto
può essere non tanto praticato quanto subito dal bambino solo otto giorni dopo l’uscita dal grembo
materno: si tratta della circoncisione. In quel momento, egli avrà un nome, sarà un vero individuo,
che avrà ancora delle potenzialità con probabilità sempre maggiori di tradursi in atto.
La biologia si intreccia in questo caso con la Legge e la tradizione. In altre tradizioni, il nome sarà
imposto prima (per esempio, al momento del battesimo) o l’uovo fecondato sarà già considerato
equivalente all’individuo strutturato nei suoi organi, che potrà avere il proprio metabolismo grazie
all’ossigeno che egli assorbe dall’aria mediante i suoi alveoli polmonari e non dal sistema
circolatorio della madre.
Chi è nel vero? È il caso di dire che “colui che può affermarlo scagli la prima pietra”.
Ci sono però nella vita situazioni nelle quali persino quelle che chiamiamo (convenzionalmente)
civiltà superiori dispongono della vita di persone viventi, adulte e coscienti con una disinvoltura
molto maggiore di quella con cui dispongono di un embrione di pochi giorni. E si pongono a noi
pertanto domande angoscianti. Ad esempio: è lecita la pena di morte? È lecita la guerra o può
esistere una guerra che si chiami “santa”? come comportarsi nelle emergenze, quando si può salvare
la vita di alcuni, a spese di altri? Nel caso in cui fosse palese che un assassino sta per sopprimere la
vita di un altro essere umano, è lecito, se non vi è altra possibilità, sopprimere il potenziale
assassino? Si può diventare omicida per procura se il rifiuto comporta l'uccisione di colui che ne è
stato incaricato?3
A queste domande, che la tradizione ebraica si poneva mille e settecento anni fa, avendo il coraggio
di aprire una discussione sul tema, oggi si tende troppo spesso a non rispondere, o a rispondere con
tanti “purtroppo” o con appelli generali e spesso generici. Ma la morte è intanto divenuta parte del
nostro panorama quotidiano; e non è la conclusione di un processo naturale, ma sempre di più è la
conclusione della violenza umana organizzata e professionalizzata. E le voci che la mettono in
discussione sembrano diventare ogni giorno più flebili, quasi che lo sviluppo delle possibilità
tecniche sappia solo peggiorare la qualità della vita. Non possiamo dimostrarlo, ma possiamo solo
creder che questo non sia un percorso fatale, una strada senza alternativa.
3
C’è un passo bellissimo nel Talmud (Pesachim, 25b) dove un tale chiede a un famoso Maestro come comportarsi,
visto che l’Autorità (persiana?) lo avrebbe incaricato di uccidere una certa persona, pena la sua stessa vita in caso di
rifiuto. A questo quesito, il Maestro risponde: fatti assassinare e non fare tu l’assassino di quella persone: ritieni forse
che il tuo sangue sia più rosso del suo? Sia detto incidentalmente, questa risposta può essere estesa a comprendere i casi
di obiezione di coscienza. E vale anche come risposta ai numerosi Eichmann e Priebke che si dichiaravano unschuldig,
“non colpevoli”, perché, secondo loro, in quanto militari, sarebbero stati soltanto esecutori di ordini ai quali non
avrebbero potuto sottrarsi neanche volendolo fare.
6
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
2.3. La fecondazione artificiale
2.2.1. Il parere di Riccardo Di Segni
[cfr. R. DI SEGNI, Il punto di vista ebraico su aborto, contraccezione fecondazione artificiale, in Religioni e
Bioetica. Un confronto sugli inizi della vita, a cura di L. Biagi e R. Pegoraro, Gregoriana, Padova 1997, pp.
293-298].
[Riguardo alla fecondazione artificiale bisogna considerare due dati di valore opposto.] Il primo,
negativo, nasce dalla preoccupazione che lo sviluppo di queste tecniche possa portare ad una
aberrante tecnologia della riproduzione, con un sistema diffuso di gravidanze “mercenarie” e
selezioni genetiche. […] D’altra parte, su un piano più diretto e immediato, esistono istanze
positive, che l’ebraismo valuta con attenzione ed anzi promuove, come il desiderio della maternità e
della paternità ed il mantenimento dell’armonia e della pace coniugale.
[La questione della fecondazione omologa è relativamente più semplice rispetto alla fecondazione
con donatore/i esterno alla coppia], ma anche su questo punto le opinioni dei decisori sono divise.
Un primo gruppo di maestri (tra i quali Ovadia Yosef e A. Neventzal) ritiene che la procedura sia
permessa, se è l’unica possibile, purché sia sicuro che si usi esclusivamente seme del marito. Altri
assumono una posizione negativa, fondata più su preoccupazioni generali di ordine morale che su
precise motivazioni giuridiche. Altri infine (come Rav Eliezer Woldenberg) assumono una
posizione di principio rigoristica basata su considerazioni giuridiche.
Per i favorevoli, la fecondazione artificiale non si discosta essenzialmente dall’inseminazione
artificiale, nella quale il seme impiegato viene dapprima raccolto fuori e quindi inserito nel corpo
della donna; procedura che viene consentita, in determinate condizioni, almeno quando avviene
nell’ambito della coppia.
Per i contrari, il fatto che la fecondazione avvenga al di fuori del corpo della donna crea una
situazione del tutto nuova e non paragonabile, per cui ciò che viene consentito (la raccolta esterna
del seme) ai fini di una fecondazione nella sede naturale, non può più esserlo in condizioni
artificiali, nelle quali, tra l’altro, la possibilità di un successo è statisticamente ridotta. Per i contrari,
in particolare, l’artificialità della procedura e la sua ridotta probabilità di successo sono tali da far
considerare la raccolta del seme come un’azione proibita; i favorevoli, invece, ritengono che anche
una minima probabilità di successo e l’intenzione procreativa giustifichino la raccolta in qualsiasi
condizione.
Alle preoccupazioni morali i favorevoli rispondono che queste vanno tenute nella dovuta
considerazione, ma che non sono di per sé comunque sufficienti per impedire di risolvere casi
particolari immediati sui quali non esistono vere e fondate obiezioni giuridiche.
[Riguardo alla fecondazione con donatore o donatori esterni] le preoccupazioni generiche per la
disgregazione sociale si fanno più cogenti; vi si associano tutte le questioni sulla definizione della
paternità e maternità giuridica, che insieme determinano un orientamento generalmente negativo a
priori.
Bisogna infatti a questo punto tenere presente che uno degli interessi e delle tematiche fondamentali
nel diritto matrimoniale ebraico è quello della definizione dello jochas, cioè dello stato giuridico
della persona in rapporto ai suoi genitori.
La questione ha implicazioni fondamentali in vari campi della legge ebraica: prima di tutto esiste un
obbligo di riproduzione, che si adempie facendo un figlio maschio ed una figlia femmina; poi
esistono dei doveri dei genitori nei confronti dei figli, e dei doveri dei figli nei confronti dei
genitori; le regole ereditarie stabiliscono le modalità di passaggio della proprietà dai genitori ai figli
e, tra l’altro, si applica l’istituto della primogenitura; il levirato presuppone la definizione di due o
più persone come fratelli, e si applica quando una donna non ha avuto figli dal marito che le è
morto. Vi è poi il rigoroso divieto di incesto, per applicare il quale bisogna conoscere che è il
genitore di ogni persona. E infine, ma non meno importante, ogni persona si definisce nella società
ebraica in rapporto ai suoi genitori.
7
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
[…]
[Inoltre] si nasce ebrei solo da madre ebrea: se quindi la madre non è ebrea, i suoi figli non sono
ebrei.
[…]
Un problema del tutto particolare, e apparentemente nuovo, è quello posto dall’utero “in affitto”. Se
una donna dà l’ovulo, e un’altra donna porta avanti la gravidanza, chi è la madre, secondo
l’halakhah? La prima (la madre genetica), la seconda (la partoriente), o entrambe? Si diventa madri,
secondo la legge ebraica, con l’ovulazione o con il parto?
Per fare qualche esempio concreto delle possibili implicazioni: quali sono le sorelle (per le quali
esiste un divieto di incesto) di un uomo nato da una fecondazione artificiale dall’ovulo di una donna
e dall’utero di un’altra donna? Le figlie della prima e le figlie della seconda donna? Oppure, se una
delle due “madri” è mamzeret [termine che significa “spurio” e che indica la prole che deriva da un
incesto o da un adulterio, che comporta perciò una riprovazione sociale e particolari limitazioni
nella scelta matrimoniale, che ricade sulla eventuale prole], quale delle due trasmette la sua
condizione negativa alla prole? E ancora: se una delle due “madri” non è ebrea, il figlio è ebreo?
[…]
Da un punto di vista biologico il patrimonio genetico deriva dai cromosomi, mentre con una
gravidanza la madre fa crescere il feto e si stabilisce il legame materno. Ma il ragionamento
giuridico non è strettamente vincolato da queste considerazioni – come si è visto legge e biologia
non si identificano -, ma deve scegliere e deve procedere con le sue regole, che sono quelle di
cercare nella letteratura antica le prove a favore dell’una o dell’altra posizione. Ma essendo il
problema tecnicamente nuovo, le prove esplicite mancano, e sono necessari complicati
ragionamenti analogici e deduttivi; e ovviamente anche su questo punto essenziale le opinioni dei
Maestri sono divise.
3. La fine della vita
3.1. Considerazioni generali
[cfr. I. JAKOBOVITS, Ebraismo, in Bioetica e grandi religioni, a cura di S. Spinsanti, Cinisello Balsamo 1987,
pp. 39-41]
L’etica ebraica considera come la più grande forma di carità i servizi resi a quanti non possono più
provvedere a se stessi, compresa la massima considerazione per la dignità di chi sta per morire.
Tuttavia, la sofferenza dei moribondi solleva un conflitto tragico tra la santità della vita e il sollievo
delle sofferenze umane, specialmente in condizioni terminali di vita.
Nel Talmud esiste un equivalente lessicale di “eutanasia” (“mithah yafah”), che viene usato per
raccomandare di assicurare una “morte facile” anche ai criminali puniti con la sentenza capitale [e
dunque ha il senso di insegnare ad evitare torture e maltrattamenti sadici ai condannati].
Questo significa che tale attenzione va riservata a maggior ragione anche agli innocenti che
soffrono all’avvicinarsi della morte.
Di fronte al problema se il medico debba o no mettere il malato a conoscenza delle sue condizioni
terminali, vale la considerazione che la morale ebraica, da certi punti di vista, considera la pace una
virtù ancora più grande della verità; valuta perciò la pace dello spirito del paziente più della
sincerità del medico, se questa può compromettere la speranza di tranquillità mentale del paziente.
I resti mortali debbono essere trattati con grande rispetto. Il Talmud condanna il “disonorare i
defunti” in generale, mediante un’esposizione indebita, un’esumazione ingiustificata e soprattutto
con deturpazioni di vario genere.
8
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
Nell’insieme, la legge ebraica considera il corpo umano come proprietà divina, e perciò inviolabile.
Né lo stato, né nessun’altra autorità può pretendere il diritto di possesso di un corpo umano.
Ciò ha creato serie difficoltà alla pratica scientifica delle autopsie, creando molta tensione tra le
esigenze della medicina e la determinazione dei rabbini di difendere i diritti dei morti. A motivo di
queste controversie riguardo alle autopsie, l’Università ebraica (fondata nel 1925) ha potuto
costituire una facoltà di medicina soltanto nel 1948.
3.2.
La concezione ebraica della vita e della morte
[Cfr. A. LUZZATTO, Fine della vita: un punto di vista ebraico, in Alla fine della vita: religioni e bioetica, a
cura di S. Morandini e R. Pegoraro, Gregoriana, Padova 2003, pp. 176-185].
[Che vita e morte siano due concetti contrapposti, potrebbe trovare fondamento, secondo la
tradizione ebraica, in un versetto del libro del Deuteronomio (30,15): «Osserva: pongo oggi davanti
a te la vita e il bene; e la morte e il male».]
La simmetria bipolare di “bene-male” è proprio parallela a quella di “vita-morte”? Possiamo
affermare che la morte sta alla vita come il male sta al bene o che il male sta alla morte come il bene
sta alla vita? La letteratura sapienziale, comprendendovi Salmi 90,10, non sarebbe assolutamente
d’accordo: “Gli anni della nostra vita sono settanta, e per coloro che sono molto robusti sono
ottanta; e [nota bene!] per massima parte consistono in fatiche e dolori”. Per poter rispondere
affermativamente, inoltre, sarebbe necessario poter fare le seguenti due affermazioni: a) chi nasce,
muore; b) chi muore, nasce. E questo non è facile. A ben vedere, è questo il vero dilemma
dell’Ecclesiaste.
[…]
Il Qohelet fa poi un passo avanti (12,1-5), quando descrive l’invecchiamento come la perdita
progressiva delle funzioni vitali […]. L’invecchiamento non è un preludio della morte, ma è già un
inizio della morte stessa, o quantomeno una perdita, passo dopo passo, di tutto ciò che permette di
gustare la vita, di “vivere “ la vita. Si giunge così alla considerazione della morte come una fase di
questo processo, non come una sua brusca interruzione.
[…]
Dunque, la morte è intesa come un processo vitale, ma al tempo stesso come un processo
irreversibile, forse l’unico processo irreversibile fra tutti quelli che sono magistralmente descritti in
Qohelet. Nello stesso testo, invece, manca qualsiasi riferimento al momento della morte. Anzi, in
tutta la Bibbia, […] non è mai descritto il “momento” della morte naturale.
[…] Ma, allora, paradossalmente, se la vita è “bene” e se la morte è una parte del processo che
chiamiamo anche vita, anche la morte può essere solo “bene”. Nella letteratura midrashica, infatti,
si fa questa coraggiosissima affermazione, laddove si commenta il tov meod [molto buono], che è il
giudizio di Dio a conclusione di tutta l’opera del Creato (Genesi 1,31), mentre per ciascuna singola
opera, il Creatore aveva visto che era semplicemente tov [buono]. Il midrashista si permette una
correzione del testo e legge “tov mut” [è bene morire].
[…]
il Talmud afferma significativamente che “il giusto è detto vivo anche da morto e il malvagio è
detto morto anche da vivo”, introducendo fra le caratteristiche della vita il modo di essere, i
comportamento umano. Ma allora, la “vita” è un concetto primo o possiamo identificarvi delle
componenti? Credo che sia valida la seconda ipotesi. […] Una volta plasmato l’uomo, esso non si
procura da solo, automaticamente e autonomamente, le funzioni vitali; secondo la Genesi, queste gli
provengono dall’esterno: dalla parola divina, come per gli altri viventi (Genesi 1,20-22) o dall’alito
divino (Genesi 2,7). Si tratta, comunque, di realtà che vengono da Dio, esattamente come si ripete
quotidianamente nella preghiera ebraica “Elohay neshamà”, (che comincia con le parole: “Mio Dio,
9
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
lo spirito che hai messo in me è puro, Tu l’hai creato, Tu gli hai dato forma, Tu l’hai insufflato in
me, Tu lo conservi dentro a me, Tu lo sottrarrai a me e Tu lo riporterai in me nel tempo che verrà”).
A conclusione, si può affermare che non possediamo a questo punto una definizione di vita, ma solo
un insieme di caratteristiche (difficilmente elencabili in modo esaustivo) che permettono a un
vivente di riconoscere e di descrivere come vivente un oggetto di osservazione. Qualunque
“definizione”, come ad esempio quelle riferite al tema dell’aborto, è da considerarsi convenzionale
e arbitraria oppure puro atto di fede.
Spesso i confini fra la vita e la morte non sono oggettivamente univoci ma dipendono in gran parte
dalla perdita di alcuni attributi vitali, senza i quali nella coscienza (in buona parte, naturalmente,
sulla base dell’educazione e della cultura) di coloro che al momento ancora li possiedono, la “vita”
non potrebbe più essere chiamata tale.
In altre parole, ciò che prevale è l’incertezza, dalla quale si cerca disperatamente di uscire attraverso
due strade. La prima è quella del dogma fideistico. La seconda consiste nello stabilire un principio e
una fine legali, che saranno arbitrari quanto si vuole, ma che rispondono pur sempre a un criterio
pratico, che, per essere tale, deve presentare una qualche obiettività riconoscibile a tutti. Direi che
questa seconda strada è quella che ha prevalso nella tradizione ebraica.
[…]
Quanto alla morte, il problema di stabilirne “il momento”, anche se, come abbiamo detto, si tratta di
un concetto improprio, è derivato modernamente soprattutto dalle necessità mediche del prelievo di
organi […]. Tradizionalmente, con un criterio già presente nella Bibbia, la cessazione del respiro
dovrebbe far testo, come si può desumere anche dall’espressione ebraica “yatzeà nishmatò” (è
uscito il suo spirito, ovvero il suo respiro; del resto anche in italiano si dice spirare). Con acuta
osservazione, il Remà (Rabbi Moshe Isserles, 1525-1572), rilevando che l’azione cardiaca – che è
una indiscutibile funzione vitale – può proseguire sia pur brevemente anche dopo la sospensione del
respiro, sosteneva che l’interruzione del respiro vale come indicatore della imminente interruzione
dell’attività cardiaca, che andrebbe tuttavia verificata. L’uso rianimatorio dei respiratori artificiali
con la drammatica necessità di decidere se e quando “staccare la spina” dopo lunghi, spesso
lunghissimi tempi di assistenza a un soggetto totalmente inerte e non reattivo, ha fatto rivolgere
l’attenzione al riscontro di un “elettroencefalogramma piatto” per un tempo sufficiente a non
prevederne più la ripresa. Non solo si è passati dalla morte respiratoria a quella cardiaca e infine a
quella cerebrale, ma ci si è insensibilmente avvicinati al criterio “soggettivo”: se “io” fossi in quelle
condizioni, non mi considererei più vivo.
È chiara purtroppo la contraddizione in termini: infatti, “se io fossi in quelle condizioni, non
considererei” più nulla. Non si tratta dunque di un giudizio riflessivo, di una specie di autogiudizio, ma soltanto di un giudizio soggettivo su un altro me. Il contenuto di tale giudizio è
inevitabilmente “arbitrario”; e questa arbitrarietà può essere solo attenuata se condivisa con altri,
essa può, dunque, al massimo, diventare “convenzionale”.
Senza dubbio vi sono molti aspetti della vita che possono creare l’impressione di essere governati
da un prevalente determinismo; fra questi spiccano molti dati che ci insegna la genetica. Di contro
la variabilità, sulla quale si fonda la selezione naturale e pertanto l’evoluzione, ci indirizzerebbe
verso la valorizzazione di una certa aleatorietà. Visto che le nostre società credono nel valore
dell’educazione, non dovremmo credere nel contempo di essere, nella nostra vita, semplicemente
l’implementazione di un programma scritto nei nostri geni. Quando però crediamo fortemente nel
peso che ha la nostra tradizione nel guidare le nostre azioni, le nostre credenze, e soprattutto quando
crediamo che Dio ci aiuta “grazie ai meriti dei nostri Padri”, siamo, anche senza accorgercene,
deterministi per quanto riguarda gli individui considerati isolatamente – ma non per quanto riguarda
gli individui collocati all’interno della catena delle generazione e dunque non ricettori passivi
quanto elementi attivi nel contribuire alla tradizione stessa.
1
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
La frase del Capitoli dei Padri III,22: “ha-kol tzafuy we-ha-reshut netunà”, “tutto è previsto ma è
concessa la libertà d’agire” parrebbe condensare in forma molto compatta entrambi questi
orientamenti. Sia pure in una forma talmente contraddittoria da esprimere più un travaglio sincero
che una sua soluzione. Dio è onnisciente e onni-preveggente; perché allora punire il malvagio se il
suo comportamento era scontato a priori? La mia risposta personale è che la traduzione della frase
dall’ebraico - almeno quella che è di gran lunga la più comune - è semplicemente sbagliata. […] La
traduzione del versetto citato dovrebbe suonare pressappoco così: “Tutto è palese [al cospetto di
Dio] e tu, essere umano, opera secondo il tuo libero arbitrio, ben sapendo che nulla sfugge al
Signore” e che verrai portato in giudizio perché sei responsabile delle tue azioni. Ecco dunque
un’altra componente della vita [umana]: la responsabilità, che poi incide sugli atti più materiali e
più fisiologici che permettono di “gustare” la vita, anzi, ne fanno un obbligo; ma impongono anche
delle rinunce e degli atti di altruismo, di solidarietà, di amore gratuito per il prossimo.
3.3.
Prolungamento e qualità della vita
[Cfr. A. LUZZATTO, Fine della vita: un punto di vista ebraico, in Alla fine della vita: religioni e bioetica, a
cura di S. Morandini e R. Pegoraro, Gregoriana, Padova 2003, pp. 187-185].
“Vita” e “coscienza” sono o non sono sinonimi? […] A questo domanda, si tenderebbe di primo
impulso a fornire una risposta negativa, confortata dall’espressione quasi-medica, entrata nell’uso
comune, di “vita vegetativa”.
Ma c’è di più. Colui che dorme, almeno quello che non si trova nella fase onirica, in quella cioè che
parrebbe coincidere con il “sonno REM”, può dirsi “vivo ma privo di coscienza”? Se la risposta è
affermativa, i due concetti di “vita” e “coscienza” non si possono sovrapporre; se è negativa, forse
sì.
Nella preghiera ebraica, almeno nell’inno Adon ‘olam che conclude le preghiere principali, si
afferma: Be-yado afqid ruchi --- be-‘et yshan we-a’ìra // We-‘im ruchì gewi-yati --- Adonay lì we-lo
irà (Nelle Sue mani affido il mio spirito – quando mi addormento e quando mi sveglio; // e con il
mio spirito [gli affido] il mio corpo – il mio Signore è con me ed io non ho paura). Questo significa
che io sono cosciente del fatto che in un determinato momento, passando dallo stato di veglia a
quello di sonno, nel momento in cui divento privo di coscienza potrei perdere anche il mio corpo.
Ho fiducia che ciò non accada. Di solito è proprio così, ma non vi è alcuna certezza che anche
questa volta sia come al solito ed io potrò verificarlo solo a posteriori, quando Dio mi restituirà la
coscienza per verificarlo. Dunque possiamo perfezionare quanto già detto e precisamente
aggiungere a “le caratteristiche che permettono a un vivente di descrivere e riconoscere come
vivente un oggetto dell’osservazione” le parole “e anche se stesso”. Non è un circolo vizioso.
Possiamo immaginare un osservatore esterno che in qualche modo rilevi la capacità di
autocoscienza del soggetto […]. Si badi bene: non abbiamo affermato di sapere che cosa sia la
coscienza e tanto meno l’autocoscienza, ma solo di aver rilevato dei segni che indicano che
dovrebbe esistere uno stato di coscienza vigile nel soggetto osservato. Pare paradossale affermare
che riteniamo che vi sia qualcosa che, in sé, rinunciamo a conoscere. Eppure questo procedimento è
molto frequente, anche in altri campi dello scibile umano.
Dunque, esistono situazioni che si trovano al confine tra la vita e la morte e che potrebbero
facilmente scivolare nell’una o nell’altra direzione. Se le cose stanno così, non è la perdita della
coscienza in sé e per sé che “significa” la morte, perché la perdita della coscienza può essere una
normale fase di un ciclo alla quale segue il recupero della coscienza stessa. Si tratta semmai della
perdita irreversibile della coscienza. Possiamo esserne sicuri?
Tranne casi estremi […] quasi mai. È vero che la probabilità che, dopo alcune ore di un
elettroencefalogramma piatto, le funzioni cerebrali ricompaiano è talmente esigua da potersi
considerare, “a fini pratici”, quasi nulla. Ma dobbiamo convenire che stabilire un limite di ore
(qualsiasi esso sia) per decidere di questa irreversibilità, è arbitrario e frutto di una convenzione.
1
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
Si badi bene: questa affermazione non vale per affermare che non si debba procedere in questo
modo, ma solo per dire che una convenzione è una convenzione e non una “verità biologica” o,
peggio, un dato “scientificamente dimostrato”.
Proprio questa convenzione, tuttavia, ha permesso di spostare il riconoscimento della perdita
irreversibile della coscienza e dell’autocoscienza come segno di processo mortale compiuto e
irreversibile da un suo collegamento alla sospensione del respiro a quello della sospensione
dell’attività cardiaca fino a quello della sospensione dell’attività cerebrale, riducendo a livelli di
eccezionalità il rischio di errore. E questo ci dovrebbe bastare.
3.4.
Criteri per l’accertamento della morte
[Cfr. A. M. RABELLO, Problemi connessi con la fine della vita e l’eutanasia alla luce del Diritto Ebraico, in
Bioetica e confessioni religiose. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il
12 maggio 2006, a cura di E. Camasa e C. Casonato, Università di Trento 2008, pp. 39-43]4.
I decisori [ossia le autorità riconosciute per l’emanazione di un parere legale] della nostra
generazione sono concordi nel ritenere che una persona può essere dichiarata morta anche se una
parte delle sue membra sia ancora viva, ma essi si sono trovati divisi sul problema di quale sia
l’organo la cui morte sia sufficiente a far dichiarare la morte della persona secondo la Halachà. Vi è
chi ritiene che per dichiarare la morte di una persona sia necessaria la cessazione dell’attività
respiratoria e di quella cardiaca, onde bisogna proseguire a curare il malato fino a quando non cessi
il battito del cuore o quanto meno non bisogna cambiare la situazione e quindi considerano proibito
staccare il malato dall’apparecchio della respirazione artificiale; altri ritengono che sia possibile
staccarlo dall’apparecchio, come chi fa cessare l’attività di un oggetto che impedisce la morte del
malato, onde in ogni caso il cuore cesserà la sua attività dopo qualche minuto, ma nel frattempo è
proibito avvicinare la morte del malato con una nostra attività, come potrebbe essere l’estrazione di
organi per un trapianto. Vi è chi sostiene che per stabilire la morte sia sufficiente constatare la
cessazione della circolazione del sangue, poiché in varie fonti bibliche appare il nesso fra sangue e
vita, mancanza di sangue e perdita della vita. Allo stesso modo la morte di alcuni organi considerati
dai Saggi indispensabili per la vitalità di una persona, come il cuore, il cervello o il fegato, a causa
della cessazione della circolazione sanguigna, può essere segno sufficiente per stabilire la morte
della persona, nonostante il flusso sanguigno persista in altri organi. Vi sono poi decisori che
ritengono che sia il cervello l’organo decisivo per stabilire la definizione di vita e di morte, onde la
morte completa del cervello, in tutte le sue parti e le sue cellule, è il segno necessario per stabilire la
morte di un individuo; altri decisori ritengono che il momento della morte sia fissato dall’assenza di
respirazione autonoma, perfino se vi è ancora attività cardiaca, e ciò se è chiaro che la cosa è
assoluta e irreversibile, onde il fatto decisivo è la mancanza della respirazione, che è considerata
dalle fonti tradizionali l’elemento che definisce la vita o la morte di una persona. Poiché
conosciamo tuttavia vari casi in cui la mancanza di respirazione è solo temporanea, diventa
fondamentale il parere del medico. Infatti la morte può essere provata mediante le conoscenze dei
medici che constatano la cessazione della funzione cardiaca o il mancato funzionamento assoluto
del cervello, ove risiede anche il centro respiratorio; il cervello non sarebbe dunque importante in sé
e per sé per la definizione di morte, ma solo in quanto centro della respirazione.
Si deve inoltre tenere presente che così come è proibito anticipare la morte di una persona, ed è
proibito quindi estrarre un organo per il trapianto, se in questo modo si provoca l’anticipazione
della morte del donatore, allo stesso modo è anche proibito prolungare la vita di un moribondo
soltanto per permettere di poter usare i suoi organi per il trapianto.
[…]
4
Alfredo Mordechai Rabello è professore emerito di Storia del diritto e Diritto comparato all’Università ebraica di
Gerusalemme e all’Università di Haifa.
1
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
[Nel 1986 il Rabbinato di Israele nominò una commissione di rabbini e medici, consigliandosi
anche con esperti in neurologia, anestesia, chirurgia, cardiologia, trapianti e neurofisiologia. Alla
fine pubblicò la sua decisione]. Dal punto di vista medico viene osservato che mentre una volta ci si
basava solo sulla elettroencefalografia (E.E.G.) - sistema che non era tuttavia certo né per stabilire
con sicurezza la morte, né per stabilire la morte del cervello - oggi si hanno sistemi più progrediti.
Basandosi su un passo del Talmud, e sulla decisione del Chatam Sofer [«… ma uno che è ridotto
come un sasso muto, e non ha battito, se poi è venuto a mancare il respiro, secondo la nostra santa
Torà è morto»] e su una opinione del Rav Moshè Feinstein, viene stabilito che il momento della
morte secondo la Halachà coincida con il cessare della respirazione (alito, fiato, respiro, neshimà).
Pertanto è necessario stabilire che la respirazione sia cessata completamente, in modo irreversibile.
Ciò si può stabilire oggi con metodi che verifichino la morte di tutto il cervello, compresa la
corteccia cerebrale, che è considerata appunto la parte che permette l’autorespirazione nell’uomo. Il
Rabbinato ha fatto propria la definizione di morte cerebrale, richiedendo, accanto agli esami del
cervello, condotti clinicamente, anche l’esame di laboratorio, cioè un esame obiettivo chiamato
BAER: si produce un’eccitazione sonora sul sistema uditivo e con l’aiuto di un computer si
analizzano le onde elettro-cerebrali che derivano dal sistema stesso. Se nell’esame viene ricevuta la
prima onda, che ha origine nell’orecchio interno (con l’assenza di onde elettriche provenienti dalla
corteccia cerebrale), è segno che l’orecchio è funzionante, ma la corteccia cerebrale è morta. In tal
caso il malato che non esercita una respirazione propria, non potrà più respirare ed è quindi
considerato morto secondo la Halachà; tuttavia, per non lasciare la decisione ai soli medici, il
rabbinato ha richiesto la presenza di un rabbino per dare il consenso al trapianto.
3.5.
L’eutanasia
[cfr. I. JAKOBOVITS, Ebraismo, in Bioetica e grandi religioni, a cura di S. Spinsanti, Cinisello Balsamo 1987,
p. 49].
L’eutanasia in senso proprio è rifiutata senza riserve dalla legge ebraica. Essa condanna ogni
accelerazione attiva e volontaria della morte come un assassinio puro e semplice, sia che il medico
agisca con o senza il consenso del paziente. L’ebraismo giudica il suicidio ancora peggiore
dell’omicidio, sotto alcuni punti di vista, poiché non si può riparare in alcun modo con il
pentimento con l’autodistruzione.
Per quanto riguarda la “eutanasia passiva” le opinioni rabbiniche contemporanee divergono.
Alcuni non permettono nessuna sospensione degli sforzi, per quanto artificiali e in definitiva senza
speranza, rivolti a prolungare la vita. Altri, invece, non esigono che il medico ricorra a “metodi
eroici”; essi consentono l’eliminazione di medicinali o macchinari che servono unicamente a
protrarre il supplizio del paziente che sta morendo, purché non vengano eliminati i mezzi naturali di
sussistenza (p. es. il cibo).
[Cfr. A. M. RABELLO, Problemi connessi con la fine della vita e l’eutanasia alla luce del Diritto Ebraico, in
Bioetica e confessioni religiose. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il
12 maggio 2006, a cura di E. Camasa e C. Casonato, Università di Trento 2008, pp. 44-47].
È evidente quindi che la posizione dell’Ebraismo nei confronti della c.d. “eutanasia” è negativa; è
fatto assolutamente divieto di praticare la cosiddetta “morte bella” e chi uccide un moribondo, che
ne affretta la morte commette praticamente un omicidio e che lo fa su se stesso commette
praticamente un suicidio.
Secondo autorevoli decisori, vi sono senz’altro diversi casi in cui è meglio non attaccare l’ammalato
all’apparecchio se non ci sono serie possibilità di ripresa e se vi sono sofferenze molto grandi per il
malato. Più difficile invece sarà permettere di staccare l’apparecchio una volta collegato al paziente;
qui, come avevamo accennato, la maggior parte dei decisori ritiene di dover proibire tale distacco,
1
ISSR “S. Lorenzo Giustiniani” - Corso “Bioetica e dialogo interreligioso” – a.a. 2011-2012
parte 5
sia pure per salvare un altro malato, che necessiti della stesso (forse unico) apparecchio. È
comunque da notare che proprio di recente vi è chi è arrivato alla soluzione che solo se i medici
hanno raggiunto la certezza assoluta che non sia più possibile salvare il malato, quando il malato
non ha più alcuna possibilità di vivere, allora sarà permesso, ed in taluni casi perfino doveroso,
staccarlo dall’apparecchio. Degna di nota anche la decisione del Rav Feinstein, che una volta
appreso l’uso assai diffuso in alcuni ospedali americani di prolungare la vita del paziente onde poter
guadagnare di più, fece espresso divieto ai medici di compiere attività che possano prolungare la
vita umana, qualora il periodo di vita prolungato abbia come risultato soltanto quello di prolungare
le sofferenze per il paziente; compito primo del medico è infatti quello di curare e non quello si
prolungare le sofferenze. Il decisore ha anche preso in esame il problema se sia permesso
prolungare la vita del paziente, magari provocandogli sofferenze, qualora questo serva a permettere
il prelievo di organi da trapiantare in un altro malato: anche in tal caso egli è giunto ad una
conclusione negativa.
È da ribadire che “se e quando applicare o sospendere la respirazione artificiale deve essere
determinato dall’interesse del paziente stesso, e non per ottenere un organo vitale a scopo di
trapianto, poiché sarebbe riprovevole manipolare una vita per il bene di un’altra”5.
Uno dei Rabbini Capo di Israele, il Rav Shelomò Goren, che ha esaminato in vari saggi vari
problemi connessi con l’eutanasia dal punto di vista della Halachà, è arrivato alle seguenti
conclusioni: a) è considerato opera pia pregare per un malato terminale, che soffre molto e non vi è
speranza che possa guarire, affinché sia accelerata la sua fine e sia liberato dalle sofferenze; b) è
proibito praticare ogni forma di eutanasia su richiesta dei un malato terminale, anche se sappiamo
che il malato non vivrà a lungo; c) non si deve accogliere la richiesta di un malato terminale che
soffre moltissimo e vive con apparecchi di rianimazione artificiale e chiede che sia fatto cessare
l’uso di tali apparecchi per permettergli di morire di morte naturale; anche se si sono vuotate le
bombole d’ossigeno e quelle di nutrimento artificiale, non si deve accogliere la richiesta del malato
di non riempirle di nuovo, per riguardo alla sua vita attuale: i precetti “e tuo fratello vivrà con te” e
“non assistere inerte al pericolo del tuo prossimo” sono in vigore anche quando il malato ci chiede
di affettare la sua morte; d) invece il malato può rifiutarsi di prendere una medicina in fase
sperimentale; e) nel caso di un malato terminale in stato di agonia (goses), che sappiamo che non si
potrà riprendere e che è attaccato ad apparecchi di rianimazione e che gli permettono di prolungare
l’agonia, non è permesso staccare questi apparecchi, ma grandi decisori (poskim), come il Bet
Jaakov e il Shvut Jaakov hanno permesso di non riempire, in questo caso particolare, le bombole e
lasciarlo morire di morte naturale.
5
I. JAKOBOVITS, Ebraismo, in Bioetica e grandi religioni, a cura di S. Spinsanti, Cinisello Balsamo 1987, p. 49.
1