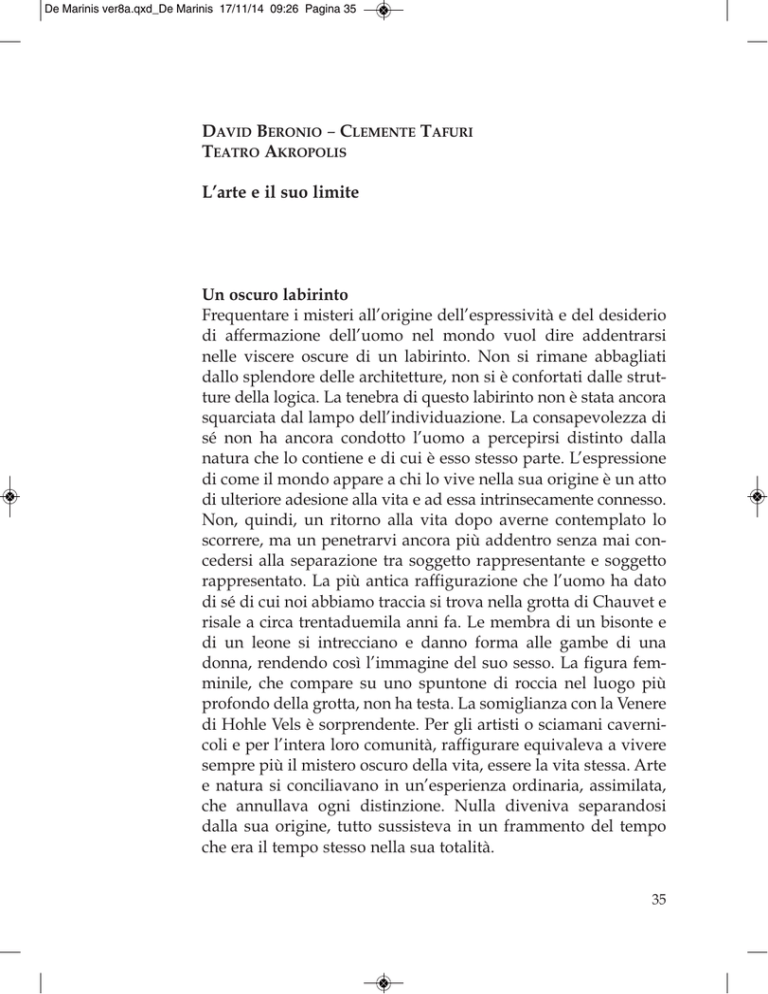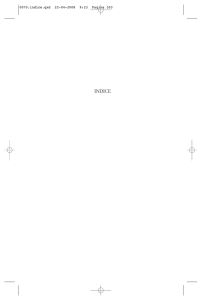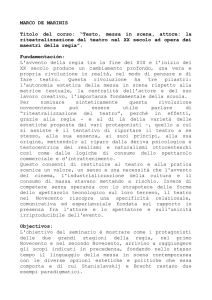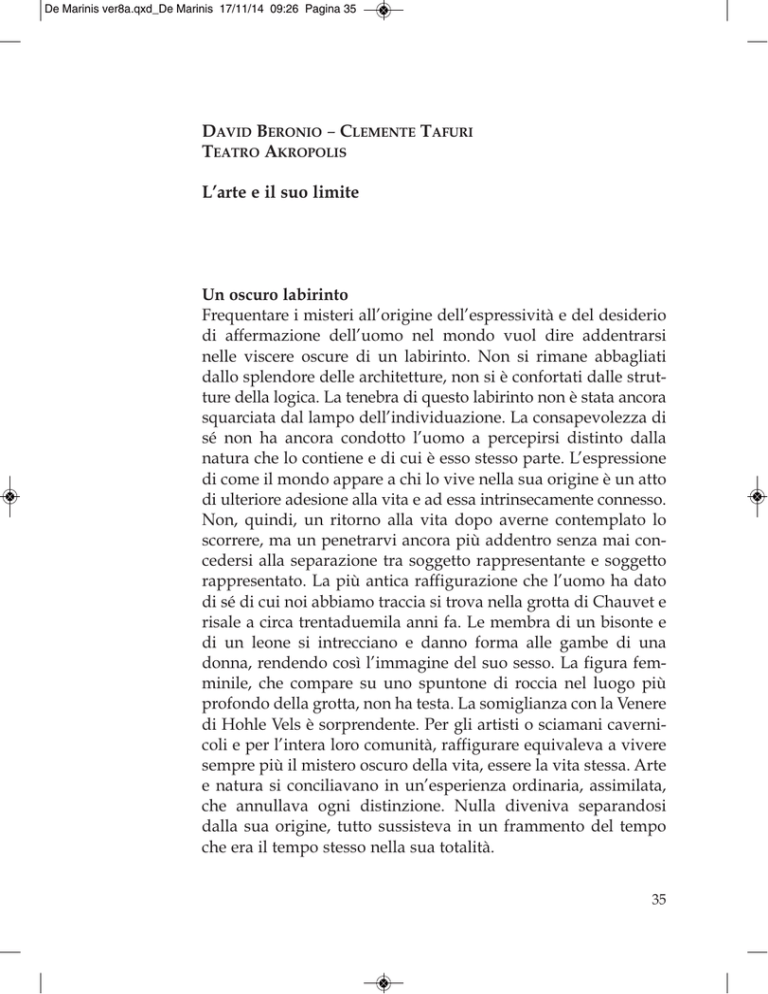
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 35
DAVID BERONIO – CLEMENTE TAFURI
TEATRO AKROPOLIS
L’arte e il suo limite
Un oscuro labirinto
Frequentare i misteri all’origine dell’espressività e del desiderio
di affermazione dell’uomo nel mondo vuol dire addentrarsi
nelle viscere oscure di un labirinto. Non si rimane abbagliati
dallo splendore delle architetture, non si è confortati dalle strutture della logica. La tenebra di questo labirinto non è stata ancora
squarciata dal lampo dell’individuazione. La consapevolezza di
sé non ha ancora condotto l’uomo a percepirsi distinto dalla
natura che lo contiene e di cui è esso stesso parte. L’espressione
di come il mondo appare a chi lo vive nella sua origine è un atto
di ulteriore adesione alla vita e ad essa intrinsecamente connesso.
Non, quindi, un ritorno alla vita dopo averne contemplato lo
scorrere, ma un penetrarvi ancora più addentro senza mai concedersi alla separazione tra soggetto rappresentante e soggetto
rappresentato. La più antica raffigurazione che l’uomo ha dato
di sé di cui noi abbiamo traccia si trova nella grotta di Chauvet e
risale a circa trentaduemila anni fa. Le membra di un bisonte e
di un leone si intrecciano e danno forma alle gambe di una
donna, rendendo così l’immagine del suo sesso. La figura femminile, che compare su uno spuntone di roccia nel luogo più
profondo della grotta, non ha testa. La somiglianza con la Venere
di Hohle Vels è sorprendente. Per gli artisti o sciamani cavernicoli e per l’intera loro comunità, raffigurare equivaleva a vivere
sempre più il mistero oscuro della vita, essere la vita stessa. Arte
e natura si conciliavano in un’esperienza ordinaria, assimilata,
che annullava ogni distinzione. Nulla diveniva separandosi
dalla sua origine, tutto sussisteva in un frammento del tempo
che era il tempo stesso nella sua totalità.
35
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 36
Porsi di fronte a queste immagini con tale consapevolezza significa affrontare il problema della natura dell’arte da un punto di
vista in cui la dimensione letteraria, la mediazione di un linguaggio rigidamente codificato e il rapporto con una tradizione
che esercita il suo potere fluidamente sono completamente
assenti. Questa condizione ci consente di riflettere su un’espressione creativa senza dover considerare quegli elementi che
diventeranno la struttura stessa e il senso delle opere di epoche
successive. Uno di questi elementi, per esempio, è quello della
comunicazione, che costituisce un piano sul quale sempre più
viene focalizzata la lettura del significato ultimo di un’opera, e
che nell’arte paleolitica appare assolutamente estranea alla natura
delle immagini. Quelle figure non comunicano nulla ma costituiscono un’azione che traspone in forma di immagini una parte
del mondo.
Le incisioni e le sculture paleolitiche sono certamente magiche,
ed è vano cercarvi riti di pubblica utilità. [...] Il mimetismo è alla
radice di quelle opere composite in cui l’uomo si camuffa da
bestia lasciando talvolta trasparire il proprio volto sotto la
maschera [...] ma questo mimetismo, che prolunga certi prodigi
della natura circostante, è orientato verso la partecipazione
magica.1
Il concetto di magia evocato da Breton a proposito della funzione
essenziale dell’arte ne denota il fondamentale doppio carattere
superando il problema dell’arte come imitazione della natura.
Da un lato l’arte come prassi, cioè, esattamente come la magia,
un agire volto ad uno scopo la cui ragione ultima ricade intimamente all’interno dell’azione stessa: un’azione capace di ribadire
la sua origine comune con la natura, capace di operare dall’interno
dell’omogeneità e dell’unità di tutte le cose. Dall’altro l’arte
come traccia di una precisa consapevolezza, quella cioè di una
posizione dell’uomo non come soggetto assoluto di fronte al
mondo che lo circonda, ma come parte fluida e non individuabile
di un universo tanto insondabile quanto intimamente vicino.
36
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 37
L’arte del Paleolitico conserva intatto il primato di questi due
caratteri, quello cioè di non essere importante innanzitutto come
opera, come manufatto, ma come azione di cui l’opera è una
traccia. E quello di mettere immediatamente in primo piano
l’evocazione di un mondo in cui il soggetto, l’“autore”, scompare
lasciando che l’immagine del mondo venga alla luce senza che
il medium dell’artista la riporti su un piano psicologico e individuale.
La donna della grotta di Chauvet non è imitazione o copia di
quanto esiste ma equivale alle «incorporazioni visibili dell’estraneo nell’aspetto di ciò che è familiare»2. Per noi, ridotti a vivere
contemplando l’immagine della vita, appare oltre umana la
facoltà di essere tutt’uno con un’azione che conduce il suo attore
a una perdita di sé e contemporaneamente a un totale controllo
del sé organico. È dunque evidente che l’arte, nella sua origine,
faceva a meno di definirsi in un oggetto concluso, e pertanto
anche nell’interprete che conduce a questa conclusione.
Uomini e donne del Paleolitico avrebbero riso del nostro stupore
di fronte ai loro dipinti.
La percezione del mondo
Per la comprensione di una tale prospettiva diventa necessario
ripensare il modo abituale di considerare la natura delle cose per
come si impongono all’esperienza sensibile. Questa esperienza,
che si definisce sempre più nel porsi di fronte alla rappresentazione e non all’essenza del mondo, è viziata irrimediabilmente
dal dovere di comunicare. Si tratta di un dovere connaturato al
soggetto dell’esperienza secondo cui ogni attimo deve essere
riportato su un piano di condivisibilità, e si tratta di un livello
tanto pervasivo da riguardare anche la maggior parte dei tentativi di negare coscientemente l’intenzione di comunicare. È così
che, in un mondo orientato in funzione di un finalismo o di un
determinismo universale, ogni momento, anche il più insignificante, assolve alla sua funzionalità e quindi deve avere un potere
comunicativo. Deve essere comunicazione.
37
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 38
Per potersi liberare da tutto ciò occorre innanzitutto definire
l’orizzonte entro il quale un’esperienza possa essere vissuta, e
questo orizzonte è quello di un’esperienza che non sia mediata
da una visione intellettualistica della realtà: non si tratta di classificare due diverse concezioni del mondo, una in cui gli oggetti
dell’esperienza sensibile esauriscono da soli il piano della realtà,
e un’altra in cui il mondo sensibile è un segno di un mondo
ontologicamente superiore sottratto alle leggi del divenire.
L’intellettualismo sta piuttosto nello stabilire un’identità rigida e
immutabile per il soggetto, che non prevede spiragli nella propria
individuazione ed è impermeabile nei confronti di ciò che lo
circonda. Tale identità viene enunciata da Kant:
L’unità della coscienza è il solo elemento che costituisca il riferimento delle rappresentazioni ad un oggetto, e quindi la loro validità oggettiva; di conseguenza, il solo far sì che esse divengano
conoscenze. Tale unità è dunque ciò su cui si fonda la possibilità
stessa dell’intelletto3.
Kant inserisce questa riflessione nell’ambito delle sue considerazioni sull’esperienza del fenomeno attraverso le sensazioni, e sul
presupposto che esista una realtà ulteriore, che egli stesso definisce noumeno, e che pone al di fuori delle possibilità dell’esperienza. Ma se ritorniamo al fenomeno come principio di realtà in
quanto oggetto dell’esperienza, e rifiutiamo, con Nietzsche,
l’ipotesi di un mondo dietro il mondo, ancora non siamo giunti alla
possibilità di concepire quella totalità che l’arte nella sua origine
ha avuto la capacità, come abbiamo visto, di esprimere. E questo
perché non abbiamo superato quell’unità della coscienza che costituisce il principium individuationis, non una dimensione strutturale dell’essere umano, ma una condizione in cui esso si ritrova.
La vera rivoluzione copernicana, allora, non è, come pensava Kant,
quella di spostare i principi che regolano l’intuizione dagli
oggetti al soggetto, ma quella di considerare una nuova natura
del soggetto. Non più un passivo collettore di sensazioni, ma un
attore permeabile al mondo che lo circonda.
38
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 39
L’esperienza dei sensi noi l’afferriamo istantaneamente poi la
lasciamo cadere; se vogliamo fissarla, inchiodarla, la falsifichiamo.
Questo è il significato dei frammenti che tradizionalmente vengono interpretati a sostegno di una presunta dottrina eraclitea
del divenire. Eraclito non crede che il divenire sia più reale dell’essere; crede semplicemente che “ogni opinione è una malattia
sacra”.4
La ferita della metafisica
Abitualmente si utilizza il termine metafisica conferendogli
molteplici significati, attribuendogli connotazione ora positiva,
ora negativa. Esso può indicare una dimensione ulteriore e più
ricca rispetto a quella dell’esperienza sensibile oppure può riferirsi ad un sistema di riferimenti promossi da una fede religiosa
e considerati illusori. Occorre tuttavia chiarire un significato
univoco in modo da evitare ambiguità e confusioni.
Kant affronta la questione all’inizio della Critica della ragion pura:
In un genere delle sue conoscenze, la ragione umana ha il particolare destino di venir assediata da questioni, che essa non può
respingere, poiché le sono assegnate dalla natura della ragione
stessa, ma alle quali essa non può neppure dare risposta, poiché
oltrepassano ogni potere della ragione umana. [...] essa cade in
oscurità e contraddizioni, dalle quali a dire il vero può inferire,
che alla base debbono sussistere da qualche parte errori nascosti;
essa non può tuttavia scoprirli, poiché le proposizioni fondamentali, di cui si serve, non riconoscono più alcuna pietra di paragone
nell’esperienza, dal momento che oltrepassano il confine di ogni
esperienza. Ebbene, il campo di battaglia di questi contrasti senza
fine si chiama metafisica5.
Kant pone la sua attenzione sulla natura problematica della
metafisica stessa, come campo di indagine umana che dapprima
diventa regina di tutte le scienze, e in un secondo momento, messa
in discussione dallo scetticismo della filosofia moderna, è fatta
39
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 40
oggetto di un totale disprezzo. La criticità di una tale impostazione,
che parte dalla constatazione che esiste una distinzione fra
l’oggetto dell’esperienza e l’oggetto della ragione, risale a
Platone e si protrae per tutto il corso del pensiero occidentale.
Ma Heidegger la mette in discussione:
Il pensiero metafisico si fonda sulla distinzione fra ciò che è veramente e ciò che, confrontato con quello, costituisce l’ambito del
non veramente essente. Per l’essenza della metafisica l’elemento
decisivo non risiede tuttavia per niente nel fatto che la distinzione
menzionata si presenti come opposizione tra soprasensibile e
sensibile, ma nel fatto che quella distinzione, intesa come una
fenditura aperta, rimanga l’elemento primo e determinante. La
metafisica sussiste allora anche quando la gerarchia platonica tra
soprasensibile e sensibile viene rovesciata, e il sensibile viene
esperimentato in modo più essenziale e più ampio.6
La metafisica dunque consiste in una frattura, e in quanto tale si
delinea il suo carattere fondamentale di separazione di ciò che
prima era unito. Porre la distinzione fra razionale e irrazionale
significa creare una antitesi insanabile fra due tipi di esperienza
che quotidianamente vengono vissuti dall’uomo. Uno è quello
cioè in cui prevale una visione del mondo filtrata attraverso la
necessità di compiere azioni finalizzate al raggiungimento di
uno scopo ben preciso, e a tal scopo l’elemento importante della
natura è quello che ci perviene attraverso la sensibilità ordinata
dalla ragione. L’altro aspetto è quello delle esperienze gratuite,
libere da ogni finalità, delle visioni oniriche, dell’esperienza tragica dell’individuo e del suo destino. Porre in conflitto questi
due tipi di esperienze significa lasciare spazio agli irrisolvibili
contrasti senza fine di cui parla Kant. Ma se invece di prendere
parte per la razionalità in favore dell’esperienza empirica o per
un’ineffabile spiritualità in favore dell’esperienza mistica, se
invece di invertire la gerarchia fra sensibile e soprasensibile, proviamo a porci da un punto di vista anteriore a quella divisione,
allora si può aprire per l’uomo una prospettiva davvero nuova.
40
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 41
Anzi, antichissima, dal momento che si tratta della prospettiva
raccontata in Grecia prima di Socrate.
Quindi con il termine metafisica si deve indicare innanzitutto
l’assunto che il pensiero occidentale ha fatto suo da Platone in
poi: quello della divisione di un mondo vero da uno apparente.
Metafisica è quella dogmatica che nega realtà al mondo dove si
svolge la vita umana in favore di un mondo ultraterreno, ma è
anche quella che liquida come mondo apparente tutte le esperienze del sacro e riduce tutte le attività spirituali ad un mero
epifenomeno biologico.
Chronos e aion
L’esperienza razionale del tempo è un’esperienza lineare, presieduta da un’attività ordinatrice del prima e del dopo che classifica tutti gli eventi e li collega fra loro con nessi di causalità.
Un’esperienza quindi metafisica che induce l’uomo a rivolgere il
suo sguardo all’indietro credendo così di scoprire i princìpi che
regolano tutto ciò che accade, e questo con la nascosta pretesa di
proiettare quei princìpi nel futuro, di predire e di ammaestrare.
Questo sguardo sul tempo è la storia, che corre avanti e indietro,
compiendo la sua infaticabile analisi, sulla linea che ha tracciato.
La più terribile condanna di questa visione del tempo è quella di
Nietzsche: «La storia, pensata come pura scienza e divenuta
sovrana, sarebbe una specie di chiusura e liquidazione della vita
per l’umanità»7. Un rifiuto così netto proviene dalla convinzione
che il confronto con il proprio passato possa generare una reale
conoscenza a patto che non ci si limiti a compiere un’analisi delle
forze astratte che concorrono al determinarsi degli avvenimenti,
ma che si prendano le mosse da quel principio antistorico che è
l’uomo inteso nella sua dimensione più vitale: «Il nostro punto di
partenza è quello dell’unico centro permanente, e, per noi, possibile, dell’uomo che soffre, aspira ed agisce quale è ed è sempre
stato e sarà»8. Riconsiderare la natura del tempo, non più inteso
come successione di momenti di uguale valore cronologico, significa riconoscere il primato dell’esperienza di una immediatezza
41
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 42
vissuta solo grazie ad un profondo collegamento con il passato:
«Ciò che un tempo fu gioia e disperazione ora deve diventare
conoscenza, proprio come nella vita dell’individuo»9. L’idea che
la storia debba essere un fattore interiore, e che possa dare origine
ad uno sviluppo veritativo, è stata pensata da Burckhardt in
polemica con il concetto di filosofia della storia, cioè di una disciplina che possa arrivare ad un risultato conoscitivo procedendo
con un’analisi razionale dei fatti accaduti. L’intuizione di
Burckhardt viene ripresa da Nietzsche che recupera la possibilità
del valore della storia solo «in quanto sia al servizio della vita, è
al servizio di una forza non storica, e perciò non potrà né dovrà
diventare mai, in questa subordinazione, pura scienza, come per
esempio lo è la matematica»10. Ma ancora più profondamente
questo concetto è stato pensato da Giorgio Colli, che dice che
«ciò che di vivo esiste nel presente è soltanto il riaffiorare di una
vita del passato»11 e che «poiché la nostra individuazione non è
altro che un nesso di conoscenze, e ciò che sopravanza, al di là
dell’individuazione, è ancora conoscenza, ma un’altra conoscenza,
ecco allora che, strappato il velo della persona, appare l’occasione
dell’estasi, la conoscenza che sta alla sorgente, l’attimo, il primo
ricordo di ciò che ormai non è conoscenza»12. La conoscenza
più profonda può essere vissuta solo nell’esperienza dell’immediatezza, che consiste nell’intuizione di sé al di là della propria
individuazione. Ma tale esperienza procede attraverso il riconoscimento dell’origine della conoscenza da ciò che un tempo fu gioia
e dolore, cioè dal suo radicamento nel passato. Questa consapevolezza spezza la linea retta del tempo, in cui tutti i punti sono
uguali, smaschera l’inconsistenza del tempo cronologico e fa
trapelare una temporalità diversa, che appartiene profondamente
all’uomo. È l’aion, il tempo che annulla in sé la distinzione fra
presente e passato, il tempo che non conosce la proiezione dei
timori e dei desideri in un futuro che non esiste. Il tempo dell’immediatezza, il tempo dell’estasi che è «una conoscenza non
condizionata dall’individuazione»13. L’opera d’arte in quanto
opera, ovvero oggetto finito, si colloca irrimediabilmente nel
tempo cronologico, finendo per riferirsi a determinati orizzonti
42
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 43
culturali. Essa entra in una relazione necessaria con tutto ciò che
la circonda e non per forza la riguarda. Essa è portatrice di un
contenuto e in quanto tale si offre alla critica e all’opinione e al
confronto diretto con le altre opere. L’opera è la testimonianza
della storia, reca su di sé i segni del suo tempo e crea una
distanza tra sé e la vita. L’opera è un complesso dogmatico che
non ammette un ripensamento delle strutture che lo definiscono
come opera e che sono la sua ragion d’essere. Nulla di più
distante da quanto compare nelle viscere della grotta di
Chauvet.
Opera e letteratura
Le strutture non possono essere intaccate. L’artista inganna
inconsapevolmente se stesso mentre con la più profonda consapevolezza procede verso la definizione sempre più accurata del
mondo che lo circonda e della cultura che lo pervade. Le strutture
sono quelle della letteratura. Ma il concetto di letteratura qui
non si esaurisce nella pagina scritta. Si estende a tutte le forme
d’arte e si manifesta nel rapporto dialettico con il sistema culturale che le accoglie. Il dogma, discusso, stravolto, abbandonato,
continua ad affermare il suo dominio, il suo senso. Definisce i
piani comuni tra l’opera e chi ne fruisce stabilendo la possibilità
di un confronto e quindi affermando la sua inscalfibilità.
Ciò riguarda anche il teatro, anche se nel teatro l’opera non c’è.
Il teatro è l’arte, come la musica, che non produce il suo oggetto,
non lascia, al termine del processo creativo, un’opera che ne rappresenti il culmine e il termine. Non un’immagine, non un
oggetto. Il teatro, tutt’al più, lascia dei pezzi inerti, delle parti
inutilizzabili degli elementi che lo hanno composto: un costume,
il bozzetto di una scenografia, un copione. La drammaturgia
stessa è una forma letteraria che non ha la minima autonomia e,
se fatta oggetto di semplice lettura, diventa poco più che il documento di un progetto. Eppure, anche se interamente pervaso
dalla struttura letteraria, il teatro offre la possibilità di aprire uno
spiraglio fra le sue fitte maglie. L’intuizione che la performatività
43
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 44
teatrale possa essere l’occasione di sfuggire alla condanna dell’individuazione e del tempo storico è un patrimonio comune
delle esperienze teatrali del Novecento. Seconda questa tradizione
chi agisce sulla scena e chi nello stesso istante assiste non solo
condividono il medesimo tempo, ma convivono nell’esperienza
del farsi dell’opera, e tale condivisione apre alla possibilità di un
nuovo modo di vivere il tempo, «il decorso del tempo nel dramma
è una successione assoluta di “presenti”. Il dramma stesso come
assoluto, garantisce e crea da sé il proprio tempo. Ogni istante
dell’azione drammatica deve quindi contenere il germe del
futuro»14. La messa in discussione delle strutture dell’opera
porta necessariamente alla messa in discussione della concezione
temporale cronologica, al prefigurarsi di un «presente [che]
passa operando un mutamento, e dalle sue antitesi sorge un
nuovo e diverso presente»15. Da ciò balena la possibilità di una
temporalità alternativa.
Tuttavia sostenere che l’attore possa vivere un tempo assoluto,
definitivo e in grado di contenere un’esperienza veritativa è
un’utopia. Vivere un tempo eterno, o un frammento vuoto di
tempo lineare, è un paradosso. Il tempo così immaginato è già
finito nel nostro pensare, determinato anche dall’assenza e
ricondotto alle ragioni di Chronos. Ma il tempo dell’aion non è
una mera ipotesi logica, né la memoria di una visione del mondo
ormai remota e per noi in parte incomprensibile. Esperire una
temporalità diversa da quella cronologica è in realtà possibile in
diverse occasioni, nel sogno oppure negli stati di trance, anche se
nessuno di questi esempi ha direttamente a che fare con l’aion.
Ma non è importante definire la qualità psicologica o filosofica
di questa temporalità pre-individuale, è necessario, piuttosto, in
questa sede, collocarla in un’esperienza storicamente individuabile, la Grecia arcaica, che ha visto nascere le prime forme teatrali.
È proprio il teatro nella sua origine a recare traccia della possibilità di vivere il tempo dell’aion. L’arte greca più in generale è
espressione di una duplice concezione del tempo dove alla fredda
successione cronologica si affiancava una temporalità profondamente legata ad ogni istante della vita.
44
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 45
Ma l’attore può farsi testimone di un tempo diverso da quello
quotidiano, anche se non può viverlo sulla scena e, tanto meno,
farlo vivere a chi assiste al suo lavoro.
Come può avvenire tutto questo?
La natura non si palesa ma si nasconde, sì che bisogna con mille
astuzie e quasi frodi, e con mille ingegni e macchine scalzarla e
pressarla e tormentarla e cavarle di bocca a marcia forza i suoi
segreti: ma la natura così violentata e scoperta non concede più
quei diletti che prima offriva spontaneamente. [...] Le bellezze
dunque della natura conformate da principio alle qualità ed ordinate al diletto di spettatori naturali, non variano pel variare de’
riguardanti, ma nessuna mutazione degli uomini indusse mai
cambiamento nella natura, la quale vincitrice dell’esperienza
e dello studio e dell’arte e d’ogni cosa umana mantenendosi
eternamente quella, a volerne conseguire quel diletto puro e
sostanziale ch’è il fine proprio della poesia (giacché il diletto nella
poesia scaturisce dall’imitazione della natura), ma che insieme è
conformato alla condizione primitiva degli uomini, è necessario
che, non la natura a noi, ma noi ci adattiamo alla natura.16
Questa riflessione si inserisce nella polemica letteraria che si
sviluppò, all’inizio dell’Ottocento, fra i sostenitori delle nuove
istanze romantiche e i difensori dell’estetica classicistica. In realtà
il classicismo di Leopardi consiste in una costante ricerca rivolta
all’indagine dell’origine, e la categoria di natura sta qui ad indicare uno stato umano oltre che una categoria ontologica, e va
riferito più propriamente alla physis dei greci del VI secolo piuttosto che alla natura della filosofia moderna. L’arte viene investita
del compito di offrire un approccio alternativo a quello scientifico
e positivo che porta la natura a nascondersi e a piegarsi alla
lettura che il metodo sperimentale tenta di darne. Sembra quasi
che prenda corpo l’illusione che la natura muti i suoi princìpi per
uniformarsi alle teorie che pretendono di indagarla. La natura
inganna chi forza i suoi segreti e offre quello che da lei si pretende.
Leopardi parte dall’assunto, che apparentemente sembra assurdo
45
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 46
negare, che la natura è immutabile. Ma ciò porta con sé la conseguenza che il solo modo di avvicinarsi a lei è quello di uniformarsi alla sua immutabilità. Questo significa abbandonare tutti
gli schemi razionali e sociali con i quali abitualmente ci si
relaziona alla vita. Si tratta di superare le pretese di dominio
sviluppate con la supremazia della tecnica, che è diventata il
punto di vista principale attraverso il quale oggi guardiamo al
mondo che ci circonda, perché «restiamo sempre prigionieri
della tecnica e incatenati ad essa, sia che la accettiamo con entusiasmo, sia che la neghiamo con veemenza»17. Ma si tratta anche
di lasciarsi alle spalle gli schemi della letteratura, che portano a
esprimere un rapporto con il mondo regolato dagli infiniti
rimandi sociali e culturali che creano un struttura destinata a
rimanere vuota. Il compito della poesia, e dell’arte in generale,
diventa allora quello di recuperare la dimensione primitiva in cui
l’uomo non era ancora rigidamente determinato dal suo principio
d’individuazione, in cui era ancora in grado di vivere il tempo
dell’aion.
Ciò attraverso il processo artistico dell’imitazione, cioè quella
stessa mimesis che Aristotele pone alla base della pratica teatrale
nella Poetica. Chiaramente non si tratta di una riproduzione della
parte più profonda della natura che in sé è irriproducibile, né
della rappresentazione attraverso un linguaggio codificato di ciò
che non può essere classificato se non a costo di stravolgerlo.
La mimesis per Leopardi è piuttosto una tecnica che riguarda
l’atteggiamento dell’artista, il quale deve fare suoi i princìpi e
le suggestioni della natura con cui è chiamato a confrontarsi.
Si tratta di adattarsi, quindi di modificare le proprie premesse e
le proprie categorie, di modificare tutto se stesso per raggiungere
quello «stato primitivo de’ nostri maggiori»18 che consente di
attingere ad una condizione originaria perduta. L’imitazione di
Leopardi è un processo performativo che riguarda l’artista in
prima persona e di cui l’opera è una testimonianza, una traccia.
Chi meglio di un attore, proprio quando non è in scena, può liberarsi dalle strutture letterarie e compiere questo itinerario?
Quella che potrebbe apparire una condizione paradossale, ovvero
46
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 47
un attore senza scena, è in realtà una situazione privilegiata per
frequentare il limite in cui le strutture metafisiche vengono oltrepassate. La scena, o qualsivoglia occasione di confronto con un
pubblico, diventa il luogo di una possibile profanazione di questo
limite, il luogo in cui si tradisce, pur custodendola, un’esperienza
che non può sopravvivere in una forma, per quanto, come il
teatro, possa essere libera, aperta e fluida. Seguendo questa prospettiva, la parte più vitale degli studi dei maestri del teatro del
Novecento è proprio quella che si riferisce alla natura dell’attore,
a quanto un individuo, come attore e come uomo, può fare per
spingersi sino alla soglia imposta dalla propria creatività oltre la
quale il lavoro si cristallizza in un’opera, in uno spettacolo, in
una prova, in una improvvisazione.
Esiste la possibilità, per alcuni, di oltrepassare i limiti assegnati
all’arte in generale e al teatro in particolare seguendo un percorso
di frequentazione della tecnica fino a che il confronto con essa
non conduce a un momento di apertura, alla scoperta di un’essenza che non è più limitata al tema dell’espressività, della rappresentazione, della comunicazione, al rapporto con il personaggio, alla relazione con il pubblico e a ogni elemento culturale che
definisce le strutture portanti di una qualsiasi convenzione.
Un’essenza che riguarda l’uomo nella sua totalità. Ed è in questo
orizzonte che l’attore conosce se stesso innanzitutto come parte
di un insieme non individuato. Lo studio e la ricerca del
Novecento tracciano nettamente la separazione tra il lavoro dell’attore su se stesso e quello della scena. E gli stessi studi spesso
hanno testimoniato come sia impraticabile trasferire in modo
convincente sul piano della costruzione scenica l’intensità di
queste pratiche vissute proprio quando l’attore è meno costretto
nel suo ruolo di attore, ma nonostante questo ne frequenta profondamente la natura.
Al di qua di questa soglia è possibile frequentare il limite di
un’esperienza conoscitiva che nell’opera può trovare, nella
migliore delle ipotesi, solo un riverbero. Un riverbero che tuttavia,
conservando ancora parte della potenza che lo ha originato,
costituisce il valore principale dell’opera stessa.
47
De Marinis ver8a.qxd_De Marinis 17/11/14 09:26 Pagina 48
Note
1 André Breton, L’arte magica, Adelphi, Milano 2003, p. 101.
2 Martin Heidegger, Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1997, p. 135.
3 Immanuel Kant, Critica della ragion pura, trad. it. di Giorgio Colli, Adelphi, Milano
2004, p. 163.
4 Giorgio Colli, La nascita della filosofia, Adelphi, Milano 1998, p. 65.
5 Immanuel Kant, Critica della ragion pura, cit., p. 7.
6 Martin Heidegger, Saggi e discorsi, cit., p. 80.
7 Friedrich Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, Adelphi, Milano
2007, p. 15.
8 Jacob Burckhardt, Sullo studio della storia, Boringhieri, Torino 1968, p. 18.
9 Ivi, p. 23.
10 Friedrich Nietzsche, Sull’utilità e il danno..., cit., p. 16.
11 Giorgio Colli, Dopo Nietzsche, Adelphi, Milano 2008, p. 63.
12 Ivi, p. 62.
13 Ivi, p. 61.
14 Peter Szondi, Teoria del dramma moderno, Einaudi, Torino 1992, p. 12.
15 Ibidem.
16 Giacomo Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, BUR,
Milano 2007, pp. 82-83.
17 Martin Heidegger, Saggi e discorsi, cit., p. 5.
18 Giacomo Leopardi, Discorso di un italiano..., cit., p. 83.
48