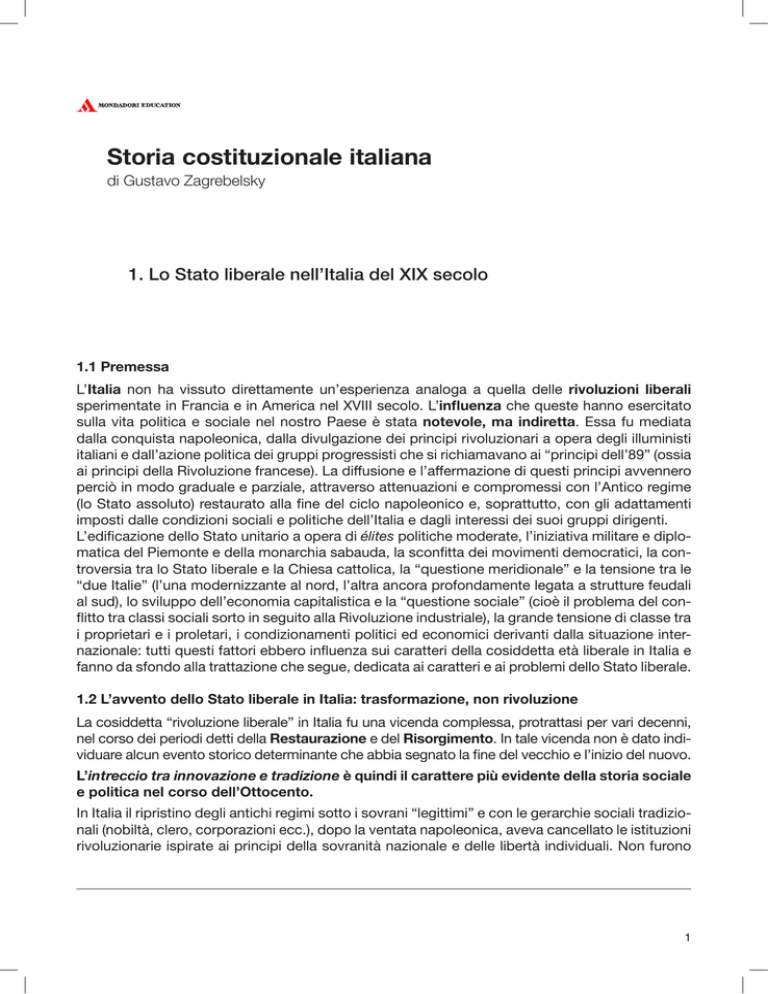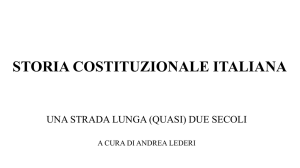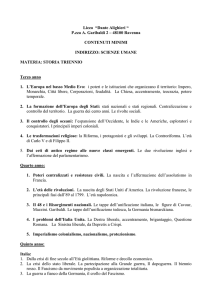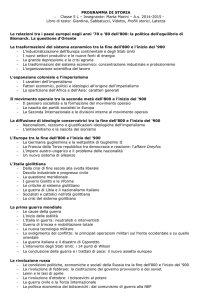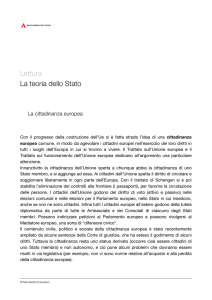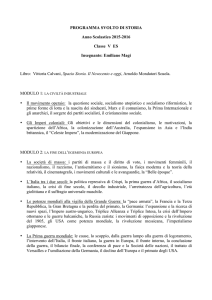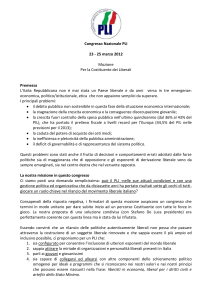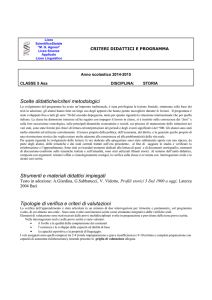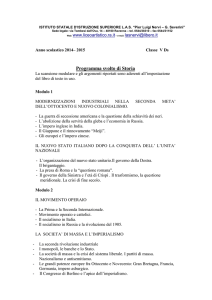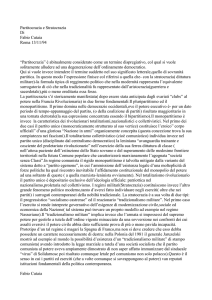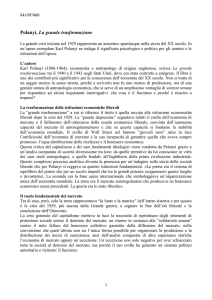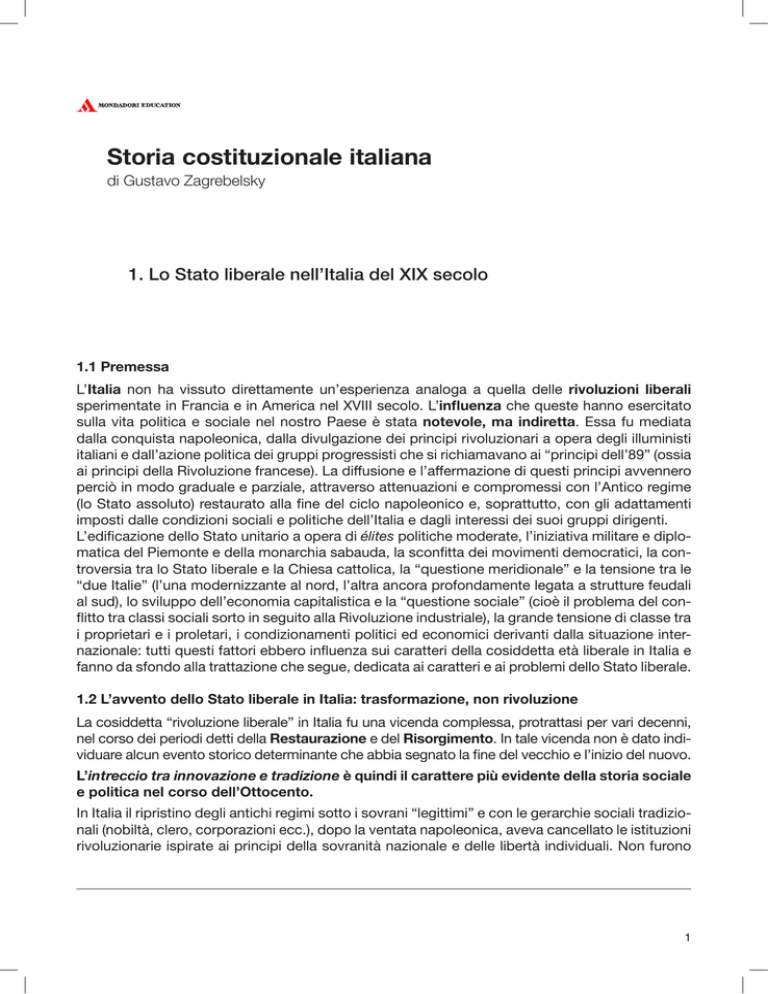
Storia costituzionale italiana
di Gustavo Zagrebelsky
1. Lo Stato liberale nell’Italia del XIX secolo
1.1 Premessa
L’Italia non ha vissuto direttamente un’esperienza analoga a quella delle rivoluzioni liberali
sperimentate in Francia e in America nel XVIII secolo. L’influenza che queste hanno esercitato
sulla vita politica e sociale nel nostro Paese è stata notevole, ma indiretta. Essa fu mediata
dalla conquista napoleonica, dalla divulgazione dei principi rivoluzionari a opera degli illuministi
italiani e dall’azione politica dei gruppi progressisti che si richiamavano ai “principi dell’89” (ossia
ai principi della Rivoluzione francese). La diffusione e l’affermazione di questi principi avvennero
perciò in modo graduale e parziale, attraverso attenuazioni e compromessi con l’Antico regime
(lo Stato assoluto) restaurato alla fine del ciclo napoleonico e, soprattutto, con gli adattamenti
imposti dalle condizioni sociali e politiche dell’Italia e dagli interessi dei suoi gruppi dirigenti.
L’edificazione dello Stato unitario a opera di élites politiche moderate, l’iniziativa militare e diplomatica del Piemonte e della monarchia sabauda, la sconfitta dei movimenti democratici, la controversia tra lo Stato liberale e la Chiesa cattolica, la “questione meridionale” e la tensione tra le
“due Italie” (l’una modernizzante al nord, l’altra ancora profondamente legata a strutture feudali
al sud), lo sviluppo dell’economia capitalistica e la “questione sociale” (cioè il problema del conflitto tra classi sociali sorto in seguito alla Rivoluzione industriale), la grande tensione di classe tra
i proprietari e i proletari, i condizionamenti politici ed economici derivanti dalla situazione internazionale: tutti questi fattori ebbero influenza sui caratteri della cosiddetta età liberale in Italia e
fanno da sfondo alla trattazione che segue, dedicata ai caratteri e ai problemi dello Stato liberale.
1.2 L’avvento dello Stato liberale in Italia: trasformazione, non rivoluzione
La cosiddetta “rivoluzione liberale” in Italia fu una vicenda complessa, protrattasi per vari decenni,
nel corso dei periodi detti della Restaurazione e del Risorgimento. In tale vicenda non è dato individuare alcun evento storico determinante che abbia segnato la fine del vecchio e l’inizio del nuovo.
L’intreccio tra innovazione e tradizione è quindi il carattere più evidente della storia sociale
e politica nel corso dell’Ottocento.
In Italia il ripristino degli antichi regimi sotto i sovrani “legittimi” e con le gerarchie sociali tradizionali (nobiltà, clero, corporazioni ecc.), dopo la ventata napoleonica, aveva cancellato le istituzioni
rivoluzionarie ispirate ai principi della sovranità nazionale e delle libertà individuali. Non furono
1
Storia costituzionale italiana
invece eliminate quelle istituzioni che erano servite all’accentramento del potere assoluto sotto
un unico sovrano: emblematico fu il caso del prefetto, agente del Governo che controllava l’intera vita locale, istituito da Napoleone e mantenuto dai sovrani “restaurati”. I sovrani della Restaurazione tennero conto, avvalendosene per i propri fini, della concentrazione del potere politico
che era stata la grande realizzazione della Rivoluzione francese. Sotto questo aspetto essi erano
assai più assolutistici dei loro predecessori.
Non fu possibile però eliminare le esigenze economiche e sociali nuove, che in Francia si erano
manifestate attraverso la rivoluzione e in Italia, come altrove, covavano sotto la cenere. Esse erano radicate nella parte più viva della cultura di allora ed erano destinate a riaffacciarsi di quando
in quando in moti insurrezionali e in congiure locali. Trovarono anche parziali realizzazioni attraverso le riforme che i governi più “illuminati” (in Toscana e in Lombardia, nonché in Piemonte con
Carlo Alberto, Re di Sardegna dal 1831 al 1849) operarono nei loro Stati.
La Restaurazione reazionaria si aprì così poco per volta alla “Restaurazione liberale”.
Quest’ultima fu la continuazione, nell’Ottocento, della politica di quei sovrani assoluti che, nel
secolo precedente, avevano concepito il loro potere in funzione dell’interesse dei propri sudditi,
il quale veniva però interpretato paternalisticamente e sovranamente dal Re stesso. Era il cosiddetto “Stato di polizia” (ove polizia significava – da pòlis – “buon governo dello Stato”).
La “Restaurazione liberale” fu lo Stato di polizia con in più il riconoscimento alla borghesia
della possibilità di influire sulla politica accanto al sovrano.
Anche l’atto più significativo di questo periodo, la concessione dello Statuto albertino (insieme
con le altre costituzioni non piemontesi dalla effimera vita), è solo una riforma che la monarchia
restaurata fece a favore della borghesia. Esso fu un evento molto meno rivoluzionario di quanto
spesso si dice. D’altro canto, il carattere innovativo dello Statuto non fu tanto dovuto al suo contenuto, quanto agli sviluppi che esso rese possibili.
Fu un impasto, un compromesso tra il vecchio e il nuovo e solo progressivamente e non integralmente il nuovo prevalse sul vecchio.
L’assenza di una rivoluzione liberale nel nostro Paese – e quindi l’assenza di un ripudio
radicale delle vecchie strutture, della vecchia mentalità, delle vecchie gerarchie – è uno
degli aspetti ai quali gli storici sono propensi ad attribuire un grande significato, nella comprensione dei caratteri della nostra società (anche di quella attuale).
1.3 Il significato moderato dello Statuto albertino: la difesa contro la rivoluzione sociale
Le considerazioni precedenti sul carattere moderato delle trasformazioni liberali in Italia possono
essere verificate a proposito delle vicende che hanno portato allo Statuto albertino (4 marzo
1848). Esso è una carta costituzionale unilateralmente concessa (octroyée, come si usa dire,
traendo la formula dalla Restaurazione in Francia) dal sovrano ai sudditi.
Questo fatto costituisce un’essenziale differenza rispetto alla Costituzione rivoluzionaria elaborata in Francia dall’Assemblea nazionale nel 1791. Lo Statuto è espressione di un potere sovrano
che resta nelle mani del Re; la Costituzione francese proveniva invece da un nuovo sovrano –
l’Assemblea – che aveva spodestato il vecchio. Lo Statuto non fece nascere quindi un nuovo
regime politico, perché non vi fu sostituzione del sovrano: espresse solo la volontà di questo di
autolimitare il proprio potere, senza metterne in gioco il fondamento.
© Mondadori Education
2
1. Lo Stato liberale nell’Italia del XIX secolo
Dal punto di vista della realtà politica, è noto però che il sovrano fu indotto, o costretto, a
concedere lo Statuto dalle condizioni storiche che erano venute a determinarsi in tutta Europa
(e anche in Piemonte) nel corso del 1848. Questo è l’anno in cui per la prima volta, a Parigi,
si accendono moti rivoluzionari in nome del socialismo. Essi si svilupparono dalle penose
condizioni delle masse operaie che l’organizzazione capitalistica (sfruttamento intensivo della
mano d’opera, introduzione delle macchine e disoccupazione crescente) rendeva progressivamente peggiori.
La posta in gioco non era solo il cambiamento del regime politico, ma anche il sovvertimento del
sistema sociale attraverso l’abolizione della proprietà privata e la presa del potere da parte del
popolo. È del 1848 il Manifesto del Partito comunista di Karl Marx (1818-83) e Friedrich Engels
(1820-95) che inizia evocando ironicamente lo “spettro che si aggira per l’Europa”, lo spettro del
comunismo.
La grande paura di un generale sconvolgimento sociale che avrebbe travolto le gerarchie
tradizionali, il potere dell’aristocrazia e della Chiesa, delle corti presso i sovrani e della
borghesia, saldò occasionalmente in un unico intento difensivo i vecchi ceti dominanti e la
nuova classe emergente (la borghesia).
Lo Statuto fu, in Piemonte, il patto difensivo di queste forze. Tale carattere è enunciato, per
esempio, da un testimone come il Cavour (1810-61), che, in una lettera del 1848, scriveva al suo
interlocutore:
Se foste a Torino da un mese in qua, non dubito che avreste diviso l’opinione che una Costituzione è indispensabile per arrestare il moto progressivo delle passioni e frenare il partito radicale, che mira nientemeno a
fondare nelle istituzioni municipali una Costituzione ultrademocratica1.
In termini più drammatici, lo stesso Cavour indicava così il compito delle classi dirigenti:
salvare l’ordine sociale da una distruzione assoluta; serbare intatti i sacrosanti principi della famiglia e della
proprietà, minacciati dal socialismo e dall’anarchia; preservare la civiltà moderna da una invasione di barbari2.
Tuttavia, le forze storiche dell’Antico regime (monarchia, aristocrazia e clero) dovettero cedere
molto alle forze del nuovo (la borghesia), per il timore di perdere tutto in un più radicale rivoluzionamento sociale. La borghesia moderata fu la vera vincitrice nel compromesso. Si difese
anch’essa dalla rivoluzione proletaria, ottenendo ciò che le premeva: nuove istituzioni politiche
in cui poter esercitare un peso più conforme alla sua importanza sociale.
Lo Statuto fu il superamento delle forme assolutistiche in una monarchia costituzionale
(basata cioè su una Costituzione e su istituzioni parlamentari), isolò le tendenze più radicali, aprendo la strada a una moderata modernizzazione politica e sociale richiesta da una
società che stava per superare poco a poco la civiltà feudale.
Lo Statuto riuscì così a legare alle nuove istituzioni i conservatori illuminati (cioè disposti ai cambiamenti necessari nei nuovi tempi per salvare l’essenziale dei vecchi) e gli innovatori moderati
(cioè interessati alla continuità rispetto al passato), isolando le ali estreme, reazionaria e rivoluzionaria. Fu insomma un’operazione riformatrice “di centro”.
1. CHIALA, L., (a cura di), Lettere edite e inedite, Botta, Torino, 1886, V, p. 174.
2. CAVOUR, in “Il Risorgimento”, 30 giugno 1848.
© Mondadori Education
3
Storia costituzionale italiana
Non fu invece un evento rivoluzionario, se per rivoluzione si intende il rovesciamento del regime
precedente, l’eliminazione della classe dirigente anteriore, il mutamento radicale delle regole
della vita sociale ed economica.
1.4 I caratteri dello Statuto: i diritti dei cittadini
Lo Statuto di Carlo Alberto assomigliava alle altre “carte” venute alla luce durante la restaurazione liberale. Era ispirato a quelle francesi del 1814 e del 1830 e a quella belga (tuttora in vigore)
del 1831. Si trattava però, più che di una semplice copiatura, del prodotto di un movimento
storico-politico di dimensione europea, il liberalismo moderato. Negli anni precedenti esso
aveva assunto posizioni notevolmente precise sui due aspetti fondamentali delle costituzioni del
tempo: i diritti dei cittadini e l’organizzazione dei poteri costituzionali.
La proclamazione dei diritti era ispirata, con molta moderazione, alla Dichiarazione dell’89.
Lo Statuto affermava: (a) l’uguaglianza di fronte alla legge e la parità di accesso alle cariche
pubbliche, salve però le eccezioni determinate dalla legge (art. 24); proteggeva (b) la libertà
individuale e vietava gli arresti e i processi arbitrari, cioè contrari alla legge (art. 26); vietava
le violazioni della (c) libertà del domicilio, eccezion fatta per i casi previsti dalla legge (art.
27); diceva (d) libera la stampa, ma prevedeva una legge per reprimerne gli abusi (art. 28);
garantiva (e) il diritto di riunione, conformemente alle leggi che ne regolassero l’esercizio nel
pubblico interesse, ma le riunioni pubbliche ricadevano interamente sotto il potere di polizia
(art. 32). Senza essere espressamente menzionato, (f) il diritto di associazione si riteneva
compreso tra le libertà individuali, come specificazione del diritto di riunione. Come tutte le
costituzioni liberali, lo Statuto difendeva (g) il diritto di proprietà, dichiarandolo inviolabile,
pur prevedendo l’espropriazione dietro indennità, nel caso di pubblico interesse dichiarato
dalla legge (art. 29).
Lo Statuto si esprimeva invece in modo assai meno deciso in materia di (h) libertà religiosa, anche se rispetto alle persecuzioni del passato contro le minoranze (valdesi, ebrei) rappresentava
un progresso. La religione cattolica era proclamata la sola religione dello Stato (che esso
avesse una propria religione non corrispondeva affatto alle idee liberali e appariva piuttosto un
residuo dell’Antico regime). Gli altri culti erano semplicemente tollerati, conformemente alle
leggi (art. 1). Inoltre, lo Stato offriva alla Chiesa cattolica il suo aiuto (il “braccio secolare”) per
reprimere le pubblicazioni religiose non approvate dal vescovo (art. 28).
In confronto con l’assolutezza delle proclamazioni contenute nella Dichiarazione dell’89, si
può notare il costante rinvio alle leggi come strumento per limitare i diritti apparentemente
riconosciuti a tutti.
Ciò corrispondeva a una visione classista dei diritti costituzionali, poiché la legge non era la
volontà di tutti, ma la volontà di una ristretta oligarchia in cui la borghesia esercitava un ruolo
egemone. Perciò la garanzia dei diritti non valeva ugualmente per tutti, ma solo per coloro che
disponevano del potere di fare le leggi.
I diritti dell’89 erano proclamati in astratto, per tutta l’umanità: le carte liberali dell’Ottocento erano invece la proclamazione dei diritti della vincente borghesia. Si temeva che i diritti riconosciuti
incondizionatamente a tutti potessero agevolare la sovversione sociale e l’instaurazione del regime democratico (la bestia nera dei liberali moderati).
© Mondadori Education
4
1. Lo Stato liberale nell’Italia del XIX secolo
Il riconoscimento dei diritti era così condizionato alla difesa della società liberale e delle
sue gerarchie sociali. Lo Statuto parlava il linguaggio delle società aperte (come la Dichiarazione dell’89), ma si apprestava a permettere che una società chiusa si affermasse.
Più precisamente, la società che ne sarebbe derivata era – per così dire – a due strati: era aperta
per coloro che appartenevano alle classi dominanti, che avevano accesso allo Stato e partecipavano alla legislazione; era chiusa per le masse subalterne, escluse dallo Stato (non potevano
votare), le quali potevano percepirne soltanto l’aspetto autoritario e repressivo.
I critici di questo tipo di costituzioni (Karl Marx, per esempio) vedevano in queste dichiarazioni
dei diritti l’affermazione di principi di libertà e la loro contraddizione: si dava con una mano – lo
Statuto – ciò che con l’altra – la legge – ci si preparava a togliere. I diritti non erano per tutti.
1.5 I caratteri dello Statuto: la monarchia rappresentativa e il “Governo misto”
L’organizzazione del potere prevista dallo Statuto corrispondeva allo schema della monarchia
costituzionale (o Governo costituzionale). Con questa formula non si intendeva qualunque Governo retto da una Costituzione, bensì il Governo vagheggiato dai liberali moderati. Esso consisteva nell’introdurre, accanto ai principi tradizionali dell’Antico regime (i principi monarchico e
aristocratico), il terzo principio (detto impropriamente “democratico”) attraverso la rappresentanza elettiva della borghesia. Per questo motivo le monarchie costituzionali si dissero anche
monarchie rappresentative.
Il modello delle costituzioni liberali della Restaurazione, tra cui lo Statuto albertino, era rappresentato dal sistema di governo inglese. Esso si era venuto formando nel corso dei secoli in
modo pragmatico nella vita politica concreta, senza una vera e propria carta costituzionale che
ne definisse i contorni (tuttora la Gran Bretagna non ha una Costituzione scritta e si regola secondo la tradizione). Nel corso del XVII secolo i Re della casa Stuart tentarono di stabilire una
monarchia assoluta, umiliando i “ceti” feudali che si riunivano nel Parlamento.
Tale tentativo assolutistico fu però sconfitto dalla “gloriosa rivoluzione” del 1689, che riuscì a
imporre il rispetto dei diritti del Parlamento. Il Bill of Rights (Dichiarazione dei diritti) affermò che il
Re non poteva sospendere a suo piacimento la legge, cioè che egli era – come tutti – assoggettato alla legge comune. Questa era la fine dell’assolutismo, come regime del Re legibus solutus
(“esentato dal rispetto della legge”).
La legge, a sua volta, era il prodotto dell’accordo dei tre massimi organi politici: il Re, la Camera
dei Lords (formata ereditariamente dai “Pari d’Inghilterra”, cioè dall’aristocrazia) e la Camera dei
Comuni (eletta dalla nascente borghesia). Le leggi erano approvate dalle due camere e il testo
così approvato veniva “sanzionato” (cioè confermato) dal Re. Nessuno dei tre organi, perciò,
comandava da solo. La legge era un accordo che esprimeva un equilibrio fra tre centri di potere
ed era obbligatoria per tutti.
Il regime inglese veniva considerato dai suoi ammiratori – per esempio, da Montesquieu nel capitolo 5 del libro IX dell’Esprit des lois, e, in Italia, da Massimo d’Azeglio (1798-1866) e da Cavour
– come il solo che potesse assicurare un regime libero e moderato al tempo stesso: un regime al
riparo dagli eccessi della Rivoluzione francese, quando un solo organo (l’Assemblea nazionale o
la Convenzione) aveva monopolizzato tutto il potere politico. Per questo, l’Inghilterra assurse al
ruolo di Paese guida dei regimi liberali della Restaurazione. Le costituzioni di questi ultimi sono
il tentativo di trasporre negli Stati continentali le istituzioni inglesi.
© Mondadori Education
5
Storia costituzionale italiana
Lo Statuto albertino si fondava dunque anch’esso – sull’esempio inglese – sui tre principi
– monarchico, aristocratico e “democratico” –, ai quali corrispondevano tre organi: il Re, il
Senato e la Camera dei Deputati.
Fra questi tre organi era suddivisa la massima autorità politica, quella di fare le leggi: “il potere
legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due camere: il Senato e quella dei deputati” (art. 3). Ciò non ha nulla a che vedere con il principio della separazione dei poteri, il quale
comporta che funzioni diverse siano attribuite a organi diversi. Per l’esercizio della massima
funzione politica, quella legislativa, lo Statuto prevedeva non la separazione ma, all’opposto, la
compartecipazione dei massimi organi della Costituzione, ciascuno dei quali esprimeva una parte della società del tempo. Erano escluse, peraltro, le grandi masse popolari, che non avevano
diritto di voto; perciò il regime non poteva propriamente dirsi democratico.
Si trattava dunque non della separazione dei poteri, ma del Governo misto: la partecipazione
al vertice dello Stato di tutte le componenti sociali attive politicamente, affinché ciascuna vi trovasse la propria garanzia. La legge era approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato ed era
poi “sanzionata”3 dal Re. In mancanza di uno di questi passaggi non vi era legge possibile. L’idea
fondamentale del Governo misto è dunque quella di unificare nello Stato le diverse componenti
della società. In questa impostazione si coglie facilmente la distanza tra le costituzioni dell’Ottocento – basate su una visione della società di tipo prerivoluzionario – e quella rivoluzionaria,
fondata invece sull’idea di società di individui uguali.
La teoria del Governo misto era una teoria moderata che mirava alla stabilità e all’equilibrio.
Lo scopo era analogo a quello della separazione dei poteri, ma i mezzi erano diversi, adeguati
a una società ancora divisa in ceti. Può essere interessante ricordarne il fondamento teorico,
che risale addirittura all’antico storico Polibio4. Egli aveva notato che ogni regime “semplice”,
cioè basato su un solo principio, tende a corrompersi. Così la monarchia (governo di uno),
l’aristocrazia (governo dei migliori) e la democrazia (governo di tutti) tendono a divenire tirannia (governo arbitrario di uno), oligarchia (governo egoistico di pochi) e demagogia (governo
irrazionale della piazza). La mancanza di freni permette queste degenerazioni. Secondo Polibio
occorre
non stabilire una Costituzione semplice e uniforme, ma riunire tutti i pregi e le caratteristiche dei sistemi politici migliori, in modo che nessuno di essi, acquistando una forza maggiore del necessario, devii verso la sua
forma peggiore, ma in modo che la forza dell’uno neutralizzi quella degli altri e i diversi organi si equilibrino e
nessuno ecceda e così il sistema di governo rimanga lungamente in perfetto equilibrio, a guisa di nave che
vince le forze di opposte correnti5.
Nelle intenzioni di questo sistema il Re è tenuto a freno dal popolo che partecipa al potere in
misura adeguata, e il popolo è tenuto a freno dal Senato.
Malgrado questo schema tripartito, la monarchia costituzionale funzionò in realtà come
regime dualistico.
3. La “sanzione” (dal latino sanciscor, sanctio) è l’atto con cui si imprime carattere di ufficialità a qualche avvenimento.
4. Polibio di Megalopoli (202-118 ca. a.C.) greco di nascita, fu attivo a Roma dopo che questa ebbe conquistato la Grecia. La sua
fama è legata a una lucida analisi dell’ascesa di Roma contenuta nelle sue Storie, che coprono il periodo 220-146 a.C. (da Annibale
alla distruzione di Cartagine).
5. POLIBIO, Storie, VI, 10.
© Mondadori Education
6
1. Lo Stato liberale nell’Italia del XIX secolo
Il Senato, organo di nomina regia, era infatti espressione di ceti ormai in declino, che non ebbero
un ruolo decisivo, ma si conformarono alle posizioni del Re e della sua corte. I senatori erano
nominati, per tutta la vita, tra gli alti funzionari dello Stato, i vescovi, i deputati con una certa anzianità, nonché tra chi con servizi e meriti insigni avesse reso illustre la patria oppure possedesse
redditi consistenti. La composizione risultava, soprattutto all’inizio, prevalentemente nobiliare.
Inoltre, non essendo previsto un numero massimo di senatori, il Re poteva in ogni momento piegare la maggioranza ai propri desideri, attraverso le “infornate”6 di nuovi senatori fedeli.
Il dualismo Re-Camera elettiva fu la manifestazione dell’opposizione tra l’assolutismo, impersonato dal Re, e il liberalismo, impersonato dai deputati della Camera.
Al di là degli schemi tripartiti, il Governo costituzionale dell’Ottocento si basò dunque sul Re e
sulla Camera. L’art. 2 dello Statuto albertino diceva del resto esplicitamente: “lo Stato è retto
da un Governo monarchico e rappresentativo”. E, come si vedrà, anche questo equilibrio venne
rapidamente superato dagli svolgimenti storici concreti.
1.6 Il carattere oligarchico del regime liberale
Nella Camera dei Deputati, formata elettivamente, si vedeva realizzato, come si diceva, il principio democratico. La legge elettorale riconosceva “il diritto di eleggere a quel maggior numero
di cittadini che è compatibile con le condizioni di un Governo sicuramente rappresentativo”, ma
non a tutti. Il suffragio universale (che, del resto neppure la Rivoluzione dell’89 riconobbe integralmente) veniva considerato un pericoloso portatore di tendenze rivoluzionarie o reazionarie,
in ogni caso incompatibili con il carattere moderato dello Statuto.
Le condizioni per poter godere dell’elettorato attivo (cioè del diritto di voto) consistevano
nel saper leggere e nel pagare una certa imposta sul reddito.
Il primo requisito veniva giustificato sostenendo che la partecipazione alla vita dello Stato non
poteva considerarsi adatta a coloro che fossero totalmente privi di cultura, non fossero in grado
di leggere i giornali e non facessero perciò parte della “opinione pubblica”. Il requisito economico o “censitario” (che per lo più andava di pari passo con quello culturale) veniva giustificato
affermando che i nullatenenti o “proletari”, non avendo niente da difendere e quindi niente da
temere, avrebbero agito irresponsabilmente e sarebbero diventati facili prede dei demagoghi. Lo
Stato si confermava così come affare dei proprietari e dei produttori di reddito.
Inoltre, dal voto erano escluse le donne (e lo saranno fino al 1946).
Si immaginino le condizioni di vita di allora, per lo più in campagna, dove c’erano poche possibilità di socializzazione. Si diceva che le donne non avrebbero espresso voti consapevoli e personali, ma si sarebbero rimesse alla volontà dei parroci (ciò che avrebbe dato ai clericali un’influenza decisiva nella vita dello Stato) o dei mariti (violando così il principio di uguaglianza tra uomini,
sposati e celibi). Più in generale, l’esclusione delle donne derivava dal fatto che solo gli uomini
erano produttori di reddito, cioè cittadini a pieno titolo nello Stato della borghesia produttiva.
L’imposta richiesta era di 40 lire e non era giudicata eccessiva (Cavour, per esempio, aveva
proposto 100 lire). Risultava così per le prime elezioni del Regno di Sardegna nel 1848 un corpo
6. Nomine di blocchi di persone del medesimo orientamento.
© Mondadori Education
7
Storia costituzionale italiana
elettorale (cioè l’insieme dei potenziali elettori) di circa 80.000 cittadini su 4.900.000 circa, con un
rapporto di 1 elettore ogni 62 abitanti (in Inghilterra, a quell’epoca, il rapporto era di 1 a 30; in Belgio, di 1 a 55; nell’ultracensitaria monarchia di luglio in Francia era di 1 a 145). A ogni deputato
corrispondevano 300 elettori (e 18.700 cittadini, di cui quindi 18.400 erano esclusi dalle elezioni).
Se si considera poi che la partecipazione al voto non era elevatissima, si comprende il
carattere fortemente oligarchico e tutt’altro che democratico di quel sistema, dal quale la
stragrande maggioranza del popolo era esclusa.
Il rapporto numerico tra il deputato e gli elettori (da 1 a 300, come si è detto) consentiva il contatto diretto tra loro e un rapporto di conoscenza e frequentazione personale basato nel migliore
dei casi sulla comunanza di ideali politici, nel peggiore sul clientelismo e la corruzione.
Questo fu il punto di partenza per uno sviluppo che non poteva mancare, nell’interesse stesso
del regime liberale. La sua base sociale era minima e la sua stabilità molto incerta, di fronte alle
rivendicazioni delle classi popolari e alla cosiddetta “questione sociale”. Nei decenni successivi
furono quindi attuate varie riforme elettorali (nel 1882, nel 1912 e nel 1919), con l’intento di
allargare il suffragio e coinvolgere nello Stato strati sociali via via più vasti. Ciò trasformò poco a
poco i caratteri del sistema politico liberal-oligarchico fino ad aprirlo alla democrazia. La riforma
elettorale del 1912 di Giovanni Giolitti (1842-1928), introducendo il suffragio universale (maschile), fu il segno dell’avvenuta trasformazione: l’avvento del cosiddetto “Stato pluriclasse”
(laddove l’Ottocento era stato “monoclasse”) e del regime dei grandi partiti politici, precursori di
quelli che conosciamo oggi.
Nello Stato liberale, infatti, non erano esistiti partiti politici nel senso attuale. Marco Minghetti
(1818-86), esponente politico della “Destra”, così definiva i partiti dei suoi tempi:
un’accolta di uomini aventi voce nella cosa pubblica, i quali concordano nelle massime fondamentali circa
il modo di governare e cooperano tutti insieme affinché siffatto modo e non altro si tenga. Coloro i quali intendono di seguire certi concetti loro comuni e vogliono che si operi ad un medesimo modo nelle parti più
sostanziali del pubblico reggimento, fanno accordo tra loro e, se non espressa, pur vi ha una tacita intesa
che li collega. L’idem sentire de republica [avere la medesima concezione della vita pubblica] è insomma il
fondamento che natura pone al partito politico: ma siccome non tutti possono idem sentire in tutto, indi nasce
la distinzione dei partiti7.
Nello Stato liberale i partiti politici non avevano i caratteri che noi oggi riconosciamo loro: grandi
macchine politiche, con grandi burocrazie, impegnate a cercare consensi e a diffondersi nello
Stato.
La “destra” e la “sinistra” erano semplici aggregazioni parlamentari di deputati che rappresentavano esigenze e presentavano programmi affini, le quali operavano al momento
delle elezioni come “comitati elettorali”, oppure servivano a coordinare il voto dei parlamentari alla Camera dei Deputati.
Non avevano invece dietro di sé alcun apparato, stabile e organizzato, con iscritti e funzionari. Al
più, i deputati, come singoli, avevano i loro “clienti” (da qui trae il nome il clientelismo, fenomeno
anche oggi rigogliosissimo, legato non solo alle singole personalità politiche, ma anche ai partiti
come tali).
7. MINGHETTI, M., I partiti politici e la pubblica amministrazione, 1881, Cap. I.
© Mondadori Education
8
1. Lo Stato liberale nell’Italia del XIX secolo
Qualche volta si manifestò quello che si disse il “partito governativo”. Per vincere le elezioni esso
mobilitava l’apparato del Governo, distribuendo favori, corrompendo e, finanche, truccando i
risultati; ciò avvenne a partire dai governi di Cavour fino a quelli di Giolitti (1842-1928), il cui
largo uso di queste tecniche gli valse l’epiteto di “ministro della malavita”, coniato dallo storico
Gaetano Salvemini (1873-1957). In ciò si manifestava l’aspetto peggiore della politica come
organizzazione partitica: l’uso del potere per il potere. È l’uso che ne viene fatto su larga scala
ancor oggi quando i partiti al governo dispongono di risorse di “sottogoverno”, che impiegano
per orientare i comportamenti elettorali.
Per il resto, però, non vi è vera affinità tra i partiti di allora e quelli attuali. La Camera, in periodo
liberale, era composta di singoli notabili, eletti in quanto tali e non in quanto espressione di organizzazioni politiche solide. Inoltre, essi appartenevano al medesimo strato sociale, quello costituito
dalla borghesia delle professioni e degli affari e dai proprietari terrieri. Nelle questioni di politica
interna, soprattutto economica e sociale, la loro omogeneità era notevole (a differenza che nelle
questioni di politica internazionale ed ecclesiastica e in quelle riguardanti l’unificazione nazionale,
ove si ebbero gli scontri più acuti). L’assenza di vincoli di partito rigidi e la prevalente omogeneità
di posizioni spiegano la fluidità politica all’interno di quella che fu chiamata “camera dei notabili”.
Su questa base si fondò il trasformismo parlamentare, un fenomeno non ancora superato oggi:
il passaggio di singole personalità o gruppi da uno schieramento all’altro, cioè dall’opposizione alla
maggioranza governativa, senza chiare ragioni politiche, ma solo per i vantaggi che la partecipazione spregiudicata al potere rende possibili. Di molti parlamentari si poteva senza troppa difficoltà
comperare l’appoggio: l’uomo politico inglese Robert Walpole (1676-1745) (capo del Governo inglese dal 1721 al 1742) aveva cinicamente affermato di conoscere la tariffa della coscienza di tutti
i deputati. E questo poteva valere anche per molti deputati del Parlamento italiano.
1.7 L’evoluzione dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare
La monarchia costituzionale, come qualunque sistema dualistico, era continuamente esposta al
rischio di dissolversi, qualora fossero sorti contrasti insanabili. Essa esigeva la collaborazione tra
le due parti (il Re e la Camera), ma è chiaro che, in questa collaborazione, la parte politicamente
più influente, perché espressione delle forze sociali più forti, poteva prendere il sopravvento.
È quanto accadde già nelle primissime applicazioni dello Statuto.
La Camera dei Deputati assunse il ruolo decisivo e il Re – pur non rinunciando a influire
su certi settori, quali la politica estera e quella militare, e a gestirli autonomamente – si
adeguò.
I fattori decisivi di questa evoluzione sono stati: a) la configurazione del potere esecutivo come
espressione della maggioranza parlamentare e b) l’estromissione del Re dalla funzione legislativa.
a)Il potere esecutivo e di governo – cioè il potere di impulso e gestione degli affari dello Stato
– era attribuito al Re, il quale – a questo scopo – nominava e revocava i suoi ministri (artt. 3 e
65). Secondo lo Statuto, il Governo (cioè l’insieme dei ministri, ai quali spettava la direzione
dei diversi settori di attività dello Stato) era dunque Governo del Re, non del Parlamento.
Ma già alla metà degli anni Cinquanta del XIX secolo si era consolidata una prassi secondo la quale la nomina e la permanenza in carica dei ministri dipendevano dalla fiducia dei
deputati (mentre la sfiducia comportava le loro dimissioni).
© Mondadori Education
9
Storia costituzionale italiana
Il Governo del Re aveva dunque bisogno dell’accordo della Camera, senza il cui consenso non
avrebbe potuto tradurre in leggi i propri progetti, ottenere l’approvazione del bilancio e quindi il
riconoscimento del potere di esigere tributi e di spendere per realizzare i propri intenti. Una Camera debole e manovrabile si sarebbe ovviamente piegata al volere del Re e del suo Governo,
ma una Camera forte poteva costringere il Re a piegarsi, come avvenne in effetti a partire dalla
formazione della maggioranza cavouriana del “connubio” tra la destra e la sinistra moderate.
La Camera, oltre che organo legislativo, divenne così il centro propulsore della vita politica,
esercitando il controllo sul Governo: in questo consiste essenzialmente il regime parlamentare. I ministri continuarono a essere nominati dal Re, che però li sceglieva tra gli esponenti
della maggioranza, e furono quindi ministri di questa, assai più che del sovrano. Facendo
cadere i ministri (togliendo loro la fiducia) la Camera poteva controllare l’azione del Re stesso,
di cui i ministri erano i necessari collaboratori (tutti gli atti del Re dovevano infatti essere “controfirmati” dai ministri e senza la loro controfirma il Re non poteva far nulla).
Attraverso questa evoluzione in senso parlamentare dello Statuto si riuscì a neutralizzare le
forze reazionarie, che avevano il loro luogo di cospirazione nella corte: esse furono costrette, per contare qualcosa, a entrare in Parlamento, dove si giocavano le partite decisive. Ciò
rafforzò il regime statutario, impedendo mene e cospirazioni oscure da parte di coloro che
auspicavano il ritorno all’Antico regime.
b) La volontà parlamentare non poteva divenire legge se non con il consenso (la “sanzione”) del
Re. In ciò si è individuato un aspetto del Governo misto. Ma anche a questo riguardo, il potere
del Re si sottomise rapidamente a quello della Camera.
Il veto reale cadde in disuso.
Il Re agiva in alleanza con la borghesia liberale moderata: i progetti dell’uno e dell’altra si incontrarono; solo con l’accordo di quella forza, la casa di Savoia poteva aspirare a porre la propria
candidatura come dinastia di tutta la nazione italiana o, meglio, della borghesia moderata di tutta
l’Italia. È chiaro che il Re, se si fosse opposto alle leggi con le quali la borghesia realizzava il proprio
programma liberal-moderato, avrebbe contraddetto il suo stesso progetto e i suoi stessi interessi.
In entrambi i punti ora indicati si verificò un’alterazione molto significativa del sistema
statutario a favore della Camera e della classe sociale che in essa si esprimeva. Questa si
impadronì del Governo così come della legislazione.
Il Re non si ridusse però a coprire un ruolo puramente formale: non fu solo un Re che “regna,
ma non governa”, secondo la formula di Benjamin Constant (1767-1830), il teorico della “restaurazione liberale” in Francia. Non mancò infatti di far sentire il proprio peso quando erano in
gioco interessi vitali dello Stato (si pensi al proclama di Moncalieri, agli interventi moderatori nelle
questioni che contrapponevano lo Stato al Papa, alla politica estera ecc.). Fu quindi una sorta
di potere di riserva, non contro la Camera, ma per supplire alle sue difficoltà di funzionamento e
difendere lo Stato e lo Statuto dagli eccessi delle tendenze radicali.
1.8 Il problema della sovranità nello Stato dell’Ottocento: i rapporti tra il Re e la Camera
rappresentativa
Nello Statuto, come in tutte le carte costituzionali dell’Ottocento, c’era un equivoco, un’ambiguità fondamentale. Era incerta la questione centrale della Costituzione: a chi dovesse attribuirsi
© Mondadori Education
10
1. Lo Stato liberale nell’Italia del XIX secolo
la sovranità, cioè il potere politico “ultimo” o decisivo. Ciò fu oggetto di disputa per un secolo.
Qui di seguito schematizziamo le principali interpretazioni della questione.
a) Il Re, nel momento stesso in cui concedeva “sovranamente” lo Statuto, riaffermava la propria
sovranità. Nel preambolo dello Statuto Carlo Alberto ribadiva il suo titolo di Re “per grazia di Dio”
e sottolineava di agire “prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del suo cuore”, “considerando le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto come un mezzo
il più sicuro di raddoppiare quei vincoli di indissolubile affetto che stringono all’itala … corona un
popolo che tante prove ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore”. Perciò, concludeva il preambolo: “di nostra certa scienza, regia autorità abbiamo ordinato e ordiniamo, in forza di Statuto e
legge fondamentale…”. Se dare una Costituzione è attributo della sovranità, il Re non lasciava
dubbi su chi dovesse considerarsi il sovrano.
b) Lo Statuto, peraltro, attribuiva il potere politico massimo – quello legislativo – ai tre organi di
vertice: la Corona, il Senato, la Camera. Si poteva sostenere che la sovranità, dato lo Statuto e avendo il Re irrimediabilmente perduto il potere di revocarlo, era ormai divisa tra questi
soggetti, ciascuno dei quali doveva rispettare la posizione degli altri. In un certo senso la sovranità, come attributo di un solo organo, elevato al di sopra di tutti gli altri, era stata abolita.
Concependo la società come insieme di gruppi, operanti attraverso i loro organi, la questione
della sovranità diventava (secondo l’immagine adoperata dal primo costituzionalista che studiò lo Statuto albertino, il Melegari, professore nell’Università di Torino dal 1851) analoga al
problema di capire se nel corpo umano il compito essenziale fosse del cervello, del cuore o
dello stomaco, tutti ugualmente necessari alla vita. Era questa l’interpretazione chiusa, statica
e organicistica dello Statuto, propria dei conservatori: “lo Statuto, nulla di più, nulla di meno
dello Statuto”, secondo la famosa formula di Massimo d’Azeglio (1798-1866).
c) La terza interpretazione, quella più aperta alle esigenze delle riforme liberali, fu avanzata da
Cavour due giorni dopo la concessione dello Statuto, in un articolo pubblicato sul giornale “Il
Risorgimento”8. In esso, per respingere le critiche provenienti dalla sinistra liberale, che auspicava riforme politiche più radicali, Cavour sostenne la tesi, divenuta classica e vincente,
secondo la quale il Re era legato allo Statuto dal suo carattere irrevocabile e perpetuo ma,
d’altro canto, al Parlamento e al Re insieme era consentito qualsiasi potere, anche quello di
cambiare lo Statuto attraverso la legge.
Questa concezione sottintendeva una visione contrattuale dello Statuto, come patto tra il
Re e la Nazione: visione politicamente corretta, dal punto di vista dei fatti storici che condussero allo Statuto (anche se non conforme al tipo di concessione dello stesso). Come
ogni patto, anche lo Statuto poteva essere modificato col consenso delle due parti.
Così, da un lato ci si garantiva contro le mene reazionarie, escludendo la revoca unilaterale dello
Statuto; dall’altro si contrastavano le aspirazioni democratiche verso un’assemblea parlamentare
onnipotente, cioè verso un’assemblea “giacobina”9, libera da ogni freno. In sostanza, la concezione cavouriana indicava la via di un equilibrio non statico, ma aperto alle esigenze dell’innovazione
8. CAVOUR, C., Critiche allo Statuto, in “Il Risorgimento”, 10 marzo 1848, n. 63, ora in PISCHEDDA, C., TALAMO, G, (a cura di), Tutti
gli scritti di Camillo Cavour, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1976, vol. III, pp. 1113 ss.
9. “Giacobino” è il potere che, in nome di astratti principi politici, è capace di tutto, compreso il Terrore (come avvenne nel periodo del
governo dei giacobini in Francia).
© Mondadori Education
11
Storia costituzionale italiana
politica; faceva del Parlamento e, in esso (per le ragioni già viste), della Camera dei Deputati il
centro motore della vita costituzionale e del Re il centro moderatore contro i rischi del radicalismo
parlamentare; indicava nelle riforme legislative lo strumento del progresso; preannunciava uno
sviluppo futuro delle istituzioni come evoluzione del Parlamento rappresentativo, luogo di raccolta e confronto delle forze politiche e sociali ammesse alla vita dello Stato, sottratte all’azione
diretta della piazza. Questo intento si andò realizzando man mano che la Camera rappresentativa, all’inizio espressione di una classe ristrettissima, si aprì a una più ampia rappresentanza e
riuscì a “parlamentarizzare” progressivamente le forze sociali. Lo Statuto, per usare una formula
di Francesco Crispi (1818-1901), poteva servire per “impedire ai governi di tornare indietro, non
già per non andare avanti”10.
1.9 Lo Statuto come Costituzione flessibile e il significato dell’onnipotenza della legge
La ripartizione della sovranità tra la rappresentanza parlamentare e il Re significava che il loro
accordo, realizzato nella legge, poteva tutto.
Con una legge si poteva quindi perfino contraddire e modificare lo Statuto. In ciò consisteva la sua flessibilità, carattere comune alle costituzioni dell’Ottocento (che le distingue da
quelle del XX secolo, che, al contrario, sono rigide).
In ciò consisteva anche l’onnipotenza della legge, la quale – come si diceva in Inghilterra – poteva tutto, salvo che trasformare l’uomo in donna.
Lo Stato dell’Ottocento non era lo Stato della supremazia della Costituzione, ma lo Stato
della supremazia della legge. La legge era la fonte del diritto primaria e la sua sottomissione allo Statuto era solo apparente.
Spostando lo sguardo sulla realtà politica e sociale, appare la ragione effettiva della flessibilità
dello Statuto. Tale ragione risiede nel carattere “monoclasse” dello Stato liberale dell’Ottocento, nel quale l’egemonia era detenuta dalla borghesia e le altre componenti sociali erano in declino
(quelle sopravvissute all’Antico regime) o erano escluse (le masse popolari). I gruppi politici dirigenti
(sia la “destra” sia la “sinistra”) erano essenzialmente espressione della borghesia, la quale non aveva
dunque da temere per i propri interessi. Le tendenze democratiche e radicali della borghesia erano
state del resto sconfitte irrimediabilmente all’epoca della crisi del 1849, dopo la disfatta di Novara e
lo scioglimento della Camera seguito al proclama di Moncalieri. In questa situazione, una concezione dello Statuto come Costituzione rigida, cioè immodificabile dalla legge, non avrebbe avuto senso.
D’altro canto, il regime liberale oligarchico era interessato a disporre di tutti gli strumenti legislativi necessari per mantenere l’ordine sociale, potenzialmente minacciato dalle masse popolari,
escluse dalla partecipazione alla vita dello Stato.
Una Costituzione rigida avrebbe impedito la possibilità di limitare i diritti fondamentali, privando così le forze dominanti di uno straordinario strumento di controllo dell’ordine pubblico. La legge poteva quindi comprimere le libertà, poteva addirittura sospendere lo Statuto
in situazioni di emergenza. Ciò avvenne nei numerosi casi di “stato d’assedio” proclamati in
occasione di disordini sociali, quando il potere passò nelle mani delle autorità militari.
10. Camera dei Deputati, seduta del 23 giugno 1881.
© Mondadori Education
12
1. Lo Stato liberale nell’Italia del XIX secolo
Nei casi in cui le tensioni sociali minacciavano la saldezza del potere della borghesia lo Statuto,
per così dire, si ritirava e la libertà di stampa, di riunione e di associazione, la stessa libertà di
sciopero (non proclamata dallo Statuto, ma teoricamente consentita) venivano violate.
La Costituzione flessibile era insomma il riflesso di una società non democratica, in cui esisteva una divisione profonda tra dominanti e dominati, i primi dentro, i secondi fuori dello Stato.
Chi esercitava il dominio non aveva alcun bisogno di garantire la propria libertà né alcun interesse a limitarla. Anzi, poiché le minacce potevano derivare da tensioni prodotte dalla classe sociale
esclusa, occorreva evitare che lo Statuto divenisse un ostacolo per l’azione di autodifesa della
classe dominante: per questo doveva essere interpretato come Costituzione flessibile.
È facile capire, in conclusione, come la secolare vicenda dell’emancipazione delle masse subalterne nel corso dell’Ottocento e nella prima parte del Novecento non si sia richiamata allo
Statuto. In esso non c’era forza liberatrice per gli esclusi; quella era la Carta di un’oligarchia,
non di tutto il popolo. Molto diversa, come si dirà, sarebbe stata la funzione storica della Costituzione democratica repubblicana rispetto alla promozione sociale e politica dei gruppi sociali
più deboli.
1.10 Liberalismo e liberismo, la loro equiparazione, il conflitto di classe e i problemi dello
Stato liberale
Il liberalismo è una dottrina che difende la libertà degli uomini; il liberismo è la dottrina (e
la pratica) della libertà economica dei proprietari (e, correlativamente, dell’astensione dello Stato da misure correttive, redistributive, programmatrici, tali da alterare la libertà del
mercato).
Si tratta dunque di due teorie diverse. La borghesia liberale del XIX secolo le ha invece fatte coincidere; ha per così dire ridotto il liberalismo a liberismo, sostenendo che la libertà tout court si
identifica con la libertà economica e che ogni limitazione di quest’ultima si traduce in violazione
della prima. Così facendo, ha trasformato la libertà di tutti in potere dei proprietari.
L’equiparazione liberalismo-liberismo fu la giustificazione del prevalere degli interessi di pochi su
quelli di molti, il fondamento della miseria di grandi masse popolari, estromesse dalla vita civile
e ridotte all’indigenza dallo sfruttamento di un capitalismo che non ammetteva limiti. Il liberismo
non fu dunque lo strumento della prosperità e, così, della libertà di tutti, ma la causa del “pauperismo” e della “questione sociale” che dalla metà del secolo in poi minacciò la stessa stabilità
del regime politico liberale.
Le parole più chiare contro l’errata identificazione di liberalismo e liberismo vennero proprio
dal maggior filosofo liberale italiano, Benedetto Croce (1866-1952):
Quando i liberisti sostengono che non vi può essere liberalismo senza liberismo economico commettono lo
stesso errore che è proprio dei socialisti di elevare a ideale morale un programma economico di cui si tratta
di valutare di volta in volta l’opportunità politica (che non ha nulla a che vedere con la verità filosofica), e
contribuiscono a screditare l’idea liberale riducendola a principio egoistico, materialistico, utilitaristico, così
giustificando la critica degli avversari.
Mentre il liberalismo è ideale etico, il liberismo è un principio economico che, convertitosi arbitrariamente in
ideale etico, si trasforma nella morale utilitaria. Onde non ci si deve preoccupare se un provvedimento sia più
o meno conforme ai principi del liberismo ma se sia più o meno liberale, se cioè contribuisca a accrescere la
libertà; e non è affatto escluso che in determinati momenti sia più energico promotore di libertà un provvedimento economico ispirato alla dottrina economica (non filosofica) socialista. Proprietà individuale e collettiva
© Mondadori Education
13
Storia costituzionale italiana
non sono beni in sé ma […] da valutare in relazione al contributo che possono dare all’accrescimento dell’unico bene in sé, che è la libertà11.
La pratica economica liberista creò nella società la dicotomia proprietari-proletari, capitalistilavoratori. I primi erano la classe dominante, godevano delle libertà riconosciute dallo Statuto,
operavano nello e attraverso lo Stato (è di Karl Marx la definizione dello Stato ottocentesco come
“comitato esecutivo della borghesia”); i secondi erano la classe subalterna, ridotta a estrema indigenza, esclusa dai diritti e dallo Stato. Ciò fu la causa degli squilibri sociali che continuamente
minacciavano la sopravvivenza dello Stato liberale, che si trovava in una perenne condizione di
emergenza potenziale ed era spesso effettivamente impegnato a difendersi con misure repressive eccezionali (si pensi ai moti sociali tra Ottocento e il primo Novecento).
Il problema politico che l’Ottocento ha lasciato al XX secolo è stato la composizione di quella grande divisione sociale e, insieme, la neutralizzazione delle tensioni distruttrici che ne derivavano.
I tentativi, in Italia, furono compiuti seguendo due direzioni. La prima è quella di un’evoluzione
in senso democratico del regime liberale (la liberal-democrazia), cioè del tentativo di superare le
tensioni attraverso l’avvicinamento delle parti, l’apertura dello Stato a tutte le componenti sociali
e la sua democratizzazione. È quanto si è iniziato a fare, imperfettamente e senza successo,
all’inizio del Novecento, nel periodo giolittiano.
La seconda direzione è stata quella di tipo autoritario, che mirava piuttosto a contenere le tensioni attraverso la repressione o attraverso l’ingabbiamento delle forze sociali in strutture e ruoli
rigidamente fissati. Si tratta della via tentata alla fine dell’Ottocento, con la stretta autoritaria
operata dai governi Crispi, Pelloux ecc. e definita dagli storici il “colpo di Stato della borghesia”
e poi messa in atto sistematicamente nel ventennio del fascismo.
2. La crisi dello Stato liberale
2.1 La decadenza del Parlamento e la degenerazione della vita politica nell’Italia unificata
L’unificazione della penisola avvenne estendendo a tutta l’Italia l’organizzazione costituzionale e
amministrativa del Piemonte. Le idee federaliste di Carlo Cattaneo (1801-69) o di Vincenzo Gioberti (1801-52) e quelle regionalistiche di Minghetti non si erano affermate.
Perciò le istituzioni e le tradizioni pubbliche locali furono soffocate dall’impianto piemontese, fortemente accentrato e livellatore, nemico di ogni autonomismo.
Il Piemonte aveva infatti una struttura centralistica di tipo napoleonico, ciò che costituì la sua
forza in guerra, ma lo rese inadatto al governo della pace.
11. CROCE, B., Liberismo e liberalismo, in “La critica”, 1928, ora in CROCE, B., EINAUDI, L., Liberismo e liberalismo, Ricciardi, Napoli,
1988.
© Mondadori Education
14
2. La crisi dello Stato liberale
Con le strutture amministrative, civili e militari il Piemonte diffuse in tutta Italia la sua burocrazia.
Per poter sottoporre a controllo regioni e popolazioni diversissime tra loro, questa stabilì alleanze
con i notabili locali che erano stati mantenuti al loro posto e che, dal canto loro, collaborarono
con i piemontesi per garantire i loro antichi privilegi contro le classi popolari. Il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo12 esprime questa idea di immutabilità dei rapporti
sociali, pur nel nuovo Stato: occorre che tutto cambi perché tutto resti uguale (occorrono cioè
nuovi padroni affinché i vecchi si possano appoggiare a loro e perpetuare lo stato di cose del
passato). Questo era vero soprattutto nel Mezzogiorno, ancora impregnato di rapporti sociali di
tipo feudale e profondamente refrattario all’influenza delle idee della rivoluzione liberale, cui lo
Statuto malgrado tutto si richiamava.
Questo impasto tra “piemontesismo”, che temeva le novità, e notabilato locale, anch’esso
portato alla conservazione, fu una delle cause della decadenza della vita politica.
Il Parlamento cessò di essere il luogo di espressione delle energie vive del Paese (come era stato
nei primi decenni di vita statutaria) e divenne lo specchio dei suoi vizi. Gli affaristi abbondavano,
il Governo se ne assicurava il consenso e l’appoggio con la corruzione. Le consorterie, spesso
regionali o locali, soppiantarono il libero dibattito politico. Il Governo, burocratico e autoritario,
divenne il padrone della situazione. Il sistema parlamentare si trasformò in un regime dominato dal Governo. Il “partito di Governo” usava l’amministrazione per favorire gli amici e colpire i
nemici, violando l’imparzialità degli uffici pubblici (è quel che oggi si chiama sottogoverno).
Contro questo “Stato morboso” Marco Minghetti, nel saggio I partiti politici e la pubblica amministrazione, denunciò la corruzione che dilagava rapidamente come una lebbra, producendo
questo effetto: che il Governo, invece di essere tutore dei diritti dei cittadini, diventava strumento
per affermare interessi di parte.
Se l’essenza e lo scopo dello Stato sta nel rendere giustizia a ciascheduno, e nel fare il bene di tutti, se le
istituzioni politiche non sono altro che mezzi e garanzie per l’ottenimento di quel fine, chi non vede che la
giustizia di partito e l’amministrazione di partito sono la negazione dello scopo medesimo dello Stato?
Minghetti poneva la questione generale della compatibilità del regime parlamentare, inteso come
governo di partiti, con l’interesse e i fini generali della società e dello Stato. A tale questione,
in seguito – come si vedrà –, la critica antiparlamentare e poi il fascismo dettero una risposta
negativa, cercando così di giustificare l’autoritarismo di fine secolo e, successivamente, la reazione fascista. I parlamentari, dal canto loro, facevano di tutto per giustificare la critica corrosiva
contro il Parlamento. La polemica (e la satira) antiparlamentare (contro la vanità, l’incompetenza,
l’arrivismo, la corruzione, l’inconcludenza dei deputati), in sé non priva di giustificazioni, finì per
indebolire il Parlamento stesso e agevolare l’involuzione autoritaria del sistema.
2.2 L’involuzione autoritaria dello Stato liberale
Le tensioni sociali che si ebbero alla fine dell’Ottocento avrebbero forse potuto essere affrontate democraticamente in un Parlamento davvero rappresentativo di tutti gli strati sociali del
Paese. Così non fu: anche l’allargamento del suffragio che si ebbe nel corso del XIX secolo non
12. TOMASI DI LAMPEDUSA, G., Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano, 2002. Il romanzo uscì nel 1958, un anno dopo la morte di Tomasi
di Lampedusa (1896-1957).
© Mondadori Education
15
Storia costituzionale italiana
arrivò a inserire le masse popolari nel Parlamento e a fare di questo un luogo di decisione accettato da tutti. La responsabilità di mantenere una situazione sociale sempre più esplosiva ricadde
naturalmente sugli apparati del Governo, civili (i prefetti, i ministri degli affari interni, il presidente
del consiglio) e militari (si pensi all’episodio estremo dei cannoni del generale Bava Beccaris che
sparano contro i dimostranti di Milano nel 1898, facendo decine di morti e feriti).
Gli anni della fine dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento videro insomma soppiantato
lo Stato parlamentare da un sistema che faceva perno sull’esecutivo e sui suoi apparati. Il
Governo-potere esecutivo sostituì il Parlamento nel compito di integrare i diversi gruppi,
ceti, classi sociali nell’unità dello Stato.
Questo compito, in Parlamento, si sarebbe svolto democraticamente, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti; l’esecutivo, invece, essendo espressione di gruppi ristretti
– la borghesia e la burocrazia – non poteva che adottare una politica autoritaria e repressiva nei
confronti degli strati popolari. Poiché non si voleva dare voce a questi ultimi democratizzando lo
Stato e il Parlamento, non rimaneva che la politica della mano forte condotta dal Governo.
In questo quadro, profondamente antiparlamentare e orientato a un esecutivo autoritario, si colloca
lo scritto dell’uomo di Stato della destra, Sidney Sonnino (1847-1922), Torniamo allo Statuto13, che
propugnava il ripristino del Governo come diretta espressione della monarchia (la monarchia
costituzionale) e l’emarginazione del Parlamento quali mezzi per fronteggiare la crisi, i disordini
sociali e la disgregazione della vita politica di fine secolo.
Più che di un ritorno allo Statuto, si trattava invece di un’involuzione autoritaria gestita dalle
classi dirigenti liberali, che si dimostravano così disposte a contraddire se stesse (il loro liberalismo) pur di non dover ridimensionare il potere che avevano, aprendosi all’integrazione sociale
attraverso la democrazia.
È significativo – e non si considera mai sufficientemente questo punto – che l’unificazione sociale sia stata poi tentata attraverso un altro strumento tipicamente autoritario, la terribile
“grande guerra” del 1915-18, cercata e voluta dai gruppi dirigenti in alternativa alle politiche
orientate alla democrazia e al progresso sociale. La guerra è stata spesso il mezzo usato da
gruppi oligarchici per chiamare a raccolta tutto il popolo, alimentandone il sentimento nazionale
unitario, evitando così di mettere in discussione le posizioni di potere esistenti, anzi rafforzandole
(la guerra come strumento di politica interna).
2.3 Lo Stato liberale che contraddice se stesso: lo Stato-tutto assorbe i diritti individuali
La seconda parte del XIX secolo non fu l’epoca dei diritti individuali, ma del potere dello Stato. Fu questo il tempo dello Stato-potenza, sia sul piano dei rapporti internazionali sia su quello
della politica interna. Dietro questo Stato vi erano gruppi di dirigenti che avevano bisogno di
ordine interno e di espansione nelle zone del mondo più facilmente assoggettabili agli interessi
delle nazioni industrializzate.
Al colonialismo (dei privati) dei secoli precedenti si sostituisce il ben più potente imperialismo, cioè il colonialismo di Stato.
13. SONNINO, S., Torniamo allo Statuto, in “Nuova antologia”, 1897, 1° gennaio, ora in SONNINO, S., Scritti e discorsi extraparlamentari (1897-1902), Laterza, Roma-Bari, 1972, p. 575 e segg.
© Mondadori Education
16
2. La crisi dello Stato liberale
Questo tipo di Stato si trasforma e si “chiude”: diventa il “tutto” che domina sulle sue parti e chiede
a esse (e se non ottiene, impone) collaborazione nelle sue imprese. È il superamento del concetto
liberale dello Stato, come luogo “aperto” in cui si manifestano le libertà politiche e sociali di tutti.
Lo Stato viene ora assolutizzato, come non era mai accaduto nel periodo liberale, e viene concepito come persona giuridica nella quale si inseriscono, come suoi organi, tutte le articolazioni politiche in cui la società si esprime. Nello Statuto, si è visto, la sovranità era ripartita: lo
Stato-persona giuridica, invece, ora assume su di sé in toto la sovranità; tutto il resto è suo
organo e quindi è subordinato. Nello Stato, poi, per le ragioni dette nel paragrafo antecedente, è
l’esecutivo ad assumere il ruolo di organo dominante; e dietro l’esecutivo vi sono i gruppi oligarchici legati alla borghesia. Così, la borghesia si identifica con lo Stato-tutto e si erge a classe
generale: si proclama unica realtà politica.
Il mutamento di significato dello Stato si manifesta nella corrispondente trasformazione dei
diritti individuali. Essi, secondo la tradizione del costituzionalismo settecentesco, erano concepiti come patrimonio dei singoli che lo Stato doveva riconoscere, poiché erano diritti innati della
persona e precedevano dunque la sua stessa formazione. Il regime autoritario di fine secolo afferma invece che ogni diritto è creato dallo Stato e prima di esso non vi è nulla. Lo Stato assume
così il monopolio del diritto disponendo dei diritti dei singoli: i diritti naturali sono soppiantati
dai diritti creati dallo Stato. I diritti vengono dunque “affievoliti”: valgono fin quando lo Stato,
autolimitandosi, li vuol riconoscere, conformemente ai suoi interessi. Non valgono più quando
essi sono in contrasto con gli interessi dello Stato, che li può allora annullare.
La teoria dei diritti individuali come “autolimitazione” dello Stato è insomma una falsa teoria:
essa non riesce né a nascondere la libertà per lo Stato di negare i diritti tutte le volte che lo
ritenga opportuno, né a fare dei diritti individuali qualcosa di diverso da semplici concessioni.
Sulla base di queste premesse si comprende come lo Stato “liberale” abbia potuto negare libertà
come quelle di riunione, di associazione, di sciopero tutte le volte in cui ciò appariva necessario
agli interessi predominanti, identificati con quelli statali. L’organizzazione politica e sindacale
delle classi popolari – il Partito socialista, le sue organizzazioni di lavoratori, lo strumento dello
sciopero – si scontrò con queste difficoltà.
Prevalenza dell’esecutivo, assolutizzazione dello Stato come organismo onnicomprensivo, affievolimento dei diritti: sono tre elementi di capitale importanza che confluiranno
nella costruzione dello Stato fascista.
I fascisti poterono a buon diritto affermare di essere gli eredi e i perfezionatori di quest’epoca, di
essere i continuatori di una tendenza ben visibile della storia nazionale.
I germi del fascismo sono infatti nelle degenerazioni dello Stato “liberale” unitario: il fascismo
stesso può essere definito come sistematizzazione coerente di tali degenerazioni.
© Mondadori Education
17
Storia costituzionale italiana
3. Il fascismo
3.1 Il crollo dello Stato liberale e l’avvento del fascismo
Il XX secolo pose un problema politico essenziale del quale il regime liberale in Italia non riuscì
a venire a capo.
Le classi popolari si erano organizzate e quindi chiedevano una politica nuova, ponendo
la propria candidatura alla direzione dello Stato. Perciò, esse entrarono inevitabilmente in
conflitto con la vecchia classe dirigente liberale.
Il problema difficile era assorbire questo conflitto, evitando la guerra civile.
Si trattava di compiere il passo decisivo, da un regime oligarchico a uno veramente democratico.
In certi Stati (l’Inghilterra, la Francia) questo passaggio avvenne senza traumi. In altri (l’Italia e la
Germania) il vecchio regime “chiuso” non volle cedere il passo e costrinse la storia della democrazia a un percorso più lungo e drammatico.
Per comprendere le condizioni dell’Italia occorre tenere conto del fatto che il regime liberaloligarchico era andato progressivamente sfaldandosi. Lo Stato si era aperto: sia pure imperfettamente, era in corso un processo di democratizzazione. Le elezioni politiche, ormai a suffragio
universale (maschile), avevano introdotto i partiti popolari in Parlamento. Lo Stato era divenuto, come si dice, “pluriclasse” e le classi avevano interessi contrapposti. Nelle elezioni del
1919 il Partito socialista aveva ottenuto 156 deputati; il Partito popolare di don Luigi Sturzo
(1871-1959), che rappresentava i cattolici rientrati nella vita politica, 100 deputati. Insieme,
erano la maggioranza. Di fronte a queste nuove forze i liberali erano in declino. La vita politica si avviava a diventare lotta tra partiti fortemente organizzati e capaci di mobilitare masse
ingenti di popolazione.
Accanto ai partiti si costituirono i grandi sindacati nazionali, la Confederazione generale dei
lavoratori, di ispirazione socialista, e la Confederazione italiana dei lavoratori, di ispirazione cattolica. A queste si contrapposero le associazioni dei proprietari terrieri (gli “agrari”) e degli imprenditori industriali.
Una società di questo tipo era fortemente conflittuale. Le esigenze di giustizia sociale delle classi subalterne, a lungo compresse dallo sviluppo capitalistico e dalla crisi economica
che seguì alla fine della guerra, determinarono una situazione esplosiva.
Tra il 1919 e il 1920 (il cosiddetto “biennio rosso”) si ebbero occupazioni delle terre da parte dei
braccianti, occupazioni delle fabbriche da parte degli operai, assalti ai negozi da parte delle masse indigenti. Dal canto loro, le forze padronali si organizzarono con squadre di azione pronte a
usare la violenza (la distruzione delle Camere del lavoro, sedi del sindacato socialista, i pestaggi
dei loro iscritti ecc.). Il miraggio o il terrore (secondo i punti di vista) della Rivoluzione bolscevica
in Russia non erano senza echi in Italia. La situazione sociale si tese fino a determinare una sorta
di guerra civile latente, che non poteva consentire il funzionamento dello Stato.
Su tutto dominava una grande incertezza, mentre nessuna forza di governo riusciva ad affermarsi per stabilire un ordine accettabile. Giolitti tentò di creare un’alleanza politica con la partecipazione dei partiti popolari e di dare così allo Stato una maggiore stabilità. Questo tentativo
© Mondadori Education
18
3. Il fascismo
fallì di fronte all’indisponibilità dei socialisti a entrare in governi “borghesi” e alle divisioni e alle
incertezze del mondo cattolico.
L’estremo tentativo di Giolitti di creare un blocco nazionale di centro, che mettesse ai margini le
frange estremistiche, fallì nelle elezioni del 1921. Anzi, queste elezioni portarono alla Camera
per la prima volta 35 deputati fascisti, accolti dai liberali nelle loro file.
Su questo germe iniziale puntarono vecchi borghesi che non si erano rassegnati alla democrazia.
Essi accettarono una forza, il fascismo, che si presentava come restauratrice dell’ordine e dello
Stato, anche se profondamente ostile alla più vera tradizione liberale.
Alla fine la borghesia, che aveva inizialmente pensato di usare il fascismo solo per sconfiggere il socialismo, fu costretta dal primo ad abdicare in suo favore.
Lo Stato era debole e il suo crollo fu possibile perché la democrazia si era fatta strada nella vita
politica, ma non nella vita sociale. La società era segnata da enormi disuguaglianze di condizioni
economiche, di potere effettivo, di modi di vita. La democrazia politica non si accompagnava
alla democrazia sociale. Nessun regime democratico può sopravvivere quando manca la democrazia sociale: le tensioni nella società risultano enormi e i gruppi più forti, alla prima occasione,
sono indotti a liberarsi, con un colpo di Stato, della democrazia politica e delle esigenze delle
classi subalterne, per ristabilire un ordine a loro stessi favorevole. Il fascismo si affermò per questo. Appresa questa lezione, la vigente Costituzione si è preoccupata di fondare lo Stato democratico su una democrazia sociale, come si dirà in seguito.
3.2 La concezione organica della società e dello Stato
La filosofia politica liberale aveva fondato la società e lo Stato sui diritti dei singoli individui. Al
contrario, il fascismo considerò l’individualismo la causa prima della disgregazione sociale. Il suo
compito di restaurazione si attuò perciò attraverso il rovesciamento dei principi liberali: i diritti
dei cittadini vennero sostituiti dai doveri, la libertà dalla soggezione allo Stato. Fu la (ennesima)
rinascita dell’organicismo sociale. Queste parole del teorico fascista Alfredo Rocco (1875-1935)
sono molto chiare:
La società, per il fascismo, non è la somma degli individui che la compongono in un dato momento. È qualcosa di più e di distinto. È la serie infinita delle generazioni, passate, presenti e future che ne fanno parte.
Conseguentemente, essa ha dei fini e una vita che trascendono i fini e la vita degli individui. Gli individui non
sono che gli elementi infimi e passeggeri della società: essi nascono, crescono, muoiono, sono sostituiti da
altri, mentre la società, attraverso i tempi, resta sempre identica a se stessa. L’individuo non può, perciò, secondo la concezione fascista, essere considerato come il fine della società, essendone solo il mezzo.
La società ha dei fini propri, storici, di conservazione, di espansione, di perfezionamento, che sono totalmente distinti dai fini degli individui e che possono eventualmente giungere perfino a contraddire gli obiettivi degli
individui. Per la realizzazione di questi fini che le sono propri, la società deve utilizzare gli individui come mezzi
e tutta la vita sociale consiste nel fare dell’individuo lo strumento dei suoi fini. Da ciò la conseguenza che, per
il fascismo, il problema fondamentale non è quello della difesa dei diritti degli individui o delle classi sociali,
ma solo il problema di garantire il diritto dello Stato, al quale corrisponde il dovere dell’individuo14.
Qui è riassunto tutto il programma del fascismo, dominato da un’idea ricorrente, quella dell’unità
da realizzarsi in uno Stato che assorba in sé tutta la società, cioè l’idea di uno Stato totalitario.
14. ROCCO, A., La crise de l’Etat En Italie: la solution fasciste, in «Reveu des vivants» luglio 1927.
© Mondadori Education
19
Storia costituzionale italiana
3.3 Il totalitarismo fascista
Stato totalitario non è sinonimo di Stato autoritario. I regimi autoritari riconoscono l’esistenza di
una vita privata dei singoli, anche se sono disposti a violarla quando ciò serva ai loro scopi.
I regimi totalitari negano invece quella vita privata e proclamano che nulla nell’esistenza
degli individui riguarda solo loro stessi, ma che tutto riguarda tutti e che lo Stato ha perciò
il diritto e il dovere di immischiarsi in ogni momento nella vita di ciascuno.
Secondo un motto di Mussolini: “Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo
Stato”. Commentando questa formula, Norberto Bobbio scrive che essa può considerarsi come
la sintesi dottrinale dello Stato totalitario, cioè dello Stato che afferma la politicizzazione integrale della vita
dell’uomo, la riduzione dell’individuo a ingranaggio della macchina del potere statale. Tutto ciò che sarà poi
chiamato ‘dottrina del fascismo’ sarà una serie di variazioni, piuttosto monotone, sul tema dello Stato-potenza, dello Stato-tutto, dello Stato superiore agli individui15.
Il diritto privato, conquista della rivoluzione liberale, cede il passo all’espansione del diritto pubblico, che esprime la supremazia dello Stato rispetto ai singoli. I diritti individuali di libertà cessano di esistere e si trasformano nel loro contrario, in obblighi di agire nell’interesse dello Stato. È
la paradossale concezione hegeliana della libertà come diritto di fare il proprio dovere.
Così, per esempio, il diritto di riunione non viene eliminato nel senso che non si fanno più riunioni. Viene invece trasformato nel dovere di prendere parte alle manifestazioni organizzate dal
regime. Sono anch’esse riunioni, ma nell’interesse non di chi vi partecipa, bensì del regime che
le organizza come mezzi di mobilitazione. Il diritto di pubblicare giornali viene eliminato non nel
senso che non si pubblicano più giornali, bensì nel senso che ciò che si scrive deve essere finalizzato all’interesse dello Stato e si trasforma così da informazione in propaganda.
Anche le manifestazioni della vita che siamo abituati a considerare riservate alla sfera privata
degli individui vengono piegate ai fini dello Stato. Per esempio, il matrimonio e la procreazione
divengono questioni di Stato, concernenti la sua politica demografica. Le manifestazioni scientifiche, artistiche e culturali sono soggette a promozione o repressione da parte dello Stato a seconda che giovino o nuocciano al regime. Per esempio, le opere di Albert Einstein (1879-1955),
volgarizzato come il teorico del “relativismo” contrario alle certezze del regime fascista, furono
proibite dal Ministero della Cultura Popolare, un ministero che nessun regime liberale potrebbe
nemmeno concepire. Uno degli elementi che caratterizzano i sistemi democratici e liberi, ed è
invece del tutto assente nei regimi totalitari, è infatti il diritto di ogni cittadino ad accedere alle
fonti di informazione disponibili e a ricevere dai vari mezzi di comunicazione informazioni non
manipolate né selezionate dalle autorità; e benché anche nella democrazia ci siano limiti all’esercizio di tale diritto, essi vengono posti non per proteggere l’interesse pubblico, ma altri diritti
delle persone, come il diritto alla privacy.
Nel regime fascista, al contrario, lo Stato entrò dappertutto, diventando appunto totale. Per svolgere i suoi compiti sviluppò un imponente sistema di interventi (autorizzazioni, controlli, censure
ecc.) che ingabbiavano la società. Questori, prefetti, ministri, gerarchi dei più diversi tipi stesero
una rete burocratica che privò il Paese delle sue energie creative.
15. BOBBIO, N., in AA.VV., Tent’anni di storia italiana (1915-1945), Einaudi, Torino, 1975, p. 160.
© Mondadori Education
20
3. Il fascismo
Completamento di questa concezione totalitaria fu la distruzione della morale individuale e la
sua sostituzione con l’etica statale. Lo Stato etico – escogitazione, a uso del fascismo, del
filosofo Giovanni Gentile (1875-1944), tratta dalla filosofia dello Stato di Hegel – è lo Stato che
ha la sua morale, che è anzi unica vita morale e che richiede perciò ai singoli individui immedesimazione e partecipazione totali. L’unica morale individuale che il fascismo è quindi disposto a
riconoscere è quella che esige l’adesione incondizionata allo Stato e l’annullamento del singolo
dinanzi a esso: l’obiezione di coscienza di fronte agli ordini, anche i più insensati e immorali dello
Stato, diventa così inammissibile. La “restaurazione dello Stato” che il fascismo aveva intrapreso
avveniva attraverso l’annientamento della società civile e delle sue forze interiori.
Quanto si è ora esposto corrispondeva alle aspirazioni del regime, ma non fu completamente
realizzato. C’erano enormi difficoltà a mettere in atto un piano di così capillare intromissione nella
società. Scarseggiavano gli strumenti tecnici per un simile controllo sociale di massa (strumenti
come l’informatica, i mass media, allora ai loro primi passi). Ma, soprattutto, il fascismo non riuscì a piegare la religione ai propri fini. Il totalitarismo dovette accettare un limitato pluralismo
in questo caso, data l’esistenza in Italia della potente organizzazione della Chiesa cattolica, con
la quale venne a patti.
3.4 Il fascismo e la Chiesa cattolica
Il fascismo non riuscì a fare della Chiesa cattolica la Chiesa di Stato, cioè uno strumento di potere alle sue dipendenze, come la sua tendenza totalitaria avrebbe richiesto.
Il Concordato del Laterano del 1929 fu il segno tangibile della necessità di “venire a patti”
con la Chiesa: fu un accordo paritario tra Stato e Chiesa, qualcosa che ripugnava a una
ideologia totalitaria che non poteva ammettere l’esistenza di organizzazioni indipendenti
dallo Stato.
Ciononostante, il Concordato fu un grande successo del fascismo perché chiuse la questione romana, iniziata in epoca risorgimentale. Con esso il fascismo si assicurò l’appoggio della
Chiesa ufficiale in cambio di un sistema di privilegi: l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole di Stato, il valore civile del matrimonio religioso, il trattamento tributario di favore per i beni
della Chiesa, il finanziamento dei parroci da parte dello Stato (in quanto suoi funzionari) ecc. La
religione cattolica fu riconfermata come religione di Stato, come cemento morale del nuovo regime, e per questo ne divenne obbligatorio l’insegnamento, come “fondamento e coronamento”
dell’istruzione scolastica. Le altre religioni furono invece sottoposte a misure restrittive, essendo
sospettate di antifascismo. Dal canto suo, lo Stato vedeva riconosciuto un potere di ingerenza
negli affari della Chiesa, soprattutto attraverso l’approvazione della nomina dei vescovi da parte
del Governo.
Si determinò così una commistione tra Stato e Chiesa (tra Cesare e Dio) che legò il cattolicesimo
italiano ufficiale alla politica del fascismo. Casi di antifascismo tra i cattolici vi furono, e furono
numerosi, non però sul piano ufficiale delle gerarchie ecclesiastiche, ma tra i laici dell’Azione
cattolica e tra singoli sacerdoti che temevano l’influenza dei privilegi materiali sull’indipendenza
spirituale della Chiesa.
Il fascismo, se non poté avere una sua religione, si assicurò almeno la benevolenza o la non opposizione di quella cattolica. Non era tutto per un regime che aveva aspirazioni totalitarie, ma era
già molto rispetto all’ostilità che la Chiesa aveva nutrito contro lo Stato risorgimentale.
© Mondadori Education
21
Storia costituzionale italiana
3.5 Il corporativismo fascista
Il fascismo proclamava il superamento delle due grandi dottrine sociali ed economiche
dell’Ottocento:
a) l’individualismo liberale della borghesia capitalistica, che sottoponeva a sé il proletariato
attraverso la proprietà privata dei mezzi di produzione;
b) il collettivismo socialista, che era il progetto del proletariato per eliminare lo sfruttamento
capitalistico e abolire la divisione della società in classi, attraverso la socializzazione dei mezzi
di produzione.
Il fascismo era convinto di avere scoperto la terza via che avrebbe potuto mettere tutti d’accordo, in nome di un superiore interesse economico dello Stato. Qual era per il fascismo il torto dei
capitalisti e dei proletari? Era, in entrambi i casi, quello di porsi al di sopra di tutto e volere perciò
sottomettere o eliminare l’altra parte. Ma sopra tutte le parti della società, per il fascismo, c’erano la nazione e lo Stato fascista, che non erano né borghesia, né proletariato, ma una totalità.
Occorreva perciò che i proprietari e i lavoratori collaborassero tra loro, nel superiore interesse
dello Stato.
La Carta del lavoro del 1927 (il “manifesto” delle dottrine economiche del fascismo) proclamava
così la sua ispirazione: “la nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono; è un’entità morale, politica
ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista”.
Questa collaborazione, se non può essere spontanea, può e deve essere imposta dallo Stato
stesso. Qui c’è la differenza essenziale rispetto al corporativismo cattolico, così come è elaborato nell’enciclica Rerum novarum del papa Leone XIII.
La dottrina sociale della Chiesa predica la collaborazione spontanea tra le classi, come
dovere di solidarietà: è quindi un corporativismo senza autoritarismo di Stato, che si
basa sulla fratellanza degli uomini in Cristo. Il fascismo ha una visione molto più realistica e cruda dei rapporti sociali e ritiene, perciò, che questi non possano essere affidati
alla spontaneità e allo spirito di solidarietà, ma debbano essere imposti dall’azione dello
Stato.
Il corporativismo fascista può dunque definirsi come la dottrina volta a mantenere la divisione
della società in classi e a imporre la loro collaborazione a favore di un terzo: lo Stato, titolare del
superiore interesse alla produzione nazionale.
Lo Stato diventa così il soggetto economico essenziale: le classi sociali operano come semplici
strumenti dell’economia di Stato. Questo è un punto importante da sottolineare, perché segna un
distacco dal ruolo che in passato si attribuiva allo Stato. Quando le classi sociali si dimostrano
ìmpari al loro compito, lo Stato può (e deve) intervenire direttamente e farsi Stato-imprenditore.
La Carta del lavoro dice nella tesi IX: “l’intervento dello Stato nella produzione economica ha
luogo [...] quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata o quando siano in gioco interessi
politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell’incoraggiamento e
della gestione diretta”.
Questi principi trovarono la loro prima applicazione in occasione delle conseguenze della grande crisi economica del 1929. Lo Stato rilevò numerose imprese e banche private che rischiavano il fallimento, acquistandone il capitale e facendole gestire da un ente pubblico apposito,
l’Iri (Istituto per la ricostruzione industriale, creato nel 1933). Da allora, anche dopo la caduta
© Mondadori Education
22
3. Il fascismo
del fascismo, l’intervento dello Stato nell’economia si è esteso. Ma esso, da strumento dello
Stato totalitario, si è trasformato in mezzo di politiche pubbliche rivolte a correggere le ingiustizie del mercato. Solo di recente, con la politica delle “privatizzazioni” (avviata negli anni Ottanta del secolo scorso), si è cercato di invertire questa tendenza a favore del libero mercato
e lo Stato ha cessato di svolgere la propria attività in settori nei quali era marginale e il suo
intervento era poco efficace.
Riguardo ai rapporti tra imprenditori, lavoratori e Stato, la Carta del lavoro stabiliva i seguenti
principi:
a) il lavoro è un dovere sociale. Gli obiettivi del lavoro sono unitari e si riassumono nel benessere dei produttori e nello sviluppo della potenza nazionale;
b) i sindacati sono sottoposti al controllo dello Stato (sono i sindacati fascisti, che soppiantano la libertà di quelli socialisti e cattolici). Vi sono, per i diversi settori, sindacati dei lavoratori
e dei datori di lavoro. I contratti stipulati tra loro sono obbligatori per tutti i lavoratori e i datori
di lavoro del settore. Sono i cosiddetti contratti erga omnes, cioè validi per tutti, anche per i
non iscritti ai sindacati, purché appartenenti ai diversi settori (per esempio, metalmeccanico,
tessile, chimico ecc.) cui il contratto si riferisce.
I sindacati delle due parti (lavoratori e datori di lavoro) sono organizzati insieme nelle corporazioni, organi dello Stato dipendenti dal Ministro delle corporazioni. Le differenze di
interesse tra lavoratori e datori di lavoro vengono conciliate dalla corporazione e, in ultima
istanza, dal ministro. La lotta di classe, conseguentemente, è proibita.
In questo contesto, che non conosce più la libertà sindacale, viene naturalmente soppresso
anche lo sciopero. Esso diventa un delitto contro la produzione nazionale, punito con pene severe dal codice penale (la stessa cosa avviene anche riguardo alla serrata, cioè la chiusura degli
impianti a opera degli imprenditori). Il massimo strumento di emancipazione della classe operaia,
attraverso il quale essa era riuscita a migliorare le proprie condizioni economiche e sociali, veniva così eliminato.
Per la dottrina fascista lo sciopero non aveva più ragion d’essere. La parità tra le classi sociali e
la giustizia nei rapporti di lavoro dovevano essere assicurate dallo Stato attraverso le corporazioni. Esse avrebbero dovuto impedire ogni sopraffazione di una classe sull’altra.
Non fu così. La pacificazione delle relazioni sindacali imposta dallo Stato fu, in realtà, una misura
che risultò vantaggiosa per una sola parte. Il sistema corporativo chiuse gli anni delle tensioni sociali che avevano preceduto l’avvento del fascismo e portò l’ordine nelle fabbriche. Ma,
soprattutto, cristallizzò i rapporti tra le classi, rapporti che non erano certo favorevoli a quella
lavoratrice.
Infine, il gran parlare dello Stato che il fascismo faceva dappertutto, anche in campo economico,
che cosa nascondeva? Che cosa era o, meglio, chi era lo Stato fascista? Di chi era l’interesse
che lo Stato aveva per la produzione? Lo Stato era la rappresentazione della nazione nel suo insieme: questa era la risposta ufficiale. Ma chi davvero agiva in quello Stato? Quali erano le forze
effettive che avevano portato il fascismo al potere e lo avrebbero sorretto negli anni seguenti?
Queste sono domande da rivolgere alla storia generale (e al corso relativo). Qui, per ritornare al
nostro tema, basti dire che quelle forze non furono certo le classi lavoratrici. Esse furono non le
protagoniste, ma le vittime della cosiddetta “rivoluzione fascista” (o, come si dovrebbe dire, della
“controrivoluzione fascista”).
© Mondadori Education
23
Storia costituzionale italiana
3.6 Il fascismo come regime a partito unico e lo svuotamento dello Statuto albertino
La libera competizione tra ideologie e interessi diversi era stata la caratteristica del sistema liberale democratico. Le elezioni e la pluralità dei partiti erano state il segno più evidente di quella
libertà. Il fascismo sostituì a tutto ciò un regime a partito unico, il Partito nazionale fascista
(PNF). Esso costituì dapprima lo strumento con il quale il movimento fascista si inserì nello Stato
e poi lo strumento di assoggettamento dello Stato stesso. Per poter assumere cariche pubbliche di qualsiasi genere era necessario appartenere al Partito fascista e, quindi, accettarne la
disciplina e le gerarchie. L’espulsione dal partito comportava la decadenza da esse: questa era
la conseguenza del predominio del partito sullo Stato, poiché si era funzionari dello Stato solo
se il partito lo consentiva.
Il PNF non era un’organizzazione democratica che esprimesse, dal basso verso l’alto, la volontà
degli iscritti. Era piuttosto uno strumento di mobilitazione (non di partecipazione) guidato dal
Duce, capo del fascismo. Il rapporto tra il duce e le masse era un rapporto personale, plebiscitario e di immedesimazione irrazionale. Il Duce si considerava “rappresentativo” del fascismo e
della nazione in quanto da un lato ne esprimeva gli umori e dall’altro li determinava in un rapporto
diretto di tipo demagogico (i riti di massa, la propaganda ecc.). Il partito serviva a questa immedesimazione ed era alle dirette dipendenze del Duce. Esso era quindi uno strumento antidemocratico: “gli ordinamenti e le gerarchie, senza le quali non può esservi disciplina di sforzi ed
educazione di popolo, ricevono luce e norma dall’alto, dove è la visione completa degli attributi
e dei compiti, delle funzioni e dei meriti” (dallo Statuto del Pnf del 1926). C’è qui il rovesciamento
dei principi liberal-democratici: potere dall’alto invece che dal basso; rapporti sociali fondati,
invece che sull’uguaglianza, sulla disuguaglianza di gerarchi e gregari.
Il PNF costituiva una struttura parallela a quella dello Stato prevista dallo Statuto albertino. In
un primo tempo vi fu coesistenza, poi il fascismo si sovrappose allo Stato, senza però mai giungere all’abolizione dello Statuto. Le strutture tradizionali (il Re, il Parlamento, la Magistratura)
non furono soppresse, ma furono svuotate come gusci, oppure riempite da uomini del fascismo.
Così, il regime si creò un proprio corpo armato, la Milizia, che si affiancò alle forze armate tradizionali; una propria polizia, con compiti di repressione delle opposizioni politiche (l’Ovra); un proprio alto consesso (il Gran Consiglio del fascismo), comprendente i più alti gerarchi; una propria
Magistratura composta di fascisti (il Tribunale speciale per la difesa dello Stato), che giudicava i
reati politici e poteva infliggere la pena di morte agli oppositori. La Camera dei Deputati fu dapprima mantenuta, ma, poiché il voto poteva essere dato soltanto a una lista unica di candidati
formata da soli fascisti, perse ogni significato e peso politico. Alla fine fu sostituita dalla Camera
dei fasci e delle corporazioni, comprendente uomini del regime, tratti dal partito. Il Senato, dal
canto suo, comprendeva anche alcuni antifascisti, ma aveva già da tempo perso importanza.
Il Re aveva acconsentito all’avvento dei fascisti al potere, in particolare nominando Benito Mussolini (1883-1945) capo del Governo nel 1922, e, comunque, non avrebbe avuto la forza, da solo,
di controbilanciare il regime fascista, capillarmente diffuso nella società italiana.
Il massimo organo del regime – una volta svuotati tutti gli altri – risultò essere il Governo,
a capo del quale stava il capo stesso del fascismo, cioè Mussolini. Nella sua persona si
identificavano Stato e partito e lo Stato diveniva il mezzo con il quale egli perseguiva i
propri scopi.
© Mondadori Education
24
3. Il fascismo
Chi non era nel partito non era, perciò, nemmeno nello Stato, diventava un cittadino di seconda
categoria. Lo Stato non era di tutti, ma solo dei fascisti. Questo era il regime di partito, oppressivo per coloro che non ne erano iscritti.
3.7 Il nazionalismo fascista
L’ossessione fascista per l’unità (nell’economia, nella politica, nella cultura ecc.) doveva necessariamente sfociare nel nazionalismo. Il mito nazionalista fu una delle idee-forza del regime (che
spiega la retorica patriottica, l’esaltazione acritica della storia e della civiltà dell’antica Roma).
Il principio di identità nazionale, che era stato una delle parole d’ordine del Risorgimento
e della politica d’unificazione nazionale, si trasformò nell’idea di appartenenza esclusiva
e totale a una comunità di vita. Lo Stato fascista fu visto come l’organizzazione di tale
comunità nazionale.
Sta qui il principio dell’intolleranza verso tutto ciò che è antinazionale e, per ciò stesso, pericoloso per l’unità: contro coloro che non si integrano nella società nazionale, coloro che appartengono a culture, lingue, tradizioni, gruppi etnici diversi da quelli dominanti. La “giustificazione” della
discriminazione delle minoranze, fino alla persecuzione degli ebrei con le leggi razziali del 1938
e alla collaborazione con i nazisti al loro sterminio, sta in questa nozione “chiusa” di nazione.
Sul piano internazionale, il nazionalismo comportava un atteggiamento di ostilità verso le nazioni
“diverse” e apriva la via alla politica imperialistica di espansione coloniale, nella quale si univano
volontà di potenza e disprezzo razzista degli altri popoli. La guerra, insomma, fu un ingrediente
essenziale del nazionalismo fascista.
Sul piano culturale, la conseguenza fu la chiusura provinciale nei confronti di ciò che si pretendeva essere genuinamente nazionale, contro le culture diverse e prima di tutto contro quelle
cosmopolitiche, che si rivolgono all’umanità come tale piuttosto che alle singole nazioni. In questo stato di cose tutto ciò che era straniero non era considerato semplicemente estraneo alla
nazione, ma potenziale fonte di pericolo.
Si può dire, insomma, che il nazionalismo fu il coronamento ideologico della società chiusa
voluta dal fascismo. Per questo fu sistematicamente propagandato dal regime ed entrò a far
parte del modo quotidiano di pensare della gente. Ancora oggi, nelle più diverse circostanze,
si vedono gli effetti residui di questa che è la più ottusa delle passioni, in pieno contrasto con
l’ispirazione della Costituzione vigente.
© Mondadori Education
25
Storia costituzionale italiana
4. La rinascita della democrazia in Italia e la Costituzione
4.1 L’Assemblea costituente e il referendum istituzionale
La caduta del fascismo fu l’inizio di una nuova fase della nostra storia, la democrazia.
I primi anni del secolo avevano visto affacciarsi la democrazia politica nello Stato liberale,
ma non avevano conosciuto una democrazia sociale. Caduto il fascismo, si trattava di gettare le basi di una democrazia più solida e profonda di quella già conosciuta. Questo fu il
compito dell’Assemblea costituente.
Dopo la caduta del fascismo (25 luglio 1943) e il ripristino di un clima di libertà politica (nei limiti
che la situazione bellica consentiva), si determinò un contrasto riguardo al modo di giungere a
quel rinnovamento della vita collettiva che appariva necessario a tutti. Da un lato, le forze moderate che facevano capo al Re operavano per ripristinare lo Statuto albertino e i suoi organi e
per affidare a essi le trasformazioni che la fine del fascismo e la sconfitta nella guerra rendevano
necessarie. Dall’altro lato, le principali forze politiche antifasciste, riunite a partire dall’8 settembre 1943 nei Comitati di liberazione nazionale (CLN), esprimevano una molto più radicale
esigenza di rifondazione dello Stato, che rompesse non solo col fascismo (come era ovvio), ma
anche con il regime liberale anteriore, accusato, per così dire, di averlo tenuto a battesimo. A
questo fine si imponeva la necessità di convocare un organo totalmente nuovo, straordinario,
non previsto dallo Statuto. Tale organo era un’assemblea democraticamente eletta da tutti gli
italiani e dotata di pieni poteri in materia costituzionale.
Il contrasto fu superato nel giugno 1944 attraverso un accordo, detto “tregua istituzionale”,
resosi necessario per concentrare gli sforzi nella lotta contro gli occupanti tedeschi e il regime
fascista della Repubblica di Salò. L’accordo riguardava questi due punti:
1) la rinuncia del Re Vittorio Emanuele III all’esercizio di tutti i suoi poteri, affidati al figlio Umberto
II, col titolo provvisorio di luogotenente del regno, fino al momento della scelta definitiva tra
monarchia e repubblica;
2) la convocazione di un’Assemblea costituente, non appena la guerra fosse terminata con la
liberazione dell’intero territorio nazionale.
L’accordo era un rinvio dei principali problemi, ma stabiliva due principi fondamentali: il congelamento della monarchia, che successivamente avrebbe potuto essere confermata o rifiutata, ma
alla quale, per il momento, veniva impedito di operare nel pieno delle sue funzioni; la decisione
costituente, che chiamava il popolo italiano, per la prima volta nella sua storia, a pronunciarsi
democraticamente sui massimi problemi della vita politica e sociale.
In seguito l’Assemblea costituente venne privata del potere di risolvere la questione istituzionale. La scelta tra monarchia e repubblica fu affidata a un referendum popolare, per dare
una possibilità in più alla monarchia. Infatti, la sua sorte sarebbe stata segnata fin dall’inizio
in un’Assemblea costituente nella quale la grande maggioranza dei partiti era di orientamento
repubblicano.
Il 2 giugno 1946 gli elettori si espressero contemporaneamente sulla questione istituzionale
e sull’elezione dei deputati dell’Assemblea costituente. Il sistema elettorale era, per la prima
volta, interamente democratico, poiché il diritto di voto era stato riconosciuto a tutti i cittadini
© Mondadori Education
26
4. La rinascita della democrazia in Italia e la Costituzione
maggiorenni, uomini e donne. La scelta repubblicana prevalse di poco su quella monarchica
(12.717.923 voti contro 10.719.284) e il risultato non sarebbe cambiato nemmeno se le schede
nulle o bianche (circa 1.500.000) fossero state contate a favore della monarchia, in quanto voti
che non esprimevano una volontà di cambiamento (questa era la tesi dei monarchici).
Fu una decisione di grande importanza: non si trattava solo di scegliere se avere un Re o un
Presidente della Repubblica al vertice dello Stato. Era in gioco la continuità col regime precedente. Il popolo italiano scelse la rottura, cioè un regime integralmente nuovo, attraverso l’abolizione della monarchia, il segno più visibile e rappresentativo della continuità. Il Re si allontanò
dall’Italia e l’Assemblea costituente si accinse alla propria opera con il campo sgombro dalla
“questione istituzionale”, in un’atmosfera più serena e con un’indicazione del popolo italiano a
favore di una profonda trasformazione costituzionale.
L’Assemblea costituente fu eletta dai cittadini votando liste di candidati predisposte dai partiti,
secondo un sistema elettorale proporzionale (un sistema cioè che dà a ogni partito un numero
di eletti proporzionale al numero di voti ottenuti). Ciò consentì di verificare la misura del consenso che ciascun partito politico riscuoteva nel Paese (in precedenza, nei CLN, i partiti erano
rappresentati pariteticamente, poiché fino a una verifica elettorale non era possibile constatare la forza rispettiva). L’Assemblea costituente era dunque un’assemblea di partiti, come
si addiceva ormai a una democrazia di massa, in cui non vi era più spazio per i notabili del
periodo liberale. Qui si vede l’origine del carattere partitico della nuova Costituzione (da non
confondere con la “partitocrazia”, che è la degenerazione della democrazia dei partiti).
Il quadro che si delineò fu questo: la Democrazia cristiana (DC) (con il 35,1% dei voti e 207
seggi) era la maggior forza politica. Ma il Partito comunista italiano (PCI) (con il 18,9% dei
voti e 104 seggi) e il Partito socialista italiano (PSI) (con il 20,7% dei voti e 115 seggi), uniti
da un “patto di unità d’azione”, costituivano il polo di sinistra, a sua volta maggioritario.
Questi partiti erano i tre grandi della politica italiana. Le forze liberali erano rappresentate,
ma non in misura altrettanto consistente, a dimostrazione del fatto che la loro egemonia, su
cui lo Stato unitario era stato edificato, era ormai tramontata. Il Partito liberale italiano (PLI)
era rappresentato da 41 deputati (6,8% dei voti) e i partiti di ideologia liberal-democratica (il
Partito repubblicano italiano, PRI, con 23 seggi e il 4,4% dei voti; il Partito d’azione, PdA, con
7 seggi e l’1,5% dei voti) non andavano al di là di modesti risultati. Esisteva poi, oltre ad altri
raggruppamenti trascurabili, la formazione dell’Uomo qualunque (UQ: 30 seggi e il 5,3% dei
voti), che si richiamava più o meno espressamente al regime anteriore e rifiutava la politica, i
partiti e la democrazia, secondo un atteggiamento che da allora si chiamò qualunquismo. I voti
dell’Uomo qualunque confluirono poi, nel 1948, nel Movimento sociale italiano (MSI), un partito
fondato nel dicembre 1946 da esponenti della classe politica fascista reduci della Repubblica
Sociale Italiana.
Questo era il quadro politico della nuova Italia: due formazioni maggiori, la Democrazia
cristiana da un lato e i Partiti comunista e socialista dall’altro, si fronteggiavano; le forze
“laiche” liberali, con un ruolo complementare, erano incapaci di una politica autonoma, ma
in condizione di influenzare la politica degli altri.
Tra queste forze maggiori fu stipulato il patto che dette luogo alla Costituzione o, come si disse
fin da allora, il compromesso costituzionale.
© Mondadori Education
27
Storia costituzionale italiana
4.2 La Costituzione come compromesso
Il compromesso da cui nacque la Costituzione fu messo in luce già durante i lavori dell’Assemblea costituente. Piero Calamandrei (1889-1956), uomo di grande prestigio del Partito d’azione,
parlò di “compromesso tripartito” (tra DC, PSI e PCI). Soprattutto gli esponenti della tradizione liberale vedevano in ciò un segno di confusione e debolezza della nuova Costituzione. Essi
auspicavano una Costituzione più semplice, lineare e univoca, ciò che però la composizione
dell’Assemblea costituente rendeva impossibile.
Ma contro questa interpretazione negativa del compromesso costituzionale se ne avanzò un’altra, di segno positivo. Palmiro Togliatti (1893-1964), allora segretario del PCI, osservò:
Che cos’è un compromesso? I colleghi che si sono serviti di questa espressione probabilmente l’hanno fatto
dando ad essa un senso deteriore. Meglio sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare a un’unità, cioè di
individuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse, un terreno comune che fosse abbastanza solido perché si potesse costruire sopra di esso una
Costituzione, cioè un regime nuovo, uno Stato nuovo abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli
che possono essere gli accordi politici contingenti dei singoli partiti.
Se questa confluenza di diverse concezioni su un terreno ad esse comune volete qualificarlo come ‘compromesso’, fatelo pure. Per me si tratta invece di qualcosa di molto più nobile e elevato, della ricerca di quell’unità che è necessaria per poter fare la Costituzione non dell’uno o dell’altro partito, non dell’una o dell’altra
ideologia, ma la Costituzione di tutti i lavoratori italiani, di tutta la nazione.
Dal canto suo, Lelio Basso (1903-78), esponente socialista, aveva detto:
noi voteremo in questa Costituzione degli articoli che certamente non corrispondono alle tradizioni del nostro
partito e altri che contraddicono a quelle che sono le nostre aspirazioni lontane; ma voteremo degli articoli
che siano l’espressione della complessa realtà oggi in atto e li voteremo con perfetta lealtà.
Nella Costituzione vi sono certamente norme poco chiare, che furono approvate dalle diverse
forze politiche con l’intento di piegarle – se e quando lo avessero potuto – alla loro visione di
parte (per esempio, alcune disposizioni in materia economica, o altre sulla scuola).
Ma sono casi sporadici. Per lo più si può dare ragione a Togliatti, poiché le norme della Costituzione non esprimono punti di vista unilaterali di singoli partiti, ma punti di incontro tra posizioni
diverse. Le costituzioni contrattate tra più forze politiche e sociali non sono manifesti ideologici
che devono obbedire a una rigorosa logica unitaria: sono documenti che, per poter valere, devono rappresentare tutte le parti dell’accordo.
Infine, aveva ragione anche Basso: una Costituzione che non avesse rispecchiato la “complessa
realtà”, ma l’avesse semplificata arbitrariamente, sarebbe stata una Costituzione monca, debole,
incapace di ottenere l’adesione di tutte le forze politiche.
Il compromesso non fu quindi la debolezza, ma la forza della Costituzione.
Ciascuna parte dovette rinunciare a qualcosa e accettare qualcos’altro che non coincideva con
le proprie aspirazioni, pur di raggiungere l’accordo (per esempio, le forze di ispirazione marxista
rinunciarono alla statalizzazione dei mezzi di produzione, le forze laiche accettarono i Patti lateranensi ecc.). Solo così la Costituzione poté giungere all’approvazione, ottenendo un larghissimo
consenso: nel voto finale si contarono 453 favorevoli e solo 62 contrari. La Costituzione non
rispecchia perciò un’idea semplice di democrazia, ma un’idea complessa, poiché la società che
l’ha espressa era una società a tanti lati, una società, come si dice, caratterizzata da pluralismo.
© Mondadori Education
28
4. La rinascita della democrazia in Italia e la Costituzione
Naturalmente, dei tre aspetti del compromesso – il mercanteggiamento di Calamandrei, l’elevata ricerca di unità di Togliatti, la rinuncia di Basso – è essenziale quello sottolineato da
Togliatti: se la Costituzione non avesse espresso un incontro effettivo e leale tra le forze costituenti, se fosse stata solo mercanteggiamento e rinuncia, non sarebbe riuscita nel suo compito unificatore e pacificatore che svolge da tanti anni, anche in condizioni difficili per la nostra
democrazia.
4.3 Il terreno d’incontro: il valore della persona umana e lo Stato sociale
Se si considerano l’attuale litigiosità dei partiti politici e l’estrema difficoltà di ogni accordo su
questioni di fondo, ci si può stupire della riuscita del compromesso costituzionale. La ragione
principale di quel successo sta nel fatto che la Costituzione non fu concepita allora come strumento di affermazione di qualche partito a danno di qualche altro. L’Assemblea costituente
lavorava indipendentemente dalle vicende politiche quotidiane, in una prospettiva di lunga
portata: essa, come è stato felicemente detto da Calamandrei, era un’assemblea “presbite”.
Neppure la rottura della collaborazione tra i tre maggiori partiti e l’estromissione dal Governo
dei due partiti di sinistra, alla metà del 1947, compromisero la realizzazione dell’impresa costituente. Quella rottura influenzò certi contenuti: in particolare, furono rafforzati i meccanismi
di garanzia delle minoranze, necessari nell’incertezza su quale dei due blocchi – la sinistra o
la Democrazia cristiana con i suoi alleati di centro – sarebbe prevalso in futuro. Tutti avevano
perciò interesse a premunirsi nel caso in cui si fossero trovati in minoranza.
La condizione essenziale del successo fu ciò che si chiama “velo dell’ignoranza”, cioè il fatto
che nessuno allora era in grado di sapere chi, nel futuro prossimo, sarebbe stato danneggiato
o favorito da questa o quella regola costituzionale. In tale situazione favorevole, che si crea
solo all’inizio di un’esperienza costituzionale nuova, il problema costituente non fu vissuto dai
partiti come problema di potere (ciò che avrebbe paralizzato ogni accordo) e tutte le parti si
prestarono a ragionare in astratto, facendo prevalere le considerazioni più elevate su quelle
più egoistiche. Le soluzioni costituzionali si accoglievano o si scartavano perché conformi o
contrarie a visioni generali, non a interessi di parte.
Ciò favorì l’incontro attorno a un nucleo costituzionale di ampio significato. Tale nucleo
è rappresentato dal valore della persona umana.
Attorno a esso si formò un movimento culturale di matrice cattolica, il personalismo, espressamente orientato al compromesso tra culture diverse. Esso si diffuse in Francia tra le due guerre
e influenzò – attraverso l’opera della sinistra democristiana (Dossetti, La Pira, Moro ecc.) – i
lavori dell’Assemblea costituente. Poiché di solito non si sa molto in proposito, è opportuna
qualche parola su questo argomento.
Il maggiore esponente di questa corrente di pensiero, il francese Emmanuel Mounier (190550), così si esprimeva:
[Il personalismo] non sarà mai un sistema né una macchina politica. Noi adoperiamo questo comodo termine per designare una certa prospettiva dei problemi umani e per porre l’accento, nella soluzione della
crisi del XX secolo, su certe esigenze che non sempre sono messe in valore. Non si diviene personalisti
abbandonando le proprie fedeltà di prima o i punti di vista pratici, scelti per la soluzione dei problemi concreti. Si può essere cristiani e personalisti, socialisti e personalisti e, perché no? comunisti e personalisti.
La miglior sorte che possa toccare al personalismo è questa: che dopo aver risvegliato in un sufficiente
© Mondadori Education
29
Storia costituzionale italiana
numero di uomini il senso totale dell’uomo, si confonda talmente con l’andamento quotidiano dei giorni da
scomparire senza lasciare traccia16.
Non era dunque una nuova filosofia politica, né un nuovo manifesto politico che volesse eliminare tutti gli altri: era invece un tentativo di gettare ponti in tante direzioni, per cercare collaborazioni rispettando le diversità. Si poneva al centro dell’attenzione delle forze politiche la persona
umana, il vero “valore” di ogni scelta politica:
La persona non è una cellula, nemmeno in senso sociale, ma un vertice, dal quale partono tutte le vie del
mondo. […]
La persona umana non è un concetto solo metafisico, come spesso si inducono a considerarla i filosofi
spiritualisti, che si perdono in chiacchiere sullo ‘spirito’ umano e non si degnano di gettare lo sguardo sulle
deplorevoli condizioni della vita quotidiana di tanti uomini: ‘non vi siete accorti di nulla, e questo vi condanna’.
Non è però nemmeno un concetto solo materialista, che riduce l’uomo ai suoi bisogni economici, come avevano fatto le due grandi filosofie dell’Ottocento, quella liberale e quella marxista,
l’una nemica dell’altra, ma sullo stesso terreno. Secondo il personalismo, la persona poneva problemi sia spirituali che materiali: anzi, in una situazione storica data, di indigenza diffusa, i problemi economico-strutturali assumevano un’urgenza primaria, condizionando lo sviluppo spirituale
dell’uomo: “il primo passo della rivoluzione spirituale è la rivoluzione economica e politica, che
apre a quella la via verso traguardi ancora troppo offuscati dalle preoccupazioni elementari della
difesa della propria vita”.
Per gli aspetti ora indicati, il personalismo offriva un terreno d’incontro indubbiamente
fecondo tra una parte del mondo cattolico (il “cattolicesimo sociale” che si richiamava
al filosofo francese dell’“umanesimo integrale”, Jacques Maritain, 1882-1973) e le forze
di sinistra, interessate a una trasformazione profonda della realtà economica e sociale
dell’Italia del dopoguerra: era una visione di matrice cristiano-cattolica che, per una volta,
non si rassegnava a convivere con la società così com’era, ma indicava la via di un impegno per la trasformazione.
Le conseguenze pratiche di tale concezione sul terreno costituzionale furono numerose. Essa consentì convergenze importanti. In primo luogo, si impose la visione della società italiana quale realtà
da trasformare, per combattere le ingiustizie sociali (art. 3, secondo comma Cost.). Correlativamente, si abbracciò la concezione dello Stato come strumento di questa trasformazione. Fu un grande
passo in avanti rispetto alla visione dello Stato “guardiano notturno” dell’Ottocento liberale e a quella della “sussidiarietà” dello Stato, propria del cattolicesimo tradizionale, secondo cui il ruolo dello
Stato era solo di porre rimedio alle crisi sociali momentanee, non di trasformare la società.
Così si apriva la strada all’innovazione più importante riguardo alla concezione dello Stato:
lo Stato che governa i processi economici e limita e indirizza i diritti economici dei privati,
i diritti che il secolo precedente aveva proclamato sacri e il Novecento vuole subordinati
agli interessi generali. È lo Stato interventista o programmatore.
Altro punto significativo è la visione comunitaria dell’uomo e della società. Ogni persona è concepita non in astratto, ma nelle relazioni sociali concrete in cui è inserita: si tratta del cosiddetto
16. Mounier, E., Che cos’è il personalismo?, Eiunaudi, Torino, 1948, pp. 9 ss.
© Mondadori Education
30
4. La rinascita della democrazia in Italia e la Costituzione
uomo situato. Ciò significa che è improprio considerare gli individui tutti astrattamente uguali,
ma che occorre considerare l’operaio, il contadino, il padre, la madre, il membro di una famiglia,
il credente ecc., ciascuno con le proprie esigenze e le proprie particolarità. Secondo la concezione cattolica, di cui il personalismo è figlio, l’uomo è inserito in comunità naturali, cioè dipendenti non dalla sua volontà, ma dalla sua stessa indole di individuo sociale (la famiglia, la Chiesa,
il sindacato, la fabbrica, la scuola ecc.), comunità che, essendo appunto “naturali”, hanno i loro
propri diritti naturali che nemmeno lo Stato può violare. Anche su questa concezione antiindividualistica e comunitaria della vita sociale si trovò l’accordo con le forze di sinistra, le quali si
erano formate storicamente attraverso organizzazioni di tipo comunitario: i sindacati, le leghe dei
lavoratori, i partiti, i cui componenti si chiamavano ”compagni”.
Si trattava però di un accordo non di tipo dottrinale, ma pratico. Per i marxismi di tutti i tipi i
caratteri dei gruppi sociali (famiglia compresa), non sono naturali, ma derivano dai rapporti economici. Ma, per il momento, la visione concreta dell’uomo, legato alla cerchia delle persone con
cui condivide esperienze di vita, garantiva il rispetto delle organizzazioni della classe operaia e il
riconoscimento del loro ruolo negli anni a venire.
Tutto ciò portava a una visione pluralistica della società italiana, non concepita quale somma di
individui tutti indifferentemente assoggettati alla stessa legge, ricchi e poveri, proprietari e proletari, potenti e privi di potere, ma come la risultante di tante realtà sociali differenziate, ciascuna
con le proprie aspirazioni da soddisfare. Si pensi alle “formazioni sociali” di cui parla l’art. 2
della Costituzione, alle “confessioni religiose” dell’art. 8, alla famiglia come “comunità naturale”
dell’art. 29, al “mondo del lavoro” dell’art. 35 e seguenti, al sindacato dell’art. 39 e al partito politico dell’art. 49 ecc.
Non era propriamente un ritorno all’antico, alla società per ceti prerivoluzionaria: allora, ogni
uomo apparteneva integralmente a un ceto, aveva uno status definito che ne limitava il ruolo
sociale.
La Costituzione considera invece che ogni persona si proietti in quelle comunità per sviluppare se stessa, quasi come le sostanze chimiche che possiedono molte “valenze” che
ne consentono l’unione con altre, in nuove sostanze complesse aventi altre proprietà. La
società per ceti amputava le potenzialità della persona; la società comunitaria, invece, le
aumenta.
La novità, rispetto all’Antico regime, si vede bene in questo: nel fatto che accanto ai diritti
dell’“uomo situato” sono comunque mantenuti i diritti classici della tradizione liberale, i quali
attengono all’individuo come tale e costituiscono il minimo comune denominatore della condizione di libertà di tutti gli uomini. In ciò la Rivoluzione francese dimostrava di non essere morta.
I contenuti della “persona” cui il personalismo si ispirava, così come il rapporto tra le “comunità”
e lo Stato, non erano definiti una volta per tutte. Si tratta di orientamenti di pensiero e di metodo da tener presenti nell’affrontare i problemi sociali, più che di una ricetta per fornire risposte
precise. Per questo motivo il personalismo non divenne mai una parola d’ordine, un proclama
capace di produrre effetti propagandistici di massa: fu piuttosto un discorso per élites intellettuali e politiche, come quelle che operarono nell’Assemblea costituente.
Le forze di sinistra ne furono attratte, tanto più in quanto avevano abbandonato il proposito rivoluzionario immediato e si affidavano a una “lunga marcia” attraverso lo Stato. La sinistra richiedeva la democratizzazione politica e soprattutto sociale (la cosiddetta democrazia progressiva di
© Mondadori Education
31
Storia costituzionale italiana
Togliatti) e le aperture trasformatrici del cattolicesimo sociale e personalistico facevano intravedere prospettive in tal senso. Era un punto di accordo iniziale che lasciava integre le possibilità
future che ciascuna forza politica aveva di far valere le proprie istanze trasformatrici; era un accordo – per riprendere una formula già usata a proposito dello Statuto albertino – che non avrebbe
impedito di andare più avanti.
Non si riconobbero in queste prospettive le forze liberali: le critiche più forti al compromesso
costituzionale vennero infatti da loro.
Non si può dire però che la tradizione liberale non sia riconoscibile nel testo costituzionale: le dichiarazioni dei diritti e delle libertà individuali (salvo che nella decisiva materia
economica) sono di matrice liberale.
Per questa parte, i diritti della Rivoluzione francese si dimostrarono assai più che “diritti borghesi”, come il marxismo li aveva riduttivamente considerati: erano invece conquiste universali della
libertà e della dignità dell’uomo. Tuttavia, a differenza delle concezioni liberali classiche, tali diritti
e tali libertà non erano l’ultimo orizzonte della Costituzione: erano inseriti in un più ampio quadro
di tipo sociale, cui la tradizione liberale si riteneva estranea.
Ecco dunque la struttura portante del compromesso costituzionale, raggiunto dai cattolici-sociali e dai Partiti comunista e socialista, con l’apporto delle concezioni liberali dei diritti e delle
libertà individuali.
Ne scaturì quello che, con una formula sintetica che allude a quanto si è detto, si definisce
Stato di democrazia sociale.
5. Il sistema politico italiano nel secondo dopoguerra
5.1 Il multipartitismo
La democrazia prevista dalla Costituzione è fondamentalmente, anche se non esclusivamente, rappresentativa. La rappresentanza democratica comporta non solo che vi sia qualcuno
che decide per altri, ma anche che vi sia un legame effettivo, una coincidenza concreta tra gli
orientamenti dei rappresentati e quelli dei rappresentanti: solo così i primi possono non essere
espropriati della sovranità dai secondi.
A questo fine esistono i partiti politici, ai quali spetta presentare agli elettori proposte elettorali e candidature di persone da eleggere al Parlamento. La scelta degli elettori avviene
così tra le diverse indicazioni, di programmi e di persone, date dai partiti.
Il funzionamento della democrazia non dipende solo dai caratteri dei singoli partiti, bensì anche
dal “sistema dei partiti”, cioè dal loro numero e dai loro rapporti.
L’aspetto principale del sistema partitico italiano è stato, fino a tempi recenti, il multipartitismo.
© Mondadori Education
32
5. Il sistema politico italiano nel secondo dopoguerra
In altre grandi democrazie (la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Germania, la Francia ecc.) esiste,
almeno tendenzialmente, il bipartitismo: un partito di maggioranza esprime il Governo, l’altro è
all’opposizione, fino a quando nuove elezioni non rovescino i rapporti di forza; nella storia della
repubblica italiana, invece, ci sono sempre stati numerosi partiti e ciò ha reso difficile la formazione di maggioranze (di coalizione).
Le ragioni del multipartitismo italiano sono, innanzitutto, storico-ideologiche. Consideriamo il
sistema dei partiti in Italia così come si presentava fino ai primi anni Novanta del secolo scorso. Vi
era il partito che rappresentava i cattolici in politica, denominato Democrazia cristiana (DC), che era
stato al governo fino dalla nascita della Repubblica. Questa formazione politica non era precisamente caratterizzata dal punto di vista degli interessi sociali che rappresentava. Se ne è parlato come di
un partito interclassista perché, sebbene rappresentasse ampiamente il ceto medio conservatore
e nemico delle novità, in esso convivevano tendenze accentuatamente di destra e di sinistra.
Vi erano poi i partiti che derivavano dal movimento socialista, eredi del Partito socialista italiano (PSI), fondato nel 1892, e dalle sue successive scissioni, che dettero vita nel 1921 al Partito comunista italiano (PCI) e, nel 1947, al Partito socialdemocratico italiano (PSDI). Nel 1991,
in seguito alla caduta del muro di Berlino (avvenuta nel 1989), il Partito comunista si è trasformato in Partito democratico della sinistra (PDS), abbandonando la sua ispirazione marxista; in
quell’occasione, in seguito a un’ulteriore scissione, si è formato alla sua sinistra un altro partito,
denominato Partito della rifondazione comunista (PRCI), che ha invece continuato a richiamarsi
alle concezioni politiche del marxismo.
Il Partito liberale italiano (PLI) e il Partito repubblicano italiano (PRI) si collegavano alle due
grandi correnti politiche e culturali del Risorgimento, quella cavouriana e quella mazziniana.
All’ambito del liberalismo, ma con accentuate connotazioni sociali, si richiamava anche il Partito
d’azione, presente all’Assemblea costituente e successivamente disciolto, e si richiama oggi il
Partito radicale, un movimento particolarmente orientato alla difesa delle libertà individuali e
spesso operante con gli strumenti della democrazia diretta (lo si è chiamato “partito del referendum”), contro la democrazia parlamentare.
Infine, il Movimento sociale italiano (MSI), fondato nel 1946 da esponenti della classe politica
fascista reduci della Repubblica Sociale Italiana, esprimeva le posizioni contrarie alla democrazia parlamentare e liberale, che sono state sempre presenti nella storia d’Italia e si erano
riconosciute nel fascismo.
Dopo la nascita della repubblica l’Italia è stata retta da governi di coalizione, dapprima fondati
sulla solidarietà dei partiti antifascisti; nel 1947, tuttavia, Alcide De Gasperi estromise i comunisti
e i socialisti dal governo e inaugurò una politica di centro, che venne sostenuta dai repubblicani, dai liberali e dai socialdemocratici.
All’inizio degli anni Sessanta fu composto il primo governo di centro-sinistra, formato da
DC, PSI, PSDI e PRI; a essi si aggiunse, successivamente, il PLI, e nel 1981 i cinque partiti
dettero vita al cosiddetto pentapartito. Il pentapartito ha governato l’Italia fino alla crisi del
sistema, avvenuta all’inizio degli anni Novanta.
Nel corso degli anni Ottanta e Novanta la tendenza alla moltiplicazione dei partiti si è accentuata,
provocando un’ulteriore frammentazione della vita politica in Italia.
Dalla rivolta contro la corruzione dei partiti tradizionali, per imporre una forte rigenerazione morale della politica, nasceva la Rete, che comprendeva forze del mondo cattolico e di sinistra.
© Mondadori Education
33
Storia costituzionale italiana
Parallelamente, la polemica contro il centralismo dello Stato e la corruzione “romana” conduceva alla formazione della Lega nord, partito politico nato dal movimento chiamato Lega lombarda, che si era costituito nel 1984. La presenza di minoranze etnico-linguistiche aveva già da
tempo determinato la formazione di partiti regionali in grado di ottenere una piccola rappresentanza in Parlamento: tra essi si possono citare l’Union valdotaîne, in Valle d’Aosta, e la Südtiroler Volkspartei, nella provincia di Bolzano. Per la tutela dell’ambiente dal degrado determinato
dall’incontrollato sviluppo industriale del nostro Paese gli ambientalisti si organizzarono prima in
movimenti indipendenti e in seguito, dal 1986, nella Federazione dei Verdi.
5.2 La cosiddetta “seconda Repubblica”
La situazione appena descritta ha subito fondamentali cambiamenti nei primi anni Novanta, in
seguito ad avvenimenti che hanno segnato uno spartiacque tra due epoche politiche. Abitualmente si parla, infatti, di “prima Repubblica” e di “seconda Repubblica”: l’anno della fine dell’una
e dell’inizio dell’altra viene considerato da alcuni il 1992, con l’avvio di un’importante inchiesta
giudiziaria sui partiti politici, mentre da altri viene considerato il 1994, anno in cui sono scomparsi dal Parlamento i gruppi politici storici che avevano governato il Paese dalla nascita della
Repubblica.
Il primo fattore di cambiamento fu certamente la fine, nel 1989, del comunismo internazionale,
segnata dal crollo del muro di Berlino. La divisione del mondo in due parti – quella comunista
e quella anticomunista –, che per vari decenni aveva determinato i rapporti internazionali (la cosiddetta “guerra fredda”), aveva anche strutturato il sistema politico italiano.
Con la caduta dei regimi comunisti si determinarono le ragioni della trasformazione dei
due grandi partiti che avevano rappresentato in Italia i due fronti, il Partito comunista e la
Democrazia cristiana, e, soprattutto, venne superata la contrapposizione politica che per
tanti anni aveva irrigidito le relazioni politiche.
Il secondo fattore di cambiamento fu l’inchiesta giudiziaria “Mani pulite”, che coinvolse un’ampia parte della classe politica italiana. Essa mise in luce un sistema di corruzione pubblica (“Tangentopoli”) assai consolidato e diffuso, che coinvolgeva settori della finanza e dell’industria da
un lato e amministratori pubblici e partiti politici dall’altro. I primi versavano compensi ai secondi
per ottenere in cambio favori illeciti, come la distribuzione di appalti redditizi, in violazione delle
norme che regolano le gare pubbliche.
La scoperta della sistematica corruzione che innervava la vita di molti partiti ne minò alle fondamenta la credibilità, aprendo una crisi interna di tale portata che in due anni scomparvero i partiti
maggiormente coinvolti, DC e PSI – ossia quelli che avevano costituito per decenni il perno delle
coalizioni di governo. Mentre il Partito socialista fu annientato (e solo di recente, tra molti contrasti
interni, si è ricostituito), la Democrazia cristiana si disgregò in una serie di partiti più piccoli.
Il terzo fattore di innovazione è stato la trasformazione in senso maggioritario del sistema
elettorale. Essa ha accelerato il processo di cambiamento del sistema politico italiano, fino ad
allora caratterizzato dalla presenza di numerosi partiti, e ha favorito la nascita di due coalizioni di
partiti, quella di centro-destra e quella di centro-sinistra.
Infatti, dopo la disgregazione della DC, un numero significativo di suoi militanti ed elettori di area
moderata o conservatrice entrò nelle fila di un nuovo soggetto politico, Forza Italia, costituito nel
1994 per iniziativa dell’imprenditore Silvio Berlusconi, che fino ad allora non si era mai impegnato
© Mondadori Education
34
5. Il sistema politico italiano nel secondo dopoguerra
attivamente in politica ed era, tra l’altro, titolare della massima società privata di trasmissioni televisive. È un dato, questo, che in Italia e all’estero ha suscitato dubbi sulla scelta politica di Berlusconi, dato il conflitto di interessi che essa faceva sorgere. Da un lato Forza Italia, che fin dalla sua
nascita si è identificata totalmente con il suo fondatore, ha raccolto le spoglie della DC, dall’altro si
è rivolta alle forze della piccola e media imprenditoria per offrire loro la prospettiva di una modernizzazione della cosiddetta «Azienda Italia».
Dato l’elevato consenso elettorale ottenuto, anche tra elettori che fino ad allora avevano
votato partiti di sinistra, Forza Italia ha assunto un ruolo centrale nella coalizione di centrodestra, poi denominata Popolo delle Libertà (PdL).
A guida della coalizione di centro-sinistra si è posto, invece, un partito nato in seguito allo scioglimento del PCI e denominato dapprima Partito democratico della sinistra (PDS) e poi Democratici di sinistra (DS). Nel 2007 questo organismo si è sciolto e ha dato vita al Partito democratico
(PD) insieme ad altri gruppi politici, tra i quali il più importante era quello della Margherita, un
partito in cui confluivano posizioni liberal-socialiste e cristiano-democratiche.
Il processo di ristrutturazione del sistema dei partiti è stato complesso, date le anomalie presenti
tanto nella coalizione del centro-sinistra, quanto in quella del centro-destra.
Innanzitutto, non era affatto assicurata una sufficiente omogeneità politica tra le due parti contendenti, tale da produrre politiche coerenti e stabili. Nello schieramento di centro-sinistra ha
stentato a formarsi una leadership riconosciuta da tutte le sue componenti e lo schieramento è
oggi diviso al suo interno.
In secondo luogo, alle estremità dei due schieramenti continuano a esistere alcuni partiti che
operano autonomamente. A essi si devono aggiungere altri movimenti, inclini a mantenere la
propria autonomia, come quello radicale e quello dell’Italia dei valori (IDV), fondato da Antonio
Di Pietro (uno dei magistrati che avevano condotto l’inchiesta Mani pulite).
Alle elezioni del 2013, infine, si è presentato un movimento politico chiamato “Cinque stelle”
che, soprattutto in forza della lotta alla corruzione che esso proclama come suo primo obiettivo,
ha ottenuto un largo consenso, per cui il sistema politico, che faticosamente era diventato
bipolare, è diventato tripolare, con la conseguente difficoltà di formare maggioranze di governo
stabili.
© Mondadori Education
35