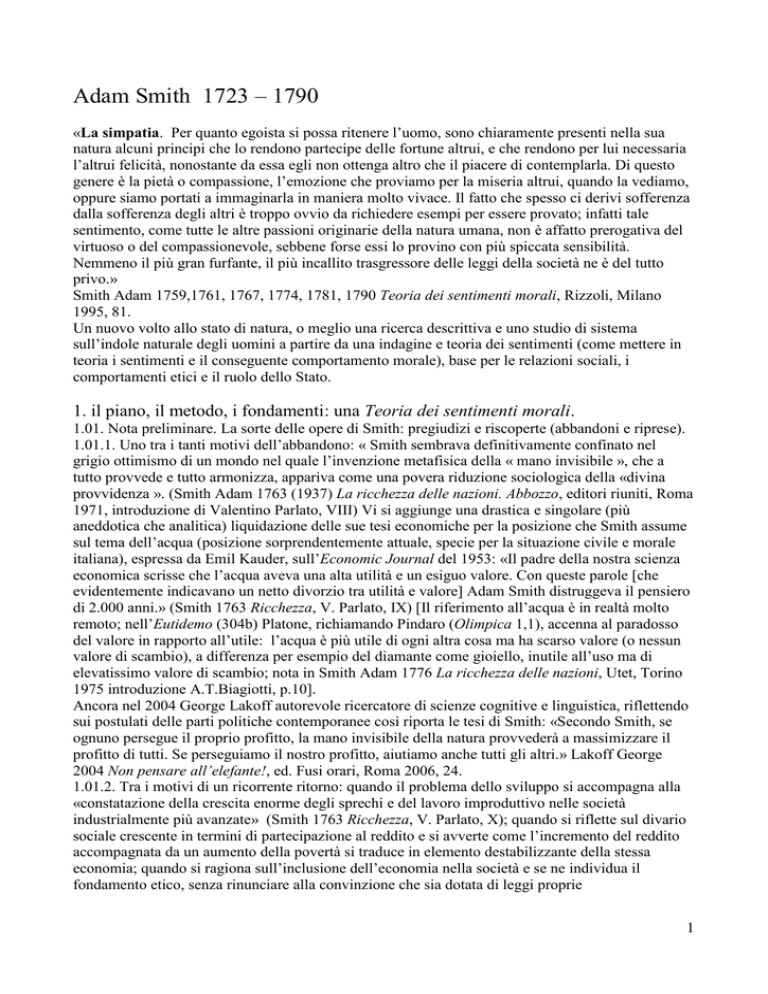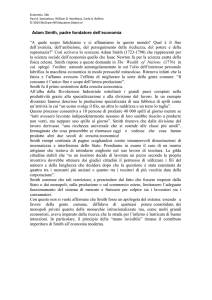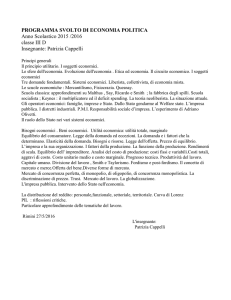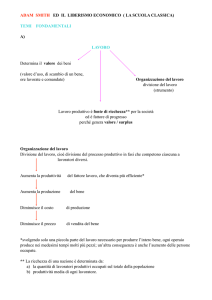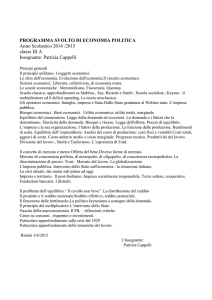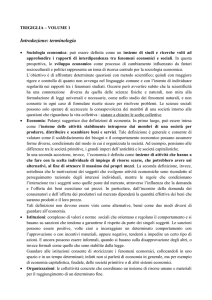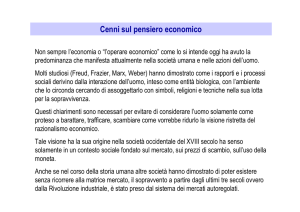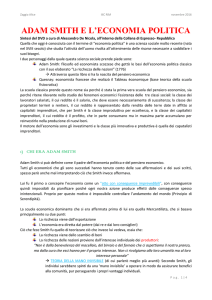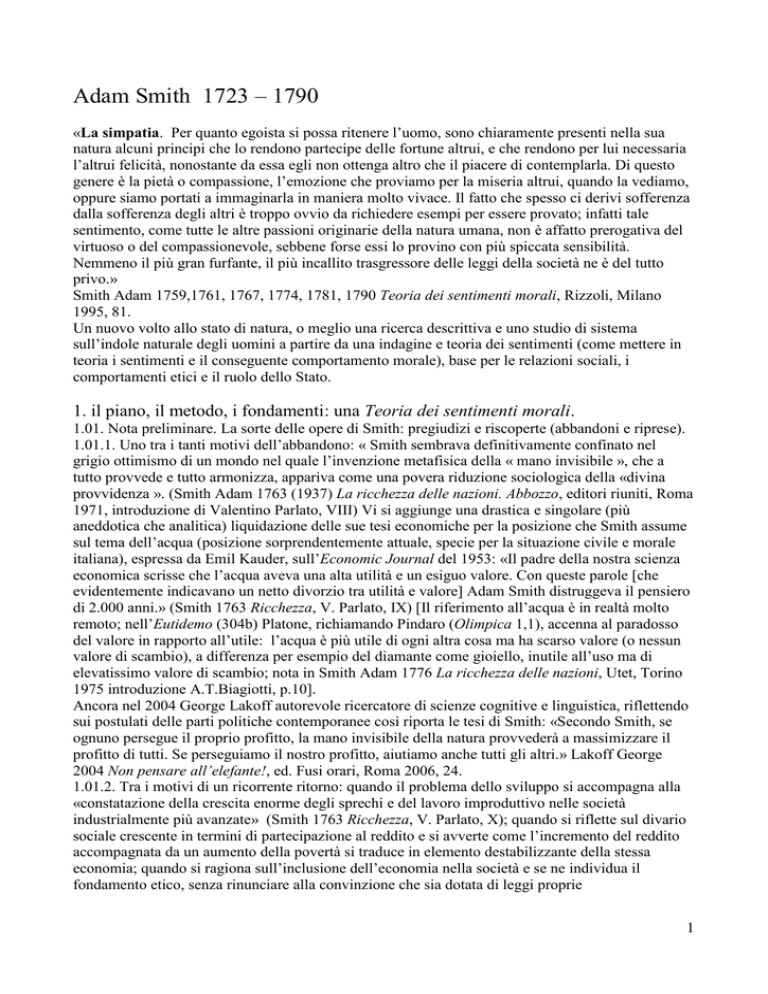
Adam Smith 1723 – 1790
«La simpatia. Per quanto egoista si possa ritenere l’uomo, sono chiaramente presenti nella sua
natura alcuni principi che lo rendono partecipe delle fortune altrui, e che rendono per lui necessaria
l’altrui felicità, nonostante da essa egli non ottenga altro che il piacere di contemplarla. Di questo
genere è la pietà o compassione, l’emozione che proviamo per la miseria altrui, quando la vediamo,
oppure siamo portati a immaginarla in maniera molto vivace. Il fatto che spesso ci derivi sofferenza
dalla sofferenza degli altri è troppo ovvio da richiedere esempi per essere provato; infatti tale
sentimento, come tutte le altre passioni originarie della natura umana, non è affatto prerogativa del
virtuoso o del compassionevole, sebbene forse essi lo provino con più spiccata sensibilità.
Nemmeno il più gran furfante, il più incallito trasgressore delle leggi della società ne è del tutto
privo.»
Smith Adam 1759,1761, 1767, 1774, 1781, 1790 Teoria dei sentimenti morali, Rizzoli, Milano
1995, 81.
Un nuovo volto allo stato di natura, o meglio una ricerca descrittiva e uno studio di sistema
sull’indole naturale degli uomini a partire da una indagine e teoria dei sentimenti (come mettere in
teoria i sentimenti e il conseguente comportamento morale), base per le relazioni sociali, i
comportamenti etici e il ruolo dello Stato.
1. il piano, il metodo, i fondamenti: una Teoria dei sentimenti morali.
1.01. Nota preliminare. La sorte delle opere di Smith: pregiudizi e riscoperte (abbandoni e riprese).
1.01.1. Uno tra i tanti motivi dell’abbandono: « Smith sembrava definitivamente confinato nel
grigio ottimismo di un mondo nel quale l’invenzione metafisica della « mano invisibile », che a
tutto provvede e tutto armonizza, appariva come una povera riduzione sociologica della «divina
provvidenza ». (Smith Adam 1763 (1937) La ricchezza delle nazioni. Abbozzo, editori riuniti, Roma
1971, introduzione di Valentino Parlato, VIII) Vi si aggiunge una drastica e singolare (più
aneddotica che analitica) liquidazione delle sue tesi economiche per la posizione che Smith assume
sul tema dell’acqua (posizione sorprendentemente attuale, specie per la situazione civile e morale
italiana), espressa da Emil Kauder, sull’Economic Journal del 1953: «Il padre della nostra scienza
economica scrisse che l’acqua aveva una alta utilità e un esiguo valore. Con queste parole [che
evidentemente indicavano un netto divorzio tra utilità e valore] Adam Smith distruggeva il pensiero
di 2.000 anni.» (Smith 1763 Ricchezza, V. Parlato, IX) [Il riferimento all’acqua è in realtà molto
remoto; nell’Eutidemo (304b) Platone, richiamando Pindaro (Olimpica 1,1), accenna al paradosso
del valore in rapporto all’utile: l’acqua è più utile di ogni altra cosa ma ha scarso valore (o nessun
valore di scambio), a differenza per esempio del diamante come gioiello, inutile all’uso ma di
elevatissimo valore di scambio; nota in Smith Adam 1776 La ricchezza delle nazioni, Utet, Torino
1975 introduzione A.T.Biagiotti, p.10].
Ancora nel 2004 George Lakoff autorevole ricercatore di scienze cognitive e linguistica, riflettendo
sui postulati delle parti politiche contemporanee così riporta le tesi di Smith: «Secondo Smith, se
ognuno persegue il proprio profitto, la mano invisibile della natura provvederà a massimizzare il
profitto di tutti. Se perseguiamo il nostro profitto, aiutiamo anche tutti gli altri.» Lakoff George
2004 Non pensare all’elefante!, ed. Fusi orari, Roma 2006, 24.
1.01.2. Tra i motivi di un ricorrente ritorno: quando il problema dello sviluppo si accompagna alla
«constatazione della crescita enorme degli sprechi e del lavoro improduttivo nelle società
industrialmente più avanzate» (Smith 1763 Ricchezza, V. Parlato, X); quando si riflette sul divario
sociale crescente in termini di partecipazione al reddito e si avverte come l’incremento del reddito
accompagnata da un aumento della povertà si traduce in elemento destabilizzante della stessa
economia; quando si ragiona sull’inclusione dell’economia nella società e se ne individua il
fondamento etico, senza rinunciare alla convinzione che sia dotata di leggi proprie
1
1.01.2. Alla base di una ricorrente presenza delle opere di Smith, l’ampiezza degli interessi e degli
interventi. Noto per le teorie economiche formulate nell’opera Ricchezza delle nazioni, pubblicata
nel 1776, l’impegno di Smith tocca ambiti molto vasti che esprime in cicli di conferenze e scritti
sulla retorica, le belle lettere, la formazione del linguaggio, la giurisprudenza; è professore di logica
e di filosofia morale, si occupa di economia per aspetti applicativi (commerci, dogane e dazi, in cui
rivesta cariche pubbliche) e teorici generali, partecipa ai circoli dei “philosophes” illuministi.
1.1. Un progetto fondativo e di sistema sulla base dell’osservazione. Come più volte dichiara,
tutta la sua ricerca è volta a individuare i principi generali che riguardano l’etica, il diritto, il
governo «e dei diversi rivoluzionari mutamenti che essi hanno subito nelle varie età e periodi della
società». (note da Eugenio Lecaldano in Introduzione a Smith, 1759, 9) Direzione e ampiezza di
impegno espressi anche, indirettamente, nelle note conclusive alla Teoria dei sentimenti morali
quando interviene sul «modo con cui i diversi autori hanno trattato le regole pratiche della
moralità»: «Ci si potrebbe aspettare che i ragionamenti dei giuristi sulle diverse imperfezioni e
perfezionamenti delle leggi dei diversi paesi avrebbero dovuto dare occasione a una ricerca su quali
siano le regole naturali della giustizia, indipendentemente da tutte le istituzioni positive. Ci si
sarebbe potuti aspettare che quei ragionamenti li avrebbero dovuti condurre a tentare di stabilire un
sistema di quella che potrebbe essere appropriatamente chiamata giurisprudenza naturale, ovvero
una teoria dei principi generali che dovrebbero percorrere le leggi di tutte le nazioni, ed esserne a
fondamento. Ma sebbene i ragionamenti dei giuristi abbiano effettivamente prodotto qualcosa del
genere, e sebbene nessun uomo abbia sistematicamente trattato delle leggi di ciascun particolare
paese senza mescolare nella sua opera molte osservazioni di questo tipo, nel mondo si è pensato
molto tardi a un tale sistema generale, e molto tardi la filosofia del diritto ha cominciato a essere
trattata per se stessa, senza riguardo per le istituzioni particolari di ciascuna nazione. In nessuno dei
moralisti antichi troviamo tentativi di enumerazione particolareggiata delle regole di giustizia.
Cicerone nel suo De Officiis e Aristotele nella sua Etica trattano della giustizia nella stessa maniera
generale in cui trattano tutte le altre virtù. Nelle leggi di Cicerone e Platone, dove ci saremmo
naturalmente potuti aspettare qualche tentativo di enumerazione di quelle regole di equità naturale,
che dovrebbero essere rinforzate dalle leggi positive di ogni paese, non c’è tuttavia nulla del genere.
Le loro leggi sono leggi di amministrazione civile (police), non di giustizia.» (Smith, 1759, 639640)
Si tratta di osservazioni che oltre a indicare il piano contengono indicazioni di metodo innovative.
«Smith procederà in modo tale da suggerire che i risultati più originali e saldi di una ricerca
filosofica mossa da esigenze scientifiche potevano essere ottenuti non tanto cercando i principi
relativi alla natura umana complessivamente intesa, quanto piuttosto affrontando in modo esclusivo
e approfondito lo studio dei diversi lati della condotta degli uomini nella vita associata.» (Smith,
1759, introduzione Lecaldano 10-11)
In queste note di metodo sono in atto notevoli cambiamenti:
1.1.1. Non la ricerca sulla natura umana che rimanda o a mitici mondi naturali o ad aree di carattere
metafisico (nella tradizione che viene da Locke, la sostanza è una idea complessa, non è un dato
d’esperienza ma solo uno strumento per gestirla), ma l’osservazione e studio “dei diversi lati della
condotta degli uomini nella vita associata”.
1.1.2. Diventa allora centrale non la costruzione di una società ideale o di un sistema politico che
ponga al centro o al primo passaggio il tema del proprio ordinamento giuridico e il sistema delle
leggi, ma il problema della giustizia e delle equità; osserva Smith infatti nel passaggio sopra
richiamato: «ci saremmo naturalmente potuti aspettare qualche tentativo di enumerazione di quelle
regole di equità naturale, che dovrebbero essere rinforzate dalle leggi positive di ogni paese, non c’è
tuttavia nulla del genere. Le loro leggi sono leggi di amministrazione civile (police), non di
giustizia.» (Smith, 1759, 640)
1.1.3. Smith indica allo scopo l’assoluta priorità di una ricerca sui sentimenti su cui si fondano le
relazioni umane, la loro moralità, le attese e le condizioni naturali di giustizia e di conseguenza le
2
regole positive di governo; riprendendo le parole citate di Smith: «avrebbero dovuto dare occasione
a una ricerca su quali siano le regole naturali della giustizia, indipendentemente da tutte le
istituzioni positive […] una teoria dei principi generali che dovrebbero percorrere le leggi di tutte le
nazioni, ed esserne a fondamento avrebbero dovuto dare occasione a una ricerca su quali siano le
regole naturali della giustizia, indipendentemente da tutte le istituzioni positive.» (Smith, 1759, 639)
La riflessione di Smith nell’opera Teoria dei sentimenti morali si sviluppa su tre cardini:
Sentimento Immaginazione Spettatore. Rispettivamente con funzione di: fondamento,
connessione, giudizio morale.
1.2. Perché il sentimento.
1.2.1. Un’alternativa al razionalismo dominante in altre teorie morali e politiche. Nella sua forma
assoluta (tesa cioè a indicare principi assoluti, veri e certi, dell’agire morale) il razionalismo o resta
formale, privo di contenuti operativi efficaci, o diventa sede dell’eteronomia e condanna l’uomo ad
una inesorabile dipendenza morale; nel suo rigore logico, nella sua fedeltà eccessiva alla coerenza,
non riesce a determinare l’incontro tra teoria ed esperienza, quella chiara e definita, questa
complessa e imprevedibile (per dirla con Aristotele: manca di phrònesis, di saggezza); nel suo
versante pratico non è in grado di coinvolgere nell’agire morale l’uomo nella sua pienezza e
complessità di ragione, istinti, emozioni, passioni, interessi, ecc. La tradizione empirista in campo
etico e politico pone al centro il sentimento, non lasciato alla genericità di un senso comune
indistinto e soggettivo, né definito secondo il metodo di una razionalità a priori, ma da esplorare
nella sua varietà attraverso l’osservazione sociologica e la descrizione antropologica, spostando
l’attenzione dalla ricerca metafisica della natura umana, all’attenzione osservativa della condotta
umana nelle sue diverse aree individuali, sociali, morali, economiche, politiche, religiose… «si
trattava di rendere più convincente e, in particolare, più compiuta la spiegazione della vita morale
degli uomini attraverso il principio della simpatia e secondo l’ottica dell’osservatore.» (Lecaldano
in Introduzione a Smith, 1759, 17)
Son qui in azione le direttive di metodo empirico (di tradizione inglese) percorse da Francis
Hutcheson, da David Hume e da Isaac Newton, applicate all’oggetto primo della ricerca: il
sentimento (morale), che, esplorato con una ricerca empirica, introduce nell’ambito morale e
politico rilevanti innovazioni.
1.2.1.1. Hutcheson: «La novità introdotta da Hutcheson consisteva nell’inserire la ricerca dei
principi generali dell’etica in una prospettiva tesa a fare valere l’ottica dei sentimenti di
approvazione o disapprovazione suscitati da un’azione, in un osservatore o spettatore. Ciò
significava lasciare da parte, in prima istanza, la prospettiva propria di chi agisce, sceglie o decide
ritenuta invece prevalente nelle analisi etiche di pensatori quali T. Hobbes, J. Locke e GB.
Mandeville. Smith trovava in Hutcheson non solo il prevalere dell’ottica di uno spettatore morale,
ma anche la convinzione che i principi dell’approvazione e della disapprovazione morale andassero
ricercati tra i sentimenti e le passioni naturali degli uomini e non già nella componente intellettuale
o razionale della natura umana.» (Lecaldano in Introduzione a Smith, 1759, 12-13)
Oltre a non seguire, prioritariamente, il progetto della ricerca dei principi razionali e formali
dell’agire morale (cioè un metodo razionalistico come una sorta di Critica della ragion pura pratica
poi attuata da Kant), viene abbandonata anche la priorità data alla teoria (già medievale)
dell’intentio: se si muove dal principio che a definire la imputabilità morale di un atto è l’intentio, la
ricerca allora è volta non a descrivere l’agire e le sue componenti dinamiche ma a stabilirne
l’appartenenza o meno all’ambito morale sulla base dell’intenzionalità di chi agisce; questa
impostazione sembra essere più una prospettiva giuridica o comunque di imputazione che non una
strada di osservazione descrittiva adeguata all’oggetto di indagine: il comportamento. Smith prende
le distanze anche dal razionalismo etico che risulta presente anche in autori dalla profonda
convinzione empiristica, come Locke; sono “fuorviati” da una impostazione scientifica
inesorabilmente volta alla ricerca delle cause o incapaci di mettere in conto della teoria l’indagine e
3
la spiegazione di un agire senza causa (o senza una causa consapevole e razionale attiva secondo la
linearità di causa ed effetto prevista dalle teorie scientifiche applicata al mondo della fisica).
«Fuorviati forse nelle loro analisi dall’esclusivo ricorso alla prospettiva di chi agisce e cerca le
motivazioni per una qualche condotta morale.» (Lecaldano in Introduzione a Smith, 1759, 14)
1.2.1.2. Hume: «la stessa prospettiva dello spettatore Smith poteva trovare anche al centro delle
analisi che della morale aveva offerto più recentemente Hume, prima con la terza parte del Trattato
sulla natura umana (1740) e poi con la Ricerca sui principi della morale (1751). Smith, quindi,
riceveva per quanto riguardava l’ottica dello spettatore un’eredità convergente da parte dei due
principali pensatori scozzesi che lo avevano preceduto.» (Lecaldano in Introduzione a Smith, 1759,
13). Hume pone una scienza generale della natura umana al centro di ogni altra scienza, queste
infatti si conducono secondo modalità dettate dalla natura umana. Nello studio della natura umana a
sua volta diventa centrale lo studio degli stadi originari dell’uomo: impressioni e poi idee. Tra le
impressioni si collocano le passioni e le emozioni che determinano il modo di essere dell’uomo. La
morale è una passione dell’uomo e poggia su di un fondamentale sentimento morale; i
ragionamenti, i giudizi etici, così le leggi e la loro osservanza non sorgono in assenza di un
sentimento morale. E il sentimento morale è l’istintiva capacità di sentire piacere o dolore di fronte
al bene o al male (come ricorda lo stesso Smith in apertura della Teoria dei sentimenti morali). Il
razionalismo, occupandosi di etica, si è sempre rifiutato di fondare la morale sul sentimento, e sul
sentimento del piacere, ma si tratta di un rifiuto che deriva dalla rozzezza con cui la filosofia ha, per
lo più, affrontato il tema del piacere. Mentre la filosofia, interessata al tema della conoscenza, ha
scandagliato il mondo della ragione chiarendone tappe, forme ed esiti con cura di dettagli e
ampiezza di teorie, il tema del piacere in filosofia conserva una generica unitarietà; ma si tratta di
una genericità che deriva dal difetto di analisi del vasto e variato mondo delle emozioni e delle
passioni. Anche il linguaggio comune tende a usare sempre lo stesso termine piacere per indicare
una varietà di situazioni; anche se ognuno conosce bene e immediatamente la differenza tra il
piacere dell’ascolto della musica, quello di una conversazione gradita (piacevole), i “piaceri” della
tavola e via enumerando…
1.2.1.3. Newton: nei Principi matematici di filosofia naturale (1687) si serve dello strumento
matematico per la definizione dei dati e per costruirne in leggi le relazioni, ma applicandolo
all’esperienza e fornendo delle precise regole e principi di cautela per giustificare la traduzione
dell’esperienza (notoriamente infinita e mai data completamente) in leggi necessarie della natura
che definiscono il sistema matematico del mondo. Resta dunque la priorità dell’osservazione
empirica, i cui dati sono letti e collegati con metodo matematico. Quasi come un lascito della
tradizione inglese viene seguito un «paradigma di ricerca filosofica sulla morale condiviso da larga
parte della cultura scozzese alla metà del secolo XVIII. Numerosi autori convergevano infatti
nell’impegno a presentare una ricostruzione sistematica della natura umana adeguata ai criteri
dettati da una filosofia sperimentale ed empirista modellata sull’opera di Newton.» (Lecaldano in
Introduzione a Smith, 1759, 15)
1.2.2. La centralità della simpatia: intesa come capacità di “patire-con”, “con-passione” per il dolore
e per il piacere, per la sofferenza e per la gioia [più volte Smith descrive situazioni di assenza di
morale nel non partecipare e non condividere la gioia altrui], “esperire-con”, partecipare, entrare in
comunicazione, notare osservare e condividere in una relazione biunivoca che va da noi all’altro,
dall’altro a noi e tutto ciò in modo disinteressato . Questa “simpatia” (così intesa) è alla base del
sentire e dell’agire morale del soggetto.
«In ogni passione cui la mente umana è soggetta, le emozioni dello spettatore corrispondono sempre
a quelli che, riportando il caso a sé, egli immagina debbano essere i sentimenti della persona che
soffre. Pietà e compassione sono parole appropriate per significare il nostro sentimento di
partecipazione per la sofferenza altrui. La parola simpatia nonostante il suo significato fosse forse
originariamente lo stesso, ora tuttavia può, senza eccessiva improprietà, essere usata per denotare il
nostro sentimento di partecipazione per qualunque passione.» (Smith 1759, Teoria 84) Son qui
4
operativi gli elementi che Smith intreccia per costruire una teoria morale dei sentimenti: simpatia,
spettatore, immaginazione, emozioni, passioni.
«Il piacere della reciproca simpatia. Ma, quale che sia la causa della simpatia, e il modo in cui può
venir suscitata, non c’è nulla che ci faccia più piacere che osservare in altri uomini una
partecipazione a tutte le emozioni del nostro cuore, e nulla che ci urti quanto la manifestazione
contraria. […] Ma sia il piacere che il, dolore sono sempre sentiti in modo così immediato, e spesso
in così frivole occasioni, che sembra evidente che nessuno dei due può esser fatto derivare da una
qualsivoglia considerazione di interesse egoistico.» (Smith 1759, Teoria 89) Il piacere nella
simpatia ha dunque una doppia causa: ciò che suscita in noi un’emozione (e ciò richiede amor di sé,
“egoismo”), la partecipazione altrui alle nostre emozioni (qualcuno con cui condividerle), per
condivisione e simpatia, quindi disinteressatamente. Nella doppia situazione, del piacere e del
dolore: «La parola simpatia, nel suo significato più proprio e primitivo, denota il nostro sentimento
di partecipazione alle sofferenze, non ai piaceri degli altri. […] Ma se non prendiamo interamente
parte alla gioia di un altro e non la condividiamo del tutto, non abbiamo alcun genere di
considerazione o alcun genere di partecipazione per essa.» (Smith 1759, Teoria 139,140) ed è come
se noi gli negassimo, quella gioia, sminuendola per non partecipazione.
1.2.2.1. per definizione “e-contrario” Smith presenta la definizione di non civile, del selvaggio (in
nuova versione teorica, ma molto vicino a tipologie in essere) come assenza di simpatia. «Prima di
poter avere forti sentimenti per gli altri, dobbiamo in una certa misura star bene noi stessi. Sotto i
severi morsi della miseria, non abbiamo tempo per occuparci di quella del nostro prossimo, e tutti i
selvaggi sono troppo occupati con i loro bisogni e le loro necessità, per prestare attenzione a quelli
di altre persone. Perciò, un selvaggio, qualsiasi sia la natura della propria angoscia, non si aspetta
simpatia da chi gli sta vicino, e perciò detesta mettersi in mostra, lasciandosi sfuggire la minima
debolezza. Egli non permette mai che le sue passioni, per quanto furiose e violente, disturbino la
serenità del suo atteggiamento o la compostezza della sua condotta e del suo comportamento.»
(Smith 1759, Teoria 410)
1.2.2.2. Sentimento some solido fondamento morale e sociale; principio interno e di relazione:
interno e non esterno all’individuo e alla società; in quanto fondate sul sentimento / simpatia, le
regole qui non sono precetti esterni ma assumono le forme condivise del vivere civile in costumi e
abitudini diventati una seconda natura. Se i principi morali sono precetti razionali esterni collocano
la morale e la politica nel campo del dovere e dell’obbligazione; se si fondano su un sentimento
morale, e in particolare sulla simpatia, allora la regola diventa un sentire morale convinto e
condiviso e dunque si trasforma in sentire civile rafforzato nel proprio ruolo etico. Il sentimento ha
inoltre nella condivisione e nella compartecipazione (sim-patia) la propria condizione di realtà.
«Una filosofia morale così intesa si impegna nel tentativo di individuare i principi della morale, del
diritto, del governo della cosa pubblica e della produzione delle ricchezze con ricerche sistematiche
su questi diversi settori che possono raggiungere un’ampiezza, profondità e indipendenza mai prima
realizzate.» (Eugenio Lecaldano in Introduzione a Smith, 1759, 11)
1.2.2.2.1. Echi, richiami o le eredità. Il ruolo indispensabile del sentimento nella fondazione di un
vivere morale e politico fondate su leggi operanti e rispettate in forza della condivisione è una
eredità platonica. Il tema è presentato nel dialogo Protagora:«Zeus, preoccupato che la stirpe
umana si estinguesse, decise di mandare Ermes con due doni: il pudore e la giustizia, come base su
cui edificare le loro città e comporre dei vincoli di amicizia reciproci» (Protagora 322 cd) e ripreso
nelle Leggi. Il pudore è l’interiorizzazione e quindi il rafforzamento della giustizia e della legge che
diventano così senso morale e sentire civile. Di fronte alla trasgressione non è la paura della
punizione a generare il senso morale ma la vergogna o il pudore nei confronti della trasgressione
stessa. L’assenza di vergogna è la morte della legge, sia perché viene trasgredita, ma soprattutto
perché viene trasgredita senza pudore e senza vergogna, spudoratamente; si segnala così,
indirettamente, che la legge viene avvertita come un nemico, un ostacolo; l’assenza di vergogna è
morte della legge e della polis. Giuseppe D’Avanzo (Il guscio vuoto. Metamorfosi di una
democrazia, Laterza Roma-Bari 2012) nel denunciare gli atti che hanno smontato in Italia, nei circa
5
quindici anni che precedono il 2012, i dispositivi e gli apparati dello Stato democratico
costituzionale di diritto, cita due fattori: eccezione e menzogna; sono l’esatto contrario dei due doni
che Zeus ha dato agli uomini, preoccupato che la stirpe umana si estinguesse: la giustizia e il
pudore. (e cfr. Nussbaum Martha C. 2004 Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge.
Carocci editore, Roma 2005)
1.3. lo spazio dell’immaginazione; in coerenza con il proposito di non collocare la morale
nell’ambito della sola ragione e allo scopo di indicarne il fondamento nella simpatia.
Nelle analisi sviluppate in principi che guidano le ricerche filosofiche, Smith condivide (con Hume)
«la posizione di privilegio assunta dall’immaginazione come principio di connessione nell’attività
della mente. […] L’immaginazione, secondo Smith non ha il compito di rendere conto della
struttura delle nostre esperienze abituali, ma piuttosto di svilupparsi in modo più creativo fino al
punto di trovare spiegazioni che ricostituiscano un ordine, magari diverso da quello perduto con
l’evento che suscita sorpresa e meraviglia. […] L’immaginazione, secondo Smith, si spinge ben al
di là dei dati percettivi di partenza inventando teorie che presentano un contesto del tutto nuovo in
cui i fenomeni che avevano provocato sorpresa o meraviglia trovano una spiegazione.» (Eugenio
Lecaldano in Introduzione a Smith, 1759 Teoria, 20-21)
«Dal momento che non abbiamo esperienza diretta di ciò che gli altri uomini provano, non
possiamo formarci alcuna idea della maniera in cui essi vengono colpiti in altro modo che col
concepire ciò che noi stessi proveremmo nella stessa loro situazione. […] … è solo attraverso
l’immaginazione che noi possiamo concepire quali siano le sue sensazioni. E tale facoltà non può
aiutarci in questo, altro che col rappresentarci quali sarebbero le nostre sensazioni se fossimo noi al
posto suo. Sono solo le impressioni dei nostri sensi, non quelle dei suoi, che le nostre
immaginazioni copiano. Con l’immaginazione noi ci mettiamo nella sua situazione, ci
rappresentiamo mentre proviamo tutti i suoi stessi tormenti, come se entrassimo nel suo corpo, e
diventiamo in una certa misura la sua stessa persona e di qui ci formiamo qualche idea delle sue
sensazioni e proviamo persino qualcosa che, nonostante di grado più debole, non è del tutto diverso
da esse. […] Che questa sia l’origine del nostro sentimento di partecipazione per la miseria altrui,
che questo avvenga tramite un immaginario scambio di posto con chi soffre, che noi arriviamo a
concepire ciò che egli prova, o a esserne colpiti, può essere dimostrato attraverso molte ovvie
osservazioni …» (Smith 1759, Teoria 81-82)
1.4. Il principio dello spettatore. Per molti aspetti e accezioni la posizione e l’ipotesi dello
spettatore diventano fondamento per una teoria morale dei sentimenti
1.4.1. L’osservazione come metodo che sostiene il rispetto per l’esperienza e guida alla sua
continua scoperta: osservare per cogliere, descrivere comportamenti e la morale in atto, nella sua
realizzazione sociale.
1.4.2. L’osservazione della condotta sociale, dunque su base empirica, si colloca all’origine del
formarsi delle regole e del nostro sentimento morale. «Le nostre continue osservazioni sulla
condotta degli altri impercettibilmente ci conducono a formarci certe regole generali su ciò che è
adeguato e appropriato fare o evitare.» (Smith 1759, Teoria 330) «Noi non approviamo o
condanniamo all’origine azioni particolari perché al nostro esame esse risultano in accordo o
inconsistenti con una certa regola generale. Al contrario, la regola generale è formulata scoprendo
per esperienza che tutte le azioni di un certo tipo, o caratterizzate in un certo modo, vengono
approvate o disapprovate. […] quelle regole generali sono tutte formulate in base all’esperienza che
abbiamo avuto degli effetti che le azioni dei diversi tipi producono naturalmente in noi.» (Smith
1759, Teoria 331, 332)
1.4.3. Il principio dello spettatore consente il passaggio e la connessione tra il sentimento morale e
il giudizio morale su di sé e per gli atti sociali. Dallo sguardo esterno nasce la sguardo e la scoperta
interna, la percezione e il giudizio di sé, nasce lo spettatore interiore; ed è in questa relazione che si
6
colloca il sentimento della simpatia, della partecipazione, fondamento del sentire morale. «L’uomo
che sente di più le gioie e le sofferenze degli altri è più adatto ad acquisire il più completo controllo
delle proprie gioie e delle proprie sofferenze.» (Smith 1759, Teoria 320) Viceversa: «L’uomo
interiore, l’astratto e ideale spettatore dei nostri sentimenti e della nostra condotta, ha bisogno
spesso di essere svegliato e richiamato al suo dovere dalla presenza dello spettatore reale, ed è
sempre da quello spettatore, da cui non possiamo aspettarci che la minima simpatia e la minima
indulgenza, che con ogni probabilità impareremo la più completa lezione di dominio di noi stessi.»
(Smith 1759, Teoria 322)
Dunque le direzioni dell’osservare: cogliere i comportamenti, partecipare con simpatia alle vicende
dell’altro, diventare spettatori di sé. «Supponiamo di essere gli spettatori del nostro stesso
comportamento e cerchiamo di immaginare l’effetto che ci farebbe, visto sotto questa luce. Questo è
l’unico specchio col quale possiamo, in qualche misura, con gli occhi degli altri, analizzare
1’appropriatezza della nostra condotta.» (Smith 1759, Teoria 256)
1.4.3.1. La metafora dello spettatore compare nella produzione filosofica del periodo ellenistico, la
formula Lucrezio all’inizio del secondo libro del De rerum natura, presentando l’ideale epicureo
della serena tranquillità etica: «È dolce, quando i venti sconvolgono la superficie delle acque del
mare sconfinato, osservare da terra il pericolo altrui: non già perché rechi gioia e piacere che
qualcuno sia in difficoltà, ma perché è dolce osservare di quali mali tu stesso sei privo. Dolce è
altresì osservare le grandi contese della guerra dispiegate nelle pianure, senza che tu corra alcun
pericolo. Ma nulla è più dolce che abitare i luoghi sereni protetti dalla sapienza dei filosofi, da cui tu
possa vedere ed osservare gli altri che vagano e, sbandati, cercano la via della vita; che gareggiano
con l'ingegno, contendono in nobiltà di spirito, si affaticano giorno e notte senza tregua per
emergere ai sommi fastigi ed impadronirsi del potere. Oh infelici menti degli uomini, oh animi
ciechi!» La scena, naufragio con spettatore, può suonare impietosamente “cinica” (usando il
termine in senso comune, non filosofico), è giocata tuttavia su di una doppia componente
dell’osservazione etica, la partecipazione emotiva, il distacco della conoscenza e del giudizio.
Scrive Smith: «La compassione dello spettatore deve sorgere interamente dalla considerazione di
ciò che lui stesso proverebbe se fosse ridotto nella stessa infelice situazione, rimanendo, cosa forse
impossibile, allo stesso tempo capace di osservarla con la sua attuale ragione e il suo attuale
giudizio.» Non dobbiamo perdere la posizione dello spettatore. Questo è il principio dell’etica. Il
contrario è non vedere o non volere vedere o perché si è troppo nei fatti, si è naufraghi in un gorgo
in cui ha valore solo la reciproca emulazione, e ormai incapaci di guardare con serenità, o perché si
è deciso di non vedere, negando ogni forma di partecipazione e simpatia con l’accadere degli
eventi. In entrambi i casi l’etica è negata. Naufragio con spettatore diventa la definizione dell’etica;
ciò che accade è spettacolo di cui si è spettatori con simpatia di comprensione, di immedesimazione
e partecipazione, ma ad un tempo lontani per conservare la capacità di vedere e prender giudizio;
spettatori, innanzitutto, a noi stessi e nostri giudici in forza di uno sguardo esterno.
1.4.4. Lo spettatore interiore sede e principio di moralità. In molti passaggi e con diverse formule
Smith presenta lo “spettatore interiore” e su di esso costruisce la propria teoria dei sentimenti
morali: spettatore interiore imparziale, giudice equo interiore, grande ospite del nostro cuore, quindi
universale, giudice immediato dell’umanità, semidio interiore. Formule con cui Smith pone al
centro il soggetto nella propria capacità di osservazione e di giudizio morale.
«Non riusciamo mai a esaminare i nostri sentimenti e motivazioni, non riusciamo mai a formulare
nessun giudizio su di essi, se non ci spostiamo dalla nostra posizione naturale e ci sforziamo di
osservarli da una certa distanza. Ma non possiamo fare questo se non sforzandoci di osservarli con
gli occhi degli altri, o così come si suppone che gli altri li osserverebbero. Perciò, qualsiasi giudizio
possiamo formulare su di essi dovrà sempre contenere qualche riferimento nascosto a quelli che
sono o che a certe condizioni sarebbero, o che immaginiamo dovrebbero essere, i giudizi degli altri.
Ci sforziamo di esaminare la nostra condotta come immaginiamo che la esaminerebbe ogni altro
equo e imparziale spettatore. Se, mettendoci al suo posto, prendiamo parte del tutto alle passioni e
alle motivazioni che l’hanno influenzata, l’approviamo, per simpatia con l’approvazione di questo
7
immaginato giudice equo. Se questo non succede, prendiamo parte alla sua disapprovazione, e
condanniamo la nostra condotta.» (Smith 1759, Teoria 252-3)
1.4.5. La stessa emozione provata, oltre al dato esterno che la provoca, prevede la condivisione e la
partecipazione perché possa confermarsi come evento per noi, e anche quando questo spettatore
esterno non si dà, percepiamo quelle emozioni come spettatori a noi stessi; la riflessione è come una
presenza a sé e una autopartecipazione che fa dell’emozione e della passione un evento che
registriamo come momento del nostro vivere e evento di partecipazione etica.
1.4.6. Naufragio senza spettatore può diventare, per contrasto, la metafora di situazioni culturali
contemporanee in cui a fronte dei rischi drammaticamente denunciati in cui si trovano coinvolti
l’ambiente, la natura, l’umanità, il futuro preferiamo minimizzare, girare la testa per non vedere,
negare la funzione e il ruolo di spettatori, escludere la responsabilità morale sui temi segnalati.
2. la società e le passioni
Sotto la guida e il giudizio morale dello spettatore, interno ed esterno, Smith avvia l’indagine dei
modi del sentimento ed espone in forma di visione complessiva, di teoria, la mappa delle passioni in
cui il sentimento si manifesta, descrivendo e costruendo la trama dei comportamenti umani nel
sociale e le svariate tipologie di vita di cui sono espressione.
2.1. la società. «E così l’uomo, che può sopravvivere solo nella società, è stato reso adatto dalla
natura a quella situazione per cui è stato creato.» (Smith 1759, Teoria 210)
2.1.1. È il luogo naturale del comporsi armonico o della gestione appropriata dei sentimenti, delle
passioni e delle virtù. «La società e la conversazione, perciò, sono i rimedi più potenti per riportare
la mente alla sua tranquillità, se in qualsiasi momento l’ha sfortunatamente perduta, così come sono
i migliori modi per mantenere quel carattere equilibrato e felice, che e così necessario per la propria
soddisfazione e la propria gioia. Gli uomini solitari e speculativi, che tendono a starsene in casa a
rimuginare le proprie pene o il proprio risentimento, nonostante possano spesso possedere una
maggiore umanità, una maggiore generosità, un più spiccato senso dell’onore, raramente
possiedono quell’equilibrio così comune tra gli uomini di mondo. […]
Su questi due diversi sforzi, quello dello spettatore di entrare nei sentimenti della persona
principalmente coinvolta, e quello della persona principalmente coinvolta di attutire le sue emozioni
fino a un livello condivisibile dallo spettatore, si fondano due diversi gruppi di virtù. Le virtù miti,
gentili, amabili, le virtù della leale condiscendenza e dell’indulgente umanità sono fondate sul
primo; le virtù solenni, maestose e degne di rispetto, le virtù dell’abnegazione, della padronanza di
sé, di quel dominio delle passioni capace di sottomettere tutti i moti della nostra natura a ciò che la
nostra dignità, il nostro onore e l’appropriatezza della nostra condotta richiedono, derivano
dall’altro.» (Smith 1759, Teoria 105-106)
2.1.2. La relazione bivalente. Dalla società riceviamo formazione e benessere, tutto ciò che diventa
in noi persona perciò sentimenti e comportamenti; la società deve essere da noi difesa contro ogni
forma di ingiustizia, «poiché la società non può sussistere a meno che le leggi della giustizia non
siano accettabilmente osservate» (Smith 1759, Teoria 213) (‘accettabilmente’ e non per sola
costrizione). «Lo stato o il regno nel quale siamo nati e siamo stati allevati, e sotto la cui protezione
continuiamo a vivere, è normalmente la più grande società sul cui benessere o sulla cui miseria la
nostra condotta buona o cattiva può avere molta influenza. Perciò è quella che ci viene più
vivamente raccomandata dalla natura. In essa non siamo compresi solo noi …» (Smith 1759, Teoria
450)
2.1.3. La metafora dell’armonia della macchina sociale. «La società umana, quando la
contempliamo in una luce astratta e filosofica, appare come una grande, immensa macchina, i cui
movimenti armoniosi e regolari producono migliaia di effetti gradevoli. In ogni altra bella e nobile
macchina prodotta dall’arte umana, qualsiasi cosa tenda a rendere i suoi movimenti più dolci e facili
riceve una certa bellezza da questo effetto, e al contrario, qualsiasi cosa tenda a ostruirli a causa di
ciò risulta spiacevole; allo stesso modo, la virtù, che è come un fine lubrificante per gli ingranaggi
8
della società, necessariamente piace, laddove il vizio altrettanto necessariamente offende, come
spregevole ruggine, che fa stridere e cigolare gli ingranaggi gli uni sugli altri.» (Smith 1759, Teoria
595)
2.2. le passioni
La descrizione e costruzione del sociale non prende più le mosse da un ipotetico stato di natura a
cui, per converso e per contratto, si contrappone la società fondata sulle clausole di un patto sociale.
Su quella base naturale infatti la società diventa una costruzione ideale, non trova riscontro, se non
come obiettivo astratto, nella situazione delle relazioni sociali esistenti, non spiega i numerosi
comportamenti contrari al sociale che la segnano fino a minacciarne l’esistenza. Con metodo
descrittivo Smith affronta il tema delle dinamiche sociali a partire dalla descrizione delle passioni,
forme in cui si esprime il sentimento, principio della morale.
2.2.1. passioni asociali «l’odio e il risentimento con tutte le loro diverse modificazioni» (Smith
1759, Teoria 123). La società può esistere anche come intreccio di pulsioni asociali: odio,
risentimento, vendetta, ambizione, invidia, ira, malizia… asociali perché sono «affezioni che
dividono gli uomini gli uni dagli altri, e che tendono a spezzare i legami della società» (Smith 1759,
Teoria 475). Affezioni che diventano vizi distruttivi non in sé ma quando sono privi di
appropriatezza, privi di misura; alla appropriatezza occorre guardare per definirne lo stato morale.
Anche in una simile società esistono tuttavia regole, accordi per una “insocievole socievolezza”.
Ma una società insocievole ha in sé i germi per la propria distruzione ed è l’assenza di giustizia a
determinarla.
2.2.1.1. appropriatezza. L’accurata (appassionata e rispettosa) osservazione dei comportamenti
sociali porta Smith alla convinzione della impossibilità di catalogare le passioni in cui si esprime il
sentimento morale secondo le categorie della virtù e del vizio, come fossero tabelle separate di
comportamenti tra loro opposti in termini dualistici di bene e male, giusto e ingiusto. Ambizione,
egoismo, odio, risentimento e le molte altre passioni connesse non sono di per sé vizi, come non
sono di per sé virtù la solidarietà, la stima, la gratitudine. È l’appropriatezza a renderle tali; e questa
caratteristica a sua volta si rapporta ed è definita o dalla causa che determina la passione o
dall’effetto che essa produce. In forza di una tale impostazione si afferma indirettamente che non
sono le tabelle dei vizi e delle virtù ad avere il ruolo di fondamento delle regole e del giudizio
morale, ma la persona che agisce in quanto è mossa, nel suo decidere e giudicare, dallo spettatore
interiore equo e imparziale.
«Il sentimento o affezione del cuore, da cui deriva ogni azione, e da cui dipende tutta la sua virtù o
il suo vizio, può essere considerato sotto due differenti aspetti, o in due differenti relazioni: primo,
in relazione alla causa che lo provoca, o al motivo che gli offre l’occasione; secondo, in relazione al
fine che propone o effetto che tende a produrre.
Nell’adeguatezza o inadeguatezza, nella proporzione o sproporzione dell’affezione rispetto alla
causa o oggetto che la suscita, consiste l’appropriatezza o l’inappropriatezza, la buona creanza o la
malagrazia dell’azione conseguente.» (Smith 1759, Teoria 96-97)
2.2.1.2. “insocievole socievolezza”. L’espressione, ossimorica, verrà utilizzata da Kant, nel 1784,
per indicare il fatto che l'essere umano si realizzi nella società, ma in antagonismo con gli altri; gli
esseri umani tendono ad associarsi, ma nello stesso tempo ognuno di loro vorrebbe fare quello che
gli pare. Si produce così una rivalità e una competizione che sono tuttavia (forse già per via di una
“mano invisibile”) all'origine del progresso tecnico, culturale e infine morale. Smith descrive la
situazione di una società che è caratterizzata da passioni asociali: «La società può sussistere tra
uomini diversi, come tra diversi mercanti, per il senso della sua utilità, senza alcun amore o affetto
reciproco; e anche se nessun uomo in essa dovesse essere soggetto ad alcun obbligo, o avere legami
di gratitudine con un altro, sarebbe tuttavia tenuta in piedi da un mercenario scambio di buoni uffici,
secondo una concorde valutazione. Tuttavia non può sussistere società tra coloro che sono sempre
pronti a ferirsi e offendersi l’un l’altro. Nel momento in cui comincia l’offesa, nel momento in cui si
manifestano risentimento e animosità reciproca, tutti i suoi legami si spezzano e tutti i membri di
9
cui essa è composta è come se fossero dispersi e sparsi lontano dalla violenza e dall’opposizione
dei loro affetti discordanti. Se esiste una società di ladri e assassini, essi devono almeno, secondo
un’osservazione banale, astenersi dal derubarsi e uccidersi l’un l’altro. Perciò la beneficienza è
meno essenziale della giustizia all’esistenza della società. La società può sussistere, anche se non
nel migliore dei modi, senza beneficienza; ma, necessariamente, il prevalere dell’ingiustizia la
distrugge del tutto.» (Smith 1759, Teoria 210-211) [Anche un popolo di diavoli, se intelligenti,
sceglierebbe un ordinamento basato regole e istituzioni; così affermerà Kant nella Garanzia per la
pace perpetua del 1795]
2.2.1.3. L’intreccio sociale di elementi socievoli e asociali capace di dar vita a un mondo di
relazioni nella quali è difficile (impossibile) separare secondo giusto e ingiusto elementi con
evidenza eterogenei (furbizia, violenza, furfanteria, indulgenza, odio, disprezzo, ammirazione
derisione) è descritto con vivacità da Smith. «Il furfante astuto, che per la sua abilità e la sua
destrezza si salva, se non da gravi sospetti, almeno dalla punizione o dal palese smascheramento,
viene troppo spesso accolto nel mondo con un’immeritata indulgenza. Il furfante imprudente e
stolto, che, per mancanza di destrezza e abilità, viene accusato e condannato è oggetto di universale
odio, disprezzo e derisione. In paesi nei quali i grandi crimini spesso restano impuniti, le azioni più
atroci diventano familiari, e smettono di impressionare la gente con quell’orrore con cui vengono
accolte in paesi in cui la giustizia è amministrata correttamente.» (Smith 1759, Teoria 432) «La
violenza e l’ingiustizia dei grandi conquistatori vengono spesso considerate con stolta meraviglia e
ammirazione, quella dei piccoli ladri, rapinatori e assassini vengono considerate sempre con
disprezzo, odio e persino orrore. Le prime, sebbene cento volte più cattive e distruttive, se hanno
successo, passano per segni di eroico coraggio. Le seconde sono sempre considerate con odio e
avversione, come le follie e i crimini dell’umanità più bassa e insignificante.» (Smith 1759, Teoria
433-434)
2.2.2. passioni sociali. «La generosità, l’umanità, la gentilezza, la compassione, l’amicizia
reciproca e la stima, tutte le affezioni sociali e benevole, quando vengono espresse
nell’atteggiamento e nel comportamento, anche nei riguardi di coloro che non sono particolarmente
legati a noi, compiacciono quasi sempre lo spettatore indifferente. La sua simpatia per la persona
che prova quelle passioni coincide esattamente con la sua preoccupazione per la persona che ne è
oggetto. L’interesse che, come uomo, lo spettatore è obbligato ad avere per la felicità di
quest’ultima ravviva il suo sentimento di partecipazione per i sentimenti dell’altra persona, le cui
emozioni sono impegnate sullo stesso oggetto. Per questo e abbiamo sempre una forte disposizione
a simpatizzare con le affezioni benevole. » (Smith 1759, Teoria 131)
2.2.2.1. Essenza delle passioni sociali e della socievolezza è il sentimento della simpatia,
fondamento dell’agire morale. Smith presenta una “socievole socievolezza” sorretta da tutta una
serie di passioni che esprimono la simpatia, la capacità di partecipare con immediatezza ai
sentimenti dell’altra persona. La società che fa riferimento alla socievolezza e alle passioni sociali è
una società in cui la socievolezza non è questione soltanto di leggi, ma prima e forse soprattutto di
sentimenti, di relazioni fondate sulla simpatia, principio cardine della moralità in quanto simpatia è
partecipazione e condivisione.
2.2.2.2. Ancora l’appropriatezza decide della bontà anche delle passioni sociali; anche qui
l’intreccio è complesso e non può diventare vittima di semplificazioni. «La disposizione verso le
affezioni che tendono a unire gli uomini in società, cioè la disposizione verso la bontà, la gentilezza,
l’affetto naturale, la stima, può a volte essere eccessiva. Tuttavia, anche l’eccesso di questa
disposizione rende un uomo degno d’interesse per tutti. Anche se la critichiamo, continuiamo a
considerarla con indulgenza, e anche con gentilezza, ma mai con disgusto. Ne siamo più spiacenti
che irati. Per la persona stessa che prova tali affezioni, lasciarsi andare a esse in molte occasioni e
non solo gradevole, ma bellissimo. In verità, in alcune occasioni, quando queste affezioni sono
dirette verso oggetti non meritevoli, come troppo spesso accade, la persona che le prova è esposta a
un’autentica e profonda angoscia. Anche in simili casi, tuttavia, una mente ben disposta considera
quella persona con la più sentita pietà, e prova la più grande indignazione verso chi fa mostra di
10
disprezzarla per la sua debolezza e imprudenza. Al contrario, il difetto di questa disposizione, che
viene chiamato durezza di cuore, nel rendere un uomo insensibile ai sentimenti e alle angosce degli
altri, allo stesso modo rende gli altri altrettanto insensibili verso i suoi, e, privandolo dell’amicizia
del mondo intero, lo priva dei migliori e più consolanti piaceri sociali.» (Smith 1759, Teoria 474475)
2.2.3. passioni egoistiche. «Oltre a queste due opposte serie di passioni, quelle sociali e quelle
asociali, ce n’è un’altra che occupa quasi un posto di mezzo: non è mai cosi attraente come a volte
lo è l’una, né cosi odiosa come lo è a volte l’altra. Questa terza serie di passioni è costituita dalla
pena e dalla gioia che noi traiamo dal considerate la nostra buona o cattiva fortuna privata. Anche
quando sono eccessive, non sono mai così spiacevoli come l’eccessivo risentimento, perché nessuna
simpatia opposta può mai farci volgere contro di esse; anche quando sono del tutto adatte ai loro
oggetti, non sono mai così piacevoli quanto l’imparziale sentimento di umanità e la corretta
benevolenza, perché nessuna doppia simpatia ci può spingere verso di esse.» (Smith 1759, Teoria
134) Quando nel sociale irrompe il privato, irrompono le passioni egoistiche improntate all’amor di
sé, è necessario allora procedere con la prudenza richiesta dalle situazioni intermedie. Non sono
passioni liquidabili come asociali perché la società non esiste per se stessa ma come luogo in cui la
persona trova realizzazione, è per questo infatti che la società va difesa dal potenziale distruttivo
presente nelle passioni asociali. Non sono però per se stesse sede in cui la simpatia, la
partecipazione principio di moralità, trova la propria realizzazione, quindi non sono luogo della
perfezione morale.
Nelle passioni egoistiche, che occupano “un posto di mezzo” nel quadro delle passioni composto da
Smith, prende forma e movimento la visione complessiva di Smith sull’uomo e sulla società; la sua
attenzione si rivolge infatti a quelli che chiama «i più straordinari e importanti oggetti di interesse
egoistico». Si tratta di passioni che possono sconfinare nelle passioni asociali e mettere a rischio la
macchina armonica della società, ma si tratta anche di passioni che danno densità, senso e sostegno
alle passioni sociali che non possono proclamarsi soggetto primo di moralità, norme eteronome ed
esterne, al di sopra delle persone. La loro posizione mediana si traduce in un progetto di
conciliazione tra gli estremi imprescindibili di utile e morale, privato e pubblico, istinto e ragione e
altri dualismi solitamente scomposti e alla deriva in morali sociali e politiche totalitarie e
oppressive.
2.2.3.01. L’elogio delle passioni di mezzo o la rivalutazione sociale dell’amor di sé e dell’egoismo,
per il ruolo personale che tali passioni svolgono e per i benefici sociali che ne derivano si
accompagna all’elogio del ceto medio, della sua condotta virtuosa garanzia di produttività
economica, di benessere sociale, di ordine civile e di progressi nella civilizzazione.
2.2.3.1. l’appropriatezza delle passioni egoistiche: «Le cose stanno molto diversamente riguardo ai
più straordinari e importanti oggetti di interesse egoistico. Una persona che non li persegua con un
certo grado di fervore, e per loro stessi, appare meschina. Disprezzeremmo un principe che non
fosse ansioso di conquistare o difendere una provincia. Avremmo poco rispetto per un gentiluomo
che non si sforzasse di conquistare una posizione sociale, o anche un incarico importante, quando
gli sarebbe possibile farlo senza ricorrere a meschinità o ingiustizie. Un membro del parlamento che
non mostri entusiasmo per la sua elezione viene abbandonato dai suoi amici, in quanto del tutto
immeritevole della loro devozione. Persino un mercante che non si dà da fare per qualche affare .
vantaggioso, o per qualche grosso profitto, viene considerato dagli altri un povero diavolo. Questa
energia e questo entusiasmo costituiscono la differenza tra l’uomo intraprendente e l’apatico. I
grandi oggetti di interesse egoistico, la cui perdita o il cui acquisto cambiano molto il rango delle
persone, sono gli oggetti della passione propriamente detta ambizione, una passione che, quando si
mantiene nei limiti della prudenza e della giustizia, viene sempre ammirata nel mondo, e possiede a
volte un certo strano fascino che abbaglia l’immaginazione, anche quando oltrepassa i limiti di
quelle due virtù [prudenza e giustizia], e non è solo ingiusta, ma anche stravagante. Di qui la
generale ammirazione per gli eroi e i conquistatori, e anche per gli uomini politici che…» (Smith
1759, Teoria 355-356) Senza un movente e un coinvolgimento egoistico l’azione non è piena,
11
partecipata, coinvolgente, non sembra fondarsi sulla simpatia e sul sentimento; la moralità non
definisce con completezza l’agire della persona ma diventa solo rispetto e applicazione formale di
leggi.
2.2.3.2. egoismo e virtù (elogio dell’egoismo, in situazione): «Non siamo preparati a sospettare che
una persona manchi di egoismo: questo non è affatto il lato debole della natura umana, o il difetto di
cui tendiamo a essere sospettosi.» «In molte occasioni, anche la considerazione per la nostra
personale felicità e per il nostro personale interesse appare un principio d’azione del tutto lodevole.
Si suppone che l’abitudine all’economia, all’industriosità, alla discrezione, all’attenzione,
all’applicazione e alla riflessione sia generalmente coltivata per motivi di interesse egoistico, ma
nello stesso tempo queste sono qualità degne di lode, che meritano la stima e l’approvazione di
ognuno. La mescolanza di un movente egoistico, è vero, spesso sembra macchiare la bellezza delle
azioni che dovrebbero derivare da un’affezione benevola. La causa di ciò, tuttavia, non è che l’amor
di sé non può mai essere il movente di un’azione virtuosa, ma che il principio benevolo in questo
caso particolare sembra mancare del suo dovuto grado di forza, ed essere del tutto inadatto al suo
oggetto. Perciò il carattere dell’agente sembra evidentemente imperfetto, e biasimevole piuttosto
che lodevole. Invece, la mescolanza di un movente benevolo in un’azione che abbia già nell’amor
di sé una spinta sufficiente non è altrettanto in grado di diminuire il nostro senso dell’appropriatezza
dell’azione, o della virtù di chi quell’azione compie. Non siamo preparati a sospettare che una
persona manchi di egoismo: questo non è affatto il lato debole della natura umana, o il difetto di cui
tendiamo a essere sospettosi. Tuttavia, se potessimo davvero credere di un uomo che, se non fosse
per riguardo alla sua famiglia e ai suoi amici, egli non si prenderebbe appropriata cura della propria
salute, della propria vita, dei propri averi, cosa verso la quale basterebbe a spingerlo
l’autoconservazione, riterremmo senza dubbio questa una sua mancanza, per quanto una di quelle
amabili mancanze, che rendono una persona più oggetto di pietà che di odio o disprezzo. Tuttavia,
farebbe diminuire la dignità e la rispettabilità del suo carattere. La mancanza di cura e di economia
sono universalmente disapprovate, ma non perché derivino da una mancanza di benevolenza, bensì
perché derivano da una mancanza dell’attenzione appropriata per gli oggetti di interesse egoistico.»
(Smith 1759, Teoria 575-576) Nessuna virtù ha sostanza e durata se non richiama a sé, si nutre e
soddisfa tendenze naturali solitamente chiamate vizi: egoismo, orgoglio, vanità, competizione…
Viceversa i vizi vengono corretti e redenti moralmente non quando vengono repressi ma dirottati,
investiti e realizzati in azioni ci cui esiti producono un beneficio generale. [In questo contesto si
inserisce il ripetuto confronto di Smith con le tesi di Mandeville].
2.2.3.3. egoismo privato e pubblici benefici: «I ricchi non fanno altro che scegliere nella grande
quantità quel che è più prezioso e gradevole. Consumano poco più dei poveri, e, a dispetto del loro
naturale egoismo e della loro naturale rapacità, nonostante non pensino ad altro che alla propria
convenienza, nonostante l’unico fine che si propongono dando lavoro a migliaia di persone sia la
soddisfazione dei loro vani e insaziabili desideri, essi condividono con i poveri il prodotto di tutte le
loro migliorie. Sono condotti da una mano invisibile a fare quasi la stessa distribuzione delle cose
necessarie alla vita che sarebbe stata fatta se la terra fosse stata divisa in parti uguali tra tutti i suoi
abitanti, e così, senza volerlo, senza saperlo, fanno progredire l’interesse della società, e offrono
mezzi alla moltiplicazione della specie. Quando la Provvidenza divise la terra tra pochi proprietari,
non dimentico né abbandonò quelli che sembravano esser stati lasciati fuori dalla spartizione.
Anche questi ultimi hanno la loro parte in quel che la terra produce. Per quel che costituisce la reale
felicità della vita umana, non sono sotto nessun rispetto inferiori a quelli che sembrerebbero molto
al di sopra di loro. Nel benessere fisico e nella tranquillità mentale, tutti i diversi ranghi della vita
sono quasi sullo stesso piano, e il mendicante che si crogiola al sole al margine della strada possiede
quella sicurezza per la quale i re combattono.» (Smith 1759, Teoria 375-376)
2.2.4. una sintesi: il giudizio morale alla presenza dell’“egoismo”, dell’“amor di sé” in situazione
antropologica globale. Smith studia «i diversi sistemi morali che sono stati costruiti riguardo al
principio dell’approvazione» (parte VII, sezione III, Smith 1759, Teoria 593ss). I sistemi morali si
costruiscono (anche) per indicare «il potere o la facoltà mentale che ci rende alcuni caratteri
12
gradevoli o sgradevoli, che ci fa preferire una linea di condotta a un’altra, denominare l’una giusta e
l’altra ingiusta, e considerare l’una oggetto di approvazione, onore e ricompensa, l’altra oggetto di
biasimo, critica e punizione.» (Smith 1759, Teoria 593) Il risultato della ricerca è il seguente:
«L’amor di sé, la ragione e il sentimento… sono le tre diverse origini che sono state indicate per il
principio di approvazione.» (Smith 1759, Teoria 593). L’analisi dei tre sistemi e delle tre ipotesi di
fondamento diventa contesto per sottolineare l’apporto positivo di quelle tre fonti del giudizio
morale e della nostra approvazione, e contemporaneamente denunciare le parzialità cui vanno
incontro le teorie che si fermano ad una di esse, magari assolutizzandola come principio unico di
moralità. La conclusione di Smith apre ad una visione antropologica dell’etica. Non esiste un senso
morale come senso determinato o addirittura come una «facoltà particolare» specifica che, separata
dalle altre facoltà umane, opera in campo morale determinando i gradi della nostra approvazione al
giusto e all’ingiusto. (Qui è in opera la regola di Newton, di origine scolastica: delle cose naturali
non devono essere ammesse cause più numerose di quelle che sono vere e bastano a spiegare i
fenomeni, è il non sunt multiplicanda entia sine necessitate; a meno che, osserva Smith, «qualcuno
indichi precisamente in cosa consista questo sovrappiù.» Smith 1759, Teoria 613-614) La persona
nella sua interezza (sentimento immaginazione ragione) e nella sua storicità concreta partecipa alla
situazione morale di osservazione, approvazione, scelta, azione, coinvolgimento…intreccio di
sentimenti e passioni.
«Forse ci si potrebbe aspettare che se esistesse un simile principio peculiare, come si suppone sia il
senso morale, dovremmo sentirlo, in alcuni casi particolari, separato e distaccato da ogni altro,
come spesso sentiamo la gioia, la sofferenza, la speranza, la paura, pure e non mescolate con altre
emozioni. Immagino che questo non si possa nemmeno pretendere. Non ho mai sentito riportare un
esempio in cui si potesse dire che questo principio agisse da solo e non mescolato con la simpatia o
l’antipatia, con la gratitudine o il risentimento, con la percezione dell’accordo o disaccordo di
un’azione con una regola stabilita, o infine con quel generale gusto per la bellezza e 1’ordine che
viene suscitato tanto da oggetti inanimati quanto da oggetti animati.» (Smith 1759, Teoria 614)
2.3. lo strano e ricorrente tema della “mano invisibile” (o del meccanico ottimismo sociale).
Con le parole «Sono condotti da una mano invisibile a fare quasi la stessa distribuzione delle cose
necessarie alla vita…» Smith introduce il noto tema della “mano invisibile” che compone
automaticamente, necessariamente, naturalmente gli egoismi privati in benessere collettivo:
quell’egoismo che spinge ciascuno a cercare per sé il meglio e il massimo si traduce in una
produzione di beni molto alta di cui l’intera società beneficia automaticamente e per naturale
conseguenza. Il tema diventa un luogo comune di un liberismo semplificato e diventa oggetto di
molte riserve critiche: viene letta come una versione laica della provvidenza (che lo stesso Smith
menziona immediatamente nel passo); è presente filosoficamente in altri autori, in più modi, come
un motivo ricorrente: armonia prestabilita (Leibniz), astuzia della ragione (Hegel), occasionalismo
(Descartes, Malebranche); o intesa come versione ottimistica del concetto di caso, fortuna, destino
ecc.
2.3.1. la “mano invisibile” nell’etica: non è solo la benevolenza che muove l’uomo ad agire,
l’interesse per sé e quindi l’egoismo (appropriato) diventa un’altra potente spinta che viene
riconosciuta come virtù nel comporsi delle azioni in una armonia di benessere il più possibile
collettivo. «…la mescolanza di un movente benevolo in un’azione che abbia già nell’amor di sé una
spinta sufficiente non è altrettanto in grado di diminuire il nostro senso dell’appropriatezza
dell’azione, o della virtù di chi quell’azione compie.» (Smith 1759, Teoria 576) È proprio
dell’umano la mescolanza dei moventi e, comunque, il suo esito positivo; l’agire per il solo
principio della benevolenza sembra essere proprio solo del divino: «Forse la benevolenza può
essere l’unico principio d’azione per la divinità, e ci sono molti argomenti non improbabili che
tendono a persuaderci che le cose stanno così. […] Ma in qualsiasi modo stiano le cose riguardo a
Dio, una creatura così imperfetta come l’uomo, che ha bisogno di così tante cose a sostegno della
propria esistenza, deve spesso agire in base a molti altri moventi.» (Smith 1759, Teoria 576-577)
13
2.3.2. la “mano invisibile” nell’economia: «Ognuno si sforza continuamente di trovare l’impiego
più vantaggioso per qualsiasi capitale di cui possa disporre. In verità egli mira al suo proprio
vantaggio e non a quello della società. Ma la ricerca del proprio vantaggio lo porta naturalmente, o
piuttosto necessariamente, a preferire l’impiego più vantaggioso alla società.» (Smith 1776
Ricchezza, 581) «Perciò, cercando per quanto può di impiegare il suo capitale a sostegno
dell’industria interna e di indirizzare questa industria in modo che il suo prodotto possa avere il
massimo valore, ogni individuo contribuisce necessariamente quanto può a massimizzare il reddito
annuale della società. Invero, generalmente egli né intende promuovere l’interesse pubblico né sa
quanto lo promuova. Preferendo sostenere l’industria interna anziché l’industria straniera, egli mira
soltanto alla sua sicurezza; e dirigendo quell’industria in modo tale che il suo prodotto possa avere
il massimo valore egli mira soltanto al proprio guadagno e in questo, come in molti altri casi, egli è
condotto da una mano invisibile a promuovere un fine che non entrava nelle sue intenzioni. Né per
la società è sempre un male che questo fine non entrasse nelle sue intenzioni. Perseguendo il
proprio interesse, egli spesso promuove quello della società in modo più efficace di quando intenda
realmente promuoverlo. Non ho mai visto che sia stato raggiunto molto da coloro che pretendono di
trafficare per il bene pubblico. Questa invero non è una pretesa molto comune presso i
commercianti e bastano pochissime parole per dissuaderli dal professarla.» (Smith 1776 Ricchezza,
583-584)
2.3.3. la “mano invisibile” e l’ordine sociale e “naturale”. Il tema della “mano invisibile” non
compare solo per spiegare il comporsi delle passioni nell’ordine sociale e degli egoismi privati nel
benessere collettivo; Smith ne parla nella sue lezioni di filosofia (Saggi filosofici) per spiegare in
generale fenomeni naturali e quando richiama posizioni filosofiche dello stoicismo. L’espressione
ha un carattere logico e di metodo ampio e non può essere confinata a questioni di mercato, di
produzione e di distribuzione di beni economici. Viene utilizzata «per tutti quegli equilibri che non
possono essere spiegati come risultato di azioni consapevoli dei soggetti coinvolti… […]
Probabilmente è corretto sostenere che uno dei contributi offerto da Smith con le sue ricerche è
quello di avere richiamato l’attenzione sugli equilibri che si realizzano non-intenzionalmente in una
situazione sociale.» (Lecaldano in Introduzione a Smith, 1759 Teoria, 46-47) Armonia
“necessaria” ma non prevedibile diventa un aspetto strutturale delle dinamiche della realtà sociale,
economica e politica ed è quindi vincolo di metodo per le teorie che se ne occupano. A corollario di
una metodologia empirico descrittiva del sociale e coerente con gli esiti aperti che impongono, in
tale campo, la complessità del sociale e la sua non disponibilità totale in dati di esperienza, si deve
introdurre, soprattutto nel campo delle scienze sociali il tema della non prevedibilità degli effetti e il
principio che, quando tali effetti sono noti, non riescono ad essere intesi come risultato consapevole
e intenzionale degli attori. Perciò Smith, come già riportato, invita a indagare nel campo del sociale
considerando i fatti da due differenti prospettive, relazioni o aspetti: «primo, in relazione alla causa
che lo provoca, o al motivo che gli offre l’occasione; secondo, in relazione al fine che propone o
effetto che tende a produrre.» (Smith 1759, Teoria 96)
2.3.4. la “mano invisibile” e l’autonomia dell’ordine sociale nella relazione tra azione individuale e
azione collettiva; premessa per una composizione non esterna, quindi non coercitiva né solo
volontaristica, di interesse individuale e interesse comune. Osserva Lorenzo Infantino nella
Prefazione a Hayek von Friedrich A. (Friedrich A. von Hayek) 1973, 1988 Liberalismo, ed.
Rubettino, Soveria Mannelli 2012, 12: « Chiunque voglia soddisfare i propri bisogni o realizzare i
propri progetti deve pertanto favorire il conseguimento dei fini altrui. Le azioni devono co-adattarsi.
Il che dà vita a un ordine sociale che non rientra nei piani individuali e che nessuno può
previamente programmare. Tutto ciò è stato da Adam Smith reso anche con l’immagine della
«mano invisibile»; un meccanismo sociale che, alla luce di quanto testé detto, non ha nulla di
misterioso. Indica solo che ogni atto individuale è necessariamente un Giano bifronte, al servizio di
finalità proprie e altrui. Il che è in via generale un’applicazione della teoria delle conseguenze
inintenzionali delle azioni umane intenzionali, che tra l’altro mostra come la cooperazione
14
volontaria sia un gioco a somma positiva, che avvantaggia cioè tutte le controparti: perché nessuno
liberamente accetta di partecipare a uno scambio che non possa migliorare la propria posizione.
È cosi che si dà autonomia alla società civile. Se ragioni gnoseologiche abbattono il mito del
Grande Legislatore, l’affermazione di un ordine sociale di tipo inintenzionale colma il vuoto
lasciato dalla caduta di quel mito.»
Dunque, in definitiva, il significato e la portata teorica della “mano invisibile”, come viene ripreso e
presentato da Friedrich A. von Hayek: «Il diritto e l’ordine spontaneo delle azioni. […] Come la
successiva teoria economica ha meglio chiarito, è proprio questo adattamento reciproco dei piani
individuali a mettere in grado gli uomini di rendersi reciprocamente utili, pur impiegando ciascuno
le proprie peculiari conoscenze e capacità al servizio dei propri fini personali. La funzione delle
norme di condotta non consiste quindi nell’organizzare gli sforzi individuali per il conseguimento di
obiettivi specifici e concordati, ma nell’assicurare soltanto un ordine globale delle azioni, nel cui
ambito ciascuno possa, nel perseguimento dei propri fini personali, trarre il maggior vantaggio dagli
sforzi degli altri. Le regole capaci di condurre a questo ordine spontaneo erano considerate il
prodotto di una lunga esperienza passata. E malgrado le si giudicasse suscettibili di
perfezionamento, si riteneva che tale progresso dovesse procedere lentamente, un passo dopo
l’altro, secondo i suggerimenti offerti dalle nuove esperienze.» (Hayek 1973, 46)
2.4. oltre la “mano invisibile”: giustizia e prudenza nell’arte politica
In sintesi provvisoria: l’esercizio della politica nel sociale favorisce la realizzazione etica del
sentimento e l’armonioso intreccio delle passioni imponendo il rigore della regole (giustizia) e
sostenendo la varietà degli stili (libertà; diremmo in slogan: giustizia e libertà). La metafora della
politica tra grammatica e stile è proposta da Smith.
«Le regole di giustizia possono essere paragonate alle regole di grammatica, le regole delle altre
virtù alle regole date dai critici per ottenere uno stile compositivo nobile ed elegante. Le prime sono
precise, rigorose e indispensabili. Le seconde imprecise, vaghe e indeterminate, e ci danno solo
un’idea della perfezione a cui dovremmo tendere, piuttosto che fornirci un’indicazione certa e
infallibile per ottenerla. Un uomo può imparare a scrivere in modo grammaticalmente corretto
attraverso le regole, con la più assoluta infallibilità, e allo stesso modo, forse, gli può essere
insegnato ad agire secondo giustizia. Ma non ci sono regole la cui osservanza ci farà infallibilmente
ottenere l’eleganza e la nobiltà nello scrivere, sebbene ce ne siano alcune che ci possono aiutare in
una certa misura a correggere e a fissare le vaghe idee che ci saremmo altrimenti potuti fare di
quella perfezione. E non ci sono regole dalla cui conoscenza possiamo infallibilmente imparare ad
agire in ogni occasione con prudenza, con giusta magnanimità, o appropriata beneficenza, sebbene
ce ne siano alcune che ci possono rendere capaci di correggere e fissare, sotto molti rispetti, le idee
imperfette che ci saremmo altrimenti potuti fare di quelle virtù.» (Smith 1759, Teoria 359)
2.4.1. la giustizia: «pochi hanno meditato sulla necessità della giustizia per l’esistenza della società,
per quanto ovvia tale necessità possa apparire» (Smith 1759, Teoria 216)
«La giustizia … è il principale pilastro che sostiene l’intero edificio. Se viene soppressa, la grande,
l’immensa fabbrica della società umana, quella fabbrica che in questo mondo, se posso esprimermi
così, sembra essere stata costruita e sostenuta dalla peculiare e sollecita cura della Natura,
necessariamente si sgretola in atomi in un attimo. Allo scopo di rafforzare il rispetto della giustizia,
perciò, la natura ha inculcato nell’animo umano quella coscienza del torto, quei terrori della
meritata punizione che accompagnano la violazione della giustizia, come salvaguardia
dell’associazione umana, per proteggere il debole, frenare il violento, castigare il colpevole.»
(Smith 1759, Teoria 211-212) (ricorda Platone: giustizia e vergogna i due doni di Zeus agli uomini
perché possano vivere in socievolezza)
2.4.2. la prudenza: «la durezza è il carattere più adatto alla situazione di un selvaggio, la sensibilità
a coloro che vivono in una nazione molto civile.» (Smith 1759, Teoria 416) Prudenza intesa come
saggezza, senso delle circostanze, moderazione appropriata, «sentimento di partecipazione»,
rispetto della varietà e imprevedibilità delle persone e delle situazioni; il suo contrario è lo «spirito
15
di sistema» proclamato in nome di uno “spirito civico” propagandato e perseguito con inflessibilità
e arroganza «fino alla pazzia del fanatismo», atteggiamento così illustrato da Smith: «In mezzo alla
turbolenza e al disordine delle fazioni, un certo spirito di sistema tende a mescolarsi con quello
spirito civico fondato sull’amore dell’umanità, su un vero sentimento di partecipazione per i disagi
e le angosce a cui posson venir esposti alcuni dei nostri concittadini. Questo spirito di sistema
normalmente prende la stessa direzione di quel più nobile spirito civico: lo suscita sempre, e spesso
lo infiamma fino alla pazzia del fanatismo. È raro che i capi delle parti insoddisfatte manchino di
presentare qualche plausibile piano di riforma, in grado, secondo loro, non solo di eliminare gli
inconvenienti e alleviare le angosce lamentate nell’immediato, ma anche di prevenire, per i tempi a
venire, una loro riproposizione. Propongono spesso, a tal fine, di rimodellare la costituzione,
mutando nelle sue parti più essenziali quel sistema di governo che forse ha garantito, nel corso dei
secoli, ai cittadini di un grande impero pace, sicurezza, e anche gloria. La maggior parte dei loro
seguaci vengono normalmente inebriati dalla bellezza immaginaria di questo sistema ideale, di cui
non hanno esperienza, ma che è stato loro dipinto a tinte abbaglianti dall’eloquenza dei loro capi. I
capi stessi, anche se all’inizio non miravano ad altro che all’accrescimento del loro potere, poco a
poco vengono ingannati dai loro stessi sofismi, e diventano ansiosi di questa grande riforma come il
più debole e il più sciocco dei loro seguaci. Anche se i capi riescono a conservare, come accade
comunemente, le loro teste libere da questo fanatismo, non osano deludere le attese dei loro seguaci,
ma sono spesso obbligati, per quanto in contrasto con i loro principi e la loro coscienza, ad agire
come se anch’essi fossero presi dall’illusione generale. La violenza di parte, rifiutando ogni
palliativo, ogni moderazione, ogni ragionevole compromesso, chiedendo troppo, spesso non ottiene
nulla, e quegli inconvenienti e quelle angosce, che con una piccola moderazione avrebbero potuto
venir rimossi e sanati, vengono lasciati completamente senza alcuna speranza di rimedio.» (Smith
1759, Teoria 458-459)
2.4.3. Un postulato a fondamento di giustizia e libertà: la politica non è fine a sé (per restare nella
metafora: la grammatica non è un fine, non è fine a sé, sorregge e rende possibile l’espressione nella
varietà degli stili); spesso in politica si scambiano i mezzi come fini: la politica diventa fine a se
stessa usando uomini e società come mezzi. «Tutti i governi, tuttavia, vengono valutati solo in
proporzione alla loro tendenza a promuovere la felicità di coloro che vivono sotto di essi. Questo è
il loro unico uso e fine. Tuttavia, per un certo spirito di sistema, per un certo amore dell’arte e
dell’inventiva, a volte sembra che valutiamo più i mezzi che il fine, e che siamo ansiosi di
promuovere la felicita dei nostri simili più con l’intento di perfezionare e migliorare un certo
sistema bello e ordinato, che per un immediato senso o sentimento di ciò per cui essi soffrono e
gioiscono.» (Smith 1759, Teoria 377)
2.4.4. Alla intransigenza, arroganza e follia del fanatismo Smith oppone la prudenza
dell’osservazione, la benevolenza della persuasione, della mediazione e la gradualità esecutiva del
piano. Dunque vengono messe in contrapposizione due diverse tipologie di azione politica.
2.4.4.1. «L’uomo il cui spirito civico è spinto da umanità e benevolenza, rispetterà i poteri e i
privilegi costituiti degli individui, e ancor più quelli dei grandi ordini e società in cui è diviso lo
stato. Anche se dovesse considerarne alcuni in qualche misura abusivi, si limiterà a moderare quel
che spesso non può annullare senza ricorrere a una grande violenza. Quando non riesce a
sconfiggere con la ragione e la persuasione i radicati pregiudizi della gente, non tenterà di reprimerli
con la forza, ma osserverà religiosamente quella che Cicerone definisce giustamente la divina
massima di Platone: non usare mai violenza verso il proprio paese, non più che verso i propri
genitori. Adatterà, meglio che può, i suoi ordinamenti pubblici alle abitudini e ai pregiudizi
consolidati del popolo, e rimedierà, meglio che può, agli inconvenienti che potranno derivare dalla
mancanza di quei regolamenti a cui il popolo è restio a sottomettersi. Se non riuscirà ad affermare la
giustizia, non disdegnerà di limitare l’ingiustizia, ma, come Solone, non potendo instaurare il
miglior sistema legislativo possibile, cercherà comunque di instaurare il migliore proponibile in
quel dato contesto. (Smith 1759, Teoria 459-460)
16
2.4.4.2. «Al contrario, l’uomo animato da spirito di sistema tende a essere molto saggio nel suo
giudizio e spesso è talmente innamorato della presunta bellezza del suo progetto ideale di governo,
che non riesce a tollerare la minima deviazione da esso. Lo realizza completamente in ogni sua
parte, senza alcun riguardo per i grandi interessi o per i profondi pregiudizi che possono opporvisi.
Sembra ritenere di poter sistemare i membri di una grande società con la stessa facilità con cui
sistema i pezzi su una scacchiera. Non considera che i pezzi sulla scacchiera non hanno altro
principio di moto oltre a quello che gli imprime la mano dall’esterno, mentre nella grande
scacchiera della società umana ogni singolo pezzo ha un principio di moto autonomo, del tutto
diverso da quello che la legislazione può decidere di imporgli. Se questi due principi coincidono e
agiscono nella stessa direzione, il gioco della società umana procederà facilmente e
armoniosamente, e con ogni probabilità avrà buon esito. Se sono opposti e differenti, il gioco
procederà infelicemente, e la società sarà sempre immersa nel più profondo disordine. Per dirigere
le vedute di uno statista, può senza dubbio essere necessaria qualche idea generale, e anche
sistematica, sulla perfezione della politica e della legge. Ma voler per forza stabilire, tutto in una
volta e a disprezzo di ogni opposizione, tutto ciò che quell’ordine richiede è spesso segno di
estrema arroganza. Significa erigere il proprio giudizio a supremo modello del giusto e
dell’ingiusto. Significa credere di essere l’unico uomo saggio e meritevole della società, e ritenere
che i propri concittadini debbano conformarsi a sé, e non viceversa. È per questo che, di tutti i
teorici della politica, i principi sovrani sono di gran lunga i più pericolosi. Infatti una simile
arroganza è per loro del tutto familiare. Essi non nutrono alcun dubbio sull’immensa superiorità del
proprio giudizio. Perciò, quando questi riformatori di estrazione imperiale e regale si abbassano a
prendere in considerazione la costituzione dello stato affidata al loro governo, è raro che in essa
trovino qualcosa di più ingiusto degli ostacoli che essa pone al loro volere. Disprezzano la divina
massima di Platone, e ritengono che lo stato sia stato fatto per loro, e non viceversa. Perciò il grande
obiettivo della loro riforma sarà quello di rimuovere quegli ostacoli, limitando il potere della
nobiltà, abolendo i privilegi di città e province, e rendendo gli individui più importanti e i più
importanti ordini dello stato incapaci, quanto quelli più deboli e insignificanti, di opporsi ai loro
voleri.» (Smith 1759, Teoria 460-461)
2.4.5. In queste note riemerge la positiva doppiezza e la strutturale contingenza della politica. Non
si tratta di propositi astratti dell’arte di governo ma dal suo radicato e necessario fondarsi nel
sociale. A definire la politica e le sue forme accorrono due aspetti: 1. un’idea, un ideale di progetto,
2. la consapevolezza della sua natura provvisoria. Una convinzione che possiede tutta la forza della
propria moderazione: «le disquisizioni politiche, se giuste, ragionevoli e praticabili, sono le più utili
tra tutte le attività speculative. Anche le più deboli e le peggiori non sono del tutto prive della loro
utilità. Servono almeno ad animare le passioni pubbliche degli uomini, e spingerli a cercare i mezzi
per promuovere la felicità della società.» (Smith 1759, Teoria 379)
«Ogni sistema di legge positiva può essere considerato un tentativo più o meno imperfetto di
costruire un sistema di giurisprudenza naturale, o di fornire un’enumerazione delle particolari
regole di giustizia. […] In nessun paese le decisioni della legge positiva coincidono esattamente, in
ciascun caso, con le regole che il senso naturale di giustizia detterebbe. Perciò, i sistemi di legge
positiva, per quanto meritino la più grande autorità, in quanto sono testimonianze dei sentimenti
dell’umanità nelle diverse età e nazioni, tuttavia non possono essere mai considerati come sistemi
accurati delle regole di giustizia naturale.» (Smith 1759, Teoria 638, 639)
3. economia politica (economia, etica e politica e antropologia economica)
Fin dal titolo del libro primo dell’opera, La ricchezza delle nazioni, del 1776, emerge l’intento,
l’impostazione, il piano e l’esigenza di indicare le cause della ricchezza cogliendo e studiando
contemporaneamente il legame tra economia, società e natura umana; ciò significa quindi cogliere
l’aspetto “politico” dell’economia, indispensabile per mostrarne lo sviluppo; la sua sorte è infatti
legata ad una giusta e giustificata distribuzione della ricchezza, non per esigenze primarie di
giustizia ma per il reale incremento della ricchezza stessa di una nazione, intesa come ricchezza
17
pubblica, fonte di benessere sociale. «Cause che migliorano la capacità produttiva del lavoro e
ordine secondo il quale il suo prodotto si distribuisce naturalmente tra le diverse classi sociali.»
Smith Adam 1776, 1778, 1784, 1786, 1789 La ricchezza delle nazioni, Utet, Torino 1975.
Il titolo che apre la riflessione che Smith stila, nel 1763 (pubblicata solo nel 1937), in forma di
abbozzo della futura opera La ricchezza delle nazioni, parla di «natura e cause della pubblica
ricchezza»; determinante è l’aggettivo “pubblica”. Non si tratta della ricchezza privata e non è in
studio il processo attraverso cui un singolo entra in possesso della ricchezza e ne incrementa il
valore, né si ha come obiettivo primario quello di dimostrare il diritto naturale dell’individuo alla
proprietà privata (come accade nelle opere di giusnaturalisti come Locke), ma si tende a individuare
gli elementi e i processi che sono all’origine della ricchezza di una società, di una nazione. Elementi
e processi che vengono considerati nella loro funzione sociale. È dunque l’intera economia che si
presenta nel suo ruolo di funzione costituente della società e non in astratto, ma della moderna
società, dei suoi equilibri interni e del suo benessere. La divisione del lavoro e la tendenza naturale
allo scambio sono i fattori individuati come la causa della ricchezza: entrambe sono cause sociali;
non esistono senza società; l’economia è dunque sociale e diventa immediatamente una economia
politica. «Il fondamento della ricchezza è il lavoro produttivo, che con la divisione del lavoro tende
ad essere lavoro sociale, e la ricchezza cessa di essere qualcosa di oggettivo (come la terra o l’oro) e
di altro (come di ciò che può derivare da un privilegio connesso allo status) rispetto alla società…
“la società – scrive Smith – diventa una vera e propria società commerciale”.» Smith Adam 1763
(1937) La ricchezza delle nazioni. Abbozzo, editori riuniti, Roma 1971 (dalla introduzione di
Valentino Parlato, XVI)
3.1. economia etica e politica
Sul tema della relazione fra la Teoria dei sentimenti morali e la Ricchezza delle nazioni Amartya
Sen sottolinea la sequenza cronologica e le circostanze della ripresa delle due opere da parte di
Smith: «… dei due la Teoria dei sentimenti morali è forse il più grande, e fu scritto prima della
Ricchezza delle nazioni. Ma Smith continuò a rivederli; infatti poco prima di morire egli pubblicò
un’ultima edizione della Teoria dei sentimenti morali. La Ricchezza delle nazioni venne dopo
l’altro libro, e io credo che quest’opera di argomento economico Smith la vedesse come parte di un
più ampio programma di lavoro definito nel campo della teoria dei sentimenti morali. Infatti la
Teoria dei sentimenti morali non si occupa soltanto — letteralmente — dei sentimenti delle persone
riferiti a questioni morali, ma anche di questioni politiche e di azioni, della «ragione pratica» come
si usava dire in termini generali [...].» (Tassinari S., De Renzis D. 2004, Il liberalismo, autori, temi,
prospettive, Einaudi Torino, p.163)
3.1.1. Il metodo cui Smith si attiene nei suoi studi, una teoria fondata sulla descrizione della realtà e
la natura aperta delle situazioni generali presentate, diventa la trama che impedisce di introdurre
nella teoria, per considerare poi inavvertitamente reali, distinzioni, separazioni e contrapposizioni
che non si danno nella realtà. Difficile infatti individuare, nel comportamento umano sociale, la
linea della netta distinzione tra economia, etica e politica. L’urgenza di riconoscere la logica propria
di quei campi non deve portare a dimenticare la loro connessione reale, contesto del loro sviluppo.
«Questo generalizzare dall’esperienza consentiva a Smith di portare avanti l’indagine economica
senza scindere il naturale dal morale, come poi s’è voluto con la separazione dell’economia politica
(ma in realtà astratta o pura) dalla politica economica e conseguente necessità di ricomporle in
qualche modo al momento di passare dall’analisi generale ai contenuti determinativi.» (Smith 1776,
introduzione a cura di Anna e Tullio Biagiotti, 12).
3.1.2. Considerata sia dal punto di vista degli elementi che tendono a rafforzarla incrementando
produzione e reddito, sia dal punto di vista del fine sociale che giustifica e sostiene la
partecipazione convinta all’incremento del lavoro, degli scambi e dei consumi in vista del benessere
collettivo. «L’economia politica, considerata come un ramo della scienza dello statista o del
legislatore, si propone due oggetti distinti: primo, provvedere un abbondante reddito o sussistenza
alla gente, o più precisamente metterla in grado di procurarsi da sé questo reddito o sussistenza;
18
secondo, fornire lo stato o la repubblica di un’entrata sufficiente per i servizi pubblici. Essa si
propone di arricchire sia il popolo che il sovrano.» (Smith 1776 Ricchezza, 553)
3.1.3. Il legame economia ed etica. Pensare di opporre etica ed economia risulta contraddittorio e
controproducente. L’etica è un punto di osservazione generale e globale sui comportamenti; si
declina diversamente, come metodo di indagine e come esiti, al variare degli ambiti cui si applica
(etica e religione e letteratura e arte e politica… e economia). Anche nel caso dell’economia, si
tratta di un’attenzione particolare ai comportamenti umani in grado di indicarne moventi, fini,
regole e conseguenze.
3.2. natura e cause della pubblica ricchezza
«Il lavoro compiuto da un individuo isolato non è, evidentemente, sufficiente a procacciargli gli
alimenti, gli indumenti, e il genere di alloggio, che si suppone siano richiesti in una società evoluta,
non solo dal lusso della persona di condizione elevata, ma anche dalle naturali esigenze del più
umile contadino.» (Smith 1763 Ricchezza, Abbozzo, 3)
L’attenzione va rivolta a «ciò che costituisce la spesa del pubblico benessere, ovvero come
l’essenza stessa del benessere pubblico. È ricco proprio quello Stato nel quale la ricchezza si
produce facilmente, ovvero nel quale una piccola quantità di lavoro, propriamente e
giudiziosamente impiegata, è capace di procurare a ciascun uomo una grande abbondanza di tutte
quelle cose che sono necessarie ed utili per vivere. Niente altro — ciò è evidente — può rendere
generale il benessere o diffonderlo tra tutti i membri della società. Il benessere nazionale è il
benessere di tutto il popolo, che da nulla, se non da un alto compenso del lavoro e, di conseguenza,
da una grande facilità di acquistare, può essere originato» (Smith 1763 Ricchezza, 16-17)
Ricchezza dunque non intesa come proprietà (terriera o finanziaria [aurea]) ma come processi di
produzione, quindi non in forma di diritti che danno vita ad uno status sociale (coloro che vivono di
rendita) ma una circolazione di produzione e di merci che genera un benessere collettivo sempre più
ampio per tutti. In questi processi ha sede la ricchezza di una nazione. Fanno dunque parte delle
riflessioni di Smith sull’economia anche i temi del lavoro delle sue forme e dell’andamento dei
salari, delle diseguaglianze sociale e delle povertà.
3.3. la divisione del lavoro.
«Il vestito di lana che ricopre il lavoratore a giornata, per quanto grossolano e ruvido possa apparire,
non si sarebbe potuto fare senza il lavoro complessivo di una moltitudine di artigiani: per ottenere
questo prodotto molto ordinario, il pastore, l’allevatore, il tosatore, colui che fa la scelta della lana,
il pulitore, il pettinatore, il tintore, il cardatore, il filatore, il tessitore, il gualchieraio, lo spianatore,
devono tutti mettere insieme i 1oro differenti mestieri. Tralasciando i mercanti e i carrettieri che
trasportano il materiale da un artigiano a un altro, che spesso vive in un paese molto distante, quanti
altri artigiani sono occupati nella produzione degli utensili necessari anche al più umile di essi! Non
parlerò affatto di una macchina cosi complessa come il telaio del tessitore o come la gualchiera…
[…] ma considerate soltanto quale varietà di lavoro sia necessaria per produrre questa
semplicissima macchina: le forbici del tosatore. Per fabbricarle devono riunire le loro diverse
attività il minatore, il costruttore della fornace che serve a fondere il minerale, il carbonaio che
brucia il carbone da usare in tale operazione, il taglialegna…» (Smith 1763 Ricchezza, 3-5). La
dimostrazione, osservativa ed empirica, di Smith prosegue con riferimento all’abbigliamento,
all’arredamento domestico, agli alimenti quotidiani fino al noto esempio dello spillo
(dettagliatamente sviluppato: (Smith 1763 Ricchezza, 10-12 e Smith 1776, Ricchezza 80-81). E
conclude nella tesi, che chiama in causa la situazione dell’intera società: «dovremo riconoscere che,
senza l’aiuto e la cooperazione di molte migliaia di uomini, in un paese civile la persona più umile
non potrebbe godere neanche di quelle comodità che noi erroneamente riteniamo che siano semplici
e facili. Se poi si fa il confronto con il lusso ben più eccentrico del nobile…» (Smith 1763
Ricchezza, 6)
19
3.3.1. La divisione del lavoro diventa l’elemento che distingue l’uomo civile (e sociale) dal
“selvaggio”: «È molto facile immaginare che colui che può, in ogni tempo, dirigere ai suoi propri
fini il lavoro di migliaia di uomini debba essere provvisto di tutto ciò di cui ha bisogno meglio di
chi dipende dalla propria ed esclusiva attività. […] Tra i selvaggi, invece, ognuno gode dell’intero
prodotto della propria attività. Non ci sono tra loro né padroni, né usurai, né esattori di tasse.»
(Smith 1763 Ricchezza, 6-7)
3.3.2. La divisione del lavoro diventa inoltre l’elemento che distingue l’uomo dall’animale, non in
quanto non vi sia tra gli animali ma per gli effetti che produce: il perfezionamento (Rousseau la
chiamerebbe “perfettibilità”) delle professioni e la conseguente ricchezza di una nazione.
«Sembra che il grandissimo progresso della capacità produttiva del lavoro e la maggiore abilità,
destrezza e avvedutezza con le quali esso è ovunque diretto o impiegato siano stati effetti della
divisione del lavoro.» (Smith 1776, Ricchezza 79)
«Questo immenso aumento della produzione, in conseguenza della divisione del lavoro, è dovuto a
tre diverse circostanze. In primo luogo alla accresciuta abilità di ogni singolo lavoratore, in secondo
luogo al risparmio di tempo che si perde nel passare da un tipo di lavoro a un altro, e, per ultimo,
alla invenzione di numerosissime macchine che agevolano il lavoro e mettono un solo lavoratore in
grado di svolgere la attività di molti. Il progresso dei lavoratori nell’abilità tecnica aumenta
notevolmente la quantità del prodotto; e la divisione del lavoro, riducendo ad un’operazione molto
semplice il lavoro che ogni uomo deve compiere, e facendo sì che questa operazione divenga la sola
attività della sua vita, fa necessariamente progredire al più alto grado l’abilità del lavoratore.»
(Smith 1763, Ricchezza 18; più ampiamente in Smith 1776, Ricchezza 83-88; è evidente, quasi
letterale, la ripresa delle tesi esposte nell’Encyclopédie, tomo I (1751) alla voce Arte)
3.3.2.1. Qui (tuttavia) la divisione del lavoro, più che incremento di professionalità e di accuratezza
del mestiere, introduce una specializzazione in termini di “parcellizzazione”: divisione di un
processo produttivo in parti minime consegnate a gesti meccanici, da ripetere con costanza e
precisione, in ciò facilmente sostituibili, come prevede Smith, dalla macchina; si tratta di una
specializzazione che interpreta in termini di qualità la quantità di lavoro intesa come prestazione
continua della stessa operazione, senza stacchi e senza perdite di tempo, sempre più precisa perché
ridotta al minimo del movimento richiesto. Gli esempi della fabbrica degli spilli, dei chiodi, dei
bottoni di metallo sono chiari ed espliciti in questa direzione.
3.3.3. la divisione del lavoro e l’incremento del surplus: «Solo la divisione del lavoro, per la quale
ciascun individuo si limita ad esercitare un’attività particolare può fornirci una spiegazione di
questa maggiore ricchezza che si produce nelle società evolute, e che, nonostante l’ineguaglianza
nella proprietà si estende ai più umili componenti della società.» (Smith 1763 Ricchezza, 9-10)
3.3.4. La divisione del lavoro crea diseguaglianze ma riduce tendenzialmente la distanza tra le parti
diseguali (tra le componenti sociali, tra ricchezza e povertà). Occorre ricordare il principio ribadito
da Smith: «Il benessere nazionale è il benessere di tutto il popolo»(Smith 1763 Ricchezza, 17).
«Ma per quel che riguarda il prodotto del lavoro di una grande società, non si dà mai che una tale
divisione sia fatta con assoluta eguaglianza. In una società di centomila famiglie ve ne saranno forse
cento che non lavorano affatto e che, tuttavia, o con la violenza o con la più regolare oppressione
della legge, assorbono una quantità di lavoro sociale superiore a quella di diecimila famiglie. Ed
anche la divisione di quel che rimane, dopo questa enorme defalcazione, non avviene affatto in
proporzione al lavoro di ciascun individuo; al contrario, a quelli che lavorano di più tocca di meno.
Il ricco mercante, che passa gran parte del suo tempo nel lusso e nei divertimenti, gode di una parte
dei profitti dei suoi traffici, molto maggiore di quella degli impiegati e dei contabili che fanno gli
affari.» (Smith 1763 Ricchezza, 8) E Smith ricostruisce la gerarchia dei redditi non giustificati dal
lavoro prestato, quindi la gerarchia delle diseguaglianze : proprietari, più o meno feudali,
nullafacenti ma che vivono nel lusso, ricco mercante, i suoi impiegati e contabili, gli artigiani, il
“povero contadino” «che deve combattere che contro le avversità del suolo e delle stagioni, e che,
mentre produce tutto quanto è necessario ad alimentare il lusso di tutti gli altri membri della
comunità e sostiene — come in effetti avviene — sulle proprie spalle l’intero edificio della società
20
umana, sembra schiacciato dal peso e tolto dalla vista altrui nelle più profonde fondamenta
dell’edificio.» (Smith 1763 Ricchezza, 9)
Ma, prosegue Smith: «Schiacciato da una così opprimente ineguaglianza, come dobbiamo valutare
la maggiore ricchezza e abbondanza di beni, generalmente posseduta anche da questo umilissimo e
disprezzatissimo membro della società evoluta, se li paragoniamo a quelli che il più stimato ed
attivo selvaggio può conseguire?» La risposta è nella tesi (già richiamata): «Solo la divisione del
lavoro, per la quale ciascun individuo si limita ad esercitare un’attività particolare, può fornirci una
spiegazione di questa maggiore ricchezza che si produce nelle società evolute, e che, nonostante
l’ineguaglianza nella proprietà si estende ai più umili componenti della comunità.» (Smith 1763
Ricchezza, 9-10) Al di là del facile ottimismo Smith affida un concetto: è civile quella società nella
quale i processi produttivi tendono a ridurre le diseguaglianze sociali. Per Smith il miglioramento
delle condizioni di vita a progressivo beneficio per tutti non è tesi che derivi da un sentimento di
fiducia ottimistica in una ricaduta meccanica dei vantaggi della produzione a beneficio dell’intera
società, né può essere solo affidata a propositi etici di benevolenza, ma ha radici strettamente
economiche nell’andamento naturale dei salari in rapporto al prezzo delle merci
3.3.5. La divisione del lavoro e l’andamento dei salari, in relazione all’andamento dei prezzi delle
merci. La tesi viene illustrata attraverso «un esempio molto banale»: lo spillo, la cui produzione è
immaginata in due diverse situazioni.
Situazione a. «…se tutte le parti di uno spillo dovessero essere fatte da un uomo solo
[dall’estrazione del minerale fino al prodotto finito]… il prezzo di uno spillo dovrebbe in questo
caso essere almeno eguale al prezzo del mantenimento di un uomo per la durata di un anno.» (Smith
1763 Ricchezza, 10)
Situazione b. se «il fabbricante di spilli… si preoccupa di dividere il lavoro tra un gran numero di
persone [specificata la divisione delle operazioni il calcolo di Smith arriva a] seicentomila spilli
all’anno.» (Smith 1763 Ricchezza, 11)
La conclusione: «Il padrone può permettersi, di conseguenza, di aumentare i salari dei lavoratori e
vendere tuttavia questo articolo ad un prezzo di gran lunga più basso di prima» (Smith 1763
Ricchezza, 12)
Dunque i numerosi vantaggi derivanti dalla divisione del lavoro e dal conseguente moltiplicarsi e
perfezionarsi delle professioni: l’incremento della produttività, l’aumento dei salari, la maggior
disponibilità di merci, l’accesso all’acquisto della merce da parte di un numero più alto di persone,
l’aumento del benessere collettivo, in una parola: la ricchezza della nazione; e nota bene: non in
termini di aumento di produttività (Pil) ma di aumento del benessere sociale e di riduzione della
miserie e della diseguaglianza. La società evoluta è definita da «quell’universale benessere che si
estende fino a raggiungere i ceti più bassi della popolazione.» (Smith 1763 Ricchezza,14) Si tratta di
concetti sottolineati nella rilevanza economica che hanno per Smith dalla loro continua ripresa,
quasi ripetizione.
«È in questo modo che in una società ricca e commerciale il lavoro diventa caro e il prodotto a buon
mercato, e l’esperienza dimostra che questi due fenomeni, che un volgare pregiudizio e una
superficiale considerazione ritengono del tutto incompatibili tra loro, sono invece perfettamente
possibili.» (Smith 1763 Ricchezza, 16) «Quindi, quanto più una società è ricca, tanto più il lavoro
sarà sempre più caro e i prodotti più a buon mercato» (Smith 1763 Ricchezza, 17) (vale dunque il
viceversa: una società è povera, ed è progressivamente sempre più povera, se e quando il lavoro
diventa, progressivamente, sempre meno caro. [non è Marx a sostenerlo ma Smith!])
«La domanda di salariati aumenta quindi necessariamente all’aumentare del reddito e del capitale di
ogni paese, e non può aumentare diversamente. Aumento del reddito e del capitale è aumento della
ricchezza nazionale. La domanda di salariati aumenta quindi naturalmente all’aumentare della
ricchezza nazionale, e non può aumentare senza di essa. Non è la grandezza effettiva della ricchezza
nazionale, ma il suo continuo incremento, a determinare l’aumento dei salari. Conseguentemente,
non è nei paesi più ricchi, ma in quelli più prosperi o in quelli che arricchiscono più rapidamente
che i salari sono più elevati.» (Smith 1776 Ricchezza, 158)
21
3.3.5.1. Nello stesso contesto: la schiavitù è «non solo moralmente deprecabile, ma a lungo andare
anche non conveniente dal punto di vista economico: «Dall’esperienza di tutti i tempi e di tutte le
nazioni sembra quindi si possa ritenere che il lavoro eseguito dall’uomo libero sia in definitiva
meno caro di quello dello schiavo [...] Qualunque cosa [lo schiavo] faccia oltre a ciò che basta ad
assicurargli la sussistenza, può essergli imposto con la violenza soltanto e mai da un suo particolare
interesse» (Smith Adam 1776 La ricchezza delle nazioni, Utet, Torino 1975, p. 172, 514).
Inoltre, vi erano buone ragioni per credere che gli stati che ammettevano la schiavitù avrebbero, con
buona probabilità, riconosciuto sia l’immoralità della schiavitù sia le circostanze economiche
sfavorevoli a essa qualora si fossero trovati a interagire con gli stati liberi(sti), più di quanto non
avrebbero fatto se fossero stati mantenuti in una condizione di isolamento.» Margalit Avishai 2010
Sporchi compromessi, il Mulino, Bologna 2011, p. 66
3.3.6. La ricchezza di una nazione consiste dunque, come più volte ribadito, dall’aumento del
benessere sociale (e questo passa attraverso la diminuzione del prezzo delle merci e l’aumento dei
salari). «È l’immensa moltiplicazione delle produzioni di tutte le differenti attività, conseguente alla
divisione del lavoro, che, nonostante la grande ineguaglianza nella proprietà, dà origine, in tutte le
società evolute, a quell’universale benessere che si estende fino a raggiungere i ceti più bassi della
popolazione. Si produce una così grande quantità di ogni bene, che ve n’è abbastanza da soddisfare
l’infingardo e oppressivo sperpero del grande e, al tempo stesso, da sopperire largamente ai bisogni
dell’artigiano e del contadino.» (Smith 1763 Ricchezza,14)
«Che, poiché la ricchezza nazionale consiste nel fatto che le merci siano a buon mercato rispetto
alle paghe, qualunque cosa tenda a far rialzare i prezzi delle merci al disopra di quel limite che è
precisamente necessario per invogliare il lavoratore, tende a far diminuire il benessere della
nazione. Delle imposte e di altre tasse sulla produzione [causa 1: tasse e imposte inopportune]. Dei
monopoli [causa 2 ingiusti monopoli].» (Smith 1763 Ricchezza, appunti Sulle norme dello scambio
e sulle circostanze che regolano i prezzi dei beni, 37; tra parentesi quadre da appunti Della
moneta…, 40)
3.3.6.1. L’ottimismo di Smith è diventato uno slogan proverbiale e tende a rivolgersi, spesso con
facile (e superficiale) ironia, alla tesi del comporsi o ridursi naturale delle diseguaglianze sociali, al
tradursi automatico dell’incremento della produttività in incremento dei salari, al beneficio
collettivo automatico dell’incremento produttivo industriale. Smith cerca nelle forme storica della
produzione economica l’emergere di questi sviluppi. Non è ottusità ma invito etico e progetto
politico di giustizia come equità.
3.3.7. La divisione del lavoro e la rivoluzione industriale. «Se, comunque, questo lavoro è eseguito
con grande diligenza e ponderatezza, se è basato sul concorso di tutte le forze di una grande società,
e soprattutto se è coadiuvato da innumerevoli macchine…» (Smith 1763 Ricchezza, 17) . «Fu la
divisione del lavoro che probabilmente diede occasione all’invenzione della maggior parte di quelle
macchine, con le quali il lavoro viene tanto facilitato ed abbreviato.» (Smith 1763 Ricchezza, 22;
Smith 1776, Ricchezza 86) È la divisione del lavoro, non tanto in termini di specializzazione
professionale dei mestieri artigianali, ma in quanto scomposizione parcellare, in parti minime (fino
ad individuare una «operazione semplicissima»), delle prestazioni di lavoro a consentire
l’introduzione della macchina nei processi produttivi; quel passaggio, definito poi appunto
“meccanico”, può essere svolto con regolarità e precisione dalla macchina. «Nelle prime macchine
a fuoco un ragazzo veniva adibito costantemente ad aprire e chiudere alternativamente la
comunicazione tra la caldaia e il cilindro, a seconda che il pistone salisse e scendesse. Uno di questi
ragazzi, che amava giocare coi compagni, osservò che legando una funicella…». (Smith 1776,
Ricchezza 86)
3.3.7.1. Una separazione tra settori e la nuova epoca industriale. La manifattura artigianale si
trasforma in industria; una produzione che si stacca sempre più (per ora) dall’agricoltura perché
(finché) «È proprio questa impossibilità di fare una completa e netta separazione tra tutte le diverse
branche del lavoro agricolo che impedisce sempre che il progresso di questa attività tenga il passo
con quello delle manifatture.» (Smith 1763 Ricchezza, 13)
22
3.3.7.2. Una meccanizzazione del processi produttivi e la nuova società nel lavoro. Uno spunto
destinato alla ripresa: la macchina, il progresso delle arti in generale introduce, secondo Smith
anche una emancipazione dell’uomo dall’uomo; il lavoro meccanizzato porta ad una progressiva
diminuzione del rapporto diretto tra uomo e uomo come era socialmente evidente nella produzione
manifatturiera o di prima industrializzazione (emancipazione che Marx indicherà con i termini
“alienazione dell’uomo dall’uomo”) (accenno in (Smith 1776, introduzione a cura di Anna e Tullio
Biagiotti, 17).
3.4. la tendenza naturale allo scambio
La tesi: «Questa divisione del lavoro, dalla quale derivano tanti vantaggi, non è, all’origine, un
effetto della saggezza umana che prevede e mira a quel generale benessere cui poi dà luogo. È la
necessaria, per quanto lenta e graduale, conseguenza di un certo principio o inclinazione della
natura umana, che non si propone un così grande risultato. È, questa inclinazione, comune a tutti gli
uomini, che non si trova invece in nessun’altra specie di animali: la tendenza a trafficare, a
barattare, a cambiare una cosa con l’altra. Che questa tendenza sia comune a tutti gli uomini è cosa
sufficientemente ovvia.» (Smith 1763 Ricchezza, 26) «Se questa propensione sia uno di quei
principi originari della natura umana che non si possono ricondurre ad altre cause; o se, come
sembra più probabile, essa sia conseguenza necessaria della facoltà della ragione e della parola, non
è compito del nostro presente argomento di indagare.» (Smith 1776, Ricchezza 91) «E poiché è in
questo modo, col baratto e con lo scambio, che noi otteniamo la maggior parte di quei reciproci
buoni uffici di cui abbiamo bisogno, così è questa stessa tendenza a trafficare che in origine dà
occasione al sorgere di quella divisione del lavoro, sulla quale si fonda tutto il benessere delle
società evolute.» (Smith 1763 Ricchezza, 29) La ricerca delle cause della ricchezza delle nazioni
avvia un percorso di rimando e di scoperta sempre più remota delle cause e ha l’effetto di
ricondurre l’economia ai legami sociali e alle inclinazioni naturali dell’uomo. (1.) La divisione del
lavoro, causa evidente della ricchezza della nazione, rimanda (2.) alla tendenza dell’uomo allo
scambio, questa, a sua volta, fa leva (3.) sul suo interesse, amor di sé, egoismo che lo spinge a
cercare le condizioni per soddisfare bisogni e tendere al benessere; esigenza che l’uomo, a
differenza degli animali, può soddisfare solo con (4.) “la cooperazione e l’aiuto di molta gente”
(lavoro – scambio – interesse – società). Proprio dalla tendenza allo scambio, a soddisfazione
“egoistica” del bisogno, nasce la distanza dell’uomo civile dal selvaggio (dall’uomo in natura) e
dall’animale (dallo stato animale; selvaggio e animale non equiparati in Smith ma spesso descritti
nello stesso modo e richiamati per costruire lo stesso passaggio argomentativo per introdurre lo
stato civile).
3.4.1. «in considerazione del suo proprio interesse» (Smith 1776, Ricchezza 91). Far leva
sull’interesse, sull’egoismo e non sulla benevolenza o sulla saggezza umana.
«Ma, mentre un animale che sia giunto alla maturità, difficilmente ha bisogno dell’aiuto dei suoi
simili, l’uomo, al contrario, ha costantemente bisogno dell’aiuto dei suoi fratelli e sarebbe vano
attendere tale aiuto soltanto dalla loro benevolenza. Egli avrà maggiori probabilità di ottenerlo se
riuscirà a volgere a proprio favore la cura che quelli hanno del proprio interesse e a dimostrare che
torna a loro vantaggio fare per lui ciò di cui li richiede. Si comporta press’a poco così chiunque
propone di concludere un affare di qualunque genere. E l’evidente significato di ogni offerta è:
«Dammi questa cosa di cui ho bisogno, e avrai questa di cui hai bisogno». È questo il modo con cui
noi otteniamo da un altro la maggior parte di quei buoni uffici di cui abbiamo bisogno. Non è dalla
benevolenza del macellaio, del birraio e del fornaio che ci aspettiamo il pranzo, ma dalla
considerazione che essi fanno del proprio interesse. Noi ci rivolgiamo non alla loro umanità, ma al
loro interesse, e non parliamo mai loro delle nostre necessità, bensì dei loro vantaggi. Nessuno, se
non un mendicante, sceglie di dipendere soprattutto dalla benevolenza dei suoi concittadini, ed
anche un mendicante non ne dipende completamente. Se così fosse, egli morrebbe nel tempo di una
settimana». (Smith 1763 Ricchezza, abbozzo 28)
23
3.4.2. Le passioni e la loro valorizzazione in economia e anche nel campo etico e sociale. La ricerca
del proprio interesse, in altri termini le passioni egoistiche, intese come tratti della natura umana e
quindi come principio universale di comportamento, non contrastano l’etica delle relazioni sociali
civili ma contribuiscono a una loro vivace realizzazione. Nella Teoria dei sentimenti morali, Smith
presenta le passioni egoistiche come quelle che occupano «una specie di posto di mezzo tra le
affezioni sociali e antisociali» (Smith, 1759, 354) e l’interesse egoistico, l’ambizione, è «una
passione che, quando si mantiene nei limiti della prudenza e della giustizia, viene sempre
ammirata…» (Smith, 1759, 355) e, per descrizione sociologica e per considerazione teorica diventa
oggetto di lode e di merito. Si può riprendere quel passaggio: «In molte occasioni, anche la
considerazione per la nostra personale felicità e per il nostro personale interesse appare un principio
d’azione del tutto lodevole. Si suppone che l’abitudine all’economia, all’industriosità, alla
discrezione, all’attenzione, all’applicazione e alla riflessione sia generalmente coltivata per motivi
di interesse egoistico, ma nello stesso tempo queste sono qualità degne di lode, che meritano la
stima e l’approvazione di ognuno. La mescolanza di un movente egoistico, è vero, spesso sembra
macchiare la bellezza delle azioni che dovrebbero derivare da un’affezione benevola. La causa di
ciò, tuttavia, non è che l’amor di sé non può mai essere il movente di un’azione virtuosa, ma che il
principio benevolo in questo caso particolare sembra mancare del suo dovuto grado di forza, ed
essere del tutto inadatto al suo oggetto. Perciò il carattere dell’agente sembra evidentemente
imperfetto, e biasimevole piuttosto che lodevole. Invece, la mescolanza di un movente benevolo in
un’azione che abbia già nell’amor di sé una spinta sufficiente non è altrettanto in grade di diminuire
il nostro senso dell’appropriatezza dell’azione, o della virtù di chi quell’azione compie. Non siamo
preparati a sospettare che una persona manchi di egoismo: questo non è affatto il lato debole della
natura umana, o il difetto di cui tendiamo a essere sospettosi. Tuttavia, se potessimo davvero
credere di un uomo che, se non fosse per riguardo alla sua famiglia e ai suoi amici, egli non si
prenderebbe appropriata cura della propria salute, della propria vita, dei propri averi, cosa verso la
quale basterebbe a spingerlo l’autoconservazione, riterremmo senza dubbio questa una sua
mancanza, per quanto una di quelle amabili mancanze, che rendono una persona più oggetto di pietà
che di odio o disprezzo. Tuttavia, farebbe diminuire la dignità e la rispettabilità del suo carattere. La
mancanza di cura e di economia sono universalmente disapprovate, ma non perché derivino da una
mancanza di benevolenza, bensì perché derivano da una mancanza dell’attenzione appropriata per
gli oggetti di interesse egoistico.» (Smith, 1759, 575-576) È diventato quasi un luogo comune
attribuire a Smith la tesi che l’egoismo, considerato eticamente un vizio, diventi il principio e la
molla dell’economia e quindi una virtù; la considerazione si è semplificata nel detto “vizi privati,
pubbliche virtù” ricavato da due opere di Bernard de Mandeville con cui Smith spesso si confronta
(criticamente): un poemetto pubblicato nel 1705 in forma anonima col titolo L’alveare scontento,
ovvero i furfanti diventati onesti, e quel testo riedito in forma più ampia, sviluppato in una teoria,
nel 1714 col titolo La favola delle api, ovvero vizi privati, pubblici benefici. Abbandonando il punto
di vista proprio di un’etica che si fonda su valori universali e oggettivi, per assumere una
prospettiva sociale e considerare ciò che è fonte di bene pubblico, Mandeville costata che ogni
tradizionale separazione tra vizio e virtù, valori positivi e negativi, perde significato: la società dei
commerci, propria dell’Inghilterra del tempo, guardata con l’occhio chiuso e bigotto del moralista,
appare come il regno del vizio, ma osservata con il disingannato sguardo del politico e
dell’economista, si presenta invece come il regno del benessere. Polemico verso gli utopisti, che
invece di aiutare a comprendere la società del loro tempo invitano a sognare società irreali,
Mandeville preferisce osservare in modo realistico il mondo per coglierne i meccanismi, gli
equilibri, le contraddizioni così da renderne possibile una comprensione disincantata, che aiuti ad
accettarlo quale esso é: una realtà complessa in cui è difficile scindere il bene dal male, i vizi dalle
virtù. Uno stesso realismo descrittivo, con meno spregiudicata e graffiante ironia (almeno formale),
è adottato da Smith come metodo, abbinato ad un progetto di proporre una teoria etica sistematica
dei sentimenti. Anche sul tema dell’egoismo è ora in azione il metodo che la ragione pratica adotta
nel campo dell’etica, della società e della politica.
24
3.4.2.1. la “metafora” come metodo nel campo pratico: economico e politico. Le considerazioni di
Smith sulla passione egoistica sono sorrette (come in Mandeville) dall’arte del trasferire uno stesso
impulso o principio (vizio, diritto, obiettivo) da un campo operativo ad un altro: dalla natura alla
società, dal privato al pubblico, dalla morale alla politica … e, senza limiti, il trasferimento può
avvenire tra ambiti eterogenei: dalla religione all’economia, dalla matematica all’arte ecc. Si tratta
di esercizi metaforici che, visti gli esiti, finiscono per appartenere alla prassi dell’invenzione, della
scoperta. Un elemento, trasferito, totalmente o parzialmente, in altro campo acquista nuove
definizioni e nuova produttività: diventa strumento di scoperta e di teoria. Un caso esemplare viene
dalla teoria politica di Hobbes: la forza, la violenza come istinto naturale fondato sul diritto di tutti a
tutto, trasferita nel campo politico ad opera di un contratto sociale di rinuncia, diventa la forza con
cui lo Stato garantisce sicurezza, ordine, pace e benessere; è avvenuta una metafora politica non
solo letteraria, ma fondativa della sovranità dello Stato.
L’arte del trasferire o arte metaforica diventa quindi il metodo proprio e specifico della filosofia
pratica, in particolare dell’etica civile o politica: guardando i problemi dal punto di vista di uno
spettatore della natura umana e del vivere sociale occorre evitare sia le drastiche negazioni o
divisioni, sia i giudizi morali assoluti; sarebbe una imperdonabile scorrettezza di metodo nei
confronti del proprio campo di indagine che da oggetto di osservazione diventa imputato di fronte a
principi ad esso esterni. L’osservazione rispettosa del reale, consapevole della propria inesorabile
incompletezza, invita a trovare la logica del comporre gli aspetti apparentemente antitetici e
inconciliabili della natura umana e del vivere sociale come l’istinto e le passioni con la ragione e la
riflessione, l’utile con il bene, l’interesse privato con la pubblica utilità. Lo sguardo altero e il
giudizio assoluto nei confronti di ciò che è complesso si trasforma altrimenti o in intollerante e
oppressiva utopia o nella guerra tra scuole e teorie, una specie di perenne bellum omnium contra
omnes coma accadeva nella più cupe previsioni di Hobbes. Composizione e armonia non dettata da
cedimenti o compromessi arrendevoli, ma da rispettoso e franco realismo. A “difesa del vizio” si
può infatti osservare come nel tendere al bene e all’utile, privato e collettivo, è meglio investire
sulle proprie passioni, sulle proprie tendenze naturali e anche sui propri vizi più che su propositi di
virtù: queste sono discontinue e non garantite nel successo, passioni e vizi rappresentano invece la
nostra continuità; un loro investimento alla ricerca del massimo benessere diventa economicamente
un fatto produttivo. Trasferito e collocato in nuovi campi regolamentari e di controllo il vizio
diventa virtù, processo produttivo. In una intervista del 1998 Sen osserva: «Ovviamente, nella
Teoria dei sentimenti morali e in alcune parti della Ricchezza delle nazioni, Smith sottolinea che il
puro perseguimento del proprio interesse non è adeguato per affrontare una serie di problemi. È
appropriato nel caso dello scambio, ma non lo è per la costituzione delle società umane o per
ottenere una buona distribuzione del reddito, del benessere e della ricchezza di una nazione. Ma
secondo Smith se ci si limita allo scambio la motivazione offerta dal perseguimento intelligente del
proprio interesse, può essere perfettamente adeguata. Questo è un altro risultato di cui egli fa un
ottimo uso.» (Tassinari , De Renzis, 2004, p.165)
3.4.3. L’economia ha antropologicamente natura sociale: è un tratto che dipende dalla natura
dell’uomo sia per la debolezza che la contrassegna («La sua condizione naturale è tale che egli ha
sempre bisogno della cooperazione e dell’aiuto di molta gente…» Smith 1763 Ricchezza, abbozzo
27), sia per le passioni naturali (inclinazione, tendenza) che la caratterizzano («conseguenza di un
certo principio o inclinazione delle natura umana… la tendenza a trafficare, a barattare…» Smith
1763 Ricchezza, 26).
3.4.4. L’economia e le sue due leggi o cause (la divisione del lavoro e la tendenza naturale allo
scambio) sono il contesto in cui l’uomo costruisce la propria fisionomia personale e realizza il tratto
che distingue l’uomo dall’animale: la “perfettibilità” (per indicarla con il termine di Rousseau).
Osserva infatti Smith: «In realtà la differenza del talento naturale tra i diversi uomini è forse molto
minore di quel che noi riteniamo, e il diverso ingegno che sembra distinguere uomini di differente
professione, quando costoro siano pervenuti a maturità, non è forse tanto la causa, quanto l’effetto
della divisione del lavoro. Che cosa può esservi di più diverso di un filosofo e un qualsiasi
25
facchino? Tale differenza, comunque, sembra nascere non tanto dalla natura, quanto dall’abitudine,
dal costume e dall’educazione. […] È questa disponibilità a trafficare, barattare e commerciare, che
non soltanto dà occasione a quelle differenze di ingegno o di inclinazioni, così rilevanti tra gli
uomini che esercitano professioni diverse, ma che anche fa sì che queste risultino utili.» (Smith
1763 Ricchezza, 30-31, 32).
3.4.5. «La divisione del lavoro è limitata dall’estensione del mercato» (Smith 1776, Ricchezza 96)
«Poiché è la capacità di scambiare che determina la divisione del lavoro, la misura di questa
divisione è sempre necessariamente limitata dall’entità di questa capacità o, in altre parole,
dall’estensione del mercato. Quando il mercato è assai ristretto, nessuno può essere invogliato a
dedicarsi interamente a una occupazione stante l’impossibilità di scambiare tutta l’eccedenza del
prodotto del proprio lavoro rispetto al proprio consumo contro parti del prodotto del lavoro altrui di
cui abbisogna.» (Smith 1776, Ricchezza 96) L’ampiezza dello scambio, la vastità delle relazioni
commerciali, è la molla che sollecita la divisione del lavoro e quella specializzazione produttiva da
cui deriva la ricchezza di una nazione in termini di benessere collettivo. E, a sua volta, quella
ampiezza, per essere raggiunta e garantita, richiede libertà e sicurezza; richiede una economia
politica di carattere liberistico volta cioè a difendere la libertà di produzione e di circolazione e
scambio delle merci. Il rispetto di queste condizioni produce un incremento produttivo in cui la
ricchezza della nazione si accompagna (provoca e deriva) alla massima occupazione e all’aumento
dei salari. (ricorda: ricchezza di una nazione = benessere di tutto il popolo; Smith 1763 Ricchezza,
17)
3.4.5.1. L’urgenza del liberismo, contro le tesi del mercantilismo sulla produzione, sui commerci e
sulla moneta. La politica economica dell’Assolutismo, a partire dalla seconda metà del 1600 fino al
termine del 1700, prende storicamente il nome di “mercantilismo”. Si basa sulla convinzione che la
forza dell’economia di una nazione dipenda ed esprima la forza dello Stato che la promuove e la
controlla. La politica economica mercantilistica lega la ricchezza della nazione a tre principi
fondamentali, veri postulati: incoraggiare l’esportazione di merci e impedirne l’importazione con
rigide misure doganali (incoraggiare l’importazione di materie prime e soprattutto di metallo
prezioso); promuovere i settori industriali con misure protettive politiche e contenere i prezzi dei
prodotti degli altri settori, in particolare dell’agricoltura; privilegiare la tesaurizzazione della
ricchezza nella moneta, il metallo prezioso è considerato la forma naturale della ricchezza e la fonte
del potere di acquisto di ciascuno e, soprattutto, di uno Stato. La ricchezza di una nazione è
garantita, secondo Smith da misure totalmente contrarie a quelle mercantilistiche: l’economia è
dotata di leggi proprie che lo Stato deve rispettare astenendosi da interventi di protezione o di
repressione; la libera circolazione delle merci ne incoraggia la produzione, la massima disponibilità
e quindi il benessere collettivo; la moneta è misura del valore e mezzo di scambio ma non una vera
forma di ricchezza «servendo solo a far circolare le merci, è un capitale morto che non produce
nulla e che può essere facilmente paragonato a una grande strada» (Smith 1763 Ricchezza,
appendice Della moneta, 40-41). Il tema è trattato in modo molto più analitico nell’opera del 1776,
ma restano le riserve nei confronti degli argomenti che ponevano in primo piano l’accaparramento
del metallo prezioso (residui mercantilistici): «Questi argomenti erano in parte solidi e in parte
sofistici. […] erano sofistici in quanto supponevano che per conservare o aumentare la quantità di
quei metalli occorreva maggiore attenzione da parte del governo che per conservare o aumentare la
quantità di qualsiasi altra merce utile…» (Smith 1776 Ricchezza, 559). Accaparrare metallo
prezioso è svalutarlo e, di conseguenza, aumentare il prezzo delle merci e creare diseguaglianze e
povertà sociali.
Ancora a sostegno della libertà di investimento e di impresa contro monopoli e protezionismi: «È
evidente che ognuno, nella sua condizione locale, può giudicare molto meglio di qualsiasi uomo di
stato o legislatore quale sia la specie d’industria interna che il suo capitale può impiegare e il cui
prodotto avrà probabilmente il massimo valore. L’uomo di stato che dovesse cercare di indirizzare i
privati relativamente al modo in cui dovrebbero impiegare i loro capitali non soltanto si
addosserebbe una cura non necessaria, ma assumerebbe un’autorità che non solo non si potrebbe
26
affidare tranquillamente a nessuna persona singola, ma nemmeno a nessun consiglio o senato, e che
in nessun luogo potrebbe essere più pericolosa che nelle mani di un uomo abbastanza folle e
presuntuoso da ritenersi capace di esercitarla. Dare il monopolio del mercato interno ai prodotti
dell’industria nazionale di una particolare arte o manifattura è in certa misura come indirizzare i
privati sul modo in cui dovrebbero impiegare i loro capitali, e deve essere in quasi tutti i casi
regolamento inutile o dannoso.» (Smith 1776 Ricchezza, 584)
A sostegno della libertà di commercio anche internazionale: « Se un paese straniero ci può fornire
una merce a minor prezzo di quanto ci costerebbe il fabbricarla, è meglio acquistarvela con una
parte del prodotto della nostra industria, impiegata in un modo che ci dia qualche vantaggio.
L’industria generale del paese, essendo sempre in rapporto al capitale che la impiega, non diminuirà
per questo più di quella degli artigiani sopra menzionati; ma solamente sarà lasciato a essa di
trovare il modo in cui può attuarsi col massimo vantaggio. Essa non è certamente impiegata col
massimo vantaggio quando diretta verso un oggetto che può essere acquistato a minor prezzo di
quanto costa fabbricarlo.» (Smith 1776 Ricchezza, 585)
3.4.6. Lo scambio viene inteso in senso sempre più globale e diventa legge oltre che dell’economia,
della cultura, della civiltà; anche in questi campi il principio del liberismo (libertà di produzione, di
circolazione e di scambio) diventa condizione di sviluppo e di benessere contro «alle irragionevoli
restrizioni imposte ad alcune branche del commercio, l’irragionevole incoraggiamento dato ad
altre.» Smith 1763 Ricchezza, 43). «Supponete che un uomo passi in rivista tutte le conoscenze che
possiede, relative ad ogni questione che non rientri nei limiti della sua specifica attività, ed egli
scoprirà che quasi ogni cosa che sa, l’ha acquisita di seconda mano, dai libri, dall’istruzione
scolastica che può aver ricevuto nella sua giovinezza, o da occasionali conversazioni che può aver
avuto con uomini di scienza. Si accorgerà che soltanto una piccolissima parte di queste conoscenze
è stata il prodotto delle sue personali osservazioni o riflessioni. Tutto il resto è stato acquistato come
si acquistano le scarpe o le calze, da coloro la cui attività è quella di produrre e preparare per il
mercato questa particolare specie di merci. È in questo modo che egli ha acquisito tutte le sue idee
generali relative alle grandi questioni della religione, della morale e del governo, relative alla sua
propria felicità e a quella del suo paese. Ci si accorgerà che l’intero sistema riguardante ciascuna di
queste importanti questioni è stato, originariamente, il prodotto dell’attività di altre persone, dalle
quali, o egli stesso o quelli che hanno avuto cura della sua educazione, lo hanno ricevuto allo stesso
modo di ogni altra cosa utile, col baratto e con lo scambio di una parte del prodotto del loro proprio
lavoro.» (Smith 1763 Ricchezza, 34-35; si tratta delle note conclusive dell’Abbozzo).
3.5. La teoria di Smith: un punto di vista a partire dall’antropologia economica. Come bilancio
storica alla nascita dell’economia politica e al ruolo centrale del commercio in questo emergere,
osservato dal punto di vista della “antropologia economica”: nelle annotazioni di Hann Chris, Hart
Keith 2011 Antropologia economica. Storia, etnografia, critica, Einaudi, Torino 2011.
«Se l’economia poté essere inizialmente identificata con l’agricoltura, tuttavia, anche quando
comandavano i latifondisti, erano i meccanismi degli scambi che stavano al centro dell’attenzione
degli studiosi. Con il consolidamento degli imperi europei, che crearono un primo «sistema
mondiale» (Wallerstein 2003), l’economia venne a essere sempre più identificata con i mercati, reti
costituite da atti di vendita e acquisto, che normalmente utilizzano come mezzo il denaro. I mercati,
fino a quel momento tenuti al margine delle istituzioni tradizionali su cui le nazioni erano state
basate, a partire dal XVIII secolo vennero accettati come parte fondamentale della società. Da quel
momento il dibattito politico sulla corretta relazione fra i due fu vigoroso. Adam Smith (1723-90)
viene normalmente considerato colui che ideò il progetto per far occupare al «mercato» (che ora
viene scritto per lo più al singolare) il posto di istituzione dominante nella nuova società. L’analisi
espressa in La ricchezza delle nazioni (1776) era incentrata sui vantaggi di efficienza resi possibili
da una moderna divisione del lavoro, sia all’interno delle unità economiche sia nei rapporti fra di
esse. Egli concentrò la propria attenzione sui processi «naturali» di commercializzazione. Allora
27
non si potevano ancora prevedere né l’irrompere del capitalismo commerciale né il conseguente
sviluppo di un potere consolidato britannico d’oltremare. […]
Ma perché i mercati sono considerati sovversivi per gli assetti sociali tradizionali? Perché il
commercio non conosce confini — in un certo senso ogni mercato è un mercato mondiale — e
questo minaccia i sistemi di controllo locale, offrendo agli sfruttati i mezzi potenziali di riscatto:
servi e schiavi, minoranze etniche, giovani, donne. Il potere di chi commercia su lunghe distanze
spesso si scontra con l’autonomia dei governanti locali. Quindi Adam Smith sapeva quello che
stava portando in superficie quando affermò che la società, dai mercati, non aveva nulla da temere,
ma anzi tutto da guadagnare. Egli sostenne inoltre che la motivazione primaria degli scambi fosse
l’egoismo: «Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il
nostro desinare, ma dalla considerazione del loro interesse personale» (Smith 2006, p. 92). In
quanto filosofo morale, Smith non era incline a esaltare il gretto perseguimento dell’interesse
privato nelle transazioni commerciali; ritenne invece di concedere questa prerogativa en mass
piuttosto che cedere alla concentrazione del potere economico nelle mani di élite, per quanto
illuminate. Egli riconobbe l’autorità fondamentale del buon senso, affermando che «una certa
propensione allo scambio e al baratto» facesse parte della natura umana e i mercati fossero il
miglior tramite possibile per far aumentare «la ricchezza delle nazioni». Non giunse ad asserire che
si facesse un miglior servizio agli interessi dell’intera società lasciando che se la cavasse da sola,
senza considerazione per ciò che egli chiamava «solidarietà» oppure «cameratismo»; ma queste
eccezioni sono state dimenticate da tempo. Gli economisti moderni citano disinvoltamente il suo
accenno a una «mano invisibile», ( tralasciando il fatto che Smith, in quel caso, si riferiva al disegno
provvidenziale della natura, non al funzionamento impersonale del mercato). Più che un’economia
mondiale unificata, egli prevedeva un mondo plurale in cui la Cina potesse ancora una volta
superare i mercati frammentati dell’Europa (Arrighi 2008).
All’inizio del XIX secolo l’economia politica continuava a svilupparsi come ricerca sul modo
migliore di distribuire il valore generato da un mercato in espansione, nell’interesse della crescita
economica. Se si attribuisce a Adam Smith il manifesto originale dell’economia liberista, è stato
David Ricardo (1817) a proporre una più sistematica enunciazione dei suoi principi teorici. Lui e i
suoi seguaci individuarono tre tipi di risorse, tutte dotate di «potenzialità crescenti»: l’ambiente (la
terra), il denaro (il capitale) e la creatività umana (il lavoro). Esse vengono a loro volta
rappresentate dai rispettivi padroni: proprietari terrieri, capitalisti e lavoratori. […]
La rivoluzione intellettuale di Adam Smith ha deviato l’attenzione dall’ordine domestico
all’«economia politica», e in particolar modo verso la divisione del lavoro e i mercati. Poi sono
avvenuti due fatti: prima di tutto, le aziende che governavano risorse di massa hanno rapidamente
preso il controllo del mercato, in un sistema per fare soldi con i soldi che alla fine venne chiamato
«capitalismo»; secondo: gli Stati, nell’interesse nazionale, hanno rivendicato il diritto di
amministrare il denaro, i mercati e l’accantonamento, e questa è la ragione per la quale, al giorno
d’oggi, lo Stato-nazione è il principale referente dell’«economia».» (Hann Chris, Hart Keith 2011,
31-33, 42)
4. commercio e filosofia politica: veridazione
L’economia, nella sua origine commerciale e nella sua capacità di far emergere il valore di scambio,
è nelle condizioni di porre sotto esame la politica allo scopo di rinnovarla profondamente e farne
emergere il fine; o, capovolgendo, è possibile cogliere la natura della politica a partire dalla
chiarificazione della natura e delle leggi dell’economia.
4.1. Una profonda innovazione: l’introduzione del principio del limiti nell’arte di governo.
Questo è il tratto specifico dell’età moderna in campo politico, soprattutto per la nuova natura e
fonte: il limite all’arte di governo non ha origine religiosa e non deriva da affermazioni teologiche
ma da nuove processi in atto costituivi della moderna arte di governo (della governamentalità):
28
4.1.1. la politica nasce da un contratto a partire dall’affermazione di diritti. La prassi di contratto
come atto di nascita e come definizione dell’essenza della politica costituisce una fondamentale
limitazione “esterna” alla politica come era intesa in senso assolutistico.
4.1.2. la politica si struttura in forza di proprie istituzioni e funziona attraverso un apparato sempre
più complesso di burocrazia avviando di fatto un processo interno di controllo e di limitazione. Il
limite non è solo il punto privilegiato di osservazione per cogliere il formarsi del sistema, la sua
struttura e il suo esplicativo smontaggio, il limite diventa qui arte che definisce e struttura
dall’interno il governare, la governamentalità. Specificando: l’arte o la pratica di governo non le
teorie politiche; se vi è teoria qui presa in considerazione è la concettualizzazione della pratica di
governo, quella razionalizzazione cui i governi stessi ricorrono non per far teoria, ma per urgenza e
opportunità politica e quindi ancora come pratica o arte del governare. Se vi è una teoria questa
deriva da un tentativo di concettualizzare la pratica che consiste nel governare; «la
razionalizzazione della pratica di governo nell’esercizio della sovranità politica.» (Foucault Michel
2004 Nascita della biopolitica, 14)
4.1.3. l’economia politica: «L’economia politica credo sia fondamentalmente ciò che ha consentito
di assicurare l’autolimitazione della ragione di governo.» (Foucault 2004, 25) La tesi è la seguente:
l’economia politica introduce il concetto di veridazione nell’arte di governo; avvia la veridazione
della governamentalità. Questa la teoria esposta da Foucault Michel 2004 Nascita della biopolitica.
Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano 2005
4.2. «come e perché l’economia politica abbia potuto costituire la forma originaria di questa
nuova ratio di governo autolimitativa». «D’ora in poi, in altri termini, sarà il successo o il
fallimento a costituire il criterio dell’azione di governo, non più la legittimità o l’illegittimità. Il
successo, dunque, prenderà il posto della legittimità. […] Il male peggiore per un governo, ciò che
lo rende un governo cattivo, non è tanto che il principe sia malvagio, ma che sia ignorante. […] Con
l’economia politica si entra dunque in un’epoca il cui principio potrebbe essere il seguente: un
governo non sa mai abbastanza che rischia di governare sempre troppo; oppure: un governo non sa
mai troppo bene come governare abbastanza.» (Foucault 2004, 27-29)
4.2.1. La presenza della economia politica nello stato determina un radicale passaggio: il passaggio
dello stato dal regime di giurisdizione al regime di verità; “non tanto il regno del vero nella politica,
ma un certo regime di verità, caratteristico di quella che si potrebbe chiamare l’epoca della
politica”; attraverso l’economia politica e la sua logica fa l’ingresso in politica il processo di
veridizione. Si tratta di un “cuneo formidabile che l’economia politica ha introdotto” nello stato. La
prassi finora esistente, e da lungo tempo, già da prima del XVI secolo, che attua, ad esempio, «i
prelievi fiscali, le tariffe doganali, le regole di fabbricazione, le norme sui prezzi dei cereali, la
protezione e la codificazione delle pratiche di mercato, e altro ancora» e sono prassi pensate finora
in termini di «esercizio di diritti sovrani, di diritti feudali, di salvaguardia dei costumi …» ora
mutano di ruolo nella percezione e nella funzione. Queste pratiche non dipendono da criteri di vero
e falso stabiliti all’esterno di esse, magari secondo leggi morali, naturali, divine ecc.; ora legiferano
in termini di vero e falso, costituiscono il vero e il falso, sono pratiche di veridizione e presentano la
politica come luogo di veridizione. In loro si vede «l’emergere di questo regime di verità come
principio di autolimitazione del governo». [forse a partire dalla Magna Charta Libertatum, 1215)
4.2.1.01. È interessante notare l’accostamento economia e politica, come passaggio per definire che
cos’è l’arte politica, presente nell’opera di Platone, Politico: « LO STRANIERO Per esempio tutti i
commercianti all’ingrosso, gli agricoltori, i fornai, ed inoltre i maestri di ginnastica e i medici,
quanti sono, sai tu che potrebbero tutti senza eccezione sostenere energicamente contro coloro che
sono pastori d’uomini, e noi chiamammo ‘politici’, sostenere che essi stessi sono quelli che
veramente si interessano dell’allevamento degli uomini, e non solo del gregge degli uomini, ma
pure dei capi stessi degli uomini? SOCR. IL G. E avrebbero dunque ragione? LO STR. Forse.»
(Platone, Politico 267e268a)
29
4.3. la nuova arte di governo: governare al minimo incoraggiando al massimo [una prassi e un
modello liberale]
«È una nuova arte di governare caratterizzata, per l’essenziale, io credo, dalla messa a punto di
meccanismi che sono, sì, interni, numerosi e complessi, ma la cui funzione — e in questo risalta la
differenza rispetto alla ragion di stato — non è tanto quella di assicurare l’accrescimento dello stato,
la crescita indefinita dello stato in termini di forza, ricchezza, potenza, bensì piuttosto di limitare
dall’interno l’esercizio del potere di governare. […] Infatti, non si deve dimenticare che questa
nuova arte di governare — che è arte di governare il meno possibile, tra un massimo e un minimo,
scegliendo piuttosto il minimo che il massimo — la si deve considerare come una sorta di
raddoppiamento, o per meglio dire, di raffinamento interno della ragion di stato, di cui costituisce
un principio di mantenimento, di sviluppo più completo e di perfezionamento. Dunque, non si tratta
di qualcosa di diverso dalla ragion di stato, di un elemento esterno che nega la ragion di stato, bensì
piuttosto del punto di inflessione della ragion di stato nella curva del suo sviluppo. Per usare una
formula che resta inadeguata, direi che è la ragione dello stato minimo all’interno, e come suo
principio organizzatore, della stessa ragion di stato; o ancora, è la ragione del governo minimo
come principio di organizzazione della stessa ragion di stato.» (Foucault 2004, 35, 36; in nota:
Foucault, nel “Riassunto del corso”, rinvia a Benjamin Franklin: «A virtuous and laborious people
could always be ‘cheaply governed’ in a republican system» 278)
4.3.1. « la comparsa dell’economia politica e il problema del governo minimo sono due cose tra
loro collegate» (Foucault 2004, 37) « Si arriverà a riconoscere — ed è questo l’aspetto decisivo —
che tale luogo di formazione della verità, [anziché] continuare a saturarlo con una governamentalità
regolamentare indefinita, lo si dovrà lasciar funzionare con il minimo di interventi possibili perché
possa, a ragione, sia formulare la propria verità, sia proporla come regola e norma alla pratica di
governo. Questo luogo di verità naturalmente è il mercato, non la testa degli economisti. […]
Si potrebbe formulare più chiaramente le cose dicendo, in una parola, che il mercato — nel senso
esteso del termine, per come ha funzionato nel Medioevo, tra il XVI e il XVII secolo — è stato
essenzialmente un luogo di giustizia. Lo è stato in molti modi. […] …regolamentazione degli
oggetti da immettere sui mercati, il tipo di fabbricazione, l’origine dei prodotti, i diritti da pagare, le
stesse procedure di vendita e, infine, i prezzi fissati. Questo era dunque il mercato, un luogo
investito da una regolamentazione rigorosa. Era un luogo di giustizia, inoltre, nel senso che il
prezzo di vendita fissato nel mercato veniva considerato, tanto dai teorici quanto dagli operatori,
come un giusto prezzo o come un prezzo che comunque doveva corrispondere al giusto prezzo, vale
a dire un prezzo che doveva mantenere un certo rapporto col lavoro fatto, con i bisogni dei mercanti
e, ovviamente, con i bisogni e le possibilità dei consumatori. Luogo di giustizia, al punto che il
mercato doveva essere un luogo privilegiato della giustizia distributiva. … un luogo di giustizia
distributiva. Infine, era un luogo di giustizia perché la condizione che soprattutto doveva essere
garantita nel mercato, attraverso il mercato o piuttosto grazie alle sue regolamentazioni, che
cos’era? Era forse la verità dei prezzi, come diremmo oggi? Niente affatto. Era l’assenza di frode.
Si trattava, cioè, di proteggere l’acquirente. […] Questo sistema regolamentazione, giusto prezzo,
sanzione della frode — faceva sì che il mercato fosse essenzialmente, e funzionasse realmente come
un luogo di giustizia, un luogo in cui doveva manifestarsi nello scambio e formularsi nel prezzo
qualcosa come la giustizia. Diciamo pertanto che il mercato era un luogo di giurisdizione.»
(Foucault 2004, 37-38)
4.3.2. la costituzione del mercato come luogo di formazione di verità e non più solo come ambito di
giurisdizione. «Ma è in questo luogo che si verifica un cambiamento… […] A metà del XVIII
secolo, il mercato è sembrato non essere più, o comunque non dover più essere, un luogo di
giurisdizione. […] Da una parte, sembra obbedire, e anzi sembra dover obbedire, a meccanismi
“naturali”, cioè spontanei: anche se non si era in grado di cogliere questi meccanismi nella loro
complessità, la loro spontaneità era tale che, provando a modificarli, si finiva per alterarli e
snaturarli. Dall’altra parte il mercato — ed è in questo secondo senso che diventa luogo di verità —
non solo lascia intravedere i meccanismi naturali cui obbedisce, ma qualora si dia libero corso a
30
questi meccanismi, essi permettono di determinare un certo prezzo che Boisguilhert chiamerà
“prezzo naturale”, i fisiocrati “buon prezzo”, indicato in seguito come “prezzo normale”: insomma
un prezzo, comunque lo si voglia designare — naturale, buono, normale — che è tale in quanto
esprime un rapporto adeguato tra costo di produzione e ampiezza della domanda. […] In altri
termini, è il meccanismo naturale del mercato, insieme alla formazione di un prezzo naturale, a
permettere di falsificare e di verificare la pratica di governo, qualora si valuti sulla base di questi
elementi ciò che il governo fa, i provvedimenti che adotta, le regole che impone. Il mercato,
consentendo nello scambio di collegare fra loro la produzione, il bisogno, l’offerta, la domanda, il
valore, il prezzo e così via, costituisce in questo senso un luogo di verificazione, cioè un luogo di
verifica-falsificazione per la pratica di governo. È il mercato, di conseguenza, a far sì che un buon
governo non sia semplicemente un governo che procede secondo giustizia. È il mercato a far sì che
il buon governo non sia più soltanto un governo giusto. È ancora il mercato a far sì che ora il
governo, per essere un buon governo, debba funzionare secondo la verità. […] In termini semplici e
rudimentali, possiamo dire che il mercato, da luogo di giurisdizione quale era ancora all’inizio del
XVIII secolo, sta diventando un luogo che chiamerò di veridizione […] …il mercato, dopo essere
stato per moltissimo tempo oggetto privilegiato della pratica di governo — ed esserlo diventato
ancora di più nel XVI e XVII secolo con il regime della ragion di stato, e di un mercantilismo che
faceva del commercio uno dei maggiori strumenti della potenza dello stato —, si costituiva ora
quale luogo di veridizione.» (Foucault 2004, 38-40)
4.4. in prospettiva: dall’incontro arte di governo e prassi di mercato intesi, nel loro intreccio di
ruoli, come luogo di formazione di verità e non più solo come ambito di giurisdizione si aprono
nuovi percorsi dell’arte di governo… [non più di carattere liberale ma che ne richiamano in causa il
modello e i progetti]: la biopolitica [e i suoi rischi].
Ciò che diventa proprio e specifico del politico, dell’arte di governo, attraverso l’incontro con
l’economia politica intesa nella logica storica evidenziata, è che l’arte politica non è solo luogo di
gestione del sociale e dei suoi aspetti, ma diventa luogo di definizione (costituzione, veridizione)
del sociale proprio attraverso le regole di osservazione e di gestione da lei emanate. Si tratta allora
di non pensare alle funzioni sociali, quali il mercato, l’assistenza, la malattia, la giustizia, il sistema
penale, la sessualità… come a settori definiti in sé naturalmente, neutri e astorici, quasi un assoluto,
costituiti e definiti da uno statuto proprio e messi nella forma di scienza da una teoria che si
giustifica presentando i riscontri empirici possibili dei propri concetti, dei propri universali; settori
dunque pensati in assoluto e come a priori e affidati in gestione e regolamentazione allo stato e
all’arte di governo; è proprio questa arte di governo e di regolamentazione (di giurisdizione) a
definirli e costituirli in forme che poi la stessa gestione politica considera e presenta e impone non
come prodotto della propria arte di gestione, ma come realtà naturali uniche; cercando così, in esse,
l’accesso alla propria veste e legittimazione scientifica. Il controllo dell’agire diventa la definizione
dell’agire negli aspetti della legittimità o no, della normalità o anomalia, del vero e del falso;
diventa la definizione del desiderio e dei comportamenti nella loro modalità storica, regolarmente
naturalizzata. Il processo si rovescia: non si va dalla verità (dalla teoria) alle regole e alla gestione,
al governo secondo regole coerenti al vero, ma dalle gestione, secondo le regole del diritto, alla
verità, alla definizione di ciò che è vero / falso; si tratta appunto di un passaggio dalla giurisdizione
alla veridizione. E gli ambiti in cui ciò accade sono i settori che la recente riflessione politica indica
con un termine unico: biopolitica. Foucault ne indaga le forme sottoponendo ad esame alcuni settori
sociali e politici: follia, sistema penale, sessualità.
Torna allora d’urgenza l’analisi delle modalità dello stato liberale (lo stato frugale): il problema
della limitazione dell’esercizio della potenza pubblica. La veridizione come nuova definizione delle
potenzialità dello stato spiega l’urgenza delle teorie liberali e la loro portata, soprattutto in relazione
alla tesi e all’impegno originario dello stato frugale.
4.4.1. Ricostruendo per (tre) tappe:
31
4.4.1.1. «… nel regime della pura ragion di stato la governamentalità, o in ogni caso, la linea di
tendenza della governamentalità, era senza termine, senza fine. In un certo senso la
governamentalità era illimitata. Era proprio questo aspetto a caratterizzare quella che all’epoca
veniva chiamata polizia, e che in seguito, alla fine del XVIII secolo, con uno sguardo già
retrospettivo, verrà chiamato stato di polizia. Lo stato di polizia è un governo che si confonde con
l’amministrazione: un governo che è interamente amministrativo, e un’amministrazione che ha per
sé, dietro di sé, il peso integrale di una governamentalità.» (Foucault 2004, 44)
4.4.1.2. « Ho cercato di mostrarvi come questa governamentalità integrale, tendenzialmente
illimitata, avesse trovato di fatto non un limite, bensì una sorta di contrappeso, nell’esistenza di
istituzioni giudiziarie, di magistrati e di discorsi giuridici che vertevano, per l’appunto, sul problema
di [sapere] quale fosse il diritto del sovrano a esercitare il proprio potere, ed entro quali limiti di
diritto si potesse iscrivere la sua azione. Pertanto, [il potere del sovrano] non era del tutto squilibrato
e illimitato nella ragion di stato, dato che quest’ultima comportava una sorta di sistema con due
parti relativamente esterne l’una all’altra». (Foucault 2004, 44)
4.4.1.3. « Voi capite che il problema ora è del tutto diverso. […] … dato che la governamentalità
deve pur autolimitarsi, come si potrà formulare in termini di diritto questa autolimitazione senza che
il governo si trovi paralizzato, e senza al contempo soffocare — proprio qui sta il problema — quel
luogo di verità di cui il mercato forniva l’esempio privilegiato, e che bisognava a questo titolo
rispettare? In termini chiari, il problema che comincerà a porsi, a partire dalla fine del XVIII secolo,
è questo: se c’è un’economia politica, che ne è allora del diritto pubblico? […] …e cioè non si
poteva pensare l’economia politica, vale a dire la libertà del mercato, senza porre nel contempo il
problema del diritto pubblico, e cioè della limitazione della potenza pubblica.
Potremmo parlare, dunque, di uno spostamento del centro di gravità del diritto pubblico. Il
problema di gran lunga più importante del diritto pubblico non sarà più, come nel XVII e XVIII
secolo, quello di stabilire in che modo fondare la sovranità, a quali condizioni il sovrano sarà
legittimato, e a quali altre potrà esercitare legittimamente i suoi diritti, bensì decidere come fissare
dei limiti giuridici all’esercizio di una potenza pubblica. Per schematizzare, a questa elaborazione
sono state offerte essenzialmente due vie, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. La prima è
quella che chiamerei la via assiomatica giuridico-deduttiva: via seguita, almeno fino a un certo
punto, dalla Rivoluzione francese, e che in fondo potremmo anche chiamare la via rousseauiana. In
che cosa consiste? Prende le mosse, per l’appunto, non dal governo e dalla sua necessaria
limitazione, bensì dal diritto, e in particolare dal diritto nella sua forma classica; tenta, cioè, di
definire quali sono i diritti naturali o originari di ciascun individuo, per determinare in seguito a
quali condizioni, a causa di cosa, secondo quali formalità ideali o storiche è stata accettata una
limitazione o uno scambio di diritto. Consiste inoltre nel definire i diritti di cui si è accettata la
cessione e, viceversa, quali sono i diritti a cui non è stata accordata alcuna cessione, e che restano
perciò in ogni condizione di causa, e sotto qualsiasi governo o regime politico — imprescrittibili.
[…] Detto altrimenti, in maniera più chiara e semplice, questo modo di procedere consiste nel
partire dai diritti dell’uomo per giungere a stabilire i limiti della governamentalità, passando
attraverso la costituzione del sovrano. Questa via la chiamerei, in maniera approssimativa, la via
rivoluzionaria.
L’altra via consiste, invece, nel partire, non dal diritto, ma dalla pratica di governo in quanto tale.
[…] In breve, si tratta di promuovere l’analisi del governo, della sua pratica, dei suoi limiti di fatto e
dei limiti auspicabili, evidenziando su questa base ciò di cui sarebbe assurdo o contraddittorio per il
governo occuparsi. Meglio ancora, e più radicalmente, si tratta di far emergere ciò di cui sarebbe,
per il governo, inutile interessarsi. Questo significa che la sfera di competenza del governo sarà ora
definita, seguendo questa via, secondo il criterio di ciò che sarebbe utile o inutile, per il governo,
fare o non fare, Il limite di competenza del governo sarà definito dai confini dell’utilità di un suo
intervento. […] Si tratta qui piuttosto della questione radicale, della questione del radicalismo
inglese, il cui problema è infatti quello dell’utilità.» (Foucault 2004, 44-47)
32
4.5. Come conseguenza della doppia logica del limite, due concezioni eterogenee ma connesse
di libertà. «Abbiamo dunque due concezioni del tutto eterogenee della libertà: la prima formata a
partire dai diritti dell’uomo, la seconda a partire dall’indipendenza dei governati. Sono due sistemi,
quello dei diritti dell’uomo e quello dell’indipendenza dei governati, di cui non dirò che non si
compenetrano; hanno tuttavia un’origine storica diversa, e implicano un’eterogeneità e una disparità
— io credo — essenziali.» (Foucault 2004, 49)
4.5.1. «Ci troviamo di fronte, dunque, a due strade per costituire in diritto la regolazione della
potenza pubblica, due diverse concezioni della legge, due modi di intendere la libertà. È la stessa
ambiguità che caratterizza il liberalismo europeo del XIX secolo, e anche del XX. Quando parlo di
due diversi percorsi, di due vie, di due concezioni della libertà e del diritto, non voglio dire che
siamo di fronte a due sistemi separati, estranei, incompatibili, contraddittori, che si escludono a
vicenda; voglio dire che esistono due procedure, due tipi di coerenza, due modi di fare che
risultano, in un certo senso, eterogenei. Del resto è bene ricordare che l’eterogeneità non costituisce
mai un principio di esclusione; o meglio ancora, l’eterogeneità non impedisce in nessun caso la
coesistenza, la congiunzione, la connessione. Ed è anzi in questo caso particolare, in un’analisi
come questa, che possiamo far valere, e dobbiamo far valere, se non vogliamo cadere nel
semplicismo, una logica che non dev’essere una logica dialettica. Infatti, che cos’è la logica
dialettica? È una logica che mette in gioco dei termini contraddittori nell’elemento dell’omogeneo.
A questa logica della dialettica io propongo piuttosto di sostituire quella che chiamerei una logica
della strategia. Infatti, una logica della strategia non fa valere termini contraddittori in un elemento
dell’omogeneo, destinato a garantire la loro risoluzione in unità; al contrario, ha la funzione di
stabilire quali sono le connessioni possibili tra termini disparati, che restano tali. La logica della
strategia è la logica della connessione dell’eterogeneo, non quella dell’omogeneizzazione del
contraddittorio.» (Foucault 2004, 49)
Ed è questa l’essenza logico-politica del modello liberale quale vive nella lunga tradizione del
liberalesimo, fino al contemporaneo liberalesimo democratico (vedi J.Rawls).
4.6. Ritorna il ruolo dell’interesse, posto da Smith alla radice etica dell’economia (molla ad un
tempo della ricchezza di una nazione e del benessere dei cittadini), ora principio pratico per una
sovranità limitata (o limiti della governamentalità). Problemi aperti.
«Parlando del mercato, abbiamo osservato poco fa che uno dei punti di ancoraggio della nuova
ragione di governo era il mercato, in quanto meccanismo degli scambi e luogo di veridizione per ciò
che concerne il rapporto tra valore e prezzo. Ora troviamo un secondo punto di ancoraggio della
nuova ragione di governo, costituito dal formarsi della potenza pubblica, e dalla misura dei suoi
interventi calibrati in base al principio di utilità. Scambio dal lato del mercato, utilità dal lato
dell’autorità pubblica. […] La ragione di governo, nella sua forma moderna — definita all’inizio del
XVIII secolo e caratterizzata, fondamentalmente, dalla ricerca del proprio principio di
autolimitazione —, è una ragione che funziona in base all’interesse. Solo che non si tratta più,
ovviamente, dell’interesse di uno stato interamente riferito a se stesso, che mira esclusivamente alla
propria crescita, alla propria ricchezza, alla propria popolazione, alla propria potenza, come
avveniva con la ragion di stato. L’interesse, al cui principio la ragione di governo deve ora
obbedire, è costituito da un insieme di interessi, da un gioco complesso fra gli interessi individuali e
quelli collettivi, fra utilità sociale e profitto economico, fra equilibrio del mercato e regime della
potenza pubblica, una complessa interazione tra diritti fondamentali e indipendenza dei governati. Il
governo, per lo meno quello che si esercita all’interno di questa nuova ragione di governo, è
diventato qualcosa che manipola degli interessi.» (Foucault 2004, 51)
In sintesi e per confronto: 1. nel sistema precedente: il sovrano (monarca, stato) ha presa diretta
sulle cose, sulle terre, sui sudditi in quanto sudditi… era considerato spesso proprietario del regno e
a questo titolo poteva intervenire… 2. nel sistema attuale (liberale, limitato) non ha una presa
33
diretta sulle cose, sulle persone, può intervenire, sulla base del diritto e della ragione, solo nella
misura dell’interesse. Si interessa solo degli interessi degli individui e della collettività.
4.6.1. «A partire dalla nuova ragione di governo — ed è questo il vero punto di distacco tra la
ragion di stato e la ragione dello stato minimo —, ormai il governo non deve più intervenire, non ha
una presa diretta sulle cose e sulle persone; non può averla, né è legittimato ad averla, essendo
autorizzato a intervenire, sulla base del diritto e della ragione, solo nella misura in cui l’interesse, o
gli interessi, o i giochi degli interessi, rendono un dato individuo, una data cosa, un dato bene, una
data ricchezza, un dato processo, di un certo interesse per i singoli individui, o per l’insieme degli
individui, o per gli interessi di un certo individuo a confronto con l’interesse di tutti ecc. Il governo
si interessa ormai solo degli interessi. Il nuovo governo, la nuova ragione di governo, non ha a che
fare con quelle che chiamerei le cose in sé della governamentalità: gli individui, le cose, le
ricchezze, le terre. Non ha più a che fare con queste cose in sé. Ha piuttosto a che fare con quei
fenomeni della politica che sono gli interessi, nel loro costituire in senso proprio la politica e le sue
poste in gioco: gli interessi, ovvero ciò per cui il tal individuo, la tal cosa, la tal ricchezza, e così
via, interessa agli altri individui o alla collettività.» (Foucault 2004, 52)
4.6.2. Sullo sfondo riemergono i problemi contemporanei (ma problemi di lungo corso): lo
sconforto del liberalesimo per l’insolvenza delle sue promesse e condizioni di ottimismo / il
neoliberismo come consapevolezza e rimedio / il lungo (infinito) dibattito sullo welfare e sulla sua
crisi / il rischio ultraliberistico economico e politico: «il mercato si impadronisce della vita sociale e
individuale, sostituisce e cancella ogni mediazione istituzionale» (Rodotà Stefano 2011, Foucault e
le nuove forme del potere, gruppo editoriale l’Espresso, 13), dimostrando nei fatti l’inosservanza e
l’inefficacia di tutti i propositi di autolimitazione e veridazione che mercato libero e politica dello
stato minimo andavano (più o meno consapevolmente) proclamando e promettendo.
La via di uscita intesa come punto prospettico è forse quella indicata da Smith, formulata negli
aspetti strutturali della Teoria dei sentimenti morali, che costituisce ancora il principio cardine della
tradizione liberale: il riconoscimento di un “indecidibile”, un’area nella quale non possono entrare
né mercato né stato: il sentimento, l’immaginazione e il soggetto come spettatore interiore e
universale ad un tempo.
5. rileggere anche Smith in chiave antiutilitaristica
5.1. Il problema e la tesi. Le affermazioni di Smith, più volte citate e diventate un vero e proprio
mantra del liberismo, tradotte in slogan “vizi privati = pubbliche virtù, portano a collocare Smith
nella schiera degli utilitaristi, tra cui la produzione culturale economica, etica e politica soprattutto
inglese colloca molti esponenti: Hobbes,Bentham, Hutcheson, (e i francesi) Helvétius, Mandeville,
(per alcuni a partire già da Socrate e Platone). Cerca il tuo utile egoistico e produrrai,
inconsapevolmente e quindi senza affanno e mestizia, il benessere collettivo. Anzi la convinzione è
che «non c’è vero utile per l’individuo se esso non favorisce anche il maggior bene possibile per
tutti» (Enciclopedia Garzanti filosofia 960a, 1981). «Per principio di utilità si intende quel principio
che approva o disapprova qualunque azione a seconda della tendenza che essa sembra avere ad
aumentare o diminuire la felicità della parte il cui interesse è in questione; o, che è lo stesso
concetto in altre parole, a seconda della tendenza a promuovere tale felicità o a contrastarla. Mi
riferisco a qualsiasi azione, e perciò non solo ogni azione di un privato individuo, ma anche ogni
provvedimento di governo» (J. Bentham, Introduzione ai princìpi della morale e della legislazione,
a cura di E. Lecaldano, trad. e note di S. Di Pietro, Utet, Torino 1998, cap. I, 2, p. 90).
Il confronto tra utilitaristi e antiutilitaristi attraversa quindi l’intera storia del pensiero occidentale e
non solo, per la rilevanza del tema che lo genera: «la posta in gioco è fin dall’Antichità il nesso tra
virtù e felicità» (Fistetti Francesco, prefazione a A. Caillé, 2008 Critica dell’uomo economico. Per
una teoria anti-utilitarista dell’azione, Il Melangolo, Genova 2010)
In realtà, nelle sue opere, Smith costruisce in forma ricorrente un rapporto critico proprio con coloro
che vengono catalogati tra gli utilitaristi, in particolare: Hutcheson, Mandeville. La riserva critica
nei loro confronti parte dalla tesi centrale della Teoria morale sui sentimenti. Non è l’utile
34
individuale che porta meccanicamente al legame sociale (e quindi anche all’economia e ai suoi
vantaggi) ma la simpatia; il sentimento spontaneo di partecipazione ai piaceri e ai dolori altrui.
5.1.1. Se si parte dall’egoismo è difficile costruire una convincente relazione sociale, essa è esterna
al soggetto e viene infatti, in tali casi, affidata, dallo stesso Smith, alla “mano invisibile”. Se si parte
invece dalla simpatia la relazione è un tratto naturale antropologicamente costitutivo del soggetto.
«In origine … approviamo il giudizio di un altro uomo non come qualcosa di utile, ma come
qualcosa di giusto, accurato, in accordo con la verità e la realtà … L’idea dell’utilità di tutte le
qualità di questo tipo è chiaramente qualcosa di cui ci occupiamo successivamente, e non è ciò che
primariamente le raccomanda alla nostra approvazione.» (Smith 1759, Teoria 100-101)
5.1.2. Smith osserva e descrive con esempi particolareggiati come nel vivere quotidiano noi
compiamo molte azioni che non possono essere spiegate con il principio dell’utilità; sono inutili, o
per lo meno non si collocano al primo livello per utilità, ad esse tuttavia diamo molta rilevanza e
niente ci distoglie dal dedicarci ad esse con molta cura; dalla disposizione delle sedie in un salotto
al contenuto delle nostre tasche (quelle del ‘700 ben più capienti delle nostre, basta pensare ai livre
de poche); e gli esempi sono di Smith.
«Quante persone si rovinano buttando soldi per gingilli di frivola utilità? Quello che piace a questi
amanti dei ninnoli non è tanto l’utilità, quanto 1’idoneità dei congegni che sono adatti a produrla.
Le loro tasche sono piene di piccole cianfrusaglie. Inventano nuove tasche, inesistenti negli abiti
delle altre persone, per portarsene dietro ancora di più. Passeggiano carichi di una quantità di
bagattelle, non inferiori per peso, e a volte per valore, al normale carrettino di un ambulante ebreo;
alcune di queste bagattelle possono trovare a volte una minima utilizzazione, ma si potrebbe in
qualsiasi momento fare a meno di tutte, e la loro eventuale utilità certamente non vale la fatica del
carico. E non è solo per quanto riguarda questi frivoli oggetti che la nostra condotta è influenzata da
questo principio. Esso è spesso il movente segreto dei più seri e importanti risultati della vita sia
pubblica che privata.» (Smith 1759, Teoria 369-370)
5.2. Negli ultimi anni del ‘900: il MAUSS Movimento anti-utilitarista nella Scienza Sociale.
«… un lungo cammino di ricerca, iniziato insieme ad economisti, sociologi, antropologi con la
fondazione nel 1981 della Revue du MAUSS , la rivista del Movimento anti-utilitarista nella Scienza
Sociale, la cui fonte d’ispirazione fondamentale è Marcel Mauss (1872-1950), eroe eponimo della
tradizione antropologica francese, insieme con Karl Polanyi (1886-1964), autore del celebre testo
La grande trasformazione, il cui pensiero viene assunto fin dai primi numeri come un punto di
riferimento centrale della rivista. […]
L’antropologo Mauss e l’economista Polanyi condividono l’idea che l’essere umano non è stato
sempre un animale economico, una macchina fatta per calcolare i costi e i benefici, i piaceri e le
pene di ogni sua azione. L’economia “sostantiva” non è strutturata, come ripete il dogma del
liberalismo economico, dal mercato sulla base della variabilità dei prezzi, ma dalla reciprocità al
fine di soddisfare i bisogni materiali; obbedisce alla logica del dono e del contro-dono, enucleata da
Mauss, o alla logica della redistribuzione, “i.e. della gestione familiare o statale delle risorse al cui
interno viene assicurato il controllo dei mercati e dei prezzi là dove ci sono i mercati.” Solo
l’economia moderna in quanto economia di mercato autoregolata è un’economia “formale”, nel
senso che essa tende sempre di più a presentarsi come disocciata/disincastrata (desembedded) dalla
società e a subordinare gerarchicamente le relazioni tra i soggetti umani alle relazioni con le cose.»
(Fistetti Francesco, prefazione a A. Caillé, 2008 Critica dell’uomo economico. Per una teoria antiutilitarista dell’azione, Il Melangolo, Genova 2010)
5.2.1. Mentre è diffusa l’idea che la forma primitiva e naturale posta all’origine della produzione,
dello scambio e quindi dell’economia sia il baratto, Mauss, nel Saggio sul dono, del 1925, sulla
base delle proprie letture riguardanti le ricerche antropologiche, afferma che non il baratto ma il
dono sia la prassi su cui si costruisce una società e il suo produrre. Non esiste dunque una economia
come settore autonomo e separato dalla relazione sociale che è contenuta nel dono e nella logica
specifica che antropologicamente lo caratterizza. Si tratta di un processo di dare, ricevere, restituire
35
che crea fatti sociali totali a tre livelli di totalità: tutto è scambiabile, tutto il gruppo è coinvolto
nello scambio, tutte le pratiche e attività entrano nella logica dello scambio.
(osservazioni ricavate da conferenza pubblica di Paolo Vitali, aprile 2012)
5.2.2. L’antropologia, che non si limita o addirittura smette di «riempire la casella del selvaggio»
(Appadurai), diventa studio di quanto il dono, in ogni società, costituisca la relazione sociale e si
intrecci, forse per tradizione, in occulto, senza programmazione, con la prassi mercantile dello
scambio merci. Se merce e dono individuano due modelli di società ben diversi tra loro, le loro
specifiche ambivalenze permettono tuttavia di notare margini di sovrapposizione o di vicinanza e
portano quindi a cogliere nel sociale contemporaneo, e poi immaginare nel progetto politico, le
forme di comunicazione e intreccio tra le due prassi, merce e dono.
5.2.3. Nelle scienze sociali si sono alternati e si contrappongono due soli paradigmi: individualismo
e olismo (principio dell’egoismo e principio comunitario, interessi individuali e interesse
collettivo); occorre introdurre un terzo paradigma: il convivialismo (spunti sempre da Paolo Vitali).
5.2.3.1. Secondo l’individualismo metodologico la società è la risultante dei calcoli individuali e in
particolare dell’homo oeconomicus; su tale base si costruiscono le teorie utilitaristiche, del libero
mercato, liberali (a partire ancora da Smith, Mill…). Si tratta di un paradigma che affida alla “mano
invisibile” la propria incapacità di pensare la genesi dell’alleanza sociale, la sua forma e la sua forza
intesa non solo in termini di vincolo.
5.2.3.2. Secondo l’olismo metodologico il tutto è maggiore delle sue parti; è storicamente,
logicamente e normativamente superiore agli elementi che contiene (a partire da Platone, fino a
Hegel, alle teorie socialiste stataliste e ai totalitarismi). L’olismo postula la totalità organica e
armonica come un a priori ontologico in cui formare e legittimare l’esistenza e l’azione degli
individui.
5.2.3.3. Occorre introdurre un terzo paradigma: il convivialismo. Si tratta di un paradigma che,
appena evidenziato, segnala la propria presenza, multiforme, nel corso storico delle riflessioni
etiche e politiche. Si tratta di far leva sulla tendenza naturale e sociale alla relazione espressa in più
modi. Dal “piacere della reciproca simpatia”, di cui parla Smith come sentimento e passione
originaria al tema della convivialità e del dono principio fondativo del sociale secondo le tesi di
carattere antropologico e sociologico di Mauss, Caillé, Polanyi (e del gruppo del MAUSS); obbligo
e libertà, interesse e amorevolezza (aimance) si intrecciano, secondo Caillè (Pour un manifeste du
convivialisme 2011), nella relazione sociale nella forma di quattro poli interconnessi; nessuno è
senza l’altro, nessuno può dedurre da sé l’altro vantando una priorità.
Intreccio e ambivalenza sono strumenti per smontare teorizzazioni unilaterali, paradigmi rigidi e
sempre più a priori, scongiurare ogni riduzionismo (sempre comodo e sempre strumentale);
compreso quello che può accumunare l’individualismo metodologico e l’olismo sociale e lo stesso
convivialismo: che l’eliminazione delle istituzioni, in quanto fredde e burocratiche, possa
finalmente prendere forma la comunità. Scrive, in forma di bilancio delle battaglie combattute nel
corso degli anni Sessanta, Richard Sennett: «I contestatori dei miei tempi credevano che
smantellando le istituzioni si potessero produrre delle comunità: relazioni faccia a faccia di fiducia e
solidarietà, costantemente rinegoziate e rinnovate; un mondo orientato in senso comunitario, nel
quale ognuno sarebbe diventato sensibile ai bisogni degli altri. Indubbiamente, questo non è
avvenuto. La frammentazione delle grandi istituzioni ha fatto sì che molte persone vivano in una
condizione anch’essa frammentata. I luoghi dove la gente lavora assomigliano più a stazioni
ferroviarie che a villaggi e le esigenze del lavoro hanno indotto un disorientamento della vita
familiare. L’emigrazione è l’icona dell’epoca globale, che ci spinge ad andare avanti anziché
assestarci. Smantellare le istituzioni non ha prodotto più comunità.» Sennett Richard 2006, La
cultura del nuovo capitalismo, il Mulino, Bologna 2006, 7-8
5.2.4. Non si tratta di questioni riguardanti le teorie economiche, il loro statuto, il loro metodo, la
loro evoluzione; si tratta dei problemi della contemporanea società.
«La domanda che vi è sottesa, infatti, è se il destino del pianeta è quello di diventare una grande ed
unica società di mercato o se è possibile reinventare e ridefinire le vie di un nuovo “reincastro”
36
(embeddedness) dell’economia nella società in modo che le società umane possano esercitare forme
di controllo democratico sulle dinamiche economiche e finanziarie. Si comprende, inoltre, come le
poste in gioco di questa domanda siano non solo di ordine scientifico, come la riconsiderazione
dello statuto disciplinare dell’economia, che va restituita alle scienze morali a cui pure apparteneva,
da Aristotele fino all’economia politica classica, ma anche di ordine politico. Si pensi a temi
cruciali come la qualità della democrazia, i rapporti tra democrazia e capitalismo, i limiti del
compromesso socialdemocratico, la crisi del welfare State, la questione del riconoscimento delle
culture subalterne fino ad oggi emarginate sulla scena internazionale, la trasformazione in senso
multiculturale delle società postcoloniali, la formazione di una società civile mondiale, e soprattutto
il bisogno sempre più impellente di una governance poliarchica di carattere sovranazionale in
ragione dell’insorgere di sfide transnazionali come la fame, le siccità, i disastri naturali, il
terrorismo, ecc. Rispetto a queste emergenze assolutamente inedite la ristrettezza del “modello
economico” dominante appariva sempre più evidente.» (Fistetti Francesco, prefazione a A. Caillé,
2008)
Completare proseguendo con la lettura di Fistetti a partire dal § 2
Vecchio schema
[1] Al primo punto: un quadro ampio e orientativo: l’albero del liberalesimo
Dal volume scolastico di Tassinari De Renzis: Il liberalesimo Autori temi prospettive
[2] Al secondo punto: l’economia politica (con forti tratti, in Smith, di antropologia economica)
2.1. brevi tappe storiche: mercantilismo, fisiocrazia, liberismo
[ipotesi di tre fasi: 1. I fisiocratici, il concetto fisico di valore che si evidenzia nella libertà di
scambio; 2. I mercantilisti, il concetto astratto di valore e il ruolo generale dello scambio per la sua
realizzazione, il conseguente ruolo produttivo della divisione del lavoro, specializzazione (Smith);
3. Economia politica (Marx): centralità dello scambio per definire l’economia “capitalistica”
(termine non di Marx) a partire dalla nuova natura del prodotto: individuato come merce]
[3.] al terzo punto: l’economia politica e l’arte di governo
[4] al quarto punto: le teorie di Smith
4.1. la premessa da Mandeville, la favola delle api
4.2. la teoria dei sentimenti
4.3. l’origine della ricchezza delle nazioni
4.4. il ruolo dello Stato (positivo / negativo)
Altro vecchio schema
Occasione per il convergere di più argomenti
37
1. l’albero storico del liberalesimo: da volume scolastico dell’Einaudi
2. le teorie di Smith
3. le tesi sull’antropologia economica come da testo di Hann Chris, Hardt Keith, 2011 Antropologia
economica. Storia, etnografia, critica, Einaudi, Torino (o spostare a Marx e sostenere la tesi che
l’economia classica si è sempre presentata in termini di antropologia economica e mai solo di
economia pura…)
4. le tesi di Berlin Isaiah 1958 Due concetti di libertà, Feltrinelli, Milano 2000 (il testo è a
computer) da cui concetti generali di liberalesimo e due problemi:
- distinzione libertà di, libertà da
- il rapporto costrizione e libertà (e ricorda Spinoza: si oppongono libertà e costrizione, si legano
libertà e necessità se si tratta di necessità della propria natura; è questo il solo ambito di una
possibile costrizione, in termini di libertà positiva, nei confronti [e a sostegno] di una libertà
negativa; ma vedi il dibattito in Berlin)
38