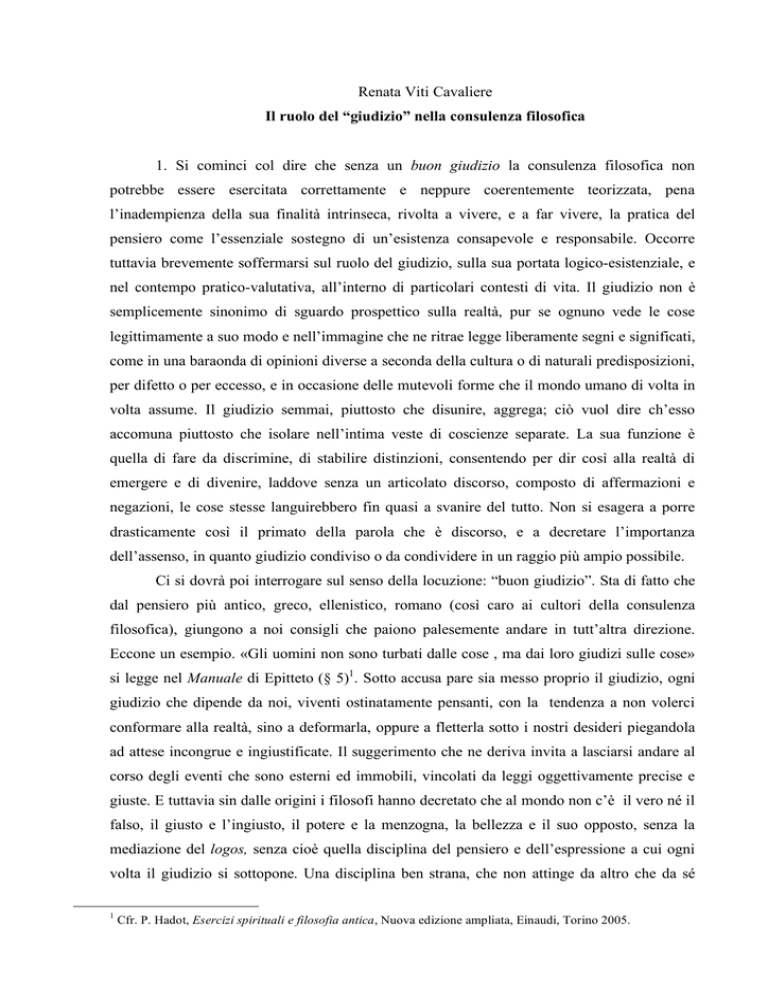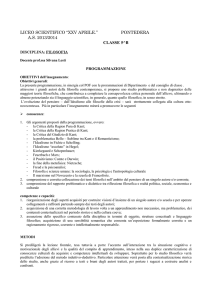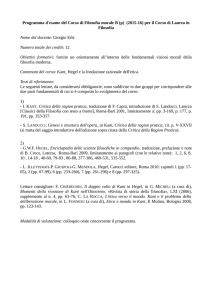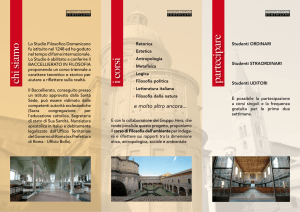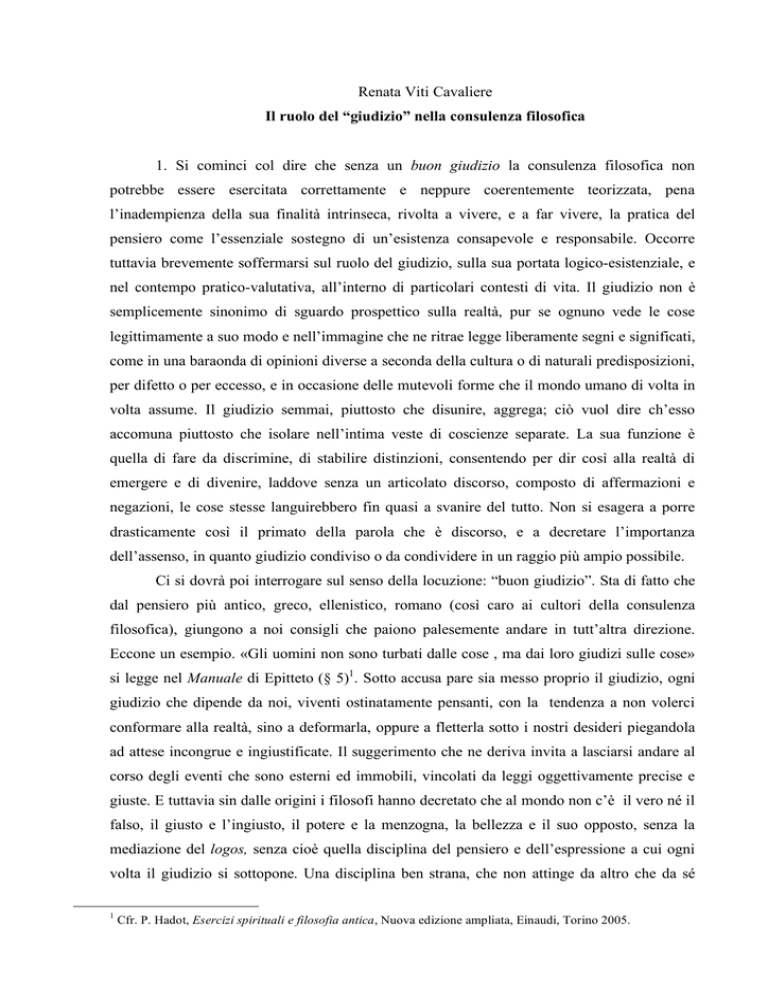
Renata Viti Cavaliere
Il ruolo del “giudizio” nella consulenza filosofica
1. Si cominci col dire che senza un buon giudizio la consulenza filosofica non
potrebbe essere esercitata correttamente e neppure coerentemente teorizzata, pena
l’inadempienza della sua finalità intrinseca, rivolta a vivere, e a far vivere, la pratica del
pensiero come l’essenziale sostegno di un’esistenza consapevole e responsabile. Occorre
tuttavia brevemente soffermarsi sul ruolo del giudizio, sulla sua portata logico-esistenziale, e
nel contempo pratico-valutativa, all’interno di particolari contesti di vita. Il giudizio non è
semplicemente sinonimo di sguardo prospettico sulla realtà, pur se ognuno vede le cose
legittimamente a suo modo e nell’immagine che ne ritrae legge liberamente segni e significati,
come in una baraonda di opinioni diverse a seconda della cultura o di naturali predisposizioni,
per difetto o per eccesso, e in occasione delle mutevoli forme che il mondo umano di volta in
volta assume. Il giudizio semmai, piuttosto che disunire, aggrega; ciò vuol dire ch’esso
accomuna piuttosto che isolare nell’intima veste di coscienze separate. La sua funzione è
quella di fare da discrimine, di stabilire distinzioni, consentendo per dir così alla realtà di
emergere e di divenire, laddove senza un articolato discorso, composto di affermazioni e
negazioni, le cose stesse languirebbero fin quasi a svanire del tutto. Non si esagera a porre
drasticamente così il primato della parola che è discorso, e a decretare l’importanza
dell’assenso, in quanto giudizio condiviso o da condividere in un raggio più ampio possibile.
Ci si dovrà poi interrogare sul senso della locuzione: “buon giudizio”. Sta di fatto che
dal pensiero più antico, greco, ellenistico, romano (così caro ai cultori della consulenza
filosofica), giungono a noi consigli che paiono palesemente andare in tutt’altra direzione.
Eccone un esempio. «Gli uomini non sono turbati dalle cose , ma dai loro giudizi sulle cose»
si legge nel Manuale di Epitteto (§ 5)1. Sotto accusa pare sia messo proprio il giudizio, ogni
giudizio che dipende da noi, viventi ostinatamente pensanti, con la tendenza a non volerci
conformare alla realtà, sino a deformarla, oppure a fletterla sotto i nostri desideri piegandola
ad attese incongrue e ingiustificate. Il suggerimento che ne deriva invita a lasciarsi andare al
corso degli eventi che sono esterni ed immobili, vincolati da leggi oggettivamente precise e
giuste. E tuttavia sin dalle origini i filosofi hanno decretato che al mondo non c’è il vero né il
falso, il giusto e l’ingiusto, il potere e la menzogna, la bellezza e il suo opposto, senza la
mediazione del logos, senza cioè quella disciplina del pensiero e dell’espressione a cui ogni
volta il giudizio si sottopone. Una disciplina ben strana, che non attinge da altro che da sé
1
Cfr. P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Nuova edizione ampliata, Einaudi, Torino 2005.
2
stessa, perché il giudizio “dipende” da noi, ed è perciò nostro compito, e nostro preciso
dovere, anche tenerlo a freno, magari proprio esasperando la sua funzione aggregante,
mettendoci in qualche modo al riparo dai tanti possibili tentativi di aggiustamento dei fatti per
scopi solamente di parte. Il bene e il male si appalesano, dunque, non altrove che nei giudizi
sulle cose, e i turbamenti dell’animo che ne nascono sono come l’interfaccia dei più intimi
patimenti del logos, che non si rassegna a tacere o ad approvare incondizionatamente. Proprio
dal mondo antico giunge a noi una immagine divenuta classica del pensiero partecipativo e
“politico”, che ha indicato ai moderni la via maestra del confronto e dell’autonomia di
giudizio, accanto alla ricerca dei modi e delle strutture in cui accadono la verità e il significato
nelle loro più varie espressioni. Quel che perciò la filosofia svela più che nascondere, magari
secondo quelle “rivelazioni successive” di cui amava parlare Lessing, potrà essere messo al
servizio della vita pratica e dell’azione individuale in virtù di un certo non immotivato ritorno
al dialogo teoretico di socratica memoria; purché si sappia che non c’è confronto dialettico
senza i temuti rischi e i relativi turbamenti, che in tal caso riguardano la possibilità dell’errore
e dell’incoerenza, proprio in virtù del richiesto passaggio – ritenuto a ragion veduta
inevitabile (come già insegnava Aristotele) – dall’astratto al concreto, dal sapere generale al
caso singolo, dallo schema al particolare inedito. «Bisogna… evitare … di essere come uno
che abbia imparato a memoria un manuale di armonia musicale e non sappia esercitarla», così
ammoniva il testo di un significativo esponente dell’antica Accademia2; e Kant, nel tempo che
fu suo, dopo un bel po’ di secoli, ancora smascherava l’inganno di coloro che esibiscono
filosofie mandate a memoria come una sorta di tecnica del pensiero, mentre elogiava la
capacità di fare un uso libero, non imitativo né meccanico, della propria ragione. Kant è stato
il teorico dell’esercizio pratico della facoltà del giudizio: un talento naturale, un dono ricevuto
non per grazia elettiva, tale da garantire l’applicazione in concreto di regole altrimenti
sicuramente a rischio di astratto intellettualismo3. I turbamenti che nascono dal giudizio sulle
cose sono dunque il sale della vita, per cui vivere filosoficamente significa frequentare il
mondo con abilità logica e spregiudicatezza teorica, e al tempo stesso con i tormenti che
accrescono la passione etico-politica. Alla domanda: «cosa s’intende per un “buon
giudizio”?», si risponde sin d’ora che in sé ogni giudizio è buono, se per suo tramite si fa
onore al vivere degnamente umano, e si allontanano – è pur vero – provvisoriamente le
angosce del quotidiano. Rispetto al senso letterale del motto di Epitteto propongo dunque una
2
Ivi, p. 158. Il riferimento a Polemone è tratto da Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, tr. di M. Gigante,
Bari 1960, p. 172.
3
I. Kant, Critica della ragion pura, Analitica dei princìpi, Introduzione: Del giudizio trascendentale in
generale.
2
3
sensibile mutazione di significato, che ha però il pregio, mi pare, di evitare il risvolto banale
di un’etica del disimpegno.
2. Cos’è in generale un giudizio? Tema cruciale della logica proposizionale, il giudizio
porta anzitutto in sé il sigillo dell’essere, vale a dire appartiene all’originario luogo da cui
proviene il mistero del discorso umano nel mondo. Soggetto e predicato sono come gli
opposti uniti nel simbolo eracliteo del logos che è fuoco e che scandisce la misura del
movimento: legge universale è il dono del discorso che coglie l’armonia dei contrari. Il
giudizio dice l’intero per Parmenide, cioè “decide” la forma dell’essere determinato,
escludendo il non essere, mentre fu merito di Platone la scoperta dell’”altro” (l’eteron,ossia il
non-essere) presente nel giudizio in qualità non già del mero sensibile ma dell’immagine
dell’individuale4. E si potrebbe procedere a lungo intorno alla logica arcaica dei presocratici e
dei platonici, sino all’aristotelica distinzione di sapere e saggezza (sophia e phronesis)5 e
infine alle suggestioni contenute nella valenza retorica del latino iudicium, nel quale si
esplicitava il carattere mondano e concreto della capacità di riflessione. A questi presupposti
peraltro induce a pensare lo stesso Kant, al quale si deve – come già sottolineato – la ripresa
dello iudicium nella figura della Urteilskraft, nella Terza Critica, e dunque la teorizzazione del
ruolo della capacità di “giudizio” nella sfera in senso stretto estetico-valutativa e in senso più
ampio pratico-teleologica6. Non è un caso che alla dottrina del giudizio riflettente, con le sue
varie implicazioni logiche, ontologiche, politiche, si rifaccia buona parte della filosofia
contemporanea, quasi a volere in ogni modo sottrarre la sfera delle motivazioni personali
legate alla pratica filosofica più in generale, ai tranelli di una perniciosa fedeltà ai cosiddetti
paradisi “istituzionali” (Gehlen), alle abitudini cronicizzate, alle regole perentoriamente
assunte ed imposte in epoca di dominio delle tecnoscienze. Una larga fetta della riflessione
odierna guarda perciò con grande interesse alla ripresa del “giudizio”, come alla facoltà
propriamente umana che responsabilizza ed aggrega parimenti, senza dare più alcun credito
ad una pura razionalità priva di passioni o a rinnovate invadenze iperrazionalistiche magari in
nome di una restaurata filosofia della storia. Il “giudizio” si pratica nella sfera riconosciuta
della contingenza del mondo umano e nella consapevolezza acquisita della totale assenza di
criteri pregressi, passivamente ricevuti dalla tradizione e dogmaticamente applicati. L’aspetto
più interessante del pensiero kantiano riguarda infatti la dottrina del giudizio di gusto inteso in
4
Un testo classico sull’argomento resta quello di E. Hoffmann, Il linguaggio e la logica arcaica (1925),
ed. it. a cura di L. Guidetti, Ferrara 1991.
5
Aristotele distingueva tra phronesis e synesis, indicando in quest’ultima la capacità critica del giudicare,
che precede il carattere imperativo del buon senso acquisito (Et. Nic., VI, 11, 1143a10). Tuttavia saggezza
e capacità di giudizio riguardano entrambe il dominio non della scienza ma della perspicacia pratica.
6
I. Kant, Kritik der Urteilskraft (1790); si preferisce ora in traduzione italiana il testo a cura di L.
Amoroso, Critica della capacità di giudizio, Milano 1995.
3
4
senso largo come la possibilità di comprendere il particolare mediante la capacità di misurare
di volta in volta la legalità del casuale. Il mondo accade veramente, quanto al suo essere per
noi che lo abitiamo, nell’evento originario del giudizio, che è fonte di relazioni interumane
nella costruzione del senso di cui ci si assume il peso e il valore. Di fatto è proprio il ruolo
imperativo dell’intersoggettività che viene progressivamente scardinato, sino a far emergere il
compito della pratica individuale del discorso in comune7. Il riferimento all’opera di Kant è
pressoché d’obbligo, anche per un motivo all’apparenza estrinseco. In essa la ragione pare
occuparsi solo di sé stessa. Ed è un bene che sia così perché la filosofia non si lascia “tradire”
nella prassi, e conserva opportunamente una impegnativa struttura teorica di fondo. Epperò,
benché in assenza di vistosi riscontri reali, sociali, psicologici e antropologici, nelle prime due
Critiche – si è detto – Kant aveva passato al laminatoio le tante questioni di biologia e di
scienza fisica, di analisi sociale e di ipotesi finali venate di malcelata metafisica, sino ad aprire
il sistema nel ’90 con la Critica del Giudizio al nuovo per definizione, al particolare, al
vivente, alla storia8. Il gusto, analizzato secondo la forma del giudizio riflettente estetico, si
svela un modo di pensare, un bisogno di confronto reale, una disposizione al bene morale, la
capacità di sentire la voce dell’universale uscendo dal particolarismo di una soggettività
irrelata. La ripresa della nozione latina di sensus communis è emblematica: ci si appellava ad
una sorta di senso che abbiamo in comune non già per avallare forti radicamenti storici e
culturali, ma per dare piuttosto spazio allo spirito comunitario sul piano della validità
universale di princìpi per loro natura trascendentali. All’identità di gruppo si sostituisce
l’esigenza di una mentalità molto ampia, la più ampia possibile, sul piano s’intende non dei
contenuti ma delle loro potenzialità d’incontro e sulla base del rispetto dei princìpi del
discorso seriamente dialettico9. Il senso comune di cui parla Kant è più vicino al vichiano
principio direttivo dell’azione (di tutto un popolo, ma anche di tutto il genere umano) che non
al mondo della vita entro chiusi giochi linguistici di stampo wittgensteiniano. Si tratta di un
senso comunitario che non alimenta apparati di dipendenza, ma sancisce che esiste un fondo
originariamente unitario nella stessa umana natura, la quale possiede la facoltà nascosta e
misteriosa del giudizio, la sola che renda la filosofia fedele al suo scopo di partenza. Il
consulente filosofico non potrà non tenerne conto.
7
Ricordo solo alcuni tra i più importanti autori contemporanei che hanno trattato il tema del giudizio:
Jaspers, Gadamer, Arendt, Lyotard, e in Italia, Croce, Scaravelli, Antoni.
8
L. Scaravelli, Osservazioni sulla “Critica del Giudizio” di Kant (1955), in Opere di L. Scaravelli, a cura
di M. Corsi, vol. II, Firenze 1968.
9
In particolar modo Hannah Arendt ha riconsiderato la nozione di “senso comune”, sia ne La vita della
mente, ed. it., Il Mulino, Bologna 1987, sia nelle sue lezioni kantiane: Lectures on Kant’s Political
Philosophy (1982), tr. it., Teoria del giudizio politico, Genova 1991.
4
5
3. Non entro nel merito della pratica della consulenza filosofica, alla quale oramai
specialisti del settore, in Italia e fuori dell’Italia, hanno dedicato scritti acuti e particolarmente
impegnati10. Aggiungo però alcune considerazioni connesse alla tesi della centralità teorica
della questione del giudizio. Il dialogo tra non esperti, tra il filosofo praticante, socraticamente
conscio di non sapere e l’ospite che richiede “aiuto” si svolge comunque in condizioni di
evidente squilibrio, se non di vera e propria dipendenza reciproca. Il postulante aspetta
conforto al suo male di vivere, e il consulente potrebbe cadere nel facile errore di trovare vie
rassicuranti muovendo in primo luogo le emozioni e poi risospingendo l’interlocutore
all’interno della sua realtà di provenienza. Entrambi i procedimenti poco o nulla avrebbero a
che fare con la filosofia e col senso da essa tradizionalmente assunto. La sollecitazione
critico-razionale, si sa, mette piuttosto l’animo in allarme producendo ansia di decisione, e
potrebbe cedere facilmente il passo a pur meritevoli ma più agili prospettive di una maggiore
serenità interiore. A ben vedere l’imbarazzo del consulente filosofico ripropone una sorta di
ricorrente tentazione in cui da sempre la filosofia è incorsa: il puro idealismo come l’estremo
pragmatismo, la metafisica dell’assoluto, il materialismo, l’edonismo, sono esempi,
autorevoli, tra altri della tendenza a fissare un’origine o un approdo, un sentiero privilegiato o
una via di edificazione e di perfezionamento. Il compito del consulente filosofico è perciò tra i
più delicati e difficili, perché attiene in primo luogo alla concezione stessa del filosofare di
fronte al proprio tempo, alla storia e ai fatti particolari che richiedono d’essere compresi e
riguardano tutti come componenti di una stessa comunità di soggetti razionali. Il confronto a
due non dovrebbe svincolarsi dal più vasto mondo di significati e di espressioni pubbliche,
pena la radicalizzazione di un rapporto declinato forse solo sul filo dell’emozione e della cura
estremizzata del sé. Al dialogo della terapia psicologica si dovrebbe sostituire magari un
colloquio a più voci, una sorta di esercitazione in comune, uno scambio tra diverse modalità
di ricezione degli eventi, che pure non sarebbe immune dal pericolo della passività e
dell’imbonimento ideologico. La responsabilità del consulente filosofico è perciò totale e
assoluta, come la responsabilità del pensiero che giudica caso per caso con il solo criterio
della sua incondizionata autonomia. Riuscire a trasmettere il bisogno di una razionalità critica,
ricca di pathos emotivo nella partecipazione a principi comuni e condivisi, è l’insegnamento
principale della filosofia come pratica di vita. A tal scopo tutti i mezzi utili sono da ritenere
buoni e tutti i rimedi saranno opportuni se capaci di cancellare un inveterato sospetto verso il
10
Anche in tal caso ricordo i testi principali: G.B. Achenbach, La consulenza filosofica, Apogeo, Milano
2004; R. Lahav, Comprendere la vita, Apogeo, Milano 2004; N. Pollastri, Il pensiero e la vita, Apogeo,
Milano 2005. Interessante anche il fascicolo di “Discipline filosofiche” (XV, I, 2005) su La svolta pratica
in filosofia, vol. 2: Dalla filosofia pratica alla pratica della filosofia.
5
6
nuovo e verso ciò che ancora non si conosce, com’è tipico del relativismo dogmatico o di un
assolutismo
metafisico.
L’antropologia
filosofica,
che
annuncia
l’aspro
cammino
dell’esistenza attiva nel mondo, segue e non precede il compito critico. Già un gran risultato
avrà raggiunto il consulente filosofico capace di provocare nell’interlocutore quella
purificazione dei suoi concetti e princìpi richiesta da Kant a chi si avvicinava al suo pensiero.
Una pratica di purificazione, di cui parlava il Forestiero di Elea nel Sofista platonico, che se
non è la cosa più dolce, «è certo indispensabile – scriveva Scaravelli a chiusura della sua
Critica del capire – a far sì che possiamo produrre in noi quella intima disposizione che ci
metta in grado di non essere costretti a vedere dappertutto solo ciò che già conoscevamo»11.
C’è un nuovo possibile significato in ogni parola anche la più ripetuta, e solo nel discorso
giudicante e disputante sarà possibile intuire la proposta di verità ch’essa contiene.
11
L. Scaravelli, Critica del capire e altri scritti, in Opere, cit., vol. I, p. 196. Sulla questione del giudizio
mi permetto di rinviare alla Introduzione al mio volume, Il giudizio e la regola. Saggi e riflessioni,
Loffredo, Napoli 1997.
6