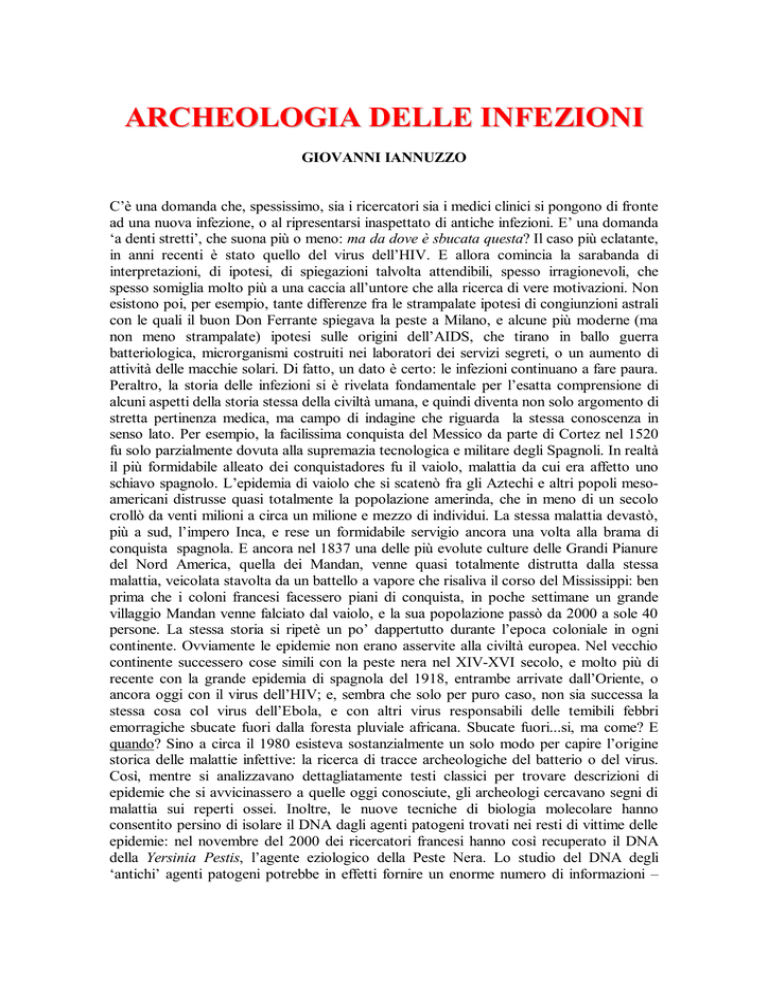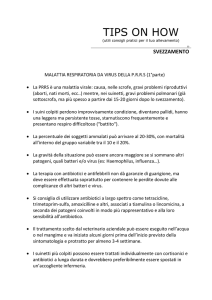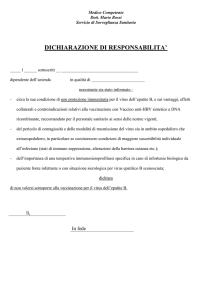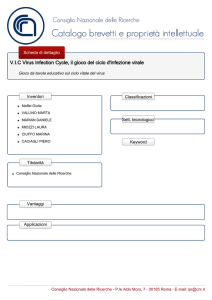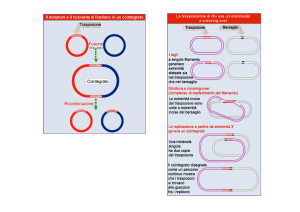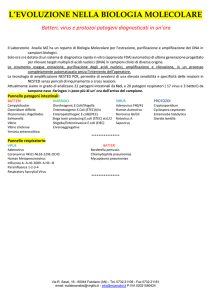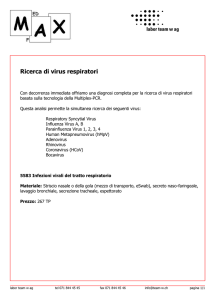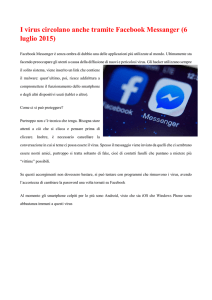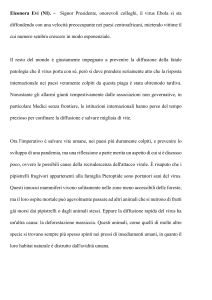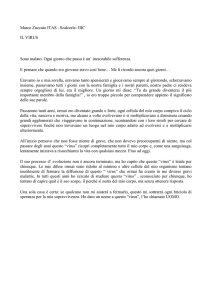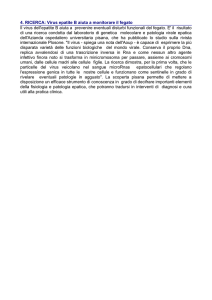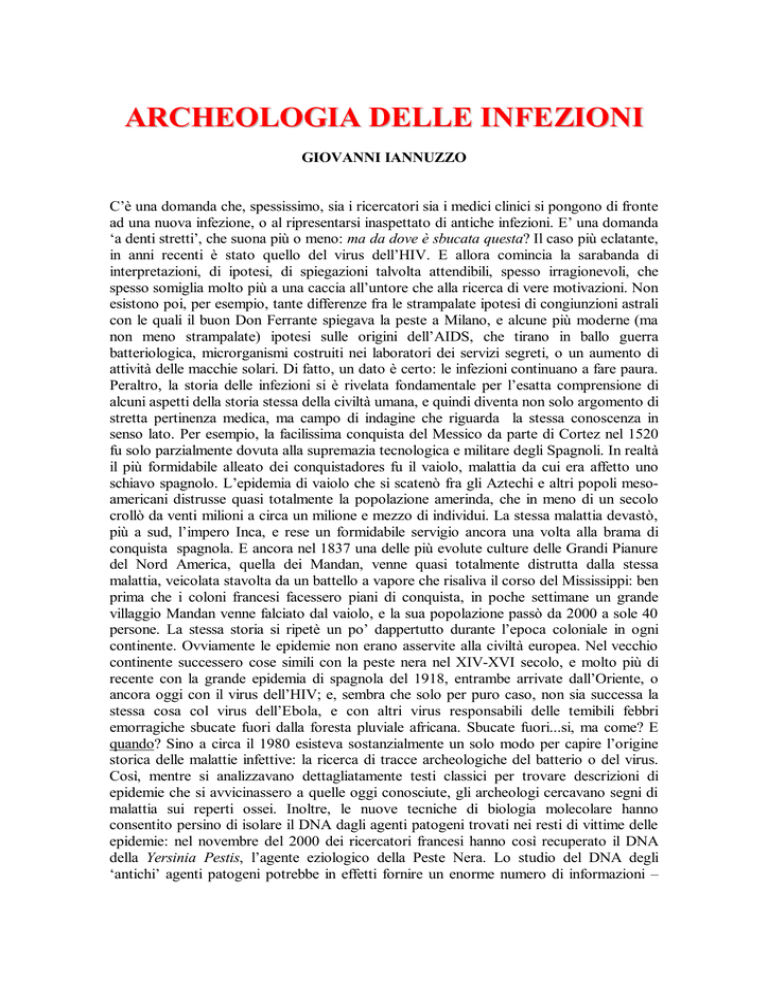
ARCHEOLOGIA DELLE INFEZIONI
GIOVANNI IANNUZZO
C’è una domanda che, spessissimo, sia i ricercatori sia i medici clinici si pongono di fronte
ad una nuova infezione, o al ripresentarsi inaspettato di antiche infezioni. E’una domanda
‘a denti stretti’, che suona più o meno: ma da dove è sbucata questa? Il caso più eclatante,
in anni recenti è stato quello del virus dell’HIV. E allora comincia la sarabanda di
interpretazioni, di ipotesi, di spiegazioni talvolta attendibili, spesso irragionevoli, che
spesso somiglia molto più a una caccia all’untore che alla ricerca di vere motivazioni. Non
esistono poi, per esempio, tante differenze fra le strampalate ipotesi di congiunzioni astrali
con le quali il buon Don Ferrante spiegava la peste a Milano, e alcune più moderne (ma
non meno strampalate) ipotesi sulle origini dell’AIDS, che tirano in ballo guerra
batteriologica, microrganismi costruiti nei laboratori dei servizi segreti, o un aumento di
attività delle macchie solari. Di fatto, un dato è certo: le infezioni continuano a fare paura.
Peraltro, la storia delle infezioni si è rivelata fondamentale per l’esatta comprensione di
alcuni aspetti della storia stessa della civiltà umana, e quindi diventa non solo argomento di
stretta pertinenza medica, ma campo di indagine che riguarda la stessa conoscenza in
senso lato. Per esempio, la facilissima conquista del Messico da parte di Cortez nel 1520
fu solo parzialmente dovuta alla supremazia tecnologica e militare degli Spagnoli. In realtà
il più formidabile alleato dei conquistadores fu il vaiolo, malattia da cui era affetto uno
schiavo spagnolo. L’epidemia di vaiolo che si scatenò fra gli Aztechi e altri popoli mesoamericani distrusse quasi totalmente la popolazione amerinda, che in meno di un secolo
crollò da venti milioni a circa un milione e mezzo di individui. La stessa malattia devastò,
più a sud, l’impero Inca, e rese un formidabile servigio ancora una volta alla brama di
conquista spagnola. E ancora nel 1837 una delle più evolute culture delle Grandi Pianure
del Nord America, quella dei Mandan, venne quasi totalmente distrutta dalla stessa
malattia, veicolata stavolta da un battello a vapore che risaliva il corso del Mississippi: ben
prima che i coloni francesi facessero piani di conquista, in poche settimane un grande
villaggio Mandan venne falciato dal vaiolo, e la sua popolazione passò da 2000 a sole 40
persone. La stessa storia si ripetè un po’ dappertutto durante l’epoca coloniale in ogni
continente. Ovviamente le epidemie non erano asservite alla civiltà europea. Nel vecchio
continente successero cose simili con la peste nera nel XIV-XVI secolo, e molto più di
recente con la grande epidemia di spagnola del 1918, entrambe arrivate dall’Oriente, o
ancora oggi con il virus dell’HIV; e, sembra che solo per puro caso, non sia successa la
stessa cosa col virus dell’Ebola, e con altri virus responsabili delle temibili febbri
emorragiche sbucate fuori dalla foresta pluviale africana. Sbucate fuori...si, ma come? E
quando? Sino a circa il 1980 esisteva sostanzialmente un solo modo per capire l’origine
storica delle malattie infettive: la ricerca di tracce archeologiche del batterio o del virus.
Così, mentre si analizzavano dettagliatamente testi classici per trovare descrizioni di
epidemie che si avvicinassero a quelle oggi conosciute, gli archeologi cercavano segni di
malattia sui reperti ossei. Inoltre, le nuove tecniche di biologia molecolare hanno
consentito persino di isolare il DNA dagli agenti patogeni trovati nei resti di vittime delle
epidemie: nel novembre del 2000 dei ricercatori francesi hanno così recuperato il DNA
della Yersinia Pestis, l’agente eziologico della Peste Nera. Lo studio del DNA degli
‘antichi’ agenti patogeni potrebbe in effetti fornire un enorme numero di informazioni –
suggerendo scenari alla Jurassic Park . Il problema è che, contrariamente a quanto accade
nel film di Spielberg, la quantità di DNA recuperabile è talmente limitata da poter fornire
poche informazioni fruibili. Allora, potrebbe essere conveniente seguire la strada inversa,
non dal passato al presente, ma dal presente al passato, indagando così il ben più ricco
filone dei geni degli agenti patogeni viventi. Il problema è di sapere leggere i dati. La
strategia è quella di ricostruire ‘alberi’ evoluzionistici degli organismi infettivi, e capire,
mediante lo studio della loro filogenesi, quali famiglie di agenti patogeni sono più antiche,
e quali si sono evolute più recentemente. Una seconda strada, forse ancora più ricca, è
quella di studiare la distribuzione geografica d’ogni famiglia, il che può suggerire da dove
essa si origini e come si è successivamente diffusa dagli ospiti iniziali alla specie umana.
E’un modello ambizioso, che consente di ottenere risposte ‘archeologiche’dove non esiste
la possibilità di acquisire informazioni per altre strade, modello ovviamente reso possibile
dai progressi della genetica da circa un decennio a questa parte, che hanno reso possibile
l’analisi di sequenze di DNA sufficientemente lunghe da agenti patogeni, e la loro analisi
con computer potenti. La prospettiva evoluzionistica è ovviamente il modello teorico che
la guida, modello complesso, ma che ha già fornito risultati importanti, e che potrebbe
fornire indicazioni sull’evoluzione da milioni di anni a questa parte delle malattie infettive
della nostra specie (a partire, per ipotesi, da quando la nostra specie nemmeno esisteva).
ANTICHE PARENTELE
Prendiamo per esempio in considerazione la malattia del sonno, un disturbo che miete
circa 300.000 vittime all’anno in Africa, e che è causato dal Trypanosoma Brucei. Una
variante americana di questo microrganismo, il Trypanosoma Cruzi, causa la malattia di
Chagas, un vero disastro epidemico nell’America del Sud, con 20 milioni di nuovi casi
all’anno. Wendy Gibson, mircrobiologa dell’Università di Bristol e il suo gruppo hanno
analizzato le sequenze geniche di 62 differenti specie del genus Trypanosoma, ed hanno
scoperto che sembra esistere un comune antenato dei due ceppi patogeni, dalla veneranda
età di circa 100 milioni di anni. Il suo luogo d’origine sembra sia stato Gondwana, il
supercontinente che comprendeva Africa, Sud-America ed Australia. Ora, i tripanosomi
africani, compreso il Brucei, appartengono tutti geneticamente ad una stessa famiglia. I
tripanosomi australiani, che infettano i canguri, mostrano invece molte somiglianze con i
tripanosomi americani, e pochissime con quelli africani. Il che costituisce una ulteriore
conferma di un fatto geologico importante, e cioè la separazione dei continenti. L’Africa
infatti sembra che si sia staccata per prima dal Gondwana, mentre America ed Australia
rimasero contigue per molto più tempo. In Africa, probabilmente per milioni di anni, il
Trypanosoma convisse tranquillamente con i primati e con gli originari antenati dell’uomo,
che avevano sviluppato sistemi anticorpali specifici. La Gibson ipotizza che ciò sia dovuto
al fatto che primati e ominidi avessero avuto un comune antenato, una scimmia che viveva
nelle pianure africane e che era stata infestata dalla mosca tsetse, che veicolava il
tripanosoma. Da questo contatto originario si era sviluppato un sistema difensivo antitripanosoma. Questo equilibrio ospite-parassita deve essersi alterato in tempi più recenti.
Lo stesso lavoro fatto con Trypanosoma, è stato, per esempio, compiuto con Helicobacter
Pylori, il batterio all’origine dell’ulcera. Sembrava un microrganismo nuovo (è stato
scoperto nel 1982), ma gli studi genetici ne hanno di molto retrodatato l’origine (la sua
diffusione ubiquitaria in tutto il mondo e la sua variabilità genetica depongono per questa
tesi). Mark Achtman, del Max Planck Institute for Infection Biology, di Berlino, è del
parere che le variazioni genetiche fra le famiglia di H.Pylori dimostrano l’esistenza di un
originario ceppo africano, che ha dato poi origine a due famiglie fondamentali una delle
2
quali oggi infetta gli europei, l’altra l’Asia Orientale. Il che sembra dimostrare che questo
split sia avvenuto all’epoca delle grandi migrazioni africane, con la separazione
dell’ondata migratoria: una parte verso l’Europa, l’altra parte verso l’Asia. Così, gli alberi
evoluzionistici dei batteri sembrano dimostrarsi utilissimi anche per lo studio degli antichi
flussi migratori della nostra specie. Disponiamo insomma di un nuovo potente strumento
per lo studio della preistoria. Ma non solo di questo.
COINQUILINI IMBARAZZANTI
Una convinzione abbastanza diffusa fra gli studiosi dell’evoluzione delle malattie infettive
era, sino a poco tempo fa, che la grande maggioranza di esse fosse relativamente recente e
coincidesse con la nascita della civiltà, insomma con quella che Gordon Childe ha
chiamato la rivoluzione neolitica (approssimativamente diecimila anni fa). In quel periodo
infatti la nascita dell’agricoltura e dei primi stabili stanziamenti umani, avrebbero
consentito molto più facilmente il passaggio di agenti patogeni da ospiti animali all’uomo,
infestando inoltre gli ambienti di vita quotidiana. Un esempio ritenuto emblematico è
quello della tenia, che ha un ciclo che si svolge fra maiali e mucche, i loro ospiti intermedi,
e l’uomo. Da ciò si è originata la teoria che i tre tipi di tenie che parassitano l’uomo
moderno, discendano da una tenia ‘progenitrice’ che parassitò per la prima volta l’uomo
dopo l’addomesticamento di maiali e mucche. Mediante la ricostruzione dell’albero
evoluzionistico delle tenie, Eric Hoberg, del Dipartimento dell’Agricoltura degli USA, ha
trovato che non esiste alcuna prova di questa teoria. I più stretti parenti delle tenie che
contagiano l’uomo non contagiano affatto maiali e vacche, bensì vivono allegramente fra
gli erbivori dell’Africa Orientale come le antilopi e colonizzano l’intestino di leoni e iene
che li uccidono e che sono pertanto il loro ospite finale. Se l’ipotesi della nascita
dell’infestazione da tenie fosse davvero legata alla fase neolitica della nascita
dell’agricoltura, le variazioni genetiche fra diversi tipi di tenie avrebbero inoltre dovuto
indicare un comune antenato risalente a circa 10000 anni fa. Ma Hoberg e il suo gruppo
trovarono dati completamente diversi, che consentivano di retrodatare il contatto fra
uomini e tenie a ben un milione di anni fa, quando gli ominidi passarono da erbivori a
carnivori e vagando o cacciando per le savane dell’Africa orientale divennero ideali nuovi
ospiti per le tenie, che si ‘specializzarono’ per vivere nel loro intestino. Fu solo dopo
centinaia di migliaia di anni che fecero la stessa cosa con mucche e maiali.
Un altro esempio, forse ancora più eclatante è quello della dissenteria, provocata, solo nel
genere umano, dalle Shigelle. Si è sempre pensato che essa fosse attecchita a causa dei
problemi igienici e di sovrappopolazione tipicamente umani, e che quindi non potesse
essere antecedente alla civilizzazione. Ma analizzando le variazioni genetiche fra i tre
principali gruppi di shigella il microbiologo Peter Reeves ha scoperto che per due tipi di
esse l’età oscilla fra 50.000 e 270000 anni fa; il terzo tipo è più giovane: fra 35 mila e 170
mila anni fa. Insomma ben prima che nascesse anche la più vaga forma di civiltà umana.
Simili ipotesi sull’origine remota di microrganismi patogeni sono state estese a molte altre
malattia. Per esempio, a quelle provocate dall’Escherichia Coli, batterio abitualmente
saprofita. La prima forma veramente pericolosa di E.Coli (il ceppo O157:H7) fu collegata
ad una grave tossinfezione alimentare negli anni ’80, legata alla contaminazione degli
hamburger. Malattia recente da fast food? Si, forse. Ma per altri motivi visti che, all’analisi
genetica, questo ceppo di E.Coli è risultato vecchio di milioni di anni. Insomma, molti
microrganismi patogeni non sono poi così giovani. Ma non è certamente un ‘gioco al
rialzo’, nel senso che tutte le ricerche dimostrerebbero la straordinaria ‘vecchiaia’di specie
batteriche ritenute ‘giovani’. E’vero, infatti, anche il contrario.
3
Per esempio, è opinione abbastanza diffusa che la peste sia malattia antichissima. Ne
parlano gli antichi greci, ne parlano i romani, e se ne trova traccia almeno apparente in
molti testi storici classici. Eppure, è più un mito che altro, visto che la prima epidemia
documentabile di peste è quella nota come ‘peste di Costantinopoli’, che mise a soqquadro,
nel 542 d.C., l’intero Impero Romano mietendo circa un milione di vittime. Allora, quanto
è antica veramente la peste? La storia molecolare raccontata dalle diverse famiglie di
Yersinia Pestis non è poi così datata. Strettamente correlata alla Yersina
Pseudotubercolosis, un microrganismo presente nelle feci dei roditori e che provoca una
moderata patologia, e dal quale prese origine, il batterio della peste è, a confronto degli
altri, un giovincello scherzoso, con un’età che oscilla solo fra i 1500 e i 20.500 anni fa...
Fra i numerosi problemi storici che potrebbero essere risolti dall’analisi genica vi è
sicuramente quello della sifilide, problema che appassiona e divide gli studiosi da almeno
500 anni. Il problema è semplice: poco tempo dopo il ritorno delle prime spedizioni di
Colombo nel Nuovo Mondo, si diffuse in Europa questo nuovo devastante morbo. D’altra
parte chiare tracce di questa malattia erano evidenti anche in America. La sifilide fu
importata dagli europei in America, o fu un poco gradito regalo dei nativi americani ai loro
colonizzatori? A tale quesito, dalle indiscutibili implicazioni politiche, non è stata data
sinora una risposta definitiva. Da almeno cinquant’anni i paleopatologi hanno tentato di
trovare una risposta, esaminando i reperti, ma con risultati quanto mai ambigui. Infatti,
esistono prove in favore e contro ambedue le ipotesi. L’unico dato di fatto che sembrava
comprovato era che la sifilide apparve in Europa dopo la scoperta dell’America, e questo
sembrava dare un certo ‘vantaggio’ alla teoria dell’importazione della malattia dal Nuovo
Mondo. Ma nel giugno 2000 è arrivata una clamorosa disconferma. Un gruppo di
ricercatori inglesi, infatti, esaminando gli scheletri trovati in un monastero nella città di
Hull scoprirono segni ossei di sifilide. Ma gli scheletri risalivano ad un periodo databile fra
il 1300 e il 1450, quindi ben prima che Colombo arrivasse in America. Ma neanche questo
ha avuto un effetto dirimente sulla polemica: infatti resta il dubbio che la sifilide possa
essere stata portata in Europa dai Vichinghi, primi veri colonizzatori dell’America.
Naturalmente, questi dati hanno scatenato una polemica ulteriore: chi dice che visto che i
monaci di Hull mangiavano parecchio pesce (e che questo può alterare i risultati del
radiocarbonio), è anche possibile che nessuno dei monaci fosse affetto da sifilide; chi dice
4
che solo il 30% degli scheletri mostrava tracce evidenti di sifilide, il che implicherebbe che
statisticamente tutta la popolazione del monastero e della zona avesse l’infezione. Il che
non pare molto attendibile. La soluzione, offerta da Bruce Rothschild, è che gli schletri di
Hull mostrano segni di frambesia, una malattia provocata essa stessa da una spirocheta,
che lascia i suoi segni ossei su una più alta frazione dei suoi ospiti. Lo stesso autore ha
evidenziato la presenza di segni di sifilide su ossa rinvenute nella Repubblica Dominicana,
e risalenti ad un periodo fra 500 e 1200 anni fa. Ancora polemiche, insomma, che
dimostrano ulteriormente come sia fondamentale disporre di metodi di ricerca più
attendibili. Su questo argomento una possibile risposta sembra quella offerta da George
Weinstock e dal suo gruppo, presso il Baylor College of Medicine a Houston, in Texas.
Nel 1998 essi hanno ricostruito la sequenza del Treponema pallidum pallidum, l’agente
eziologico della sifilide, comparandolo poi con la sequenza genica del Treponema
pallidum pertenue, l’agente eziologico della frambesia. Hanno trovato che sono molto
simili, differendo significativamente solo in quattro aree. Da questo ci si aspetta la
ricostruzione dell’albero evoluzionistico del Treponema. E la risposta ad una domanda
vecchia di cinquecento anni.
RITORNO AL FUTURO
Questi modelli di ricerca di genetica molecolare sono sicuramente affascinanti. Ci
consentono di ricostruire in laboratorio momenti sconosciuti della storia dell’uomo, e di
verificare fatti e circostanze storiche non rilevabili con altri mezzi, ma consentono anche di
fornire risposte a domande ben più attuali. E’ il caso dell’HIV. Esistono molte evidenze
(raccolte dal gruppo di Beatrice Hahn dell’Università dell’Alabama a Birmingham) che il
virus, già ampiamente presente fra gli scimpanzè dell’Africa Occidentale, ‘saltò’ la
barriera della specie, arrivando all’uomo, intorno al 1930. Esistono molte polemiche su
questa conclusione, ma di fatto esiste al riguardo un buon accordo internazionale.
Insomma, virus abbastanza giovane. Diverso il parere sui virus dell’epatite, decisamente
molto più antichi. Dalle ricerche di genetica molecolare sembra potersi infatti stabilire che
il virus abbia infettato un primate qualcosa come dieci milioni di anni fa e che poi si è
specializzato adattandosi ai suoi nuovi ospiti. Studi di questo tipo sono in corso anche sulla
malaria.
Parliamo di storia. Ma la cosa più importante è valutare la possibilità che questi nuovi
metodi di indagine possano contribuire non solo alla ricostruzione del passato, ma anche
alla ‘progettazione’ del futuro. Lo studio della storia evoluzionistica delle malattie sembra
in questo senso avere molte promesse, mantenibili o da mantenere. Dallo studio delle
varianti selvagge dei virus in effetti possiamo almeno tentare di capire quale sia il nuovo
menù che il nostro ambiente ha deciso di presentarci. Possiamo capire, cioè, attraverso la
lunga storia dei virus e dei batteri su questo pianeta, in buona parte ricostruibile in base alle
loro sequenze genetiche e alla ricostruzione dei loro alberi genetici evoluzionistici, cosa si
sta preparando, cosa c’è nel calderone di madre natura.
Il vero problema è quello di capire quanto più esattamente possibile il linguaggio parlato
dalla natura stessa e di elaborare modelli e schemi concettuali che siano adeguati ad
un’appropriata traduzione, e poi ad un’attendibile interpretazione. E questo è forse il
compito che sfida, molto più delle sequenze geniche dei batteri e dei virus, la nostra
necessità di comprendere il passato, e il nostro bisogno di prevedere il futuro.
[Pubblicato in Diagnostica Bios, 3, 2001]
5