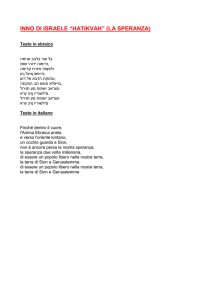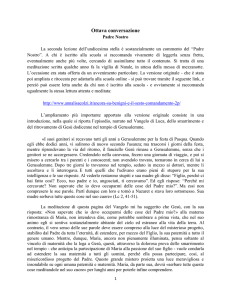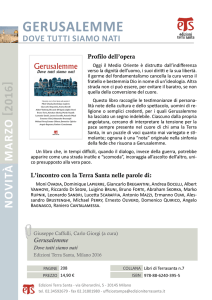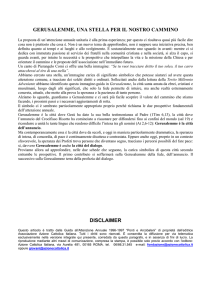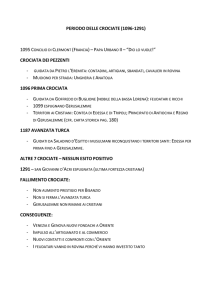“GERUSALEMME, PATRIA UNIVERSALE”
Conferenza di S.Em.za Rev.ma il Signor Cardinale Gianfranco RAVASI
tenuta per la Sezione Roma dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Roma - Casa di Dante - 1 dicembre 2010
Mi è stato assegnato un tema ben preciso, dal quale vorrei far sbocciare una mia riflessione su Gerusalemme, la
città santa, il centro, punto di riferimento, luogo imprescindibile in sede religiosa e letteraria. Il testo che prendiamo qui
in esame rappresenta un brano innico brevissimo, facente parte di quella celebre raccolta di componimenti nota col
nome di Salterio, i 150 canti o salmi di Israele.
Si tratta del Salmo 87 (86 della liturgia), uno dei cosiddetti “Inni di Sion o a Sion”. Proprio partendo da quei
pochi versi, desidererei costruire una mappa ideale della Città Santa di Gerusalemme; ovviamente non una mappa
topografica, bensì teologico-spirituale, in un certo senso, anche culturale.
Le tre pietre di Sion
Trattandosi di una mappa, quattro sono i punti cardinali prescelti. Inizierò subito dal primo, desumendolo
proprio dall’incipit di questo canto. Sui monti santi – così inizia il Salmo – Egli, Adonai, l’ha fondata; il Signore ama le
porte di Sion. Quindi, all’inizio, vediamo la rappresentazione dei monti santi, fondamento della stabilità. I monti, la
roccia, la rupe sono simboli che ininterrottamente vengono applicati a Dio partendo appunto da Gerusalemme, una città
situata a ottocento metri d’altezza su un colle arido, tant’è vero che una delle decifrazioni filologiche molto ipotetiche
della parola ebraica Sijjon è quella di luogo pietroso, quindi secco e arido. Ebbene, proprio la pietra è fondamentale
come primo punto cardinale di Gerusalemme, perché le tre grandi religioni e culture che in questa città si incrociano, si
intrecciano e perfino si scontrano, sono tutte fondate su una pietra.
Partiamo, perciò, dalla pietra fondante dell’ebraismo, la pietra chiamata dagli ebrei kótel, ossia la parete per
eccellenza, quella che tradizionalmente si definisce “Muro del pianto”. Dobbiamo far presente, tuttavia, che tale pietra
è, in verità, il punto terminale di un itinerario di pietre che sono lì sottese. Infatti, gli archeologi hanno tentato di
ricostruirle genealogicamente: si vede chiaramente che quei massi squadrati sono in stile erodiano, perché facevano
parte del tempio che Erode aveva sontuosamente costruito, lo stesso tempio che Gesù frequenterà. Quelle pietre sono
riconoscibili per il fatto che, di solito, i massi erodiani presentano una sorta di battitura o fascia che frontalmente
accompagna il rettangolo del masso. Lì, dunque, si può dire che abbia sede il tempio di Sion, cioè il cuore
dell’ebraismo, un cuore sempre amato, continuamente esaltato, perennemente celebrato e considerato come la stella
polare, non solo della spiritualità, ma anche della stessa esistenza giudaica. Si potrebbe quasi affermare che da qui inizia
un canto che varca i secoli, partendo proprio dai Salmi biblici che parlano di quella pietra particolare che è il Tempio.
A questo punto, vorrei citarvi un’espressione che mi sembra molto emblematica: l’attingo al Salmo 102, versetto
15, Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre, che nell’originale ebraico si presenta in una veste molto più significativa
che le traduzioni, come spesso accade, di solito fanno perdere. Infatti, aveva ragione Cervantes quando diceva che ogni
traduzione è come il rovescio di un arazzo, o Mounin nel suo saggio sulla traduzione, La Belle Infidèle, “La bella
infedele”. Il testo ebraico dice Ki ratsû ‘abdeka ’et-’abaneha. L’elemento fondamentale risiede in quel ratsû, cioè “sono
care” ai tuoi servi le pietre di Sion, le sue pietre. Ratsû, però, in ebraico deriva dal verbo ratsah, che indica un piacere
quasi fisico, una comunione passionale, pertanto quella pietra che è fredda, tu la baci come se fosse la tua sposa. Si
tratta, quindi, di un verbo che indica piacere – quasi erotico –, un verbo che contiene un nesso istintivo, primordiale.
La seconda pietra, come ben sanno i Cavalieri del Santo Sepolcro e tutti i pellegrini, è quella del Santo
Sepolcro, che come anima e cuore ha la pietra ribaltata del sepolcro di Cristo, segno di morte ma al tempo stesso di
vittoria sulla morte. Nel Libro dei Proverbi si dice che lo sheol – termine ebraico per designare gli inferi – è come una
bocca sempre aperta che inghiotte continuamente i morti. Ebbene, il cristianesimo afferma che questo ciclo inesorabile
è interrotto, poiché la pietra tombale viene rovesciata per celebrare la vita. E tale celebrazione pasquale è affidata a
quella grande basilica di Gerusalemme che, come è noto, presenta una planimetria particolarmente tormentata. Infatti,
come sempre, attorno alle pietre si muovono anche dei corpi che, quindi, trasformano in pietre vive l’edificio materiale.
Iniziando dall’imperatrice Elena per poi, via via, proseguire fino ai crociati, alla fine la Basilica del Santo Sepolcro
riassume in sé tante dimensioni diverse. Per questa ragione, essa è significativamente chiamata dagli ortodossi non
1
“Basilica del Santo Sepolcro” – che sarebbe evocazione di una pietra morta, almeno apparentemente – , bensì “Basilica
della Anástasis”, cioè della Risurrezione, che in arabo suona Qiyāma, che vuol dire “ergersi, salire, ascendere” verso
l’alto e l’infinito di Dio.
Si arriva, così, alla terza pietra sulla quale si fonda la terza religione e, al tempo stesso, la terza cultura che ha
in Gerusalemme la sua patria: si tratta della cosiddetta Qubbet as-Sakhra’, cioè la “Cupola della Roccia”, comunemente
detta Moschea di Omar. Una definizione, questa, erronea perché non è una moschea e non fu neppure Omar a definirla
tale. Almeno, come si presenta oggi, vediamo che al centro ha una rupe – appunto la Cupola della Roccia – e su questa
roccia la spiritualità dell’Islam ha una sua radice. Si racconta, infatti, che da qui il profeta Mohammed sia asceso al
cielo sulla sua giumenta alata, entrando, quindi, nella comunione con Dio. Perciò, anche in questo luogo è facile
rinvenire una dimensione di eternità e di infinito che trae origine e ha come seme proprio una pietra.
Ecco il primo punto cardinale che volevo ricordare, partendo dai versetti: Sui monti santi è fondata
Gerusalemme, sulla pietra l’anima di Gerusalemme si ritrova, su tre pietre che sono meta ininterrotta di moltitudini di
pellegrini e visitatori. Esse rappresentano i grandi nodi che tengono insieme la diversità delle professioni di fede e la
molteplicità delle persone che accedono a Sion.
«La città di Dio»
Il secondo elemento e secondo punto cardinale presente all’interno di questi due versetti (vv. 2-3) del Salmo è
il seguente: il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe, ossia tutte le case, tutte le città della
Terra Santa. Inoltre: Di Te si dicono cose gloriose, ‘ir ’elohîm, “città di Dio”, che potrebbe tradursi come città divina.
Tra l’altro, si parla delle porte di Sion, e qui il termine porte è ovviamente una metonimia per rappresentare la totalità,
ossia le porte e tutto ciò che sta all’interno della porta stessa. Quando Cristo dice: Io sono la porta delle pecore, in un
certo senso fa riferimento alla porta del Tempio, quasi dicesse Io sono il nuovo Tempio. Tra l’altro, ricordiamo che la
parola Babilonia – Babilu in accadico – ha assunto un significato generico in base a un’etimologia di taglio popolare,
ossia luogo della confusione, giocando sull’assonanza col verbo ebraico balal che vuol dire “confondere”. In verità, in
lingua accadica si tratta dell’espressione bab ilu, dove bab sta per porta, come in arabo e ilu, il, el, ’elohîm è Dio.
Quindi, il suo vero significato è “porta di Dio”, di qui “la città di Dio”, ‘ir ’elohîm.
Con tale termine di solito si esalta una città gloriosa e santa. Ed ecco allora il secondo punto: la città. Non
soltanto il tempio in quanto tale, ma tutta la città che nel suo grembo accoglie appunto il tempio. E si va anche oltre,
dicendo che l’Altissimo la tiene salda e la rende compatta. Qui abbiamo un’altra componente che vorrei ricordare. Si
tratta della teologia legata alla città di Sion, una teologia che paradossalmente è stata in seguito studiata in maniera
molto più sofisticata dall’antropologia culturale, ma già presente, ad esempio, nel Salmo 46. Perciò, era già stata
idealmente intuita e concepita da Israele. Una delle tesi fondamentali del famoso studioso di storia delle religioni,
Mircea Eliade, è quella secondo cui l’organizzazione dello spazio viene fatta dall’uomo primitivo attraverso la
costituzione di un centro, ossia il perno attorno al quale ruota tutto l’essere. Ebbene, l’umanità delle origini antiche pone
al centro – anche con lo sviluppo della cultura – l’area templare e l’area palatina, quindi il tempio e il palazzo del re. Si
tratta del cuore che tiene insieme non soltanto la città, ma il mondo intero che, altrimenti, si sfalderebbe. Infatti, il
Salmo 46 rappresenta il mondo che si sta sgretolando in una sorta di “de-creazione”. L’unica a rimanere salda è, invece,
Gerusalemme, fondata sulla roccia, come appunto si diceva prima. E tutto questo grazie a due presenze: quella di Dio
all’interno del tempio e, quindi, nello spazio e la presenza della divinità nel tempo e, quindi, nella storia attraverso il
palazzo reale, dimora della dinastia di Davide. Essa costituisce la sequenza verticale, diacronica lungo i secoli e
rappresenterà poi anche la dimensione messianica. Pertanto, Gerusalemme diviene il grembo di questa duplice presenza
divina su cui torneremo.
A questo punto, vorrei ricordare un bellissimo aforisma rabbinico che descrive tale universo organizzato in un
centro, e lo fa con originalità poetica ispirandosi alla struttura dell’occhio. Il mondo, dice, è come l’occhio: il mare è il
bianco dell’occhio, la terra è l’iride, Gerusalemme è la pupilla, mentre l’immagine in essa riflessa è il Tempio.
2
La mappa universale di Sion
Affrontando il terzo punto cardinale della nostra riflessione, entriamo proprio nel tema fondamentale che, però,
era necessario preparare prima illustrando altri punti fondamentali. Parliamo dell’universalismo. Se è vero che Sion, la
città che ha al suo interno il Tempio, quindi una presenza spaziale e storica, è il cuore, il centro del mondo, allora è
chiaro che tutti i popoli, ossia l’intera mappa geopolitica, vi devono convergere. Ed ecco allora le parole del poeta ebreo
che fa poesia ricorrendo a una sorta di toponomastica dal significato particolare, anche se per il lettore occidentale,
probabilmente, dice poco o nulla. Attenzione ai nomi adesso, perché si tratta di una sequenza: Iscriverò Rahab e
Babilonia fra quelli che mi riconoscono, dice il Signore. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato (v. 4). Che
significa tutto ciò? Per ora lasciamo l’ultima frase che riprenderemo più tardi e guardiamo questa mappa. Prima di tutto
Rahab, che era diventato un mostro acquatico nell’ambito della tradizione mitologica biblica, ma che era anche il
termine con cui si definiva l’Egitto, ossia la superpotenza dell’Occidente di allora. Ecco, subito dopo, il termine Babel,
Babilonia, che invece era la superpotenza orientale. Perciò, da una parte l’Ovest, dall’altra l’Est. Si passa poi al centro,
dove è il poeta, che chiama quest’area Filistea, Pelishtim, cioè la Palestina, un vocabolo, quest’ultimo, che nasce dalla
trascrizione del termine “filisteo”. Quindi prosegue citando Sūr, la città di Tiro che è in Fenicia e che rappresenta il
Nord. Infine, Cush, cioè l’Etiopia, che è il Sud.
Sono stati scelti cinque toponimi per costruire la mappa planetaria di quel tempo quasi per dire che tutti, in
fondo, sono nati a Gerusalemme e in questa città hanno la loro sorgente. Detto in altri termini, il poeta ebreo ricorda che
queste grandi potenze che incutevano rispetto e timore – l’occidentale e l’orientale, la commerciale di Tiro e, infine,
quella che forniva materie prime, cioè l’Etiopia – insomma tutti questi importanti paesi, tutti questi popoli forti e potenti
convergono verso Sion, anzi sono retti da un cuore che è la Città Santa, la città di Dio, Gerusalemme.
Questo tema andrebbe commentato con un cantico stupendo, opera del profeta considerato una specie di Dante
della letteratura ebraica, cioè Isaia. E proprio nel capitolo 2 del suo libro, questo grande profeta immagina che su tutta la
terra si stenda una sorta di coltre oscura, un sudario di tenebra. Solo un monte è illuminato, quasi fosse una sorta di
grande asse. Ed ecco che tutti i popoli della Terra cominciano a muoversi verso quel punto cardinale. Da quella città,
che è Sion, esce la Parola di Dio personificata. Essa va incontro ai popoli che vengono da ogni luogo e, una volta giunti
a Gerusalemme – è, questa, la grande intuizione dello shalom, della pace messianica – lasciano cadere dalle loro mani
spade e lance che verranno trasformate in aratri e falci per lavorare la terra e produrre frutti. Così, la guerra finirà per
sempre e la pace regnerà come strumento di benessere tra i popoli i quali ormai si stringono la mano. E come suggello,
Isaia lancia un appello finale alla casa di Giacobbe perché non resti indietro in questa grande processione dei popoli.
Una stupenda visione, senz’altro, ma, nell’avviarmi verso il quarto e ultimo punto cardinale, vorrei ricordare
che in questa rappresentazione, comprendente al suo interno non solo Gerusalemme con il Tempio, ma anche l’intero
cosmo, si ha un’altra possibilità di epifania divina, di teofania. Dio, infatti, non si presenta soltanto in Gerusalemme
ove, come si legge in I Re 8, nella preghiera di consacrazione del Tempio, shemî sham, ossia “là è il mio nome”, là è la
mia presenza. C’è qualcosa di più: tutto l’universo diventa Tempio, un’intuizione, questa, che viene modulata sul fatto
che Gerusalemme santifica tutto lo spazio e lo consacra. Il Salmo 148 è particolarmente significativo nel presentare un
corale Alleluia, voce verbale ebraica dell’imperativo, ’hallelû-Jah, che vuol dire “lodate il Signore”. Un alleluia corale
che è intonato da ventidue o ventitré creature. Ci si aspetterebbe ventuno, cioè tre per sette, dato che il sette è il numero
della pienezza. Perché, invece, ventidue (o ventitré, a causa di una ripetizione). E qui la risposta è, per certi versi,
addirittura folgorante: ventidue o ventitré sono le lettere dell’alfabeto ebraico. Quindi, tutte le realtà che vengono
denominate con l’alfabeto costituiscono idealmente una lode a Dio. E l’uomo è grande all’interno della creazione. Un
Salmo bellissimo, il 148, con il semplice ricorso all’elencazione la quale diventa un modo per esaltare il Tempio
cosmico universale. I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annunzia il firmamento, come canta il
Salmo 19, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Anche qui c’è una sorta di
rivelazione cosmica, che si associa alla rivelazione che risuona in Sion attraverso la Torah.
La tradizione cabalistica medievale, dal canto suo, ha portato avanti la riflessione, cercando di risolvere la
famosa antinomia tra infinito e spazio. Dio è infinito per definizione, ma il cosmo, che noi consideriamo infinito, non
partecipa pienamente dell’infinito di Dio, perché Dio è oltre il cosmo stesso. Esiste un canto cabalistico medievale, di
cui vorrei leggere la strofa principale, che va oltre Sion, oltre il Tempio cosmico universale, e tenta di interrogarsi su
questo mistero lasciandolo in sospeso mediante un gioco di parole ebraiche. Maqom in ebraico vuol dire “luogo”, e di
solito è il luogo per eccellenza, il luogo santo, quindi il Tempio. Il canto medievale dice: wehû hammaqôm shel maqôm
we’en lammaqôm meqomô, che vuol dire: “Egli è il luogo” (wehû hammaqôm). Dio è il luogo che assorbe tutti i luoghi.
Subito dopo si aggiunge shel maqôm, il luogo “di ogni luogo”, e we’en lammaqôm meqomô, che significa “questo luogo
non ha luoghi”. L’intuizione sta nel concepire Dio come il “luogo” per eccellenza, che comprende e consacra tutti i
luoghi ma, essendo infinito, Dio non è “luogo”.
3
«Sono in te tutte le mie sorgenti!»
Ed eccoci ora all’ultimo punto cardinale che è poi la conclusione di tutto il nostro discorso. Come si può
osservare, ci siamo mossi continuamente attorno a una serie di elementi annodati tra loro: il Tempio, la città, l’universo,
come un tutto compatto. Noi sappiamo, però, che Sion è, sì, un tempio, quindi uno spazio, espresso attraverso
un’architettura, una città globale, ma è anche una presenza viva, che non è solo quella di Dio. Sono presenza viva anche
gli uomini e le donne, per questo il Salmo si interroga sull’umanità, ossia sui “cittadini del mondo”, per indicare un
autentico universalismo. Infatti, se è vero che Gerusalemme è il cuore, il centro che tiene insieme tutto, essere cittadini
di Gerusalemme vuol dire anche essere cittadini del mondo.
Ecco, allora, le parole del poeta che enumera Rahab, Babilonia, Filistea, Tiro, Etiopia. Là costui è nato. Si dirà
di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati». E ancora: Il Signore registrerà nel libro dei popoli: «Là costui è nato».
Come si vede, è una marcata ripetizione, che in ebraico suona così: jullad sham / jullad bah, “Là e in essa siamo nati
tutti”. Ed è veramente suggestiva quell’immagine di Dio visto quasi come il “sindaco” della città universale di
Gerusalemme, che sembra avere davanti a sé l’anagrafe, il libro nel quale registra tutti i popoli della terra, non soltanto
gli ebrei, ma il popolo di Cush, cioè gli etiopi, perfino il nemico Babel, perché tutti sono nati lì in Sion. Là ha sede la
loro terra. Ed è questa, direi, l’ultima coordinata della straordinaria lettura di Gerusalemme che viene fatta dal Salmo
87.
Pertanto, Gerusalemme, – anche se ciò ha poche probabilità politiche di riuscita – dovrebbe tornare a essere
una città internazionale, non appartenente esclusivamente a un solo popolo, perché questo è, in un certo senso,
fondamentale nella stessa teologia di Sion. Essa è la città di cui tutti si devono sentire cittadini, in cui tutti devono
ritrovare la propria residenza; in Sion tutti hanno una sorta di cittadinanza nativa, anche se poi ciascuno ha la propria
cultura. Non si deve dimenticare che, per molti versi, Gerusalemme nella storia è stata a lungo un punto di riferimento e
di accoglienza dove convergevano le popolazioni più varie che, però, ritrovavano idealmente lì la loro identità. A
Gerusalemme, tenendo conto delle diverse liturgie che vi hanno luogo e delle varie componenti culturali che la città
abbraccia, si registrano e si usano almeno dodici alfabeti differenti. Di conseguenza, Gerusalemme, anche in questo
caso, rappresenterebbe proprio il convergere vitale di tutti i popoli che ritrovano nella spiritualità di questa città la loro
matrice.
Come suggello al percorso che ho proposto, vorrei concludere con una riflessione sul fatto che il cristianesimo
tende progressivamente a relativizzare lo spazio di Gerusalemme, soprattutto quell’area fondamentale che è il Tempio.
Il cristianesimo, infatti, comincia a far capire che, se si vuole scoprire la vera anima di Gerusalemme, non la si deve più
ridurre a un puro e semplice spazio e al possesso di una particella di terra, come purtroppo avviene ancora ai nostri
giorni. E qui è spontaneo pensare alla suddivisione del Santo Sepolcro in particelle di spazio, dovuta a ragioni di
presenza di ciascuna confessione cristiana. Ma ciò che è più importante è riuscire a rendere vivo tale spazio, a farne la
presenza vitale di una realtà trascendente, come la stessa figura di Cristo dimostra senza alcuna astrazione. Come è noto
dai Vangeli, Cristo ama e frequenta il tempio di Erode. Tuttavia, nel celebre prologo di Giovanni – ed è, questo, un
elemento non immediatamente decifrabile all’interno del testo greco – si dice che il Verbo, ossia il Logos eterno e
infinito, pose la sua tenda in mezzo a noi (1,14). E si tratta della tenda della carne, cioè il Verbo si fece carne e pose la
sua tenda in mezzo a noi. E la tenda è per eccellenza il Tempio che, però, nella visione cristiana, è fatto di carne, cioè è
una persona che reca in sé la presenza suprema del divino, ossia Gesù Cristo. Il Tempio, in un certo modo, viene
relativizzato: Cristo stesso dichiara che se sarà distrutto, in soli tre giorni egli lo farà risorgere. Giovanni nota,
ovviamente, che Gesù intendeva parlare del suo corpo che risorge vincendo la morte. Ebbene, nel testo greco di
Giovanni 1,14 si usa il verbo skenoún e il termine skené indica la tenda, perciò eskénosen strettamente parlando vuol
dire “ha piantato la sua tenda” in mezzo a noi. Si potrebbe addirittura cogliere una certa assonanza con la parola
fondamentale con la quale gli ebrei definivano la presenza di Dio nel tempio: la shekinà, ove si ha la radicale s-k-n
corrispondente alle lettere greche ς, sigma, κ, kappa e ν, ni di skené, “tenda”. In ebraico, invece: shin, kaf, nun. Le
stesse consonanti, la stessa radicale per assonanza, pur essendo diverse semanticamente tra loro: una vuol dire
“presenza”, l’altra “tenda”. Il prologo di Giovanni afferma, così, che ormai il Tempio è divenuto la persona di Cristo. E
Gesù stesso dirà alla samaritana: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il
Padre… Ma viene l’ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità» (Giovanni, 4, 21-23).
Ecco, ancora una volta appare il bisogno di trasferire e trasformare quelle pietre da cui siamo partiti, ossia
quella città concreta, in un simbolo, in un segno che rappresenta Dio stesso in mezzo a noi, cioè l’Incarnazione. Vorrei
qui ricordare l’impressionante e grandiosa scena finale del libro dell’Apocalisse. L’apostolo Giovanni s’affaccia su una
nuova e perfetta Gerusalemme, divenuta ormai città celeste. Egli la guarda e scopre una realtà sorprendente: «In essa
non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio» (21,22). Ma al di là di questa
suggestiva immagine simbolica di Sion, Gerusalemme deve tornare a essere un segno concreto da custodire, deve
4
essere soprattutto un segno dell’umanità che avverte in sé la presenza di Dio. Quindi, Gerusalemme è la nostra patria,
non già come terra in cui siamo nati, ma come luogo delle nostre profonde origini spirituali, come dice il Salmo 87:
«Sono in te tutte le mie sorgenti».
Una volta, da giovane, prendendo parte a lavori di scavo archeologico nel Vicino Oriente, ebbi occasione di
ascoltare un archeologo scozzese, che aveva scavato il cosiddetto Colle dell’Ophel, dove sorgeva la città di Davide.
Quel lavoro di scavo mirava a scoprire qualche traccia del tempio di Salomone. L’archeologo mi raccontava un fatto
curioso: i suoi genitori erano contadini e non erano mai stati neppure a Londra, se non forse quando si erano sposati. La
domenica, però, quando entravano nel tempio presbiteriano per cantare inni, quando intonavano i Salmi di Sion, lo
facevano con tanta gioia e amore come se la città di Sion la conoscessero bene, quasi fosse la loro patria, proprio perché
avevano capito che quella Gerusalemme non era puramente geografica, era ormai diventata un simbolo. E qui, secondo
questa forte simbologia, Gerusalemme rimane un grande segno della storia dell’umanità, nelle sue gioie e nei suoi
dolori, per questo essa è, sì, gloriosa, ma anche striata di sangue.
Desidero, allora, concludere attingendo di nuovo alla tradizione ebraica, sulla base di un testo rabbinico. Dio
sta creando il mondo, gli angeli gli si avvicinano. Su un vassoio il primo angelo regge dieci porzioni di bellezza, ossia la
bellezza dell’universo. Dio prende nove porzioni di bellezza e li assegna a Gerusalemme, mentre una sola porzione di
bellezza viene destinata al resto del mondo. Il secondo angelo porta un vassoio con dieci porzioni di sapienza e di
conoscenza. Dio prende nove porzioni di sapienza e le assegna a Gerusalemme, che è per eccellenza la terra della voce
dei profeti, mentre una sola al resto del mondo. E così via. Finché arriva l’ultimo angelo che è cupo, vestito di scuro,
anch’egli con un vassoio sul quale, però, ci sono dieci porzioni di dolore, di sofferenza, di pianto, di lacrime. E in
questo caso ci si aspetterebbe un ribaltamento dell’equazione nove a uno. E, invece, il testo rabbinico dice che Dio dette
nove porzioni di dolore a Gerusalemme e una sola al resto del mondo, proprio perché Gerusalemme deve rappresentare,
in ogni situazione, il respiro pieno dell’umanità.
5