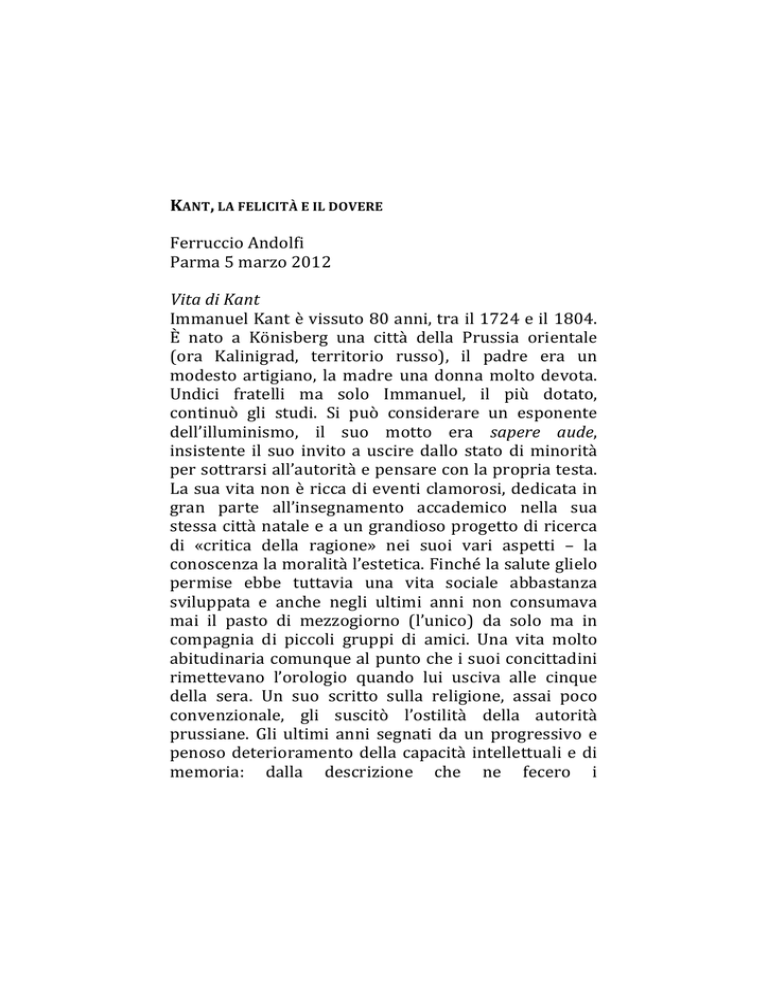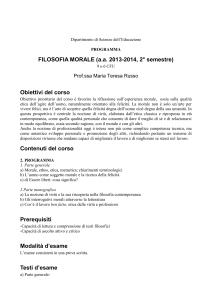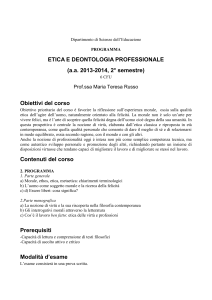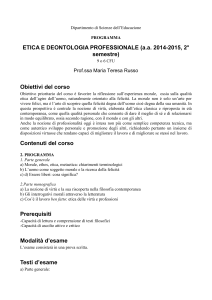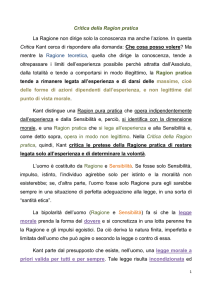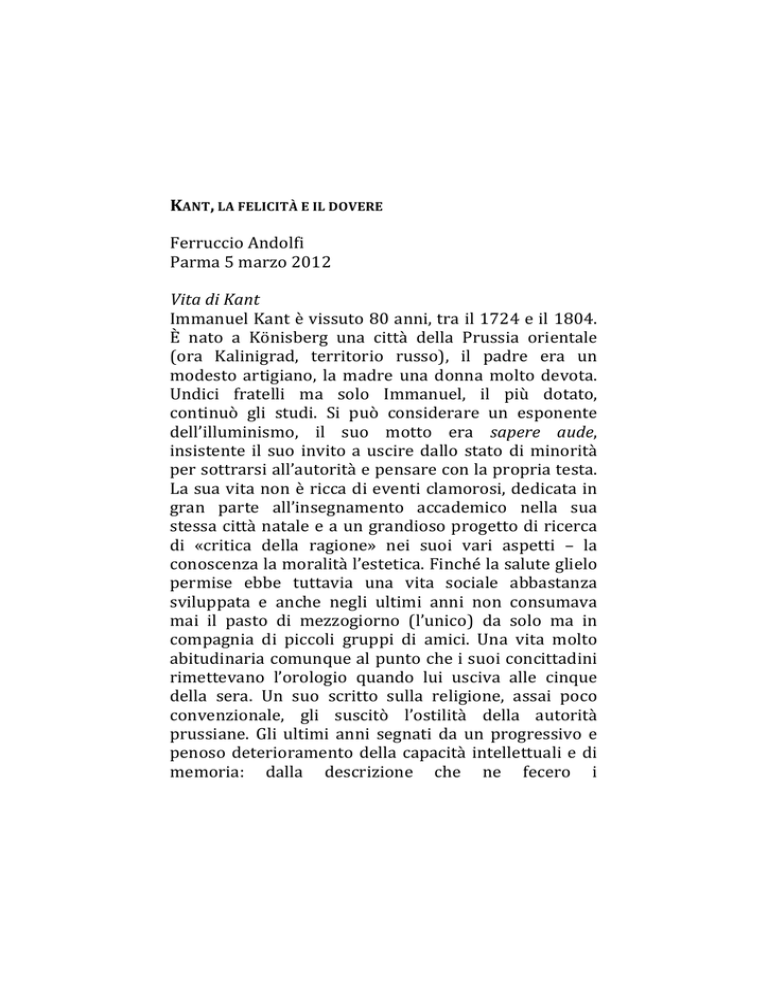
KANT, LA FELICITÀ E IL DOVERE Ferruccio Andolfi Parma 5 marzo 2012 Vita di Kant Immanuel Kant è vissuto 80 anni, tra il 1724 e il 1804. È nato a Könisberg una città della Prussia orientale (ora Kalinigrad, territorio russo), il padre era un modesto artigiano, la madre una donna molto devota. Undici fratelli ma solo Immanuel, il più dotato, continuò gli studi. Si può considerare un esponente dell’illuminismo, il suo motto era sapere aude, insistente il suo invito a uscire dallo stato di minorità per sottrarsi all’autorità e pensare con la propria testa. La sua vita non è ricca di eventi clamorosi, dedicata in gran parte all’insegnamento accademico nella sua stessa città natale e a un grandioso progetto di ricerca di «critica della ragione» nei suoi vari aspetti – la conoscenza la moralità l’estetica. Finché la salute glielo permise ebbe tuttavia una vita sociale abbastanza sviluppata e anche negli ultimi anni non consumava mai il pasto di mezzogiorno (l’unico) da solo ma in compagnia di piccoli gruppi di amici. Una vita molto abitudinaria comunque al punto che i suoi concittadini rimettevano l’orologio quando lui usciva alle cinque della sera. Un suo scritto sulla religione, assai poco convenzionale, gli suscitò l’ostilità della autorità prussiane. Gli ultimi anni segnati da un progressivo e penoso deterioramento della capacità intellettuali e di memoria: dalla descrizione che ne fecero i contemporanei si direbbe che fosse affetto da una specie di alzeihmer. La sua fama è legata alla rivoluzione copernicana da lui compiuta nella teoria della conoscenza. Impossibile a suo giudizio una conoscenza della realtà in se stessa. La realtà che conosciamo è sempre assoggettata a forme che la nostra sensibilità e la nostra mente introducono. Di che cosa costituisca il fondo delle cose se mai si può avere qualche idea a partire dalla nostra esperienza morale. Sulla sua tomba fu scritto che “Due cose riempiono l’animo di ammirazione: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me». È di questo territorio che vogliamo occuparci oggi. Kant e il controllo razionale delle pulsioni Un pensatore può interessarci perché ci fornisce materia di riflessione e ci aiuta ad orientarci nella vita o perché interpreta in maniera particolarmente efficace un tipo di mentalità proprio di una certa epoca storica, che ci è stato tramandato e per certi versi ancora ci appartiene. Le ragioni del mio interesse per Kant e la sua etica sono di questo secondo tipo. Con tutto il rispetto che penso debba essere tributato a una personalità della sua statura, non riesco tuttavia a considerarlo la fonte d’ispirazione del mio comportamento. Ci sono pensatori morali che corrispondono di più al mio modo di pensare, o almeno al mio modo di pensare attuale, Tuttavia per chi vuole affrontare problemi etici la posizione kantiana rappre-­‐
senta un passaggio obbligato: senza riferirsi ad essa non si intendono a pieno neppure le proposte di chi si è 2 posto in modo critico verso di essa. È difficile che un uomo d’oggi, anche se vuole prendere le distanze da una morale severa come quella kantiana, non abbia dentro di sé, magari come un momento da superare, proprio quella stessa istanza di controllo razionale delle pulsioni che si è espressa in quell’etica in modo esemplare. Freud ha detto qualcosa al riguardo, mostrando come l’etica nasca dalla e per la repressione degli istinti primari. Siccome l’anno passato, come ha osservato spiritosamente uno di voi, ho fatto outing per quanto riguarda la mia eredità religiosa, ora completerò la confessione dichiarando che l’etica del dovere rappresenta uno degli elementi della mia formazione originaria, contro cui ho combattuto in seguito accanitamente, in nome del principio di felicità e della singolarità del comportamento etico. L’etica degli antichi Mettiamo ora da parte questo lato autobiografico della questione a cui parecchi di voi potrebbero essere moderatamente interessati. E vediamo in che cosa è consistita l’innovazione introdotta da Kant alla fine del Settecento nel percorso della filosofia morale, I moderni sono in larga misura debitori a Kant del loro modo di impostare i problemi morali. Egli ha rappresentato una rottura rispetto all’etica degli antichi, che attraverso varie trasformazioni ha fatto sentire la sua efficacia attraverso il Medioevo fino al periodo illuministico. L’etica degli antichi nel suo complesso ha un’intonazione eudemonistica, è cioè basata e orientata 3 verso la felicità. Aristotele ha espresso appunto questa posizione. Egli fa coincidere la felicità con l’esercizio dell’attività umana più caratteristica, essenziale, cioè con l’esercizio della ragione. Noi moderni diamo per scontata un’interpretazione soggettivistica della felicità. Per Aristotele invece esiste una gerarchia oggettiva delle attività umane, la possibilità di riferirsi a un’essenza o un fine (telos) comune; in secondo luogo l’immagine della felicità è socialmente condivisa, i valori riconosciuti della polis, il suo ethos, ci indica il fine da perseguire. L’attività teoretica, la ricerca della verità, ha dunque in lui un’immediata valenza etica. Ma lo strumento del sapere morale, la saggezza o prudenza (phronesis), differisce dalla vera scienza, che consiste nella cono-­‐
scenza dell’universale. L’azione morale dipende dall’uso della prudenza nell’applicare i principi a circostanze particolari. La morale ha un fondamento nell’esperienza del mondo, come la medicina o l’arte della navigazione I mezzi per realizzare il bene (che è il fine) sono oggetto di una valutazione che deve tener conto delle circostanze, delle caratteristiche di specifiche situazioni in cui di volta in volta ci troviamo. L’uso di questa particolare assennatezza vale soprattutto quando siamo in presenza di quei doveri che, seguendo la terminologia kantiana, possiamo chiamare «imperfetti». Per es. i doveri di essere coraggiosi, generosi o benevolenti sono tali che le regole appaiono troppo schematiche per stabilire da sole quando quei doveri spettino a noi e quale sia il 4 modo giusto di assolverli. Se si tratta di stabilire quando e come essere coraggiosi o generosi, non possiamo applicare una regola di cui già disponiamo ma dobbiamo ricavarla dall’analisi della situazione. Secondo questa prospettiva la nozione di virtù non si riferisce soltanto né prevalentemente ai quei comportamenti a cui ci sentiamo obbligati, come una pedagogia improntata all’idea kantiana di dovere ci ha abituati a pensare, ma forse proprio a quei comportamenti non strettamente dovuti, di cui solo il nostro giudizio può stabilire la misura, che adottiamo «di buon grado e con piacere», sulla base di qualche desiderio intrinsecamente buono. Per farci un’idea della virtù di una persona consideriamo le sue capacità di immaginazione nel reagire a situazioni complesse piuttosto che la sua osservanza di regole morali del tutto precisate. Le teorie morali moderne, ispirate all’idea dell’uomo onesto che mantiene le promesse, offrono una visione inaridita della virtù. (Nella Metafisica dei costumi Kant, introducendo l’idea di doveri morali imperfetti, si è approssimato a un’idea più ricca della virtù, ma quei doveri li ha considerati appunto imperfetti.) Per acquisire una capacità di giudizio non serve nessun insegnamento formale. Esso si può apprendere solo attraverso la pratica e l’educazione a compiere le azioni giuste. Si diventa giusti compiendo le azioni giuste. Lo sviluppo del carattere morale dipende quindi dall’appartenenza. a una certa comunità. 5 La legge universale Ora chiediamoci quali sono invece le caratteristiche dell’etica moderna inaugurata da Kant: la legge, il dovere, la virtù, l’autonomia. Questa concezione etica non ha un carattere contenutistico, cioè non giustifica in assoluto alcun determinato comportamento, ma è, come si suol dire, formale. Non è senz’altro buono un determinato contenuto o azione, per esempio soccorrere i poveri, servire la patria, mantenere le proprie promesse o amare i nemici, ma lo diventa se è oggetto di una volontà in se stessa buona. È questa volontà buona a rendere buoni questi o altri comportamenti (Simmel 165) Esiste un criterio per verificare se la volontà è buona, che essa sia capace di dar luogo a una legge. Ora l’idea di legge comporta in primo luogo l’universalità, la validità per tutti. L’ammissibilità morale di singole azioni è valutata secondo questo criterio. La formula che Kant suggerisce di applicare è la seguente: «Agisci in modo che il principio della tua azione possa essere elevato a legge universale». Per ogni azione si tratta di chiederci che cosa accadrebbe se tutti la compissero. Provate a immaginare, dice ad esempio Kant, che cosa accadrebbe se tutti facessero promesse senza mantenerle, nessuna fiducia sarebbe più possibile; o se tutti, presi da disgusto per la vita sopprimes–sero se stessi, la vita stessa ne risulterebbe annullata. Il fatto che nessun determinato contenuto o schema di comportamento, per quanto plausibile, possa pre-­‐
tendere più un’assoluta validità ha sicuramente un effetto liberatorio. I comportamenti più sacrosanti(,a 6 cui nessuna persona benpensante rifiuterebbe il suo assenso,) possono essere messi in dubbio, se non corrispondono al criterio formale, introdotto da Kant, della possibile universalizzazione. Nessun altro criterio suggerito dai moralisti (es. il perfezionamento di se stessi, l’aumento della felicità generale, il dominio della ragione, l’intensificazione della compassione o della forza individuale) ha la stessa latitudine di quello indicato da Kant, è capace cioè di giustificare ogni possibile situazione, per complessa che sia. Solo la formulazione kantiana. che esclude dall’imperativo supremo ogni singolo contenuto, offre uno spazio illimitato alle specificità di ogni dato caso (Simmel 173). Noi moderni, ormai abituati a considerare le scelte e i modi di vivere consacrati dalla tradizione solo relativamente veri, e ad adottarne altri senza per questo sentirci colpevoli, non possiamo che apprezzare il progresso compiuto da Kant sotto questo profilo. (Le ragioni della svolta Dobbiamo fermarci un momento a valutare le ragioni e l’importanza di questa rivoluzione concettuale. Quali sono i motivi di questo spostamento e dell’abbandono dei presupposti eudemonistici tradizionali? Innanzitutto la pretesa moderna di una fondazione rigorosa, «scientifica» – dobbiamo sapere con assoluta certezza quali comportamenti sono moralmente convenienti, applicando a ogni ipotetica scelta un criterio ben definito. La possibilità di orientarsi in base a regole certe permette tra l’altro di superare il sapere 7 morale privilegiato di un’aristocrazia bennata, ren-­‐
dendo questo sapere accessibile a tutti. Sul piano sociale la ricerca della coerenza logica da parte delle singole coscienze individuali corrisponde al venir meno della coesione di comunità ristrette che condividono gli stessi valori e alla costruzione di una socialità attraverso un sistema di norme volontarie restrittive degli arbitri individuali Infine non sembra azzardata l’ipotesi che le esigenze della produzione capitalistica imponessero proprio in questa fase di avvio della rivoluzione industriale un controllo delle passioni individuali in vista di un aumento della produttività.) Il principio di felicità e la volontà pura Kant appartiene ancora alla tradizione in quanto riconosce la presenza in ogni uomo della tendenza ad essere felice e di una legittima aspirazione a raggiungere il compimento di questo desiderio. Spezza invece la tradizione in quanto nega che di questo desiderio si possa fare la base della moralità e pone anzi una opposizione netta tra il principio della moralità e il principio della propria felicità. Il termine felicità indica ogni oggetto o bene che possa essere termine di un desiderio. Non importa che sia in gioco un appagamento diretto della sensibilità; anche beni spirituali come la perfezione, in quanto costituiscono anch’essi l’oggetto, il termine di un’aspirazione, rientrano in questo stesso principio e quindi indirettamente nel dominio della sensibilità. La perfezione rimanda allo sviluppo dei propri talenti e 8 delle proprie abilità in vista dei vantaggi della vita che attraverso di essi si ottengono e la stessa obbedienza alla volontà di Dio ha l’obiettivo utilitaristico di riceverne un premio. Questa visione suppone una certa gerarchia all’interno dell’io: tra una parte essenziale, dominante, quella razionale, che è fonte di moralità (– non per nulla Kant cerca le leggi morali non dell’uomo ma di ogni possibile essere ragionevole –) e quella inessenziale, sensibile e da assoggettare alla legge. Si dirà, ed è stato detto, che si tratta di una visione non nuova, di matrice religiosa, che condanna come impura la sensibilità o la «carne». In Kant questa visione viene modulata però in un modo particolare. La inferiorità morale del principio della felicità è stabilita sulla base del fatto che esso è troppo variabile per consentire la costruzione di leggi universali, ovvero semplicemente di leggi, visto che l’universalità si ricava dal concetto stesso di legge. (Questo è un punto che Kant dà per scontato e che viceversa una diversa tradizione etica, durante l’Ottocento, avrebbe contestato. Georg Simmel, l’autore de La legge individuale (1913), immaginerà per esempio che ogni singolo organismo vivente abbia, accanto alla propria vita reale assolutamente singolare, una linea altrettanto individuale del proprio dover essere, e che questo dover essere individuale abbia la stessa imperatività della legge universale che Kant ha stabilito per ogni essere ragionevole.) La volontà (razionale) che corrisponde alle caratteristiche della legge universale è una volontà che 9 per definizione vuole la legge. Anche se forse non è possibile, ammette Kant, indicare con certezza un solo comportamento etico reale che sia non solo esteriormente conforme alla legge ma compiuto in ossequio alle sue prescrizioni, per rispetto della legge. Schopenhauer fece dell’ironia su questo assunto di «una legge di ciò che deve accadere anche se non accade mai» . L’autonomia, il regno dei fini e la convivenza sociale La volontà pura si relazione alla legge in un doppio senso: vuole istituire la legge, ma vuole insieme che l’essere sensibile a cui la volontà appartiene si sottometta ad essa – l’idea di legge evoca quella di sottomissione. Il paradosso è risolto attraverso l’idea di «autonomia» – che è libertà dal lato della ragione che istituisce la legge e sottomissione dal lato della sensibilità che viene assoggettata. Dopo Kant è difficile contestare che la morale debba essere autonoma, cioè radicarsi in una libera decisione del soggetto. Chi si sentirebbe di sostenere una forma di moralità fondata semplicemente su comandamenti divini o su prescrizioni sociali, che tragga la legge dall’altro, dall’esterno, anziché da sé, sia cioè «ete-­‐
ronoma»? L’adozione del criterio della legalità universale e dell’autonomia ha effetti sociali di grande rilievo. La ricerca di modi di comportamento suscettibili di essere seguiti da tutti si traduce in un sostegno alla convivenza sociale. Molti interpreti hanno sottolineato il carattere giuridico e politico dell’etica kantiana, che 10 esclude ogni azione lesiva dei diritti degli altri. Essa mira ad armonizzare i comportamenti degli individui, che, una volta rimossi gli interessi personali e le finalità egoistiche, costituiscono ciò che Kant chiama «regno dei fini», un’utopia che va assai oltre la più perfetta delle società liberali e sembra piuttosto una trasposizione della città celeste. in termini umanistici (Tuttavia l’intento nobile e progressivo di promuovere una simile forma di socialità non riesce a coprire del tutto la forma storica di società che Kant ha in mente, una società «commerciale» sostenuta da una reciproca affidabilità). Il motivo, così caratteristico, dello sradicamento di ogni finalità soggettiva, di ogni «particulare» contribuisce a conferire a questa posizione etica quell’elevatezza che le è stata sempre riconosciuta. Ad esso ci si richiama opportunamente ogni volta che si vuole stigmatizzare il carattere ristretto del perse-­‐
guimento dei propri interessi e le conseguenze devastanti che ne derivano per la vita sociale. (I filosofi sociali, e socialisti, del secolo XIX avranno prospettive simili: in essi diviene esplicita la ricerca della compatibilità delle azioni sul piano sociale.) L’autonomia così concepita resta tuttavia un’autonomia parziale, più della ragione che degli individui reali. La volontà che viene loro imputata, come soggetti morali, è una volontà emendata dalle caratteristiche primarie, radicate nella vita organica di ogni individuo, che contraddistinguono il volere inteso come sforzo di autoconservazione. A questo livello la volontà si presenta – lo noterà Feuerbach in polemica 11 con Kant – come una «volontà di essere» e in ultima analisi come una «volontà di essere felici». L’intero impianto dell’etica muta a partire da questa constatazione. Il dover essere appare come l’assunzione da parte di ciascuno, nella propria coscienza, della volontà di felicità dell’altro (Etica e felicità 1868). L’altro dunque e il suo bene\benessere entra costitutivamente nell’azione morale, una volta che è assunto nella coscienza di chi lo riconosce e se ne prende cura. Nel linguaggio di Kant potremmo dire che l’autonomia, riferita ora, in questa prospettiva eudemonistica, a un essere che non è più un puro essere di pensiero, viene mediata con l’eteronomia, con la legge dell’altro. O, in termini più liberi, possiamo dire che l’azione morale si situa all’interno di una rete di rapporti di dipendenza – dagli altri e dalle cose desiderabili – benché rappresenti insieme anche il riscatto dalla dipendenza e il padroneggiamento di questi rapporti. Il sommo bene La felicità, che compromette la purezza della virtù, quando è assunta come fondamento o fine dell’azione morale, non viene estromessa definitivamente dal sistema morale kantiano. Nella seconda parte della Critica della ragion pratica viene tematizzata una difficoltà nella teoria del dovere che è stata formulata nella prima. Questa teoria finisce per giustificare una dissociazione tra virtù e felicità, che si riscontra in tutti quei casi, e sono frequenti, in cui il virtuoso, divenuto perciò stesso «degno di felicità», pure non riceve 12 alcuna ricompensa ed è anzi infelice. Questo squilibrio richiede di essere sanato: Kant dice che è un’esigenza (un «postulato») della ragion pratica – cioè della ragione nel suo versante morale – che l’unione tra i due momenti della virtù e della felicità venga ristabilita. Di questa unione, egli tiene a precisare, non si può dare una conoscenza certa, si può solo affermare appunto che rappresenta una esigenza irrinunciabile, che sola permette di raggiungere la «compiutezza» del bene. Ed introduce a questo scopo la distinzione tra il bene «supremo», che resta comunque la pratica della virtù, e il bene «sommo», o completo, che include virtù e felicità. Con questo «postulato» Kant opera un passaggio dal campo morale a quello religioso, che descrive anche come luogo della speranza. Solo Dio infatti può garantire un simile eguagliamento, la sua esistenza, dice anzi Kant, può essere affermata proprio a partire da questa sua indispensabile funzione di garantire la compiutezza del bene. La felicità, d’altra parte – è un’evidenza incontestabile – non viene raggiunta, quanto meno in modo soddisfacente, in questa vita. Di qui un secondo «postulato» morale, o religioso, quello cioè che l’anima debba raggiungere la condizione di piena beatitudine, in cui virtù e felicità coincidono, solo in un progresso all’infinito, in una vita immortale. Così il sistema culmina nelle due verità religiose di Dio e dell’immortalità dell’anima, che si sostengono a vicenda. Si può discutere naturalmente se la religione, qualsiasi forma di religione, debba fondarsi su questi elementi. C’è chi l’ha contestato per il carattere tutto 13 sommato «utilitaristico», sia pure in senso elevato, di questo approccio alla religione; e ha cercato una diversa definizione della religione come sentimento disinteressato dell’Infinito. Ma in questa sede vorrei soffermarmi piuttosto sul senso di questo indiretto riconoscimento che riceve alla fine il bisogno di felicità. La beatitudine religiosa, nella concezione originaria, che può essere ben illustrata dal Paradiso dantesco, comportava la stasi in una compiutezza raggiunta una volta per tutte, in cui le anime contemplano Dio e godono di tale contemplazione. L’illuminista Kant dissolve questa compiutezza statica in un processo infinito, che riguarda sia l’adeguazione progressiva della volontà alla legge morale, mai interamente adempiuta in questa vita, che la soddisfazione dei desideri. Sembrerebbe che finalmente l’esigenza di felicità riceva quel riconoscimento che nella sfera della moralità le era mancato. Tuttavia riesce difficile precisare quali caratteristiche conservi la felicità nella sua figura sublimata. È incerto se essa rappresenti la soddisfazione degli stessi desideri di cui era stato portatore l’uomo terreno. Questi desideri – un’anima disincarnata o un corpo etereo non sembrano neppure capaci di provarli. Non si capisce neppure se nell’esistenza supposta ultraterrena si conservi lo stesso soggetto di quella precedente. Se nei due mondi il soggetto conserva, come sembrerebbe in Kant, la stessa identità, la felicità dovrebbe mantenere all’incirca le stesse caratteristiche di quella parzial-­‐
mente possibile nel mondo terreno. L’incremento 14 sarebbe puramente quantitativo, ma in questo caso si riproporrebbero le stesse difficoltà che Kant ha segnalato nella ricerca della felicità, che resterebbe comunque contingente, relativa, inafferrabile. Se invece la felicità dell’aldilà dovesse trascendere totalmente le caratteristiche di quella terrena, allora bisognerebbe chiedersi se il soggetto capace di provarla sia ancora identico a quello della vita antecedente. La continuità, nel caso di Kant, dovrebbe essere assicurata dal riferimento all’«essere razionale», che è concepito sia come soggetto del dovere come della felicità ultraterrena: ma l’essere razionale, nella caratterizzazione che egli ne ha dato, è proprio un essere che per conformarsi ai dettami della ragione, estromette dalla sua vita qualsiasi interesse particolare ed anche ogni possibilità di godimento sensibile. Feuerbach, quasi cento anni più tardi, in uno scritto sull’eudemonismo, ha osservato che Kant lascia trapelare nelle sue riflessioni sul sommo bene una preoccupazione indubbia per la felicità degli individui, dando così dimostrazione, suo malgrado, della ineludibilità del problema. Lo fa però, egli osserva, in una forma così indiretta e involuta da non cogliere il carattere essenziale di questo impulso, su cui viceversa tutta l’etica dovrebbe essere fondata. La certezza dell’azione morale Kant considera irrinunciabile – il brano che ho scelto per voi come lettura è eloquente – un’evidenza assoluta di ciò che il dovere impone in ogni singola circostanza. L’esclusione della ricerca della felicità come principio 15 guida dipende per lui proprio dall’incertezza di che cosa sia la felicità e di quali mezzi conducano ad essa. Ora invece, se teniamo conto del carattere situato e non puro della volontà, l’azione morale, diretta comunque alla felicità – dell’altro e insieme propria, tra le due non c’è contrasto di principio – avrà come guida l’«esperienza del mondo», con tutta l’incertezza che ne deriva. Il campo dell’azione morale partecipa così dell’incertezza propria dell’esperienza in generale. Il modello moderno, esemplificato da Kant, avanza pretese di rigore, vorrebbe stabilire in modo tassativo (categorico) che cosa è dovuto, senza tener in alcun conto delle capacità di cui i concreti agenti morali sono dotati. La verità incondizionata dei principi fornisce qui davvero la guida del comportamento, senza alcuna considerazione per le conseguenze che derivano dalla loro adozione. Ma quali sono i comportamenti che per questa via possono essere sottoposti a una norma? Soltanto i tipi di azioni socialmente più significative (rubare, mentire, uccidere) a cui è relativamente facile applicare i principi. Come abbiamo visto, quest’etica sembra destinata ad assicurare la convivenza attra-­‐
verso la condanna di azioni asociali. Ma la stragrande maggioranza delle azioni che noi compiamo non si presta a queste generalizzazioni, eppure è indubbio che anche queste azioni pretese ‘indifferenti’ hanno un peso nella costruzione della figura morale di ciascuno di noi. L’individuo in questa ricerca di che cosa sia giusto è lasciato solo e non sostenuto dai valori della propria comunità di appartenenza. Kant del resto si muove 16 nella prospettiva liberale e cosmopolitica dell’illu-­‐
minismo, che vuole liberare gli individui dai condizionamenti delle limitate comunità tradizionali. Alla certezza derivante dal consenso sociale subentra però quella delle leggi universali della ragione. La sua società di riferimento è quella che designa con la metafora del «regno dei fini», composta di tutti gli esseri umani in quanto fini a se stessi, degni di «rispetto», portatori di finalità razionali. La verità che funge da orizzonte per questa moralità astratta e dalla forte connotazione sociale, che i moderni hanno finito per assumere come criterio, è quella di una ragione supposta universale e uguale in tutti gli uomini. La singolarità dell’azione morale Fin dal momento in cui fu formulata questa concezione fu però a sua volta contestata in nome del diritto dell’individuo non solo ad essere felice ma a sviluppare comunque le proprie risorse dal punto di vista etico. Altrimenti a una soggezione, quella verso la comunità tradizionale, se ne sostituirebbe semplicemente un’altra, la soggezione alla verità universale della ragione – che non coincide mai con la razionalità reale dei singoli individui. Si trattava di mettere in discussione la stessa universalità della legge, o almeno di intenderla in altro modo. Uno degli artefici di questa reazione fu, alla svolta del secolo XVIII, nel 1800, un pastore protestante, Friedrich Schleiermacher, l’autore dei Monologhi. Egli, che pure da principio si era attenuto proprio a quella interpretazione della moralità, contentandosi 17 dell’uguaglianza dell’unica essenza umana presente in ogni individuo, racconta di aver subito una specie di conversione, che gli ha fatto scoprire il valore dell’individualità incomparabile di ciascun essere. «Ogni uomo, scrive, deve rappresentare l’umanità a suo modo, con una mescolanza particolare dei suoi elementi». Ogni elemento imperativo, legato a un’interpretazione giuridica della moralità, viene bandito, come ogni soggezione a una legge, fino alla sorprendente dichiarazione «non conosco più quel che gli uomini chiamano coscienza». Ciò non significa d’altra parte una ricaduta nell’arbitrio anteriore alla legge ma una ricerca di una nuova forma di legalità, pensata per ogni individuo in analogia alla legge naturale, che regge la crescita organica. Trasferiamoci ora qualche decennio più tardi. In un contesto assai diverso Nietzsche sottopone anche lui l’etica kantiana dell’uguaglianza a una critica simile. In Umano troppo umano troviamo una specie di sintetica storia dell’etica che culmina nell’indicazione di quale dovrebbe essere la morale dell’individuo maturo (§ 25 Morale privata e morale universale, § 94 Le tre fasi finora attraversate dalla moralità, § 95 Morale dell’individuo maturo). Al culmine dello sviluppo etico che si è dato finora egli vede una situazione in cui un individuo che si pretende legislatore, tuttavia «vive e agisce come individuo collettivo». «La vecchia morale, specialmente quella di Kant, pretende dal singolo, quelle azioni che si desiderano da tutti gli uomini». Questa, commenta, «era una bella e ingenua cosa; come se ognuno sapesse senz’altro quale maniera giovi 18 all’umanità nel suo complesso, cioè quali azioni siano in genere desiderabili». Forse, aggiunge, «una futura visione panoramica dei bisogni dell’umanità non fa apparire affatto desiderabile che tutti gli uomini agiscano in modo uguale» (§ 25). Forse «proprio l’agire strettamente personale corrisponde all’odierno concetto di moralità». Egli con ciò intende dire che per la stessa utilità generale giova presumibilmente di più che ciascuno si proponga di «far di sé una persona completa», tenendo presente il proprio bene e il proprio vantaggio, che non obbedire ad emozioni altruistiche. Come dire che se qualche certezza si può ottenere la si consegue piuttosto analizzando quali sono le condizioni del proprio sviluppo interiore che non interrogandosi su un’inafferrabile utilità generale. Nietzsche intravede una strada per procedere verso una nuova forma di moralità, che salvaguarda le esigenze sociali (l’utilità generale) senza sacrificare ma anzi aderendo alle esigenze proprie di valorizzazione degli individui. In questa stessa linea Georg Simmel, un grande filosofo-­‐sociologo, vissuto alla fine dell’Ottocento, ha proposto di far dipendere l’etica dalla verità, ma non da quella universale della ragione, ma da quella che si esprime in ogni singolo vivente nella forma di una «legge individuale», un dover essere tanto personalizzato quanto lo è la vita di ciascuno di noi. Ma forse, una volta che si è compiuto questo passo, si è cioè abbandonato il presupposto di una legge universale della ragione e ci si è spostati sul terreno di una normatività individuale, bisognerebbe anche 19 abbandonare l’idea stessa di poter identificare questo dover essere individuale nella sua “oggettività” e sposare invece quella di un sapere congetturale o ipotetico. La conoscenza che ho di me stesso e l’ipotesi che posso formulare sulla sostanza etica del mondo mi permette di abbozzare delle strategie di azione che possono ricevere qualche parziale conferma dall’esperienza – non gratuite ma neppure così certe che io possa permettere di imporle agli altri come criteri generali di comportamento tassativamente validi. La prudenza, che Aristotele aveva collegato all’appartenenza alla polis e alla condivisione dei suoi valori, torna ad essere valorizzata, ma come uno strumento di cui i singoli individui dispongono per orientarsi intorno alla loro «vita buona». La vita buona, in questa singolarizzazione, include il momento della felicità ma non coincide con essa. L’introduzione, o, se si vuole, il recupero, dell’istanza di felicità del pensiero classico, si accompagna, nei critici di Kant, alla sottolineatura del carattere nettamente singolare del dovere morale. I due temi a volte si intrecciano, a volte divergono. Alcuni degli autori ricordati ad esempio, assai sensibili alla questione del carattere individuale dei criteri morali, non danno soverchia importanza all’istanza di essere felici. In effetti il proprio piacere non è l’unica meta che gli individui si propongono, e forse lo conseguono meglio quando la loro attenzione non si fissa su di essa. Non di rado proprio i migliori tra gli uomini realizzano opere che hanno valore per l’umanità intera, si fanno carico di obiettivi superindividuali o addirittura di cause 20 ecumeniche. In questi casi il richiamo alla felicità che essi, nella loro dedizione, comunque ottengono serve soltanto a toglier loro la credenza illusoria e fanatica che possa darsi un puro altruismo. Riferimenti bibliografici: Aristotele, Etica nicomachea; I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, Critica della ragion pratica, Metafisica dei costumi; F. Schleiermacher, Monologhi; A. Schopenhauer, Il fondamento della morale; F. Nietzsche, Umano troppo umano; G. Simmel, La legge individuale; H. Marcuse, Critica dell’edonismo; H.-­‐G. Gadamer, Verità e metodo; E. Tugendhat, Problemi della morale; C. Larmore, Le strutture della complessità morale. 21