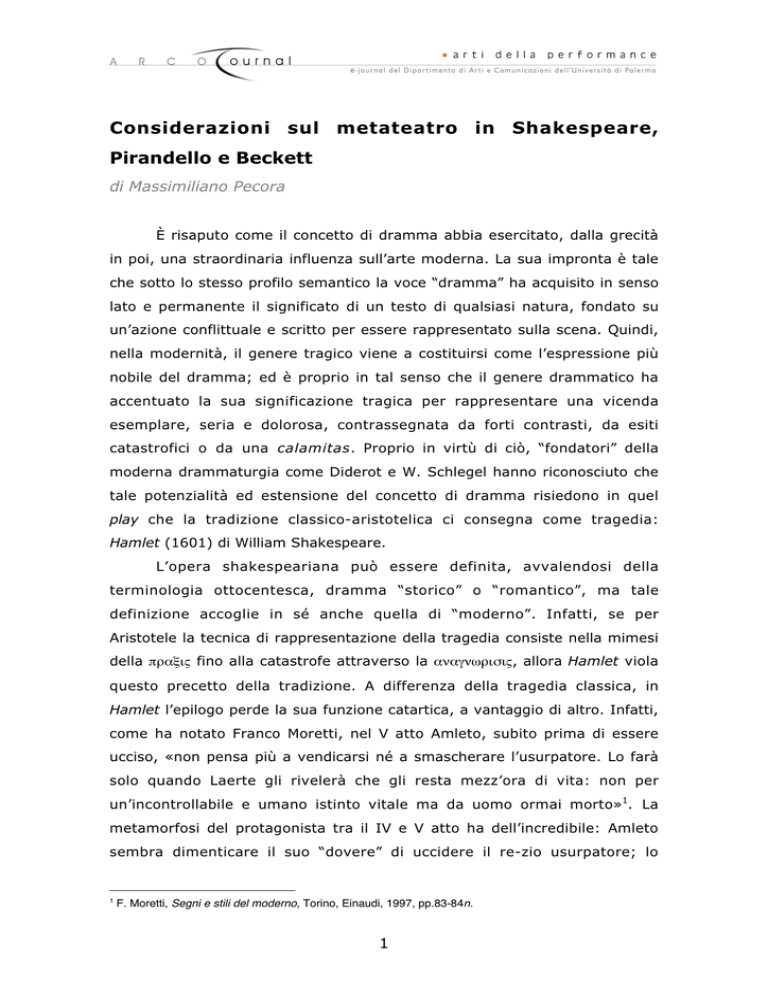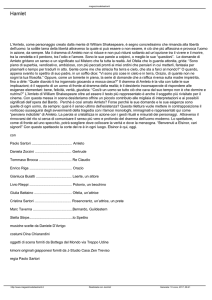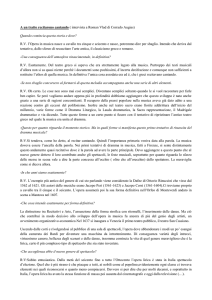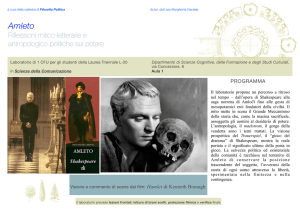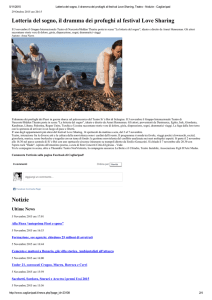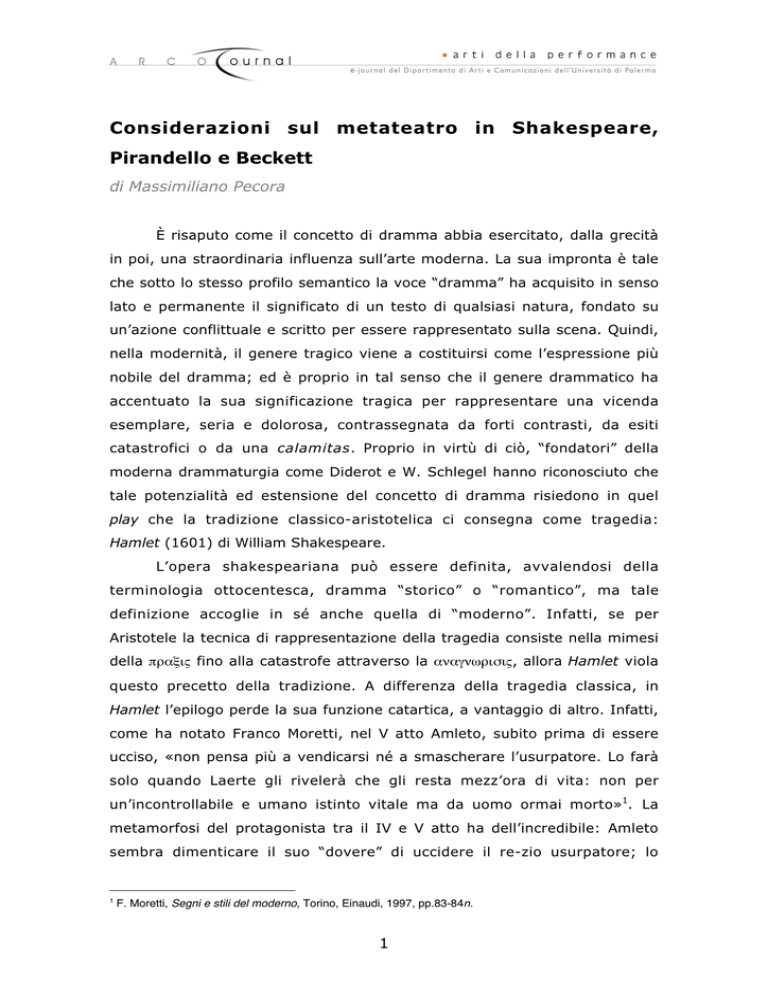
Considerazioni sul metateatro in Shakespeare,
Pirandello e Beckett
di Massimiliano Pecora
È risaputo come il concetto di dramma abbia esercitato, dalla grecità
in poi, una straordinaria influenza sull’arte moderna. La sua impronta è tale
che sotto lo stesso profilo semantico la voce “dramma” ha acquisito in senso
lato e permanente il significato di un testo di qualsiasi natura, fondato su
un’azione conflittuale e scritto per essere rappresentato sulla scena. Quindi,
nella modernità, il genere tragico viene a costituirsi come l’espressione più
nobile del dramma; ed è proprio in tal senso che il genere drammatico ha
accentuato la sua significazione tragica per rappresentare una vicenda
esemplare, seria e dolorosa, contrassegnata da forti contrasti, da esiti
catastrofici o da una calamitas. Proprio in virtù di ciò, “fondatori” della
moderna drammaturgia come Diderot e W. Schlegel hanno riconosciuto che
tale potenzialità ed estensione del concetto di dramma risiedono in quel
play che la tradizione classico-aristotelica ci consegna come tragedia:
Hamlet (1601) di William Shakespeare.
L’opera shakespeariana può essere definita, avvalendosi della
terminologia ottocentesca, dramma “storico” o “romantico”, ma tale
definizione accoglie in sé anche quella di “moderno”. Infatti, se per
Aristotele la tecnica di rappresentazione della tragedia consiste nella mimesi
della πραξις fino alla catastrofe attraverso la αναγνωρισις, allora Hamlet viola
questo precetto della tradizione. A differenza della tragedia classica, in
Hamlet l’epilogo perde la sua funzione catartica, a vantaggio di altro. Infatti,
come ha notato Franco Moretti, nel V atto Amleto, subito prima di essere
ucciso, «non pensa più a vendicarsi né a smascherare l’usurpatore. Lo farà
solo quando Laerte gli rivelerà che gli resta mezz’ora di vita: non per
un’incontrollabile e umano istinto vitale ma da uomo ormai morto»1. La
metamorfosi del protagonista tra il IV e V atto ha dell’incredibile: Amleto
sembra dimenticare il suo “dovere” di uccidere il re-zio usurpatore; lo
1
F. Moretti, Segni e stili del moderno, Torino, Einaudi, 1997, pp.83-84n.
1
spettro e l’immagine mentale del padre sembrano scomparsi non
esercitando più alcun potere. Così, per i primi quattro atti ci si rende conto
che l’esitazione amletica è sinonimo di “coscienza”, come rileva Bloom, nella
sua monografia shakespeariana2. Nel suo saggio Teoria del dramma
moderno Peter Szondi, pur escludendo dalla sua trattazione le opere
shakespeariane, individua alcune caratteristiche che determinano la
modernità di un’opera drammatica: tra queste spicca proprio quel
«predominio della parola sull’azione» che è la dominante in Hamlet. È
proprio l’inazione con il conseguente logorio verbale ed interiore del principe
danese a conferire alla “tragedia” il suo statuto di “dramma moderno”, con
la conflittualità della coscienza esplicitata per i quattro quinti dell’opera. Ma,
se per autori come Strindberg e Ibsen e, in sostanza del genere del
“dramma borghese”, il dramma resta un conflitto di personaggi e coscienze
che si sviluppa interamente e “assolutamente” sulla scena coinvolgendo solo
il piano del dictum,3 allora, pur nella sua modernità, Hamlet contiene un
nuovo elemento. Infatti mentre Szondi pone l’assolutezza come conditio
sine qua non per la modernità drammaturgica, ci si può domandare questo:
perché la storia e l’evoluzione semantico-epistemologica della drammaturgia
fanno di Hamlet l’archetipo della modernità? A ben guardare le categorie
realistico-lukàcsiane utilizzate da Szondi non possono rappresentare una
discriminante per la modernità drammaturgica; se, infatti, consideriamo
autori come Pirandello e Beckett, notiamo come questi abbiano visto nella
tragedia del principe di Danimarca un vero e proprio paradigma di contenuti
e di concetti che afferiscono o, comunque, sono sottesi da quel meccanismo
teatrale e moderno - almeno per le sue utilizzazioni novecentesche - noto
oggi col nome di “metateatro”. Proviamo a verificare la presenza di alcune
analogie tematico-retoriche tra questi autori, per rafforzare tale tesi.
L’opera shakespeariana si presenta come il tentativo virtuosistico di
identificare il teatro con la vita e di rappresentare drammaticamente tale
Weltanschaaung. A questo proposito vanno ricordate le profetiche parole di
As you like it (1599): «Tutto il mondo è teatro e tutti gli uomini e le donne
2
H. Bloom, Shakespeare. The Invention of the Human (1998; trad. it. di R. Zuppet, Shakespeare.
L’invenzione dell’uomo, Milano, Rizzoli, 2001).
3
Lo stesso Szondi utilizza la formula di «dramma-conversazione».
2
niente altro che attori». Queste parole e l’acuta percezione del teatro come
forma d’arte autoconsapevole sottolineano come già a fine ’500 fosse
diffusa un’interpretazione teatrale dell’intero universo tesa a sottolineare la
“natura scenica”, ”apparente“ di ogni forma di comunicazione e la
mescolanza di “realtà” e “finzione” nel rapporto fra gli uomini. Questa
concezione, del resto, è già testimoniata da capolavori manieristici quali la
Gerusalemme liberata (1581) di Torquato Tasso. Pensiamo ai versi che
scolpiscono la figura tragica di Solimano: «mirò quasi in teatro od in agone,
/ l’aspra tragedia dello stato umano» (XX,73) [corsivi miei]. Ora, però, va
detto, a mo’ di corollario, che il metateatro di Amleto non si esaurisce solo
con il playing within the play, La morte di Gonzago. In tutta l’opera, come
sostiene Abel4, molte sono le scene in cui un personaggio prova a dirigerne
un altro, quasi che l’intera corte di Elsinore sia una gigantesco
palcoscenico5.
A questo proposito non mancano corrispodenze evidenti in Endgame
(1956) di Beckett6 e nella trilogia pirandelliana del “teatro nel teatro”. Ma,
nell’opera shakespeariana, all’impalcatura metateatrale afferiscono anche
altri elementi allusivi al campo semantico della rappresentazione scenica.
Infatti nel monologo di I,5 Amleto accetta l’ordine dello spettro,
recuperando perfino un antico τòπος della letteratura romanza: la memoria
viene assimilata ad un libro; questo volume verrà cancellato per accogliere
nuove impressioni e raccontare nuove storie. Qui le parole del principe
sembrano alludere alla necessità di scrivere un “canovaccio”: un nuovo
drammaturgo si affaccia sulla scena, imponendosi un ruolo. Infatti Amleto
reciterà la parte del folle per divenire spettatore di un dramma che egli
stesso sta contribuendo a scrivere vivendolo sulla scena. Siamo di fronte a
un triplice paradosso che verrà ripreso ed esasperato nella drammaturgia
pirandelliana: nei Sei personaggi in cerca d’autore (1921), il Padre e il
Capocomico si porteranno da parte per
scrivere un testo teatrale che,
4
L. Abel, Metatheatre: A new view of Dramatic Form (1963; trad. it. di L. Ballerini, Metateatro, Milano,
Rizzoli, 1965).
5
Tra i diversi esempi possiamo citare: Gertrude, quando esorta Amleto a essere meno malinconico (I,2);
Polonio quando istruisce Laerte nell’arte della “dissimulazione” (I,3). Per questi personaggi che agiscono
come «tragediografi» e altri esempi cfr. Abel, op. cit., p. 72n.
6
Il dramma è fitto di riferimenti metateatrali, come nota Paolo Bertinetti nell’introduzione a S. Beckett,
Finale di partita, trad. di C. Fruttero, Torino, Einaudi, 1961, p. VI.
3
inscenato in luogo di un altro, nel corso della sua rappresentazione verrà
modificato fino alla tragedia; si pensi all’Enrico IV (1922), dove il “finto
pazzo” si rivela come un drammaturgo pronto ad uscire e rientrare nel ruolo
del folle; oppure ad Hinckfuss di Questa sera si recita a soggetto (1930):
egli costringe i suoi attori a recitare ciò che di volta in volta vuole,
modificando un copione che in realtà non esiste se non nelle sue intenzioni
“demiurgiche”.
Ciò che accomuna questi personaggi è una straordinaria “carica
autoriale” che spetta alla tipologia attanziale dei raisonneurs. Amletico è il
Leone Gala de
Il giuoco delle parti (1916): entra ed esce dal suo ruolo,
pronto ad utilizzare la parola come «un freddo ago del concetto»7. Come il
personaggio pirandelliano, sorta di filosofo del vuoto e del pieno8, il principe
danese è sempre cosciente dello scarto che si instaura tra il polo
dell’”essere” e quello del “sembrare”, tra la persona e il personaggio, che è
dominante del corpus drammaturgico pirandelliano, anche laddove, come
nel Giuoco, si risolve metateatralmente solo sul piano linguistico e
filosofematico. L’effetto pirandelliano del giuoco delle parti è centrale per il
drammaturgo Amleto: egli è consapevolmente teatrale e adopera la fictio
teatrale come strumento di difesa in un mondo corrotto. Ma Hamlet è ben
lontano dal configurarsi come un “elogio della dissimulazione”9 cortigiana,
tematica tanto cara alla trattatistica del ‘5-‘600. E, per quanto questo
aspetto sia latente nell’opera, Shakespeare gli conferisce originalità
utilizzandolo ed amplificandolo in una modalità metateatrale, se pure nel
rispetto della concezione machiavelliana della vita politica. Del resto, il
cortigiano ideale, compos sui, padrone delle sue azioni e dei suoi pensieri in
ogni circostanza, deve essere sempre attento a non far trapelare i propri
moti passionali per il conseguimento del primato di corte; deve esprimersi
con un certo “stile”, che per Amleto resta quello dell’attore di se stesso, del
“finto pazzo”. Ora, volendo analizzare questo aspetto dalla prospettiva
sintattico-narrativa, possiamo avvalerci dello schema del quadrato semiotico
7
Così A. Leone De Castris, Storia di Pirandello, Bari, Laterza, 1962.
E a questa “filosofia” allude anche Hamm in Endgame di Beckett; cfr. Finale di partita, cit.
9
L’espressione è mutuata da R. Villari, Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento, RomaBari, Laterza, 1987.
8
4
per interpretare il sistema assiologico amletico10. Tra le modalità11 troviamo
la “sanzione”, ovvero un enunciato dell’”essere” che modalizza un “essere”:
essa si configura come un comportamento attanziale che valuta se ciò che
appare corrisponde all’ “essere”. Questo “essere dell’essere” coinvolge le
modalità veridittive che, proiettate sul quadrato semiotico, articolano la
veridizione:
SEMBRARE
ESSERE
(polo della dissimulazione)
(polo della simulazione)
NON SEMBRARE
NON ESSERE
Il comportamento veridittivo è, quindi, giocato tra la sfera della
simulazione, che afferisce alla polarità semiotica della menzogna, e quella
della dissimulazione, che invece appartiene alla sfera del segreto,
imponendo di tacitare l’impulso della vendetta: il sospetto e l’indagine
costringono Amleto a custodire il terribile segreto e a fingersi folle. Ma tutto
questo può spiegare il tormento del principe di Danimarca? In realtà
«l’esitante lutto» è proprio l’occasione per abbattere la distinzione tra il polo
dell’ “essere” e quello del “sembrare”: il ruolo del folle agisce come
contenitore delle istanze di simulazione e dissimulazione che arrivano a
congiungersi,
confondendosi
nell’aspirazione
di
Amleto,
attante
autogiudicante, a una verità ontologica. Il processo narrativo che ne deriva
può essere schematizzato in questo modo:
Processo narrativo del tema della follia
[(S1 ∪ Ov) VÎ (S1 ∩ Ov)]
10
In semiotica il quadrato corrisponde a uno schema che articola qualunque categoria semantico testuale
- definita, a sua volta, per opposizione - secondo relazioni di c o n t r a r i e t à, contraddizione e
complementarità.
11
In semiotica narrativa le modalità sono definite come predicati che modificano altri predicati.
5
Dove con S1 si indica Amleto; con Ov l’oggetto di valore (la verità
sull’assassinio); con ∪ l’avvicinamento ad esso; con ∩ l’allontanamento da
esso; con VÎ la presupposizione reciproca tra questi due processi narrativi.
La follia del raisonneur Amleto agisce allora con una doppia valenza: da un
lato è strumento per il raggiungimento di uno scopo, ma dall’altro induce
l’uomo ad interrogarsi sul profondo valore della verità nel “gran teatro” dei
rapporti umani. E in tutto questo la tipologia del folle svolge la funzione di
presupposto e “contenitore” di tali istanze che strutturalmente vengono
rappresentate col ricorso al “metateatro”.
Si può quindi riscontrare un’oscillazione continua tra il polo della
verità e quello della finzione che è dominante dei grandi raisonneurs del
teatro pirandelliano: pensiamo alle parole <<Realtà[…], realtà[…],
verità[…]>> del Padre che fanno da controcanto alle battute <<Finzione[…]
Finzione>> degli attori, che chiudono i Sei personaggi in cerca d’autore. Alla
luce di questa considerazione possiamo notare come il ruolo del finto pazzo
possa amplificarsi fino a coinvolgere l’intero spazio drammatico,
trasformandolo in una gigantesca macchina del metateatro, come accade in
buona parte della drammaturgia pirandelliana, perfino in quella in cui
l’istanza metateatrale si risolve solo sul piano linguistico (come ne Il giuoco
delle parti). Infatti i ragionatori pirandelliani (si pensi a Leone Gala oppure
al Doro Palegari di Ciascuno a suo modo (1924), secondo elemento della
trilogia del “teatro nel teatro”) vengono sempre appellati con l’epiteto di
“pazzo” da interlocutori incapaci di comprendere la loro logica speculativa e
insieme ontologica (eppure Polonio arriverà a nutrire dei sospetti: «Sarà
pazzia ma non manca di logica» II, 2 vv. 205-206).
Del resto, perfino nella tradizione della letteratura filosofico-scientifica
si può rintracciare il legame che statuisce la teatralità della figura del folle.
Nell’Elogio della follia (1511) di Erasmo da Rotterdam si legge: «L’intera vita
umana non è altro che uno spettacolo in cui, chi con una maschera, chi con
un’altra, ognuno recita la propria parte finchè, a un cenno del capocomico,
abbandona la scena». Ma le analogie non si esauriscono nel recupero e nelle
modificazioni del tradizionale «Totus mundus agit histrionem». Come tutti i
6
raisonneurs pirandelliani (Leone Gala, Hinckfuss, Angelo Baldovino, etc.) il
principe danese avverte lo scarto che sussiste tra parola e azione. Questo
spiegherebbe le ambiguità del lessico amletico e di molti “eroi” del teatro
pirandelliano. Per esempio per Amleto il verbo shuffle, che significa
“ricorrere a sotterfugi”, viene usato nel significato di “sciogliersi dal viluppo”
della menzogna verso se stessi e gli altri cortigiani. Per Claudio, invece,
shuffling indica il ricorso a trucchi mortali. Questo esempio di ampliamento
del campo semantico dimostra come l’inazione amletica corrisponda, sul
piano del dictum, ad una profonda sfiducia nel potere persuasivo della
parola e nel carattere perlocutivo dell’atto linguistico. Avviene spesso che
l’eroe shakespeariano12 dia inizio ad un monologo alla presenza di tutti:
costoro non l’udranno e il monologo, dal punto di vista dell’azione
drammatica, risulterà assurdo. Pensiamo al monologo di Lucky (anche se, a
ben vedere, tutti i drammi beckettiani si caratterizzano per la mancata
corrispondenza tra parola e azione) in Waiting for Godot (1948), o al
monologo del pirandelliano Enrico IV13. Anche in questi casi essi non
costituiscono il prologo ad alcuna azione e sono destinati a non essere intesi
dagli altri, ridotti al rango di semplici spettatori o uditori di un potente
ragionatore che sembra “origliare se stesso”. Qui parla sempre una sola
voce o, meglio, un solo attante che attende ad un’unica funzione; questa
non è né referenziale, né conativa, né tantomeno espressiva, ma
autoreferenziale e dolorosamente assorbita in se stessa. E a questo punto si
pensi al lungo monologo di Bocca, unico personaggio sulla scena di Not I
(1972) di Beckett, che rappresenta l’amplificazione esasperata ed
esasperante del significato ancipite e sfuggente del monologo metateatrale.
Di conseguenza, la caratteristica precipua e dominante che accomuna le
forme del metateatro shakespeariano, pirandelliano e beckettiano è
costituita dal fatto che l’autocoscienza del raisonneur metateatrale non può
essere distinta dalla sua teatralità. Ad esempio, come nel caso della
“prigione” di Elsinore, il castello del pirandelliano Enrico è un gigantesco
12
Vedi Hamlet : I, 4, vv. 13-38; ma anche III, 2, vv. 63-74. Di questi monologhi la prima e ultima parte
contengono allocuzioni a Orazio, mentre la parte centrale rappresenta una “riflessione” amletica.
13
Si tratta del celebre monologo (a metà del II atto) di Enrico sulla pazzia dove, comprese tra le allocuzioni
ingiuriose ai servi, riconosciamo le riflessioni sull’essere attori nel teatro della vita e il legame tra il tema
della follia e il metateatro.
7
palcoscenico in cui inscenare il tormento di una coscienza frammentata: il
protagonista costringe “consapevolmente” gli altri a recitare per lui e con
lui, secondo i dettami di una regia imposta e pretesa attraverso la
“maschera” della follia. Enrico IV è un genio del teatro, al pari di Amleto.
Questi adopera per “io” sempre l’espressione selfsame pur vestendo i panni
del pazzo, del drammmaturgo, del figlio tradito e dell’”attore di se stesso”,
quasi a rivelare la multiformità della sua anima. E Hamlet come l’Enrico IV
pirandelliano è proprio il dramma del dramma, in cui il protagonista usa il
teatro per “vedersi vivere”.
Un’altra caratteristica che accomuna le tre tipologie metateatrali di
Shakespeare, Pirandello e Beckett è ciò che la moderna critica letteraria ci
consegna col nome di foregrounding; il verbo to foreground, mutuato nel
suo significato critico-letterario da una lettera di Emerson a Whitman del
185514, significa ”dare importanza, puntualizzare o attirare l’attenzione” su
particolari elementi del testo o aspetti di un determinato attante. Perfino la
“realtà onomastica” dei grandi protagonisti del metateatro di Shakespeare,
Pirandello e Beckett richiama la loro natura, attraverso il ricorso al nomen
omen15. Ma tale puntualizzazione, nel caso di un’opera drammatica, ci viene
fornita dai personaggi che ruotano intorno al protagonista e di cui sono i
principali interlocutori. Tutto questo può poi “guidare” lo spettatore al
riconoscimento del background del protagonista. Per quanto non adotti
questo termine, Abel riconosce tale tecnica come essenziale e fondativa del
metateatro beckettiano. Ora, per Szondi l’assolutezza del dramma è
garantita anche dal fatto che nessun personaggio fa riferimento al
background o all’”impalcatura” morale e culturale di un altro personaggio,
specie se assente dalla scena. Per il critico ungherese, l’assolutezza, intesa
come fondamento della moderna drammaturgia, consiste soprattutto nel
14
Il termine è introdotto con tale valenza critica da H. Bloom, op. cit.
Infatti un’analogia notevole tra questi tre autori metateatrali è rappresentata dal ricorso continuo ai “nomi
parlanti” per designare alcuni protagonisti delle loro opere: tali nomina contengono in nuce riflessi di ciò
che essi saranno o riveleranno sulla scena. Per esempio il nome Amleth , poi Hamlet , deriva dall’antica
parola norrena che significa “idiota” e designa un infido buffone che finge di essere pazzo; Leone Gala è
un vero e proprio ossimoro che allude ai modi affettati, istrioneschi di un uomo pronto alla vendetta,
perché consapevole della differenza tra il “vuoto” della maschera e il “tormentoso pieno” della vita; Hamm
è calembour, quasi un travestimento onomastico per un’allusione a Hamnet/Hamlet; questo solo per citare
alcuni dei numerosi esempi che caratterizzano l’onomastica metateatrale che ha in Hamlet il suo
paradigma.
15
8
costruire il dramma come una successione di eventi giustapposti, tali da
escludere qualsiasi ricorso alle facoltà deduttive dello spettatore: il carattere
del personaggio si deve mostrare solo e soltanto attraverso l’azione
drammatica. E così, la “citazione” è proprio ciò che attenta alla “solidità” del
precetto della quarta parete, costringendo lo spettatore a dedurre come
Amleto, Leone, Hamm, etc. sono diventati quello che sono o saranno sulla
scena. Nel corso del dramma apprendiamo che Amleto, forse un non molto
zelante studente di Wittemberg, è uno studioso di filosofia medievale (si
pensi al concetto di memoria come tabula rasa, caro agli Occamisti); è un
appassionato frequentatore dei teatri londinesi (II, 2 vv. 325-358); è un
aspirante drammaturgo allorché modifica il copione de La morte di Gonzago.
Quando parla in tono elegiaco del suo innamorato, Ofelia16 lo definissce un
cortigiano, un soldato, uno studioso, ma ben prima, dalle parole dello stesso
protagonista, comprendiamo come egli sia un metafisico e perfino un
eccellente psicologo-psichiatra (La morte di Gonzago, opportunamente
trasformata nella «trappola che acchiappa la coscienza del re», agirà con le
finalità di un autentico psicodramma, come accadde nel “teatro nel teatro”
di Ciascuno a suo modo).
Dal
foregrounding amletico possiamo dedurre un’importante
considerazione: molto prima dell’assassinio del padre e del matrimonio della
madre con Claudio, il principe era già un genio del teatro, affascinato
dall’atto del “dire” ciò che era già morto nel suo cuore («Parole, Parole,
Parole…», II, 2 v. 193), per parafrasare un celebre apoftegma nietzschiano.
Egli è, quindi, la realizzazione drammatica del principio ”la rappresentazione
è realtà”, è apoteosi della drammaturgia. Il principe di Danimarca ha così il
suo corrispondente in Enrico IV o in Leone Gala. Nel corso della tragedia
pirandelliana, veniamo a scoprire per bocca di Matilde Spina che il futuro
Enrico IV, ben prima della caduta da cavallo che ne causerà la pazzia, era
già ossessionato dall’ambiziosa pretesa di scoprire la verità della vita al di là
della finzione sociale. Leone Gala viene addirittura “citato” nelle sue
massime fondamentali, nella sua filosofia del “pieno e del vuoto” fin dalle
prime scene del I atto dall’amante della moglie. In Beckett il foregrounding
16
Hamlet III, 1, vv. 152-163.
9
si risolve sia sul piano linguistico, come in Shakespeare e Pirandello, sia dal
punto di vista scenico, esasperando la fisicità dei suoi personaggi.
Infatti, se sul versante del dictum possiamo notare gli enunciati ad
“eco”17 nelle sticomitie di Vladimiro ed Estragone, o quella sorta di ρησεις
citazionistica di Lucky (dove Abel riscontra la parodia del “ragionamento
parlato” di Joyce), dal punto di vista scenografico si può rilevare altro.
Benchè i personaggi beckettiani siano creazioni della fantasia, essi hanno
una sorta di «triste naturalezza» (Abel); vengono descritti, o meglio,
appaiono nelle loro deformità, per quanto il loro “agire” la scena sia ben
lontano da ogni concessione verso il teatro realistico. Proprio la loro
esasperata fisicità lascia intendere che una «qualche azione molto
importante» (Abel) sia stata compiuta in un antefatto, un mai rappresentato
prologo al dramma. Quindi ciò che osserviamo sulla scena si presenta come
proiezione di un dramma già avvenuto, l’epilogo di un avvenimento di cui il
pubblico può osservare solo lo stadio ultimo. L’inazione dei personaggi dei
drammi di Beckett (caratteristica comune ad Amleto come a Leone Gala,
Angelo Baldovino, etc., come si è già notato) è il frutto di un accaduto che il
pubblico può solo intuire: Vladimiro, Estragone, Hamm, etc. con i loro vestiti
o il loro corpo si sono contratti a causa di quel che fecero o fu fatto loro.
Essi si sono rattrappiti nel corpo e nello spazio (vedi Nag e Nell) a causa
della «demolitrice azione del tempo» (Abel): più il tempo trascorso da un
individuo aumenta, più il futuro che gli resta si contrae in «Attimi nulli,
sempre nulli […] che fanno che il conto torni, che la storia si chiuda», come
sostiene Hamm in Endgame (1956).
Questo incessante fluire del tempo cancella i fremiti dei godimenti
passati18 e ai raisonneurs del metateatro non resta che la nostalgia per
l’eternità che solo il meccanismo del teatro può manifestare. C’è chi la vuole
immprigionare nel “teatro della vita” come Enrico IV che uccide il rivale
17
Per esempio:
Estragone: […] , aspetti sempre l’ultimo momento.
Vladimiro: L’ultimo momento…
Ma questa sorta di struttura di “richiamo” è tale da coinvolgere l’intero dramma: infatti la conlusione
riprende in modo pressoché identico la parte finale del I atto.
18
Si pensi alle invocazioni quasi nostalgiche di Hamm: «Una volta mi volevi bene.»; «Che sogni! Quelle
foreste!» p. 7, oppure, ed è un caso più evidente, al “ricordo” della gita in barca di Nagg e Nell in Finale di
partita, cit., p. 15.
10
Belcredi, costringendosi a vivere nella maschera del “pazzo” («Qui con me,
per sempre» sono le sue ultime parole a conclusione della tragedia
pirandelliana); chi, trasformandosi in un essere inanimato fugge dalla sua
umanità non appagandosi della vendetta appena consumata (Leone si
riduce a un corpo senza parola19) o chi, poco prima di spirare, affida la sua
“storia” a un cronista (è questo il caso di Orazio che raccoglie la volontà
ultima di Amleto o di Enrico IV). Notiamo allora come la categoria dello
spazio-tempo si leghi alla struttura metateatrale. Proprio in quest’ultimo
esempio, si può verificare come la preoccupazione del principe sia quella di
un drammaturgo a cui il tempo sottrae l’occasione per rivelare qualcosa di
importante attraverso un atto di natura teatrale; in V, 2 i vv. 339-342
possono essere letti come una chiara allocuzione al pubblico, con l’effetto
straniante di lacerazione della quarta parete, a cui del resto già si allude con
la scena della morte di Polonio, dal chiaro spessore metateatrale. La
creatura shakespeariana si è fatta “autrice di se stessa”, fino a diventare
vittima dell’αναγκη degli eventi che ha determinato, quasi a testimoniare che
la fictio del teatro è diventata più forte della realtà.20 E se l’opposizione
“realtà vs finzione” rimanda, come abbiamo visto, ai Sei personaggi, essa
richiama anche il breve monologo di Vladimiro21 dove, con intenti
dissacranti, vengono riprese le considerazioni amletiche sulla realtà e
l’apparenza della vita.
Alla luce di queste congruenze possiamo notare come la dinamica del
metateatro non si esaurisca nella struttura del playing in the play, ma
presupponga e venga presupposta, quasi in un rapporto di coimplicazione
reciproca, dalla figura del raisonneur. Questo «libero artefice di se stesso»
(Hegel, citato da Bloom), il cui tragico destino è dovuto al fatto che «pensa
troppo bene» (Nietzsche), agisce la sua vita con la coscienza dell’uomo di
teatro, consapevole dell’impossibilità di risolvere i suoi rovelli e di apparire
come folle in un mondo incapace di vedersi vivere. Inoltre l’oscillazione
19
Ed è importante notare anche questa analogia tra la didascalia conclusiva de Il giuoco e quella di
Waiting for Godot; in quest’ultimo caso, l’immobilità di Vladimiro ed Estragone è evidenziata dal contrasto
con l’ultima battuta: «Andiamo».
20
La rottura della “quarta parete”, costante delle “Serate futiriste”, è dominante nella trilogia del “teatro nel
teatro” di Pirandello e allusa da Clov di Endgame nella famosa scena del cannocchiale puntato sulla
platea con la battuta: «Una folla in delirio».
21
Cfr. S. Beckett, Aspettando Godot, trad. it. di C. Fruttero, Torino, Einaudi, 1956, p. 106.
11
semiotico-narrativa tra il polo della menzogna e quello della dissimulazione
accomuna questi “eroi” dell’autocoscienza. Sia che i drammi in cui appaiono
si concludano con l’inscenamento della
morte o meno, essi sono pur
sempre protagonisti di un “dramma del dramma” oltre che di un “dramma
nel dramma”, che possiamo definire “tragedia del personaggio”. Qui la
morte è solo un elemento di coronamento di un lento processo demiurgico
ad opera di un protagonista che si serve consapevolmente delle potenzialità
del teatro per “vedersi“ o ”udirsi” vivere sulla scena, sia che si chiami
Amleto o Leone Gala o si tratti del Krapp di Krapp’s Last Tape (1958).
Data di pubblicazione on-line: 11 novembre 2004
12
Bibliografia:
L. Abel, Metateatro, Milano, Rizzoli, 1965
H. Bloom, Shakespeare. L’invezione dell’uomo, Milano, Rizzoli, 2001.
S. Beckett, Aspettando Godot, a cura di C. Fruttero, Torino, Einaudi, 1956,
200333.
-
Finale di partita, trad. di C. Fruttero, nota introd. di P. Bertinetti,
Torino, Einaudi, 1961, 200310.
-
Teatro completo, a cura di P. Bertinetti, Torino, Einaudi, 1994.
A. Leone De Castris, Storia di Pirandello, Roma-Bari, Laterza, 1962.
E. da Rotterdam, Elogio della follia, a cura di E. Garin, Milano, Garzanti,
1992.
P. Magli, Semiotica. Teoria, metodo, analisi, Venezia, Marsilio, 2004.
F. Moretti, Segni e stili del moderno, Torino, Einaudi, 1997.
F. Nietzsche, Nascita della tragedia, a cura di G. Colli, trad. di S. Giametta
Milano, Adelphi, 1971, 200020.
L. Pirandello, Maschere nude, ed. diretta da G. Macchia, a cura di A.
d’Amico: vol. I, Milano, Mondadori, 1989; vol. II, ivi, 1993.
W. Shakespeare, Come vi piace, a cura di C. A. Corsi e N. D’Agostino,
Milano, Garzanti, 1990.
- A m l e t o,
a
cura
di
N.
D’Agostino,
Milano,
Garzanti,
1984,
200317.
P. Szondi, Teoria del dramma moderno 1880-1950, introd. di C. Cases,
Torino, Einaudi, 1962.
R. Villari, Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento, RomaBari, Laterza, 1987.
13