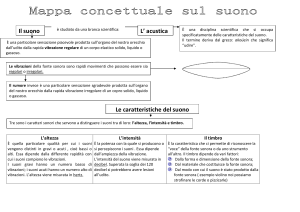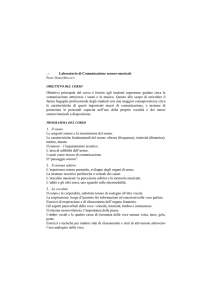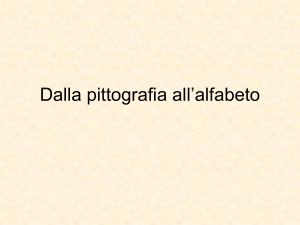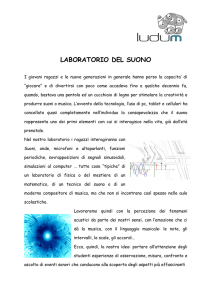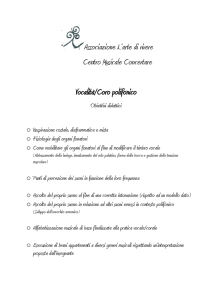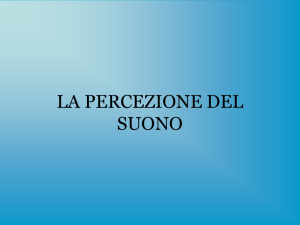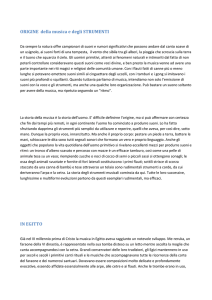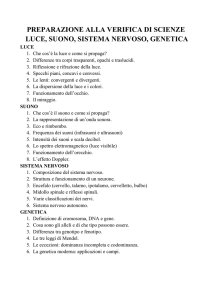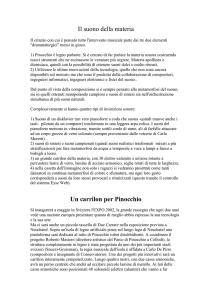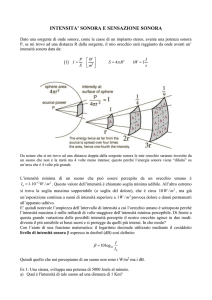Insegnamento di
Audiologia II
Lezione IV del 27.05.2015
Sviluppo della Percezione e del Linguaggio
Dott. Carla Laria
Servizio di Audiologia
Dipartimento di Neuroscienze
LINGUAGGIO
SISTEMA
COGNITIVO
PROCESSORE
PROCESSORE
MORFO-SINTATTICO
FILTRO
FILTRO
INGRESSO
USCITA
produzione
comprensione
SEMANTICO-LESSICALE
PROCESSORE
FONOLOGICO
FILTRO
INGRESSO
ANALISI UDITIVA
FILTRO
USCITA
REALIZZAZIONE FONETICA
Apprendimento del linguaggio
Sistema a due vie
VIA
DORSALE
Articolazione
Interscambio
Acusticomotorio
Corteccia
uditiva
primaria
Input
uditivo
Interscambio
Suonocomprensione
VIA
VENTRALE
Caratteristiche di elaborazione del
linguaggio verbale nel I anno di vita
• Asimmetria ricezione/produzione
• Avanzate competenze in comprensione
• Ridotte capacità produttive
VIA VENTRALE > VIA DORSALE
Quando incominciano i processi comunicativi
del neonato ?
…Da subito!!!!
predisposizione innata
all’apprendimento del linguaggio, il
piccolo umano è in grado di
apprendere in un tempo
relativamente breve un sistema
complesso come la lingua cui è
esposto.
Pre-requisiti biologici
• Prima che inizi lo sviluppo del linguaggio il
bambino deve essere pronto ad acquisirlo.
• Anche prima che il bambino pronunci la
prima parola è già iniziato un lungo processo
di sviluppo delle abilità linguistiche.
Pre-requisiti biologici
• Adeguato sviluppo e funzionamento
dell’apparato uditivo
• Esperienza acustica
Udito
PERIFERIA UDITIVA
La coclea appare macroscopicamente matura a partire
dalla 33° settimana di età gestazionale; ma il processo di
differenziazione cellulare inizia già alla 10-12° settimana
dopo il concepimento.
Il feto è in grado di udire negli ultimi due mesi di vita
intrauterina
Udito
PERIFERIA UDITIVA
La maturazione dei neuroni afferenti primari del
ganglio spirale del Corti segue un percorso strettamente
legato allo sviluppo cocleare.
La mielinizzazione inizia distalmente a partire dalla 22°
settimana e si completa a livello centrale verso la 29°
settimana gestazionale.
In seguito, la densità di mielina aumenta
progressivamente, portando alla completa maturazione
della conduzione elettrica lungo le vie acustiche entro il
primo anno di vita.
Udito
CORTECCIA UDITIVA
Mentre la coclea e le vie uditive del tronco sono
funzionalmente attive alla nascita, l’encefalo è
completamente immaturo e continua a svilupparsi
ancora per molti anni.
La stimolazione ambientale promuove nel tempo la
maturazione e la successiva stabilizzazione dei circuiti
neurali degli strati corticali della corteccia uditiva.
La percezione uditiva e alcune capacità di
discriminazione sonora sono innate, ma alcune abilità
sensitivo-motorie, percettive e cognitive vengono
acquisite nella prima infanzia entro il 2° anno di vita.
Sistema Uditivo Centrale
100
sviluppo
coclea
0
sviluppo
corteccia
nascita
6 anni
% prestazione
% prestazione
50
Sistema Uditivo Centrale
Differenziazione
progressiva delle aree
della corteccia
Lo sviluppo continua
anche dopo la nascita
Vie uditive
nuclei cocleari del tronco encefalico,
ricevono assoni del ganglio spirale del Corti
oliva superiore decussazione fibre nervose
collicolo inferiore del mesencefalo, localiz.
sorgente sonora (confronto tempo e
intensità)
corpo genicolato mediale del talamo,
processi integrativi
corteccia uditiva primaria riconoscimento
e memorizzazione, risposte volontarie
* Corteccia uditiva
La corteccia uditiva primaria
(A1, A2, R) è costituita dalle
aree dette CORE e BELT
La corteccia uditiva
secondaria è costituita dalle
aree associative dette
PARABELT:
Prefrontale (BROCA)
Temporale Posteriore
(WERNICKE)
Planuum temporale
La corteccia uditiva primaria
(A1, A2, R) è tonotopica.
È responsabile dell’analisi
spettro-temporale dei fonemi.
La corteccia uditiva
secondaria non è tonotopica.
È responsabile dell’analisi
semantica.
La capacità di processing cerebrale
dello stimolo sonoro nel neonato
• Preferential hearing
• Preferenza di ascolto della voce materna
• Capacità di percepire indici acustici relativi agli
accenti ed alla prosodia (aspetti musicali e non
semantici)
Percezione
0-1 mese: I neonati sono capaci, sin dalla nascita, di
percepire i contrasti linguistici tra fonemi:
studi su:
- suzione (aumento della forza di suzione in presenza di stimoli nuovi),
- abituazione (orientamento del neonato verso lo stimolo nuovo o nessuna
risposta in presenza di stimoli già uditi),
- generalizzazione (girare la testa verso i suoni appartenenti ad una categoria
linguistica, ma non ad altre);
Sono capaci di discriminare intonazione ed accento:
qualità del timbro, differenze di ritmo, di intensità, di
durata;
PERCEZIONE VERBALE NEL BAMBINO
• Riesce a discriminare categorie della lingua non nativa fino
a 12 mesi di età sebbene questa capacità si riduca già tra 8
– 10 mesi
• Riesce a percepire differenziazioni vocaliche già intorno ai
6 mesi
I bambini americani non sono in grado di discriminare
la
/i/ della lingua inglese ma sono in grado di
differenziarla dal medesimo suono della lingua svedese
(kuhl et al 1992)
• Riesce successivamente a «selezionare» categorie
consonantiche, processo che alla base del riconoscimento
di parole
(Boysson-Bardies, 1998)
TRASCRIZIONE IPA
<6 mesi
>10-12 mesi
TRAPEZIO VOCALICO
28
7
DISCRIMINAZIONE dei suoni linguistici
ADULTO
Discrimina gli indici acustici in modo categoriale, tende a
percepire gli indici acustici che distinguono i fonemi, ignora gli
indici acustici che non determinano cambiamenti fonemici
BAMBINO
Capacità di discriminare parecchi (tutti?) gli indici acustici
presenti nei suoni linguistici
(se così non fosse il bambino sarebbe predestinato a parlare una
lingua particolare)
Bambini al di sotto dei sei mesi sono in grado di discriminare
un discreto numero di indici acustici che identificano i
fonemi:
-occlusive (p, b, t, d, k, g), nasali (m, n), vocali;
- scarsa discriminazione dell’informazione
frequenze delle fricative (v, f);
alle
altre
Studio su bambini provenienti da tre diversi contesti
linguistici:
Scopo: discriminare contrasti fonemici PRESENTI e
NON PRESENTI nella loro lingua
a 6 mesi, i bambini erano in grado di discriminare i
contrasti fonemici di tutte e tre le lingue
verso l’anno i bambini non sono più in grado di
discriminare i contrasti fonemici non presenti nella
lingua di appartenenza che erano invece in grado di
distinguere in precedenza
Werker & Tees (1984)
SVILUPPO FONOLOGICO (percezione)
da 0 a 6-10 mesi il bambino è in grado di estrarre
informazioni fonetiche universali ovvero di discriminare
fonemi anche non presenti nella propria lingua
da 6-10 mesi a 18-24 mesi: riconoscimento delle categorie
fonetiche presenti nella lingua materna, la capacità di
discriminazione precedente decade per quei fonemi che non
fanno parte della lingua di appartenenza (interazione con
l’ambiente)
ATTENUAZIONE O PERDITA, alcune capacità
discriminanti non sono necessario all’interno di alcune
lingue, perdita della capacità di discriminazione tra questi
contrasti fonologici
Es. nel giapponese adulto, incapacità di discriminare
tra /r/e /l/
Le capacità di discriminazione non ancora presenti alla
nascita devono essere acquisite. Apprendimento dell’abilità
tramite gli input linguistici e la maturazione del SNC
NEL NEONATO LE ABILITÀ RECETTIVE
SONO MOLTO PIÙ SVILUPPATE RISPETTO A
QUELLE PRODUTTIVE
notevole capacità di discriminare le differenze tra
suoni linguistici
ridotte capacità di riproduzione degli stessi
Come nasce e si sviluppa il linguaggio
Percezione prosodica
/musicale
Unità fonetiche
Categorizzazione
delle unità fonetiche
Narrowing
Riduzione dei fonemi
della lingua nativa
Segmentazione: analisi statistica delle
adjacent transitional probabilities
Il neonato ha:
• Una sensibilità alla probabilità di sequenza tra
sillabe adiacenti;
• La possibilità di separazione della forma della
parola su base fonologica, già prima di
attribuire un significato.
Limiti dell’analisi statistica per la segmentazione.
STADI DI SVILUPPO DEI SUONI LINGUISTICI PREVERBALI
SECONDO OLLER (1980)
STADIO
ETA’ COMPARSA
TIPO DI
ESPRESSIONE
Fonazione
Nascita-1 mese
Nuclei quasi risonanti
2-3 mesi
Nuclei quasi risonanti
anche con costrizione
posteriore
Espansione
4-6 mesi
Nuclei di risonanza
completi: pernacchie,
gridolini, strilli, borbottii,
marginali lallazioni
Lallazione tipica
(babbling canonico)
7-10 mesi
CVCV con caratteristiche
temporali precise
Lallazione variata
(babbling variato)
10-12 mesi
Ampia varietà di
consonanti e vocali,
discorsi inarticolati
Suoni gutturali
Stadi di sviluppo del linguaggio nel bambino normale
Lallazione generica
Lallazione canonica
Lallazione variata
Inizio comparsa comprensione di
parole
Comparsa produzione delle prime
parole
3-7 mesi
8-9 mesi
9-10 mesi
9-12 mesi
13-15 mesi
(12/20 parole intorno ai 18 mesi)
“Esplosione” del vocabolario; dal
riferimento alla predicazione
Dai 18-20 mesi
Combinazione di parole
20-22 mesi
24-30 mesi
“Esplosione” della grammatica;
comparsa delle prime frasi
Progressiva efficienza sul piano
lessicale, grammaticale e
sintattico
24-36 mesi
LO SVILUPPO MORFO-SINTATTICO
(CHILOSI-CIPRIANI ’91)
ETA’ (mesi)
LME
FASE PRESINTATTICA
- Parole singole in successione
19-26
1.2-1.6
- Enunciati telegrafici
FASE SINTATTICA PRIMITIVA
20-29
1.6-2.8
- Enunciati nucleari semplici
FASE DI COMPLETAMENTO
24-33
1.9-3.0
DELLA FRASE NUCLEARE
- Frasi complete (verbo)
FASE DI CONSOLIDAMENTO
27-38
E GENERALIZZAZIONE DELLE REGOLE
IN STRUTTURE E COMBINAZIONI COMPLESSE
- Completamento con i funzionali
2.5-5.1
LINGUISTICA
Proprietà dei codici verbali:
Andrè Martinet (Saint-Alban-desVillards, 12 aprile 1908 – ChâtenayMalabry, 16 luglio 1999)
Last but not least
Doppia articolazione
Due livelli strutturali delle lingue
Primo livello : unità dotate di significato
Secondo livello: unità prive di significato
Il direttore mangia un panino
Il / dirett/ore mangi/a /un / panino
I/l d/i/r/e/t/t/o/r/e/ m/a/n/g/i/a/ u/n/ p/a/n/i/n/o/
Fonetica e Fonologia
• Fonetica > studio sistematico del suono.
Può essere articolatoria, acustica, uditiva
• Fonologia > studio dei fonemi, cioè della
valenza distintiva che i suoni assumono
all’interno dei sistemi linguistici
La fonetica
La fonetica è la disciplina della linguistica che tratta la componente fisica della
comunicazione verbale
La fonetica si suddistingue in tre campi principali
Fonetica articolatoria, che studia i suoni del linguaggio in base al modo
vengono articolati
Fonetica acustica, che studia i suoni del linguaggio in base alla loro
consistenza fisica e modalità di trasmissione
Fonetica uditiva, che studia i suoni del linguaggio in base al modo in cui
vengono percepiti
in cui
Fonetica articolatoria
• La fonetica articolatoria studia i suoni di una lingua e i
meccanismi che accompagnano la loro produzione
attraverso l'apparato fonatorio. Descrive gli organi che
sono coinvolti nella emissione dei suoni e come bocca,
naso o gola producano i differenti foni...
•
Un simbolo fonetico è un segno convenzionale usato per
significare la descrizione articolatoria di un suono, nonché
una sua approssimata collocazione in determinate classi
detti foni, dal momento che nessuno è in grado di
riprodurre due volte lo stesso identico suono. I simboli più
utilizzati sono quelli dell'AFI, l'Associazione fonetica
internazionale, conosciuta anche come IPA (International
Phonetic Association, it AFI)
Fonetica: l’apparato fonatorio
La classificazione dei suoni dei
linguaggio
Parametri di identificazione dei suoni del linguaggio
1. il LUOGO in cui viene articolato un suono
2. il MODO in cui viene articolato un suono (e il
contributo della
all'articolazione dei suoni)
3. la presenza/assenza di VIBRAZIONE DELLE
CORDE VOCALI
MOBILITÀ DEI SINGOLI ORGANI
La classificazione dei suoni dei
linguaggio
Possiamo individuare, in base ai parametri suddetti, due grandi
opposizioni di suoni
VOCALI, cioè i suoni prodotti senza
frapposizione di ostacoli al flusso d'aria
CONSONANTI, i suoni prodotti mediante la
frapposizione di un ostacolo
SONORI, cioè i suoni prodotti con la
vibrazione delle corde vocali
SORDI, i suoni prodotti senza vibrazione delle
corde vocali
Livelli di analisi. Elementi di fonologia: Fonemi
della lingua italiana
Le consonanti
In base al modo di articolazione del suono, le consonanti si possono classificare in
OCCLUSIVE
FRICATIVE
APPROSSIMANTI
AFFRICATE
LATERALI
VIBRANTI
NASALI
(FORTI)
(ASPIRATE)
Le consonanti
In base al luogo di articolazione del suono, le consonanti si possono classificare in
BILABIALI
LABIO-DENTALI
DENTALI
ALVEOLARI
PALATALI
VELARI
UVULARI
FARINGALI
GLOTTIDALI
Le vocali
I parametri fondamentali di classificazione delle vocali sono
1. la posizione della lingua
avanzamento o arretramento
ANTERIORI
POSTERIORI
CENTRALI
innalzamento o abbassamento
ALTE
MEDIE
BASSE
La posizione in cui vengono articolate le vocali, secondo il
duplice asse orizzontale e
verticale, può essere
rappresentato in uno schema, detto TRAPEZIO
VOCALICO
Le vocali
2. la posizione delle labbra
protrusione
ARROTONDATE O LABIALIZZATE
distensione
NON ARROTONDATE O NON LABIALIZZATE
3. il passaggio dell'aria nella cavità nasale
NASALI
Le semivocali
Le semivocali appartengono alla categoria delle
approssimanti, cioè suoni
con un modo di articolazione fra
vocali e consonanti fricative
Le semivocali si possono distinguere in
ANTERIORI
POSTERIORI
La fonologia
La fonologia studia l'organizzazione e il funzionamento dei suoni nel
sistema linguistico, a partire dalle proprie unità minime, dette fonemi
Il FONEMA rappresenta → l'unità minima di seconda articolazione del
sistema linguistico
→ una classe astratta di foni, dotata di valore
distintivo, cioè tale da opporre una
parola ad un'altra in una data lingua
La trascrizione dei fonemi è detta fonematica
La sillaba
DEFINIZIONE: le minime combinazioni di fonemi che funzionano come unità pronunciabili
per costruire la forma fonica delle parole sono dette SILLABE
STRUTTURA: in italiano e nella maggioranza delle lingue le sillabe sono costruite
attorno a una vocale, che ne costituisce il nucleo; la parte che precede la vocale è detta
attacco, la parte che eventualmente segue la vocale prende il nome di coda
10. Dalla parola ai tratti distintivi
• Riassumendo:
51
Graffi, Scalise - Le lingue e il
linguaggio - Il Mulino, 2006
Fonetica acustica
• La fonetica acustica si occupa della trasmissione
dei suoni nello spazio attraverso le onde sonore.
Per rilevarne le caratteristiche si utilizzano il
sonografo, o spettografo, e gli spettrogrammi con
esso prodotti: con questi strumenti si possono
identificare determinate bande chiamate formanti.
• Inoltre si sono analizzate le onde sonore per capire
quali siano le frequenze che contengono i dati
fondamentali, necessari e sufficienti per
identificare i suoni delle varie lingue.
Il suono come evento fisico
• Il suono si determina quando una sorgente entra in vibrazione,
generando onde di compressione e rarefazione dell’aria.
• Se ne possono studiare le caratteristiche fisiche (frequenza,
ampiezza,…) in diagrammi quali le forme d’onda, gli spettrogrammi,
ecc.
Il suono è una sequenza di compressioni e rarefazioni di un
mezzo elastico generate dalle oscillazioni delle particelle che
compongono il mezzo attorno alla loro posizione di riposo
Ogni corpo che venga posto in vibrazione in un
mezzo che non sia il vuoto genera un suono
• Tale vibrazione, propagatasi nell’aria o in un altro
mezzo elastico, raggiunge l'orecchio umano che,
tramite un complesso meccanismo interno, è
responsabile della creazione di una sensazione
“uditiva” direttamente correlata alla natura della
vibrazione.
• Per descrivere da un punto di vista
matematico un suono puro con una
determinata tonalità e per illustrare la
variazione della pressione sonora che avviene
in una posizione specifica (ad es. al timpano)si
ricorre alla funzione matematico seno (SEN)
La funzione del seno
descrive come la pressione
tende a cambiare nel
tempo, rispetto ad una
posizione precisa.
• La parte della funzione che si trova sopra l’asse delle X
corrisponde alla condensazione delle molecole dell’aria,
• La parte inferiore corrisponde alla rarefazione.
Caratteri fondamentali del suono
•
•
•
•
Durata
Altezza
Intensità
Timbro
Lunghezza d’onda
• È la distanza tra le ripetizioni di uno stesso
schema sonoro (es. distanza tra i due picchi di
un’onda)
• È espressa dalla lettera greca lambda “λ” ed è
misurata in metri
• Nell’aria, ad esempio, un tono basso può
avere una λ d’onda di alcuni metri, mentre
uno acuto di pochi centrimetri
Frequenza
• Indica quante volte in un secondo si ripete lo
schema o la forma d’onda
• Viene misurata in Hertz (Hz), ossia
cicli/secondo
• Le frequenze più basse e più alte percepibili
dall’orecchio umano come suoni, sono situate
tra i 20 Hz ed i 20000 Hz (20 kHz)
Altezza di un suono:
L’uomo percepisce come suono solo vibrazioni
comprese tra 16 e 20.000 Hz = campo uditivo
normale per un normoudente adulto
• Altezza di un suono:
Dipende dalla frequenza della vibrazione che lo
produce, ossia dal numero delle vibrazioni al
secondo
Ampiezza
• È l’oscillazione o lo spostamento massimo
registrato dalla funzione seno
• Esprime la grandezza delle variazioni di
pressione prodotte dalla condensazione e
dalla rarefazione delle molecole dell’aria,
rispetto alla sua normale pressione
• Rappresenta la pressione sonora dell’onda
• Due forme sinusoidali d’onda, identiche in
lunghezza e frequenza, ma che variano in
ampiezza, rappresentano due valori di
pressione sonora diversi
• più grande è l’ampiezza, maggiore è la
pressione sonora
• Intensità di un suono:
E’ costituita dall’energia cinetica posseduta in quel
punto dalle particelle del mezzo che vibrano. È
rappresentata dall’ampiezza del moto vibratorio. Ci
consente di distinguere tra suoni deboli e suoni forti.
L’ampiezza è una grandezza fisica oggettiva e,pertanto,
misurabile; mentre l’intensità è l’entità della
sensazione acustica.
Intensità di un suono ed ampiezza:
• Le due grandezze sono collegate da un rapporto
determinato, ma non sono sovrapponibili.
• Al fine di interpretare il complesso rapporto stimolosensazione si è ricorso alla determinazione della soglia
differenziale, cioè il minimo aumento della sensazione
apprezzabile che si realizzi per un aumento dello stimolo.
• Il rapporto tra ampiezza di un suono ed intensità raccolta a
livello di sensazione nell’orecchio è un rapporto di tipo
logaritmico = l’energia sonora cresce con progressione
geometrica, l’intensità della sensazione con progressione
aritmetica.
Energia sonora
Intensità
1 10 100 1.000 10.000
1 2 3
4
5
COME SI MISURA IL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA?
• LA Pressione è la forza esercitata rispetto ad
una determinata area e si esprime in Pascal
(Pa)
• Poiché in acustica i valori numeri sono molto
bassi, la Pressione sonora si misura in
micropascal (μPa)
Esempio:
20 μPa = 0,00002 Pa
Pressione Atmosferica= 100.000 Pa
20 μPa-------------20.000.000 μPa
• 20 μPa è la pressione sonore minima che può
essere udita dall’orecchio umano, quando il
suono è costituito da un tono puro con
frequenza di circa 2000 Hz
• Quando un suono diventa insopportabilmente
forte, nella scala dell’intensità, la pressione
sonora è di 20.000.000 μPa (1 milione di volte
più grande rispetto al suono più debole
udibile)
• Variazioni di pressione sonora particolarmente
grandi rendono difficile utilizzare i micropascal
come unità di misura
• Si è reso necessario stabilire un’unità di misura
che descrivesse con più semplicità i livelli di
Pressione sonora che l’orecchio umano
percepisce = il decibel (dB)
Decibel
• Indica la differenza tra due pressioni sonore
Pressione sonora in decibel = Pressione sonora attuale
Pres. sonora di riferimento
Poiché quella in decibel è una scala logaritmica, la
grande differenza tra 20 e 20.000.000 μPa viene
convertita nel valore più agevole di 120 decibel
Decibel
Unità di misura relativa e non assoluta, esprimendo solo
un rapporto tra due diversi valori di intensità
dB = 20 * log10 (p/p0)
Dove p0 è una costante che grosso modo corrisponde al valore di
pressione di un suono della frequenza di 1000 Hz appena percepibile
da un essere umano normoudente
p0 = 20 * 10-6 Pa
= 0,000020 Pa
Il decibel quindi misura una amplificazione o una attenuazione
rispetto ad un valore di base e mai uno specifico livello di energia.
• La sigla dB SPL indica il livello di pressione del
suono, ossia di quanti decibel esso supera la
pressione di riferimento di 20 μPa
• I livelli di pressione sonora vengono calcolati
con un misuratore apposito, il fonometro
• I livelli di pressione sonora dei suoni
ambientali si trovano in una scala che va da 0
dB SPL fino a 120-140 dB SPL
SEGNALI SONORI COMPLESSI
• Nell’ambiente in cui viviamo quotidianamente
i suoni puri sono molto rari, mentre sono
frequenti quelli complessi (es. persona che
parla, motore di un’auto)
• Il matematico francese Jean Baptiste Joseph
Fourier ha scoperto che ogni suono complesso
può essere in realtà considerato come un
insieme di suoni puri.
• Fourier inventò un’operazione matematica per
determinare le componenti frequenziali che
formano un suono complesso, detta
Trasformata Rapida di Fourier o Analisi
Spettrale
• I suoni complessi sono raggruppati in due
categorie:
– Suoni periodici
– Suoni aperiodici
Suono periodico
• Una oscillazione è periodica
se il suo moto, ad ogni
intervallo di tempo, presenta
le stesse caratteristiche.
Il moto periodico semplice produce un suono puro.
• Questo tipo di suono non esiste in natura, dove qualsiasi
vibrazione acustica è costituita dalla sovrapposizione di un
suono puro con un certo numero di altri suoni semplici. Ne
risulta una vibrazione complessa, somma di oscillazioni
semplici.
• Tra le vibrazioni componenti il suono complesso ve n’è una che
si caratterizza per la massima ampiezza e identica frequenza
della vibrazione complessa: vibrazione fondamentale!
• Le altre oscillazioni componenti hanno
abitualmente ampiezza minore e frequenza
multipla della fondamentale (2n, 3n, 4n, etc.)
e si chiamano vibrazioni armoniche
• Timbro di un suono:
È l’elemento caratteristico di quel suono che consente di
differenziarlo da altri suoni aventi la stessa frequenza ed
intensità.
Dipende dal numero e dalla qualità delle armoniche che
accompagnano il suono fondamentale.
Es. DO di un clarino da quello emesso da un altro strumento.
SUONI APERIODICI
• Altri suoni complessi, detti aperiodici,
possiedono uno schema d’onda che non si
ripete: lunghezza e forma cambiano nel
tempo.
• Es. sbattere di una porta
• La componente spettrale dei suoni aperiodici
può essere determinata attraverso l’analisi
spettrale.
SEGNALE DEL PARLATO
• Il parlato è formato da suoni quasi periodici o
aperiodici tra loro collegati
• Alcuni suoni del parlato si formano nella gola
(gutturali e sonori), altri si formano quando
l’aria passa attraverso spazi stretti come le
labbra
• Quando una persona parla, i suoi organo fonoarticolatori mutano costantemente posizione.
• Ne consegue anche un cambiamento anche
della risonanza nella cavità orale, con
produzione di una diversa “articolazione”
Intensity
Spectrum of glottal pulse
Frequency (Hz)
Harmonics of spectrum spaced at 80 Hz, corresponding to
pitch period of 12.5ms.
MECCANISMO DELLA
ARTICOLAZIONE
Gli spazi della cavità di risonanza
posseggono, a seconda della loro
configurazione momentanea,
determinate frequenze naturali, che si
formano quando l’aria entra in
oscillazione in questi spazi.
Queste frequenze si uniscono a quelle
prodotte dalle ccvv, rendendo la voce
udibile.
Intensity
Spectrum of glottal pulse
filtered by the vocal tract
Frequency (Hz)
Harmonics of spectrum spaced at 80 Hz, corresponding to
pitch period of 12.5ms.
Vowel /ar/
as in car
front, low, unrounded
Vowel /ee/
as in feet
High, front,spread
Vowel /uu/
as in rude
High, back, rounded
Fonetica uditiva
• La fonetica uditiva è probabilmente il settore della
fonetica a tutt'oggi meno esplorato e tratta di
come i suoni linguistici vengano recepiti
dall’apparto uditivo umano: per questo studia in
particolare come funziona il canale uditivo.