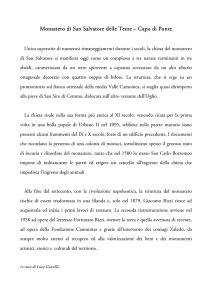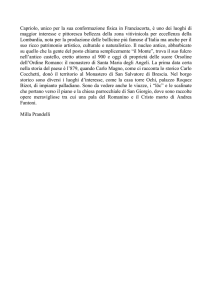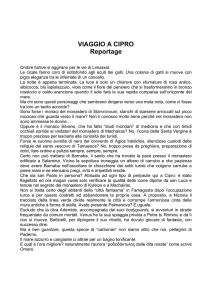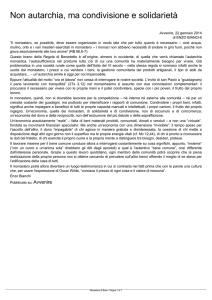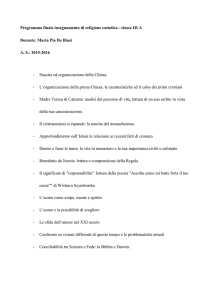28 gennaio 2009
Appunti per il 2° Corso di Formazione su San Pietro al Monte
1° incontro: l’ambiente e la storia
Relatore Carlo Castagna
1. I primi abitatori.
Liguri
Oltre tre mila anni fa, i Liguri, una popolazione di cui ci parlano diversi autori latini,
descrivendoli in modo a volte anche contraddittorio, furono i primi ad insediarsi sul nostro
territorio. Tito Livio li descrive come gente indomita, rude e fiera, in lotta con le belve e gli
elementi naturali, che viveva di caccia e di pastorizia, ma anche di un po’ d’agricoltura
sulle pendici degli Appennini e delle Prealpi. Abili artigiani della pietra, riuscivano a
preparare stupende asce di pietra, levigate con straordinaria perizia, così affilate che
permettevano di abbattere i grandi faggi dei boschi montani. Cominciarono ad usare i
metalli, soprattutto il bronzo, solo verso il 600 a.C. Coltivavano il lino e l’orzo, il melo, il
nocciolo e il castagno. Non erano conquistatori e le tribù vivevano isolate le una dalle altre
in piccoli villaggi posti presso sorgenti e vie frequentate. Il capo villaggio convocava dei
conciliabula dei capi delle famiglie, riunite in clan autonomi, in un campo di riunione. Era
lui che presiedeva anche i riti religiosi in particolari luoghi di culto.
Chi è di Civate non può non conoscere il buco della sabbia, o sapere che resti della
presenza dei Liguri sono stati ritrovati in cima alla montagna sul prato della colma. Mentre
su quel prato sotto la cima del Cornizzolo, di cui parla nella sua opera anche Plinio il
Vecchio chiamandolo monte Pedale, sono stati ritrovati semplicemente dei reperti litici,
come punte di lance e frecce e qualche piccolo utensile, il buco della sabbia è senza
dubbio la testimonianza più viva di un’epoca passata, inserita ancora nell’ambiente
naturale che l’ha vista nascere nel periodo eneolitico, cioè nell’età del bronzo. La grotta,
originariamente usata come grotta funeraria, si compone di tre ambienti successivi, non
tanto ampi, di cui l’ultimo fornito di un camino verticale di ventilazione che fuoriesce nella
roccia soprastante. Abbarbicata sulla impervia roccia a strapiombo prospiciente il lago
d’Annone in cui si specchia, fu utilizzata praticamente fino all’esaurirsi dell’insediamento
romano.
Il buco della sabbia , scoperto dagli studiosi d’archeologia solo poco più di cinquant’anni or
sono, ma ben noto da tempo immemore agli abitanti di Civate, è stato sinora considerato
un elemento isolato ed anomalo, quasi un mistero affascinante ancora da spiegare nella
sua unicità. Tuttavia, qualche ipotesi più complessiva si può azzardare se si considera il
buco della sabbia non come un singolo elemento, ma parte di un complesso più ampio.
Per fare questo occorre completare la conoscenza delle tracce rimaste d’una età tanto
lontana, aggiungendovi pure alcuni aspetti sinora ancora inesplorati. Risalendo infatti la
stessa costa montagna, sul sentiero quasi in disuso che s’arrampica impervio e dritto sul
crinale, tra quello di Linate e quello principale per San Pietro al Monte, dirigendosi verso le
corde, si incontrano, una trentina di metri prima dello stesso punto di riferimento da cui il
luogo prendono il nome le corde, una coppia di steli tozze e massicce. Esse costituiscono
una specie di rozzo portale che introduce il viandante al poggio soprastante su cui, nei
secoli più recenti, sono stati appunto collocati i tralicci a sostegno delle funi d’acciaio,
utilizzate dai contadini al momento della fienagione e del taglio dei boschi. Lo spiazzo
stesso, invidiabile punto d’osservazione e di vedetta ( e posto ideale per costruirvi un
altare), domina un paesaggio stupendo affacciato sui due bacini lacustri, oggi quasi
completamente divisi dalla penisola di Isella: il lago d’Oggiono e quello d’Annone. A destra
dello stesso poggio delle corde, attraverso altre due più massicce ed importanti steli
1
litiche, di cui quella di destra probabilmente naturale, si accede ad un piacevole pianoro
riparato, denominato prato rossino. Questo è uno spazio ampio e circolare, racchiuso a
difesa fra basse muraglie di pietrame. Il luogo, che forma una piacevole conca erbosa
irregolare, era ideale per la collocazione di un piccolo insediamento umano di capanne in
legno e paglia o di casotte. Questi tipici e rozzi ripari in pietra, costruiti a secco e per lo più
ricoperti da uno strato impermeabile di zolle erbose, sono stati imitati per millenni nella loro
struttura architettonica, come nell’uso funzionale, ed ancora sono presenti qua e là sui
pendii della nostra montagna. Le steli d’ingresso, grossolanamente ma evidentemente
sbozzate dall’uomo, potrebbero introdurre qui anche in un luogo sacro, riservato a
particolari cerimonie religiose, appunto come in uso presso i Liguri. Strordinaria infatti è la
posizione stessa delle due diverse coppie di steli. Rispetto all’insediamento di prato
rossino, le prime, a livello inferiore, sono rivolte ad est, cioè verso il sole nascente (natalis
solis). Quelle d’ingresso all’insediamento vero e proprio sono volte invece volte al sole di
mezzogiorno. Ancor più sorpendente è infine costatare che una coppia identica di steli, a
completamento della triade, si trova come portale d’accesso alla zona del buco della
sabbia, già ricordato nella sua funzione originale di grotta funeraria. Esse sono rivolte ad
occidente, verso il sole morente. Allo stesso luogo si giunge facilmente da prato rossino
attraverso un sentiero diretto ancora oggi praticabile. Tutto ciò cosa potrebbe significare?
Nella dimensione di un primitivo culto solare, l’interpretazione immediata della simbologia
richiama, proprio nella particolare collocazione e configurazione dei manufatti e dello
spazio centrale di prato rossino, la celebrazione dei tre momenti fondamentali della vita:
ad oriente la nascita, volta all’immagine del sole nascente; a meridione la maturità come
pienezza dell’esistenza, nel mezzogiorno solare; ad occidente la morte, cui è destinato
ogni essere vivente, nel tramonto solare.
Celti
I Celti, chiamati dai romani Galli e dai greci Galati, sostanzialmente identificabili con le
tribù galliche, appartengono ad una comune famiglia linguistica indoeuropea ed estesero
la loro influenza su quasi tutta l’Europa occidentale. Apparvero per la prima volta durante il
secondo millennio tra l’attuale Baviera e la Boemia. Nel primo millennio si diffusero dalla
Spagna alle isole britanniche ed al nord d’Italia, ma giunsero fino in Asia Minore. Abili
lavoratori del ferro, cui si deve la loro forte espansione, controllavano le principali vie di
comunicazione europee sul Danubio, il Reno ed il Rodano. Nel 380 a.C. si spinsero sino a
saccheggiare Roma. Si stanziarono in Italia verso il V sec. a.C. Quanto al nostro territorio,
i Celti non solo hanno dato la denominazione all’intera Brianza, dal termine brigantia, forse
per luogo elevato, ma, tra tanti altri, pure Leuki , tribù celtica che ai tempi di Cesare era
insediata in Francia, oppure dal termine indoeuropeo locas, lucus, lucos per indicare
campo/paese, per Lecco, Laus per Lodi e soprattutto hanno utilizzato la radice barros, cui
qualche studioso da il significato di cespuglieto, mentre altri la interpretano nella sua
riduzione tematica di bar o ber, come altura o recinto. Di fatto, alla radice tematica più
semplice sono legati sul territorio civatese nomi ben noti, anche se senza dubbio
trasformati e fatti propri in epoca romana, come quelli di Bar, monte Barro, Barzegutta,
Baroncello… E’ indubbiamente ai Celti che si deve far risalire il vero e proprio inizio
dell’insediamento abitativo di Civate, con l’occupazione del territorio ai piedi del
Cornizzolo, dove si colloca oggi. Alla ricerca di un luogo protetto ed adatto
all’insediamento umano, questo è certo, uno sparuto gruppo di guerrieri-agricoltori Celti,
un piccolo clan di pochi individui, parenti legati strettamente dai vincoli del sangue, ha
scelto quella che oggi è la frazione di Tozio come insediamento primitivo. Purtroppo non
sono stati mai ritrovati, o meglio, non sono mai stati conservati reperti di origine celtica
ritrovati nel territorio di Civate.
2
Romani
I romani, nel 196 a.C., pensarono bene di impadronirsi della Gallia Cisalpina, un territorio
che si estendeva dalla pianura del Po sino alle Alpi, facendo riferimento a quella capitale
che si sarebbe poi chiamata per sempre Mediolanum. I nuovi conquistatori ebbero un bel
da fare per insediarsi ed imporre la loro supremazia, ma gradualmente estesero un rigido
controllo su tutta la vasta regione, imponendo da dominatori il pagamento dei tributi. E dal
momento che questi non consistevano in denaro, ma in prodotti freschi o disseccati della
terra, soprattutto in granaglie che erano meno facilmente deperibili, i luoghi di raccolta e
conservazione erano collocati normalmente vicino alle zone agricole di produzione, difesi
naturalmente da guarnigioni o luoghi di controllo militare che ne provvedessero la
custodia.
La presenza stessa dei romani dunque, significò la riorganizzazione del territorio e la
costituzione di un sistema difensivo che proteggesse i territori collinari e della pianura da
eventuali incursioni od invasioni provenienti dalle Alpi. Tuttavia i romani non amavano
insediarsi direttamente sulle montagne. Per questo sfruttarono le barriere naturali e le
difese costituite dalle caratteristiche del territorio. La catena montuosa e l’estensione del
Lario offrivano qui la configurazione ideale per la collocazione di una linea difensiva
settentrionale di tutto il territorio brianteo ed oltre. Ai piedi delle alture, i centri fortificati
della zona comprendevano il Castrum Leucum, l’attuale Lecco, Castelmarte, vicino ad
Erba, Comum, che era anche porto della flotta lacuale, l’Isola Comacina e Castelseprio,
sotto Varese. Questi centri maggiori a loro volta erano tenuti in collegamento con un
sistema di segnalazioni luminose provenienti da fortilizi minori, dislocati a triangolo a
mezza costa sui monti. Le guarnigioni, composte da uno sparuto gruppo di soldati,
svolgevano prevalentemente funzioni di vedetta e appunto di segnalazione.
Accanto a questi esigui posti di guardia, sorgevano anche piccole edicole per il culto delle
divinità, riservate perlopiù ai soldati, che l’avvento del cristianesimo, in periodo più tardo,
trasformerà in edifici di culto cristiano. Nella zona che interessa la vallata che dal lago
d’Annone conduce al Lario sono dunque ancora individuabili, con questa origine, San
Tommaso sul Corno Birone, la chiesetta di Santa Maria sul Barro, il dosso della guardia
sul Cornizzolo e il più conosciuto Campanone della Brianza sotto il monte Genesio… Il
sistema così congegnato, semplice nella sua struttura, ma efficace nei suoi effetti,
permetteva una trasmissione relativamente veloce, anche se sintetica ed essenziale, delle
notizie dal Castello di Santo Stefano a Lecco, sino alla fortezza edificata presso Santa
Maria di Castelseprio. Il centro militare più importante della zona più prossima era
indubbiamente il Castrum Leucum, che controllava unitamente l’imbocco della Valsassina
ed i passaggi lungo l’Adda verso sud, avendo ad occidente, al di là del fiume, la
Valmadrera. Attraverso questa valle naturale una via conduceva, lungo l’attuale Rio Torto,
in prossimità del lago d’Annone, contornato ancora, come testimonia già Plinio il Vecchio
nella sua Naturalis historia, da estese ed infide paludi. Qui la strada incrociava la ben nota
ed importante arteria che dal III secolo d.C. collegava Aquileia a Como. Immaginandola,
non si deve pensare certo ad una via lastricata come la Flaminia o la Cassia, ma ad una
semplice glarea strata, cioè ad una strada caratterizzata da un fondo predisposto con
cura, ma ricoperto di semplice ghiaia. Essa dapprima, superato l’Adda presso Olginate,
con un ponte di cui rimane ancora traccia, saliva all’attuale sella di Galbiate, per poi
discendere al lago e da qui, scavalcato facilmente il piccolo emissario lacustre, risaliva la
collina ora di Civate per continuare a mezzacosta, evitando gli insidiosi acquitrini, verso
Como.
Dallo stesso sperone del monte Cornizzolo, allora chiamato Pedale, una strada si
diramava invece per Annone attraverso l’originaria insula, Isella, collegata alla terraferma
da due manufatti: uno, di più sicura e probabilmente molto più antica fattura, si trovava nel
primo tratto che costituisce ancora l’odierno collegamento con l’agglomerato urbano
3
civatese sulla collina; l’altro, una specie di lungo pontile, longus pons, in pietrisco e
legname, si snodava fra l’estrema propaggine della penisola e la stessa Annona, luogo di
raccolta delle granaglie e quindi ideale per il pagamento in natura delle imposte.Tale
delicata microrete di collegamenti ed accumulo di viveri, evidentemente richiedeva una
protezione militare sicura ben più prossima del semplice castello di Lecco, fortezza di
confine. Erano pertanto presenti le già ricordate fortificazioni minori sul Barro, come sul
Pedale e nella stessa Isella a controllo del passaggio obbligato, collegate con il resto delle
roccaforti principali della linea confinaria.
Proprio il passaggio obbligato all’incrocio con la via proveniente da Aquileia, là dove un
piccolo ponte varcava il Rio Torto, assegnava invece, naturalmente, la denominazione di
Clavis alla stessa località minore. Infatti, così come in altri punti di controllo ai piedi delle
Alpi o nelle vallate prealpine si trovano i cosiddetti punti chiusi fortificati, come ricordano
ad esempio Valchiusa, Le Chiuse di Susa, Chiusa presso Bressanone o la più vicina
Chiuso, nei pressi di Lecco, a questa confluenza i romani avevano assegnato l’attribuzione
di clavis, ossia chiave, per indicarne il senso necessitato e determinato del transito.
Toccherà in seguito ai Longobardi variare la voce latina in Clavate, da cui Ciavate o
Ciauate per arrivare all’odierna Civate, il borgo strategicamente edificato sulla collina. Ciò
che importa dunque, è che i romani, presenti con forze massicce nel castello di Lecco,
fossero anche stanziati nel punto chiave di passaggio, laddove sorgevano il ponte sul Rio
Torto e un piccolo luogo di culto, che da quasi due millenni è denominato la Santa.Nello
stesso luogo, sulla originaria clavis romana, quasi dimenticato, sorge infatti ancora
l’oratorio di S. Nazaro e Celso, santi soldati, non unico ed ultimo indizio della presenza
dell’antica postazione militare romana. In verità, anche l’oratorio, come la località, continua
ad essere più comunemente chiamato dagli abitanti la Santa. Ed il termine deriva
dall’appellativo latino sancta, che già i soldati romani della guarnigione assegnavano per
antonomasia alla loro divinità agricola, Cerere, che qui aveva sostituito la dea gallica
protettrice dell’agricoltura, venerata dai Celti. Fin qui, già si sono richiamati in alcuni
toponimi assegnati a località come clavis, sancta, annona, castrum, i segni della presenza
romana. Altri appellativi di località conservano ancora traccia di questa origine e
pervengono dai nomi propri romani o derivati dalla fusione di sostantivi celti e romani nelle
località circostanti, come: mons Pedalis, mons Baronis, barsecuta, caribiolum, vallis deae
orum e silva Diana, cioè, per riferirci solo a quest’ultima, la zona boschiva posta tra la
parte orientale del lago, la collina su cui sorge Civate e la stessa clavis. San Pietro al
Monte sorge proprio nella vallis deae orum e, per quanto concedono di ipotizzare gli indizi,
una sorgente doveva sgorgare sotto l’attuale chiesa, la cui cripta è dedicata a Maria. Gli
ultimi due toponimi, vallis deae orum e silva Diana, con la sancta, inducono a riflettere
sulla realtà non solo militare ed economica della vita della guarnigione qui stanziata e
senza dubbio della popolazione rurale circostante dell’epoca romana, ma anche sulla loro
sensibilità religiosa. E questo ci suggerisce che vi fossero evidentemente, e del resto sono
rimasti intatti quasi sino ai nostri giorni, delle sorgenti ed un bosco, dedicati come naturale
alla divinità delle fonti e della caccia. Inoltre, induce ad approfondire anche l’etimo
dell’estensione dei campi di fondo valle, aperti, coltivati e rigogliosi perché irrigati dalle
acque del fiume emissario e dei torrenti montani. La vallata, chiamata oggi Valmadrera,
nasce dalla contrazione successiva di Vallis Mater agraria, ossia inizialmente la dea
Cerere, affiancata e confusa spesso, in queste regioni limitrofe del dominio romano, con la
dea Cibele, protettrice dei campi e delle messi, oltre che degli animali. Qui, il culto
orientaleggiante di quest’ultima era andato maggiormente diffondendosi in tal senso in
tarda epoca imperiale con riti complessi di iniziazione. Nulla di strano dunque, che alla
dea, cui era dedicata la valle, gli abitanti e le truppe costruissero un tempietto rurale, dove
un tempo i progenitori Celti avevano già a loro volta dedicato un piccolo sacro edificio
all’antenata più antica della stessa Mater agraria, ossia alla triplice divinità nordica delle
4
Deae Matres. Gradualmente compaiono allora sul territorio le denominazioni di Clavis, poi
variato col suffisso in ‘ate’ in Clavate o Clauate, che già presente in epoca etrusca
continuò ad essere usato per secoli sino all’alto medioevo, di Sancta, Silva Diana, Vallis
Mater Agraria, poi Vallis M.agraria, Faël – Faëe…, Vallis Deae Orum, Mons Pedalen,
Barsecuta, Puteus, Caribiolum, Baroncellae, Boriminae, Isella, Linate…
La presenza romana sul territorio non aveva in ogni modo una finalità religiosa.
All’occupazione militare ed economica, già rilevata nei punti fortificati della Santa, di Isella,
di Annone, vanno aggiunte altre strutture militari di più tarda edificazione. E’ così che,
successivamente nel tempo, sorgono il fossatum (vallo di Isella), il castrum (Castello) e
una torre di controllo al di sopra dell’isola originaria, la Turris in Isellam, che ancora oggi
indica in dialetto il luogo della sua costruzione: Tur’niselö. Sulla montagna, le monete
romane rinvenute nel buco della sabbia, nei pressi del dosso della guardia, sono solo
alcune tracce involontariamente lasciate nei secoli dai soldati succedutisi nei turni di
guardia, che forse supplivano col gioco alla prolungata noia delle ore di riposo.
L’importanza di queste edificazioni ed il loro valore strategico sul territorio non si sono
tuttavia limitate al periodo assai lungo della presenza romana. La radicalità
dell’impostazione difensiva infatti e l’opportunità di sfruttarne le caratteristiche peculiari
sono state utili ai loro successori. Ne sono testimonianza l’occupazione, l’ampliamento e il
completamento di tali fortificazioni da parte dei Goti, dei Bizantini e dei Longobardi, attraverso opportune modifiche dettate dalle diverse esigenze e con la costituzione di speciali
distretti. Ne saranno testimonianza le fortificazioni gote sul Barro e la sala longobarda,
luogo di permanenza dei cavalieri armati detti arimanni, sotto Galbiate.
Goti
Alla caduta dell’impero romano infatti, nel 456, i Goti assunsero il compito di regnare sui
territori della penisola italica. La fine della loro dominazione ebbe fine al concludersi della
guerra gotica, conflitto combattuto fra gli stessi ed i bizantini. Questi ultimi, guidati dal
generale Belisario, occuparono la penisola e la capitale gota Ravenna, catturandone il re
Vitige nel 540. Il nuovo re dei Goti, Totila, riconquistò presto i domini perduti, ma Narsete,
succeduto a Belisario al comando dell’esercito dell’impero orientale, ebbe la meglio su di
lui e sul suo successore Teia e determinò la fine del regno goto in Italia. Anche sul nostro
territorio i Goti lasciarono tracce ancora oggi visibili del loro passaggio. La testimonianza
più evidente è la fortezza edificata sul monte Barro, i cui resti sono stati recentemente
riportati alla luce. La fortificazione stessa aveva lo scopo di aumentare il controllo sulla
zona del passaggi obbligato della Santa, dopo che alcune modifiche già operate nell’ultimo
periodo della dominazione romana ne avevano imposto l’esigenza.
La trasformazione tecnica relativa alla macinatura del grano infatti, passata prima dalla
semplice e rudimentale follatura alle molazze e molini a palmenti, tipici dell’era romana
avanzata, era pervenuta definitivamente alla macinatura con molino ad acqua, tecnica
senza dubbio meno faticosa e più redditizia, che permetteva di ottenere, con macine più
grandi, un prodotto senza dubbio migliore. Ciò aveva fatto perdere importanza ad Annone
come centro di raccolta della granaglie, non presentando la stessa località caratteristiche
idonee all’installazione dei mulini, mentre acquisiva sempre più un ruolo decisivo la località
immediatamente contigua alla stessa clavis romana, perché non solo da essa prendeva
inizio la fertile e agevole estensione della Vallis Mater agraria, il fondo valle più favorevole
alle coltivazioni, ma perché lì, allo sbocco dell’estuario del lago, era collocata la zona più
idonea alla costruzione ed al controllo dei mulini, essendo già preesistenti le antiche
strutture di controllo militare. Nulla di strano pertanto che già i Goti ponessero proprio al di
sopra di questa, sul Barro, una grande fortificazione da cui mantenere dall’alto un costante
controllo sulla posizione, certo meno difesa dalla natura di quanto lo fosse stata Annone,
col lago d’attorno e lo stretto passaggio obbligato di Isella. E non stupisce neppure che i
5
Longobardi, più tardi, costituissero l’agglomerato militare di Sala proprio nelle vicinanze e
ampliassero l’attigua Scarena, cioè il luogo di collocazione dei mulini, con l’aggiunta di un
torchio per le olive. Eppure, altri riferimenti sono visibili prima dell’arrivo dei Longobardi e
proprio sulla clavis.
Sebbene sia vero che il cristianesimo, durante l’ultimo rigurgito di vita dell’impero romano,
portasse la sua diffusione ben lontano da Roma, in città anche vicine alle sponde orientali
del Lario come Milano e la stessa Como, è altrettanto improbabile che nei pagi, i villaggi di
campagna, il nuovo annuncio religioso giungesse con convinzione e sollecitudine. E
neppure ci si deve illudere troppo che i Goti, pur con Teodorico ed i mausolei sfavillanti di
Ravenna, fossero stati più convinti e convincenti nella conversione di queste zone
prealpine. Ma i bizantini?
Bizantini
Meno visibili, tra le due presenze appena ricordate dei Goti e dei Longobardi, sono le
tracce della presenza bizantina sul territorio, almeno ad un primo frettoloso esame. In
effetti, gli emissari dell’impero d’oriente erano usi operare, per logica affinità storica e
culturale, nei modi e sulle strutture strategiche ed economiche, dove possibile, già proprie
dei romani. Eppure segni della loro permanenza compaiono, anche se in forme esteriori
meno eclatanti di quelle dei loro diretti predecessori e successori, presso la clavis.
Intanto, la presenza bizantina doveva aver assunto in Italia, nel periodo delle invasioni
barbariche, un senso ed una dimensione di vera e propria crociata in nome del ripristino
d’una civiltà, portata allo sbaraglio con crudeltà e ignoranza dai Goti, e che ormai si
identificava col cristianesimo. Quale doveva essere pertanto l’atteggiamento minimo,
immediato di questi restauratori, se non la sostituzione, senza alcun dubbio, dei simboli
barbari e pagani con simboli di civiltà cristiana e di fede? E dove avrebbe agito innanzi
tutto un crociato, moderatamente fervente perché uso ai contatti con le culture barbariche,
se non là dove permanevano le radici del culto di antiche religioni e superstizioni? Nulla di
strano dunque che soprattutto venissero pacificamente sostituiti i luoghi specifici di culto
pagano con edifici, simboli e santi cristiani che ne avessero le identiche caratteristiche e
rispondenze. Quindi, se qui non fu possibile ai bizantini, nella loro opera di
cristianizzazione, cancellare di fatto nomi come Silva Diana o Vallis Mater agraria, ormai
divenuti toponimi radicati, certamente essi si diedero da fare per sostituire, nel luogo
stesso della clavis, il tempietto rurale della Dea Mater, ormai comunemente chiamata solo
con l’appellativo di sancta e che già doveva aver a suo tempo supplito le divinità celtiche
del luogo, con un edificio cristiano dedicato non ad uno solo, ma addirittura a tre santi, che
rispettassero nel contempo i caratteri di protezione e propiziazione propri delle divinità
pagane, legandoli alle esigenze del territorio d’appartenenza: Mamete, Simone e Nazaro.
Solo pochi anni dopo dunque, al giungere delle prime avanguardie dei Longobardi nel 568,
la realtà del nostro territorio era caratterizzata dalla presenza di una serie di fortificazioni,
ma anche insediamenti, località e luoghi di culto cristiani.
Longobardi
I Longobardi giunsero in Italia entrandovi dalle regioni friulane. In pochi anni occuparono i
territori contesi ai Bizantini che, con tanta fatica e tante sanguinose battaglie li avevano
strappati alla dominazione dei Goti. Tuttavia i Bizantini rimasero un po’ più a lungo sul
nostro territorio, mantenendo alcuni punti militari strategici da cui procuravano guai ai
Longobardi. Come l’Isola Comacina, difesa per un ventennio e ceduta soltanto da
Francione, ex comandante dell’esercito bizantino, dopo ben sei mesi d’assedio posto dagli
ultimi invasori. D’origine guerriera, i nuovi arrivati non brillarono certo per la rapidità con
cui attivarono un ripristino dell’economia agricola o artigianale sul territorio squassato dalle
continue aggressioni alle postazioni militari di controllo, di cui facevano le spese, come
ovvio, il tessuto produttivo ed i suoi malcapitati operatori. E nonostante le iniziative di
6
recupero del territorio cui fanno riferimento le molte leggende legate alla regina
Teodolinda, cui si fa risalire anche quella fantastica della costruzione d’un castello e d’una
torre sul Monte di Brianza, dove sorge oggi il Campanone, i Longobardi sembrarono più
preoccupati di occupare gli insediamenti militari preesistenti lungo la linea difesa di confine
e di stabilire come e dove far pagare i tributi. Comparvero così gli insediamenti chiamati
Sala, che di fatto sostituivano i luoghi di raccolta e di difesa delle granaglie già romani e in
cui si stabilivano gli arimanni, cioè i cavalieri armati a protezione delle riserve alimentari. E
tutto si mantenne pressoché invariato se Burgundi e Franchi, che già insediavano questi
territori dal tempo della presenza bizantina, attesero ben due secoli e un re come Carlo
Magno per venirvi a fare una visita definitiva. O quasi. In effetti i Longobardi, seppur tardi,
ebbero un ruolo importante nella storia di Civate. E tutto ciò non si deve solo
all’importanza delle fortificazioni militari sul Barro ed agli eventi guerreschi in cui furono
coinvolte, ma anche a fattori di carattere religioso e culturale. E più precisamente
all’influenza dell’edificazione dei monasteri pedemontani, che in un periodo di due secoli
subì una espansione di non poca rilevanza. I monasteri, infatti, fungevano da punto di
riferimento d’acculturazione comune per la popolazione italica e longobarda, con la
diffusione dell’ormai condiviso messaggio cristiano, ed offrivano un contributo
organizzativo e diplomatico nei confronti dell’amministrazione locale e degli eventuali
confinanti. La conversione al cattolicesimo dei Longobardi, seppur scismatico, aveva
segnato una tappa fondamentale nei rapporti con le popolazioni italiche, insediate da
secoli, e la stessa Chiesa, come sottolinea con benevolenza lo stesso Gregorio Magno,
con il passaggio dall’arianesimo ad una dimensione di accettazione di fede cristiana. Da
essa nasceva l’intreccio tra il monachesimo di Non, con l’abate Secondo che assunse un
posto privilegiato alla corte longobarda e, in loco, la creazione di abbazie sparse nella
zona del centro ed alto Lario ad opera di Agrippino, monaco di Aquileia e legato alla
abbazia di Piona, roccaforte longobarda al confine con le terre dei Franchi, di S. Eufemia
sull’Isola Comacina, di Castelseprio e Castelmarte, capisaldi strategici contrapposti ai
Burgundi. L’elezione di Agrippino a vescovo di Como risale al 606. Tale monachesimo,
tuttavia, ha in seguito visto consolidarsi maggiormente, anche dopo il successivo
intervento dei Franchi, più il carattere e gli elementi della cultura transalpina che non il
prolungarsi di un legame lontano con l’humus costitutivo del cristianesimo romano o della
ortodossia orientale. E proprio il periodo del regno Longobardo in Italia, soprattutto la sua
ultima parte, è quello particolarmente significativo per la storia civatese, dal momento che
è in questo momento che sorge il monastero di San Pietro al Monte.
2. Le origini e l’alto medio evo
Origini
I documenti che parlano della prima costruzione di San Pietro al Monte di Civate non sono
contemporanei alla stessa e risalgono al basso medioevo. Essi divergono in relazione alle
varie datazioni. Tuttavia tutti rimarcano la fondazione longobarda del monastero,
affidandone l’idea della realizzazione a Desiderio, l’ultimo re longobardo. In effetti il duca di
Tuscia, Desiderio, succeduto ad Astolfo nel 756 con l’iniziale appoggio del papato,
sostenne quest’ultimo con la concessione alla Chiesa di alcuni territori dell’Esarcato, come
appartenenti al patrimonium Sancti Petri. Venuto successivamente in contrasto col papa
Stefano III, fu affrontato da Carlo Magno alle Chiuse di Susa nel 773. Definitivamente
sconfitto a Pavia l’anno successivo, fu rinchiuso nel monastero di Corbie, dove morì.
E’ dunque in questi brevi anni, fra il 756 ed il 774 che ebbe tempo di far sorgere il
monastero? E più precisamente nel 769, come è ricordato nella pergamena di un atto
giudiziario riguardante Andrea, abate del monastero nel 1018, che probabilmente doveva
saperne un po’ più di tutti coloro che ne scrissero successivamente? Il documento più
7
antico, ancora esistente, sulla realtà del monastero di san Pietro al Monte, riportato nel
Libri confraternitatum Sancti Galli, Augiensis, Fabariensis ( in Libri confraternitatum, ed.
PIPER in M:G:H:, Berolini 1884, p. 357), risale solo all’845, riferendosi al monastero
svizzero di Fabaria (Pfäffers). In esso si cita la comunità monacale di San Pietro al Monte
e si da l’elenco dei monaci presenti. L’assenza di un documento originale di fondazione ha
dato modo a diverse interpretazioni degli storici ed alla raccolta di numerosi documenti che
parlano della fondazione. Alcuni sono ripresi dalla sintesi cronologica presentata in
appendice a una serie di ipotesi di Giovanni Spinelli, pubblicata a p. 594 in Archivi di
Lecco, anno VII, 3, 1984. Le date riferite all’origine sono le seguenti:
a) 706 – maggio 10: un’antica iscrizione, ora scomparsa, che nel secolo XVII ancora si
leggeva su una parete della chiesa di S. Pietro al Monte diceva “ averla fabbricata Re
Desiderio alli 10 Maggio l’anno 706” ( Porter, III, p. 394, n. 12).“ Nel settecentosei Dino
abbate de Santo Pietro regnando Desiderio con suo figliuolo Algiesio nel regno d’Italia,
ordinò che si facesse la chiesa quale è quella di S. Pietro di Roma: quali tutte cose a
voi Padre Bartolomeo di S. Pietro in Chivate per gratia d’Iddio e della Santa Sede
Apostolica l’ho ridotte a memoria Umaine de Barzanore” ( Ms. del sec. XIV: Milano,
Biblioteca Trivulziana, cod. 2256: MAGISTRETTI, p. 333; PORTER, III, p. 394 n. 13).
b) 707 – giugno 29: “anno ab incarnatione VIICVII. Regnante christianissimo rege
Desiderio cum filio suo Aldeglixio,… Perfecto itaque opere, convocans rex Desiderius
omnes episcopos orthodoxos cum venerabili Thoma archiepiscopo, qui eo tempore
intronizatus erat in ecclesia Mediolani, deducens secum in montem Pedalem et
consecraverunt ecclesiam apostolicam, impositis in sacro altario eisdem reliquijs
apostolicis Petri et Pauli, in nativitate eorundem apostolorum, que est III° kalendas iulii
ad laudem et gloriam nostri Yhesu Christi” (Chronicha Mediolanensis (a. 606-1145)
secondo il MS. latino della Nazionale di Parigi 8315 ecc., ed. A:CINQUINI, Roma 1904.
Pp. 9-12: cfr. MARCORA, Gli stucchi di S. Pietro al Monte di Civate, Civate 1974, pp.
36-38). Si tratta di un manoscritto del sec. XIV.
c) 769 - “Beatus Thomas Mediolan. Arch. Xlviij anno Domini DCCLXVIIIJ.
d) 797 - sedit annis XXVIIJ. Isto tempore Desiderius fecit fieri Mon de Clavate, obijt anno
dni DCCLXXXXVIJ, quarto die ante kall. Octubris” (LAMPUGNANO DE LEGNANO,
Chronicon, Ms Ambr. T 56 Sup.: PORTER, III, p. 395 n. 17; cfr. anche SAVIO, La
“Chronica Archiepiscoporum Mediolanensium…”, p. 89: il medesimo testo è riportato in
forma assai scorretta da un apografo del sec. XV).
e) 770 – “Anno Dni 770. Desiderius rex Lombardorum fecit fieri monasterium S. Petri de
Clavate” ( Ms.mbr. S. Q + I. 12: PORTER, III. p. 394 n. 14 = Cod. Trivulziano 1218:
LEONIDA GRAZIOLI, La Cronica di Goffredo da Bussero, in “Archivio Storico
Lombardo”, XXXIII, 1906, vol. I, p. 234). Molte altre fonti riferiscono a Desiderio la
fondazione del monastero di Civate, senza però precisarne l’anno: cfr. PORTER, III, p.
396 nn. 22-26, dove tra l’altro Porter cita, fraintendendolo, il Chronicon di Jacopo
Malvezzi (IV, 89, ed. L.A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, XIV, Mediolani
1729, col. 848): “Hic (Desiderius) namque, ut a fide dignis percepi, Monasterium de
Giavate Mediolanensis Dioecesis condidit. In summa quoque alpe, quae ad urbe Brixia
distat
circiter
milliaria
XIV,
Monasterium
Sancti
Petri,
condidit”.
………………………………………………….
f) 780 – “A.D. 780. Desiderius rex fecit fieri monasterium sancti Vincenti et sancti Petri de
Clivate” (Annales Mediolanenses Minores). Medesima precisazione cronologica, ma
riferita esclusivamente a Civate si trova nel Chronicon maius di Galvano
Fiamma…………………………………………………………………………..
g) 800 – “Anno ad Incarnatione domini nostri Jhesu Christi DCCC vel circa Regnante
christianissimo rege Desiderio cum filio suo Aldegiso… nec non residente in sede
apostolica gloriosissimo papa Adriano… Perfecto itaque opere convocans rex
8
Desideius omnes episcopos orthodosos cum venerabili Thoma archiepiscopo qui eo
tempore intronizatus erat in ecclesia Mediolani deduxit secum in montem pedalem et
consecravit ecclesiam apostolicam impositis in sacro altari iisdem reliquis apostolicis
Petri et Pauli in nativitate eorum diem que scilicet III° Kalendas iulii ad laudem et
gloriam Domini nostri Jhesu Christi” (La leggenda di re Desiderio secondo il ms.T. 175
sup. fol. 16, ed. C. MARCORA, Il Messale di Civate, Civate 1957, pp. 62-67: cfr. il
medesimo testo nell’edizione del Cinquini, da noi riportato più sopra all’anno
707)…………………………………………….
h) 836 – “Monasterium sancti Vincenti fundavit Desiderius Longobardus rex; similiter et
monasterium sancti Petri de Clivate diocesis Mediolani anno Domini DCCCXXXVI”
(BENTIUS ALEXANDRINUS, De Mediolano civitate opusculum ex Chronico eiusdem
excerptum, ed. L.A. FERRAI, in “Bollettino dell’Istituto Storico Italiano”, 9 (1980), p. 33
………………………………………………………………………………………………
i) 844 – ottobre 14: Ramperto vescovo di Brescia è già morto, essendogli succeduto
Notingo, attestato a questa data. Prima di morire aveva chiesto al vescovo Aganone di
Bergamo un monaco che prendesse il posto di Leodegario al governo del monasteri
dei SS. Faustino e Giovita (Epistola Hagonis episcopi Bergomatis ad Rampertum
episcopum Brixianum, ed. M: LUPO, Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae
Bergomatis, I, Bergomi 1784, coll. 693-694 = ed. DÜMMLER, M.G.H., Epist., V,
Hannoverae 1899, p. 345).
Oltre a questi documenti esiste la famosa Cronica Danielis, di cui fu autore Galvano
Flamma, in cui si riporta la narrazione della leggenda del cinghiale, la successiva
edificazione della chiesa e la traslazione delle reliquie da Roma. La leggenda
evidentemente deve essere nata in un tempo successivo all’edificazione della chiesa di
San Pietro al Monte, forse addirittura quasi cent’anni dopo, quando, con solenni cerimonie
essa fu trasformata in basilica alla presenza di un imperatore. Tuttavia, anche in questo
momento le sue origini ebbero un significato importante. Pavia infatti, capitale del regno
longobardo, deve aver certo ispirato la dedicazione del monastero di Civate con la
presenza di San Pietro in Ciel d’Oro, le sue ricchezze ed il fascino che da essa poteva
venirne al popolo longobardo più della stessa cattedra dell’Apostolo. A tale dedicazione in
ogni modo non furono estranei altri elementi che caratterizzavano e sottolineavano la
religiosità del tempo.
Da una parte è possibile risalire all’importanza che già ai tempi di Gregorio Magno
assumevano la figura e le reliquie di San Pietro e Paolo cui era dedicata la chiesa, di cui
peraltro si ripete la narrazione nei racconti vari della fondazione e che divengono un
elemento comune di questi. Le reliquie diventano immediatamente, con i particolari
privilegi ed indulgenze, un motivo di richiamo e di ricchezza del monastero stesso. In
questi anni tuttavia, vari eventi storici si succedono, che lasciano il monastero ai margini
dell’attenzione. Ben presto, infatti, avviene il tracollo della dominazione Longobarda in
Italia. Il vincitore di Desiderio, Carlo Magno, assume su di sé il titolo di rex
Langabardorum, divenendo così, di fatto, il successore di Desiderio ed ereditando col titolo
regale anche tutti i suoi averi, tra cui San Pietro al Monte. Incoronato imperatore del Sacro
Romano Impero la notte di natale dell’800, Carlo Magno, coi suoi paladini, si preoccupa di
conquistare al cristianesimo i territori orientali germanici unificandoli alle terre d’Iberia. In
tali regioni Carlo favoriva la cultura diffusa dai monaci irlandesi ed anglosassoni, che dai
monasteri sorti qualche secolo prima ad opera di San Colombano ora riportavano in una
Europa distrutta l’eredità del sapere e della dottrina cristiana e latina, coltivando l’amore
per i testi antichi; amore assai raro nella barbarie dei primi secoli del medioevo. Essi
ponevano le basi delle future e famose biblioteche di Echternach, Bobbio, Fulda, San
Gallo, influenzando la produzione artistica carolingia, ottoniana e poi romanica.
L’imperatore faceva suoi ministri Alcuino da York, anglosassone monaco benedettino,
9
formatosi alla scuola di S. Agostino di Canterbury, e in seguito il vescovo Teodulfo, della
chiesa visigotica. Per interessamento degli stessi e sui disegni di Eginardo, architetto ed
orafo dell’imperatore, si sviluppò l’architettura carolingia che annovera la cappella palatina
di Aquisgrana (805), opera di Oddone di Metz, costruita sul modello di S. Vitale in
Ravenna, la basilica di Germigny-des-Prés (806), unico esempio francese del periodo.
L’intervento della corte palatina in quegli anni stabiliva la centralità del territorio renano,
legando in uno stretto rapporto di civiltà e di cultura varie città e monasteri che vedevano,
oltre ad Aquisgrana, la presenza di Colonia, Coblenza e Treviri, i centri di Magonza e
Fulda, Worms, Spira e Strasburgo, Reichenau, San Gallo e la vicina Coira, oltre il passo
alpino dello Spluga appena sopra il Lario. Di fatto tuttavia, l’imperatore quasi dimentica i
territori italiani, forse per evitare ingerenze politiche col papa. Tuttavia, l’influenza di Carlo
imperatore si ripercuoterà anche sulla basilica di San Pietro al Monte. Ecco come.
Era stato un monaco irlandese, Gallo, nel lontano 614, a dare origine all’omonimo
monastero. Nel 724, San Pirmino aveva fatto erigere la chiesa di Reichenau e nel 744 San
Bonifacio costruiva l’antica chiesa di Fulda. Nell’802 la chiesa di Fulda viene ricostruita,
per volontà di Carlo Magno, sotto l’abate Ruggiero, con l’aggiunta a quella originaria di
un’abside occidentale in cui riporre le spoglie del fondatore. La costruzione veniva
consacrata nell’819. A proposito di questa chiesa, la prima del suo genere nel periodo
carolingio, già nell’812 i monaci del monastero si erano dichiarati contrari alla ricostruzione
della stessa, supplicando Carlo Magno di far sospendere all’abate i lavori, perché “ le
costruzioni enormi e superflue, così come tutte le altre attività, affaticavano indebitamente i
monaci e sfinivano i servi”.
Del monastero di San Gallo rimane la planimetria su pergamena dell’820, forse redatta
dallo stesso Eginardo, architetto ed orafo di Carlo Magno. La chiesa, ad imitazione di
quella di Fulda, risulta biabsidata. Non solo. Ogni abside è occupata da un altare. Quello
orientale è dedicato a San Gallo e alla Vergine, quello occidentale a San Pietro. Mentre
sorgono le città palatine sul Reno, Colonia, Ingheleim, Worms, Magonza… vengono
dunque ricostruiti i monasteri tedeschi di Fulda e San Gallo sotto la sua direzione e con la
collaborazione di personaggi notevoli come Acuino da York ed Eginardo. Solo qualche
anno dopo, verso l’840, si ritorna a parlare in un documento del monastero di San Pietro al
Monte. E proprio in questo momento lo stesso monastero diviene un fulcro importante
della storia imperiale e monastica.
Lotario imperatore
Che il piccolo monastero collocato sul monte Pedale dovesse avere una grande storia,
nonostante la dimenticanza nella quale era vissuto per quasi un secolo, qualcuno avrebbe
voluto attribuirlo già ad un grande personaggio: Paolo Diacono. Tuttavia, anche se una
lapide posta sotto il pronao di San Pietro al Monte dà per certa la residenza momentanea
del grande storico longobardo a Civate, nessun documento ci da diretta testimonianza di
ciò, benché alcune sue opere, come il Carmen Larii, suggeriscano la sua permanenza su
questo territorio. Se comunque Paolo Diacono non soggiornò a Civate, lo fece per certo un
altro grande intellettuale, il Magister Hildemarus, sceso in Italia con un imperatore, Lotario,
figlio di Ludovico il Pio. E Lotario è un personaggio di rilievo fra gli imperatori carolingi e la
sua vicenda è strettamente legata alle vicissitudini politiche che interessarono l’impero alla
metà del IX secolo. Nipote di Carlo Magno, aveva raccolto, dopo la riconciliazione col
padre, le insegne imperiali e l’impegno di continuità nell’unificazione politico-religiosa di
tutti i territori del Sacro Romano Impero, ricevendo ad Ingelheim l’omaggio di Rabano
Mauro, abate di Fulda, e degli abati di San Gallo e Coira, abbazia limitrofa a Reichenau,
nell’840. Questo fatto scatenò l’ira dei fratelli che, coalizzatisi col Trattato di Strasburgo, lo
sconfissero e lo costrinsero a rifugiarsi in Italia. Egli dunque fuggì a sud delle Alpi,
10
portando al suo seguito Wolvinio, monaco benedettino suo architetto ed orafo, Wala,
abate di Corbie e due altri abati di origine franca: Leodegario ed Ildemaro.
Durante la fuga in un territorio a lui sconosciuto, Lotario dovette affidarsi all’ospitalità
offerta dai suoi alleati e risiedere nei suoi possedimenti imperiali, tra cui San Pietro al
Monte, nel periodo di trattativa con l’arcivescovo di Milano che allora era Angilberto II.
L’accordo di non belligeranza fu presto stipulato e l’imperatore non perse tempo per
riorganizzare sull’ex territorio longobardo ciò che già i suoi predecessori avevano fatto nei
territori franchi e germanici. Fu così che mentre Wala venne incaricato di fondare il
monastero di Bobbio sull’Appennino, i due abati franchi vennero incaricati, nell’841, di
attendere nientemeno che al riordino della Regola di San Benedetto da parte del grande
Angilberto. Quest’opera del Magister Hildemarus è di tale importanza che sarà diffusa in
tutti i monasteri benedettini d’Europa e fu senza dubbio una delle prime grandi opere dello
scriptorium del monastero civatese.
Col trattato di Verdun dell’843, il territorio lasciato all’imperatore, la Lotaringia, era stata
ridotta ad un lungo e stretto corridoio che dal mare germanico arrivava a comprendere il
regno d’Italia con le città imperiali di Aquisgrana, Treviri, Metz, Strasburgo, Colmar e
Basilea. Venivano esclusi i territori di Reichenau, con San Gallo e Ulma e le città dell’alto
Reno tra cui Ingelheim, Worms, Magonza e Fulda. Non stupisce che, privato di tali
ricchezze culturali e religiose, Lotario stimolasse un processo esaltante di costruzione,
rielaborazione ed arricchimento culturale che coinvolse non solo edifici già importanti
come Sant’Ambrogio in Milano, con la realizzazione dell’altare, ma anche la ricostruzione
dei monasteri-fortezza ai confini delle Alpi come San Pietro al Monte. Sarà meno difficile,
se si considera questo rapporto, capire come il ciborio di San Pietro al Monte sia
praticamente il gemello stilistico di quello ottoniano di Milano.
Ildemaro e Leodegario furono così impegnati nel progetto di ricostruzione della chiesa di
San Pietro al Monte che, con le preziose reliquie delle origini, le bolle ed i riconoscimenti
papali, era addirittura basilica. Dove tuttavia ritrovare le spoglie credibili del santo
fondatore? E chi era peraltro? Quel famoso Duro della leggenda forse?
In aiuto alla questione teologica e pratica vennero allora l’imperatore Lotario, affascinato
dalla basilica sul monte, e lo stesso arcivescovo Angilberto. La forza politica e religiosa dei
due consentì la traslazione delle reliquie di San Calocero dal monastero di Albenga, sul
mar Ligure, all’abbazia montana, ufficialmente per allontanare le reliquie tanto preziose dal
pericolo delle scorrerie dei pirati saraceni e dagli assalti dei vichinghi norvegesi e danesi
che già avevano devastato l’antica Luni e la valle del Magra. Così l’abbazia ligure divenne
semplicemente una delle sempre più numerose proprietà del monastero.
Il monastero sulla montagna, con la sua struttura di fortezza, non restò a lungo l’unico
beneficiario di queste attenzioni. Esso, infatti, seppur dotato di tante e tali preziose reliquie
e diplomi regi, non doveva prestarsi molto all’ulteriore grande sviluppo architettonico per
l’inidoneità dello spazio tanto esiguo e la difficoltà dell’ascesa. Esauritesi per lunghi periodi
le ragioni della sua particolare dislocazione su un pericoloso territorio di confine, l’aumento
delle necessità interne cui provvedere, i contatti quotidiani e gli interessi dei rapporti
esterni, resisi ormai necessari con l’acquisizione di beni e territori e la loro gestione
economica, rendevano improcrastinabile l’edificazione di un più ampio monastero a valle,
presumibilmente già preceduto da costruzioni monacali per così dire provvisorie e con
logica dotate di un sacro edificio per l’officiatura dei monaci. Un edificio funzionale al
monastero sul monte fu dapprima costruito sulla collina di Scola, sottostante il monastero
montano e situata in una posizione strategica e militarmente controllata e difendibile. Lì,
una guarnigione militare poteva facilmente verificare l’accesso alla strada per San Pietro e
tenersi costantemente in comunicazione visiva col monastero stesso. Sulla collina operava
appunto una scola, vale a dire una congregazione religiosa di laici incaricati
dell’assistenza ai pellegrini che si recavano all’abbazia e l’edificio era affiancato da un
11
primo oratorio dedicato a Santa Maria. Nel trascorrere dei decenni, la costruzione del
monastero di San Calocero, in cui furono trasportate le reliquie del santo, fu affiancata
dall’oratorio di San Vito e Modesto nel borgo di Civate che venne ad aggiungersi al già
presente oratorio di Sant’Andrea sulla penisola di Isella, alla chiesa della Santa, e ai
successivi piccoli oratori di Borima e del Brunioso. Sorgeva poi nel borgo, nelle vicinanze
del nuovo monastero di San Calocero, anche un nuovo ospizio di accoglienza ed
assistenza per i pellegrini nella Cà Nova, appellativo di un piccolo quartiere in cui un
edificio antichissimo ancora oggi, con interessanti affreschi, conserva il nome di cà di
pelegrett, cioè casa dei pellegrini.
Potenza del monastero nell’alto medio evo
Il monastero di San Pietro al Monte, a partire dal IX secolo con l’avvento di Lotario e degli
abati franchi, aveva indubbiamente sostituito le funzioni di controllo militare, politico,
economico ed amministrativo sino allora svolto dall’autorità laica. Mentre nei dintorni si
rafforzavano le pievi, con un controllo religioso-amministrativo che faceva capo
all’arcivescovo di Milano, l’abbazia manteneva fieramente la sua alleanza con l’impero e
costituirà un baluardo economico, politico e militare fastidioso per il progressivo insorgere
dell’insofferenza comunale.
Dal punto di vista economico, senza dubbio il monastero aveva aumentato ed ingrandito i
suoi possedimenti anche lontani dal territorio del monastero stesso, a partire dai laghi di
Annone e Pusiano e dall’acquisizione dei beni e del monastero di Albenga. Buona parte
dei documenti relativi a questo periodo sono, infatti, legate a transazioni di fondi. Tuttavia,
il momento storico determinava un motivo di arricchimento, perlomeno artistico, del
monastero civatese.
Nonostante infatti l’opinione comune che alla presa del potere imperiale da parte di Carlo
Magno le invasioni barbariche in Europa si fossero esaurite, gli Ungari continuarono ad
operare indisturbati le loro incursioni seminando distruzioni, violenze, privazioni,
devastazioni e saccheggi sino al 960. Due scorrerie, nel nord d’Italia, avvenute nell’899 e
924, avevano portato al feroce saccheggio di Mantova e della regale Pavia. La grande e
temuta Milano e la stessa Monza non subirono violenze, ma i centri dei dintorni pagavano
a caro prezzo la loro vulnerabilità.
Anche le abbazie coi loro territori, tesori e beni, erano facilmente preda dell’irruente forza
devastatrice. Per anni gli edifici anneriti dal fumo e squassati devono avere testimoniato
della precarietà della vita suggerendo un ritorno alla paura ed alla barbarie, risuscitando
quel senso di precarietà che già per secoli aveva accompagnato l’esistenza delle
popolazioni italiche. Ancora nel 947 l’invasione si spingeva, attraverso l’antico ducato di
Spoleto sino a Lucera ed alle porte di Benevento. Ma anche il resto d’Europa non stava
meglio: fu presa Lione, fu attaccata Parigi. Ed i monasteri di Costanza e Reichenau, la
stessa San Gallo erano investiti dalla furia devastatrice attorno al 960.
Questi anni oscuri assistevano allo scambio vicendevole di ospitalità per le comunità
monacali più colpite. Esse si rifugiavano nei monasteri più sicuri e protetti, i monasterifortezza, favorendo il riallacciarsi di volta in volta di legami intellettuali ed il trasferirsi di
conoscenze ed esperienze culturali che in epoche passate già erano tanto vivaci e
proficue. In definitiva le incursioni unne favorivano il diffondersi ed il confrontarsi di nuove
idee ed esperienze in campo culturale, ma pure artistico, smuovevano definitivamente il
ristagno delle piccole comunità in sé ricche di riflessione e percezione.
Occorre aggiungere qualche ulteriore osservazione. Infatti, alcuni critici (Marcora)
ritengono di poter collocare nel periodo alto medioevale non solo la ricostruzione del IX
secolo di San Pietro al Monte, ad opera dell’abate Leodegario e del maestro Hildemaro,
ma che lo stesso monastero a valle di San Calocero sia da assegnarsi, come prima
costruzione a questo secolo. A sostegno di ciò portano l’affermazione che le spoglie di
12
San Calocero non fossero state traslate sul Monte, ma direttamente nel nuovo monastero
a valle. Ciò è dovuto ad una interpretazione di alcuni passi della Expositio Regulae di
Hildemaro, soprattutto là dove si fa riferimento all’accoglienza di re, vescovi e funzionari
regi presso il monastero. Secondo Marcora sarebbe stato impossibile ospitare tali
personaggi in un ambiente tanto angusto ed inadatto come San Pietro al Monte. In effetti
bisognerebbe invece tener conto non solo che la revisione di Hildemaro non poteva
riferirsi al solo monastero montano, ma a tutti i monasteri consociati che erano già
monasteri ben più grandi, ma che gli stessi due abati franchi del tempo erano stati inviati a
San Pietro al Monte con l’incarico di ricostruire fisicamente lo stesso monastero! Questo è
dunque un ulteriore problema, non privo di contraddizioni, che si inserisce nella
discussione sul tempo e sulla struttura della ricostruzione di San Pietro al Monte! Sta di
fatto che i due monaci-abati erano stati inviati da Ramperto vescovo di Brescia e “tutore”
del monastero di san Faustino e Jovita, che all’845-865 si fa risalire la certificazione
dell’appartenenza del monastero montano ai monasteri tedeschi, come testimonia il Liber
confraternitates fabarienses, assieme a San Gallo, Costanza, Disentis ed i preti di Biasca,
tutti in territorio tedesco!
Di fatto resta certificata la composizione dell’Expositio Regulae da parte di Hildemaro, che
già nell’821 risultava monaco a Corbie, dove era già conosciuto per la composizione di
varie opere, insieme a Leodegario e Wala. A lui si riconducono ormai anche le versioni
che si attribuivano a Paolo Diacono ed al vescovo Basilio. Inoltre, la prima apparizione del
riferimento a San Calocero risale solo al 1018, in un documento di transazione notarile con
l’abate Andrea. Poi ritorna nell’oblio. Possibile che un monastero, che doveva aver ormai
da un secolo grandezza e fama, derivatagli dalla reliquia di San Calocero, fosse passato
sotto silenzio in ogni riferimento pubblico? E’ pur vero che l’unico documento precedente è
del 927, ma perché comunque prevale e prevarrà sempre il riferimento al monastero di
San Pietro? I documenti successivi sono del 1162 ( il famoso diploma di Federco I
Barbarossa!), del 1230-37-44-46-52-57-81. Interessante quest’ultimo, perché testimonia la
“dichiarazione del sindaco e del procuratore degli abitanti di Civate di conservarsi vassalli
del monastero e pronti a ricevere dall’abate i pesi e le misure da utilizzarsi sul territorio”!
Ciò testimonia come vi sia stata in quel periodo qualche discussione sulla autorevolezza
del potere dell’abate o era una semplice atto d’uso e consuetudine? Occorre comunque
prima fare qualche altra considerazione.
3. Il secondo millennio
L’alleanza con l’impero
La ripresa alla vita intellettuale dell’Europa non poteva così tardare molto, incrociandosi
col fiorire del nuovo millennio cristiano. Le città libere dell’Hansa del nord ed i comuni della
cerchia milanese scalpitavano sempre più sotto il morso imperiale germanico. Momenti di
grandissimo entusiasmo di fronte al futuro salutavano il secolo XI e segnavano una ripresa
di vita collettiva, sempre più tesa alla ricerca della bellezza e della conoscenza come doni
della grandezza divina. E se dei primi decenni rimangono per il monastero civatese solo
documenti di tipo giuridico, senza alcun cenno alla vita monastica che si doveva invece
certo svolgere nello stesso e degli avvenimenti storici e politici ad esso legati, uno
squarcio sulle vicende dell’abbazia si apre negli anni immediatamente successivi.
L’incontro, sul territorio milanese, della chiesa dei pàtari, nata dalla spiritualità profonda del
popolo più umile, con la realtà monastica evidenzia il contrasto con la chiesa ufficiale
milanese e le sue vicende come reazione alla simonia ed al nicolaismo imperanti già sotto
la protezione di Guido da Velate, arcivescovo. Anselmo da Baggio, futuro papa
Alessandro II, e Landolfo Cotta si posero a capo del movimento in cui militavano Corrado
13
II, figlio di Enrico IV re d’Italia, a sua volta re di Germania e duca di Borgogna, con Arnolfo
III, che diventò vescovo di Milano dopo la morte di Anselmo III nel 1093. Le vicende di
questo periodo sono ancora in parte oscure e comunque molto ingarbugliate nel loro
susseguirsi. Comunque l’elezione affretta di Arnolfo III fu contestata e contrastata
violentemente, tanto da essere approvata dal papa solo nel 1095, con la unzione data dai
vescovi Dimone di Salisburgo, Ulderico di Passau e Gabardo di Costanza, elettori tedeschi
ed estranei alla realtà della chiesa milanese che sosteneva il papato. Ed in quei frangenti
l’opposizione nella città fu tale e così pericolosa, che Arnolfo, nonostante la protezione di
Anselmo da Baggio, dovette rifugiarsi nell’abbazia di Civate. Qui rimase per un certo
periodo, prima del perdono papale e del suo riconoscimento ufficiale anche da Roma. Il
1097 è anno della sua morte e sepoltura proprio nell’abbazia sulla montagna. Ed è così
che, mentre in conseguenza della rinascita del monachesimo benedettino su ispirazione
del centro transalpino di Cluny ispirato da San Bruno e San Maiolo e sostenuto
dall’intrepido e longevo abate Ugo, nascevano sul territorio altri grandi monasteri come
Pontida, San Pietro in Vallate, san Benedetto in Val Perlana, si terminavano in Civate le
edificazioni del monastero di San Calocero a valle, l’oratorio di San Benedetto e le
decorazioni plastiche e pittoriche in San Pietro al Monte. E’ certo questo il momento più
fulgido dell’abbazia.
A conferma di ciò, si ascrive al XII secolo la realizzazione del Messale di Civate di rito
monastico, uscito dallo scriptorium civatese insieme al Manuale d’uso che risulta però di
rito ambrosiano. Due altri codici sono presenti nella Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz di Berlino. Certo però, il diploma più importante è quello che, datato 1162, fa
riconoscere allo stesso Federico I, proprio il Barbarossa, innanzitutto l’amicizia dell’abate
Algiso a sostegno della sua lotta contro i comuni, quindi l’elenco dei numerosissimi
possedimenti del monastero. Il Diploma imperiale del 1162 ricorda l’alleanza del
monastero con il Barbarossa nella lotta contro i comuni e quindi la sua avversità non solo
al vescovo milanese, ma anche al papa, che accomunati nell’esilio in Francia, già
quell’anno decidono che il monastero civatese passerà sotto il controllo del vescovo di
Milano. Cosa che avvenne nel 1176 con la sconfitta imperiale a Legnano! E non ha forse
causato proprio quest’ultima pericolosa alleanza la distruzione delle parti abitative del
monastero stesso sulla montagna, dopo la sconfitta dell’imperatore a Legnano da parte
dei comuni congiurati?
Civate ghibellina
A conferma della vicinanza del monastero con il partito imperiale, ancora nel XIII secolo e
più esattamente nel 1254, il monastero sarà rifugio di un altro arcivescovo di Milano,
Leone da Perego (1241-1257), che fuggiva dalla furia dei popolari, a capo dei quali si
trova Martino Torriani. Non è che l’inizio di scontri feroci, in cui rientra la presenza
dell’esercito dell’abate di Civate, con la partecipazione dell’arcivescovo Ottone Visconti,
che nel 1277, in un inverno freddissimo conquista finalmente Lecco e Civate. E che l’abate
di Civate continuasse a sostenere lo spirito ghibellino dell’alta Martesana lo testimonia il
fatto che, secondo l’abate Longoni, i Torriani dovettero radere al suolo, quasi un secolo,
dopo il Castello di Civate, dal momento che era loro impossibile controllarlo. Le lunghe
mani del capoluogo lombardo si facevano dunque sempre più presenti nel monastero, fino
a determinare la fine dello stesso. Divenne abate di Civate Giovanni Visconti, che pare
avesse rivendicato e documentato i diritti dell’abbazia contro il cugino Bernabò, signore di
Milano. Mal gliene incolse, dal momento che Bernabò Visconti lo fece trucidare, tagliare a
pezzi e bruciare perché non si potesse nemmeno seppellire!
Intanto però essere abate di Civate era un titolo al quale non corrispondeva più un ufficio
effettivo. Il XIV secolo aveva portato la crisi del monachesimo benedettino in tutta Europa.
Le abbazie venivano giudicati solo fonti di rendita. Le opportunità economiche che si
14
sviluppavano nelle diverse regioni allontanavano i giovani dalla vita religiosa in genere ed
esse erano prese di mira solo dalle famiglie nobili che miravano a mettere le mani sulle
rendite del patrimonio, prebende e benefici. Così per esse guerre ed affari, oltre
all’amministrazione dei beni erano più importanti della vita spirituale e meno monaci
v’erano, meno erano le spese per la mensa abbaziale. Già nel 1313 erano nate
congregazioni nuove che cercavano d’allontanarsi da questi cattivi esempi: nascevano
anche i monaci Olivetani. Ed a Civate il monastero andava svuotandosi: nel 1384 v’erano
ormai solo due religiosi, l’abate Giovanni Bossi ed il monaco Filippo Visconti. L’abate, tra
l’altro, abitava a Monza e morì nel 1411. A lui successe Galdino Vicomercati, che cercò in
ogni modo di difendere il più possibile i beni rimasti, come ricorderà in una lapide a lui
dedicata e posta nella cappella di Sant Agostino, poi dell’Addolorata, l’abate Trivulzio nel
1517. Nel 1450 era seguito l’abate Trafano Canali, già priore del monasteri di Figina, che
riesce a sistemare le liti con la stessa famiglia dei Canali. Nel 1454 Gabriele del Maino lo
segue, ma avrà solo il merito di essere l’ultimo abate benedettino del monastero. Viveva
però nella villa di famiglia di Bruzzano, che ancora esiste, godendosi i beni dell’abbazia.
Finì per ridursi il monastero, nel 1470, ad un solo monaco amanuense, di cui rimane in un
archivio di monache la testimonianza che:”… questo monaco lasciò scritti per il monastero
di Lambrugo salterii et altre belle cose: veniva da Chivate a confessar le monache et si
ritiene che fosse santo”. Con lui terminò anche il monastero benedettino.
Abati commendatari
Anche i beni del monastero si disperdevano. Il Card. Ascanio Sforza, primo abate
commendatario dal 1480 circa, che fece restaurare la basilica di San Calocero nel 1500
dotandola della volta odierna e del porticato d’ingresso alla chiesa, concedeva alcuni
possedimenti, tra cui “ una casa de la mia abatia de Chiva” alle monache del Gesù e
morendo a Roma lo stesso anno forse avvelenato. Lo stesso Giulio II, il papa guerriero,
nel 1506 passò la commenda al Card. Antonio Trivulzio, vescovo di Como dal 1487, come
ricorda una lapide sotto il chiostro, commenda che egli lasciò in morte l’abbazia al nipote
Filippo Trivulzio. Fu lui a cercare le reliquie sia in San Pietro che in San Calocero e alla
fine dell’800 ancora un suo stemma era presente in San Pietro. La commenda, di mano in
mano, arrivò dal Cardinale Agostino Trivulzio a Francesco Sfondrati che rinunciava a
favore del giovane nipote chierico, Nicolò Sfondrati nel 1548, poi vescovo di Cremona e
quindi papa Gregorio XIV. Manteneva a Civate 7 sacerdoti di cui 5 residenti in San
Calocero. Fu lui che stipulò una convenzione nel 1556 con i monaci Olivetani, che si
impegnavano a mantenere a Civate sei religiosi sacerdoti con l’obbligo della salmodia
diurna e notturna, con la messa festiva e quaresimale a San Pietro. La commenda
passata nel 1580 al chierico ventenne Paolo Camillo Sfondrati, vide il raddoppio dei
monaci con la riparazione di San Pietro e del campanile annesso. L’incarico si intrecciò
presto con la nascita della parrocchia che, tracciata nel 1575 si definirà come stabilita dieci
anni dopo. Intanto nel 1594 risultavano inviati a San Pietro dei frati romiti, non meglio
precisati, che vi rimasero per quattro anni con difficoltà e litigando coi monaci di San
Calocero finchè se ne andarono. Dal 1608 i monaci lasciarono la custodia dell’abbazia
montana in mano all’agente del commendatario, un prete milanese, Agostino Palazzi, che
nel 1611 vi fu assassinato a 102 anni, pare per rubargli il cavallo. E’ anche il periodo delle
visite pastorali che iniziano con il cardinale Carlo Borromeo (1571, 1584) e proseguono
cugino Federico Borromeo (1595, 1604, 1608, 1615).
Nel 1612 la commenda era passata dal cardinale Paolo Camillo Sfondrati a Scipione
Caffarelli, detto cardinale Borghese e nipote del Papa Paolo V, generoso nei confronti
degli Olivetani fino alla morte avvenuta nel 1633. Filippo Maria Pirovano, pure ricordato da
una lapide nel chiostro e che gli succedette, si ricorda per l’omicidio, pare da lui ordinato,
15
del bargello di campagna del governatore spagnolo di Milano. Per questo fu privato di
commenda e benefici a vantaggio del cardinale Flavio Chigi, dopo varie vicissitudini e
contrapposizioni. Nel 1693 la commenda passa a mons. Benedetto Erba-Odescalchi, poi
arcivescovo di Milano nel 1713. A lui si deve la soluzione della diatriba fra monaci e
parroco, con la ricostruzione della chiesa parrocchiale nel 1735 (lapide murata in chiesa
parrocchiale a ricordo). Seguirono mons. Mario Millini nel 1741, il cardinale Alberico
Archinti nel 1756, nel 1757 crollò il campanile di San Pietro. Tra i resti furono rinvenute
una quantità di reliquie di ossa. L’anno successivo era commendatario mons. Vitaliano
Borromeo, nunzio della Santa Sede a Firenze. Durante la sua commenda, nel 1759, si
compì la visita pastorale del cardinale Giuseppe Pozzobonelli , che per la prima volta parla
dell’ostensorio con le chiavi di San Pietro. Seguì nel 1764 mons. Alberico Lucini, nunzio
apostilico a Madrid e quindi, nel 1768, il marchese Ignazio Busca, poi cardinale ai tempi di
Pio VI, finchè il 29 giugno 1798 un decreto della Repubblica Cisalpina dichiarava
soppresso il Monastero di Civate, con la confisca dei beni, stimati a 9000 scudi e le tenute
di Beverate, Consonno, Tremolada, a vantaggio della stessa Repubblica che furono
venduti, con tutte le proprietà a vilissimo prezzo.
Gli Olivetani erano rimasti un po’ stancamente a Civate fino alla soppressione dell’ordine,
decretata dagli editti napoleonici, nel 1798. Allora il monastero a valle di San Calocero e
l’oratorio di San Benedetto furono venduti a privati, la basilica di San Pietro al Monte
assegnata al municipio. Non sapendo che farsene, quest’ultimo la donò alla parrocchia cui
ancora appartiene.
Ultimi secoli
San Calocero sembrò poter essere trasformato in ospedale per le pievi di Oggiono,
Missaglia e Incino, ma non se ne fece nulla. Passò da diversi proprietari: Zuccoli, Enrico
Demeyster, Emilio Nava. All’inizio del ‘900 venne abbattuto dall’allora sindaco Nava,
proprietario, senza ttendere i pareri della Commissione dei beni e monumenti di Como.
San Pietro andava in rovina, come testimonia il cardinal Ferrari nel 1897, nella sua visita
pastorale, fino alla riconsacrazione del 1937 ad opera del cardinal Ildefonso Schuster,
dopo che dall’inizio degli anni ’30 mons. Polvara provvedeva la restauro primo di San
Pietro, mentre mons. Edoardo Gilardi restaurava San Calocero e l’annesso monastero
trasformandolo nella Casa del Cieco. I lavori di restauro complessivi riprenderanno nel
1975 con don Vincenzo Gatti e gli amici di San Pietro.
Ulteriori informazioni: presenti sul sito internet: xoomer.alice.it/carlo315
Bibliografia: reperibile sul testo UN MONASTERO SULLA MONTAGNA di Carlo
Castagna o sul sito www.amicidisanpietro.it
16