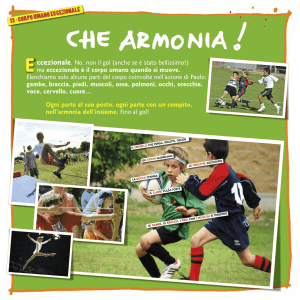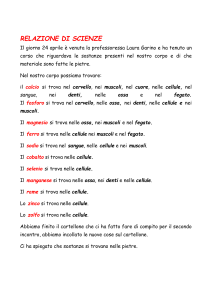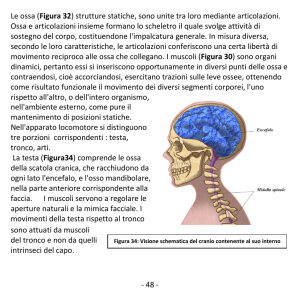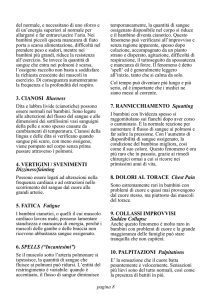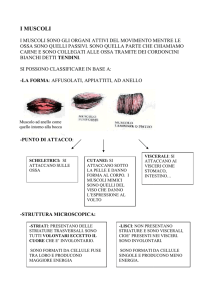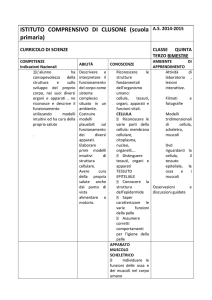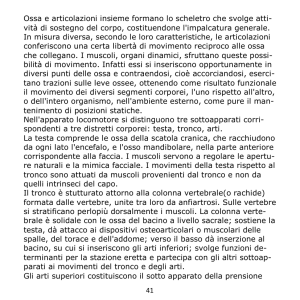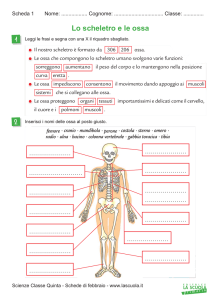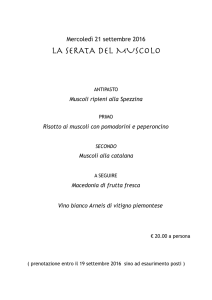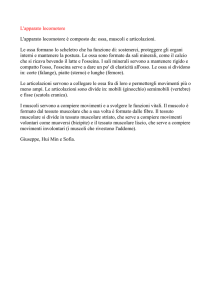SISTEMA RESPIRATORIO
Consente di immettere ed emettere aria nel corpo in modo che possa
avvenire lo scambio gassoso con il sangue.
Zona di conduzione: bocca, naso, faringe, trachea, bronchi, bronchioli. L’aria in
ingresso viene riscaldata, umidificata, filtrata.
Zona respiratoria: bronchioli, alveoli e sacchi alveolari. Qui avviene lo scambio
fra aria e sangue. Comprende quasi tutta la massa dei polmoni.
I POLMONI
Compliance (cedevolezza): capacità del polmone di espandersi sotto
pressione;
Elasticità: capacità di tornare velocemente alle dimensioni iniziali dopo aver
subito un’espansione;
Tensione di superficie: è esercitata da un sottile strato di fluido negli alveoli;
crea una forza diretta verso l’interno, direttamente proporzionale alla tensione
di superficie ed inversamente al raggio dell’alveolo (legge di Laplace). La
pressione in un alveolo piccolo è quindi maggiore di quella in uno grande, e
potrebbe portare al collassamento dell’alveolo piccolo per il flusso dell’aria
verso quello grande. Questo non avviene grazie ad un tensioattivo o
“surfactante” (surface active agent) che abbassa la tensione di superficie e
consente all’alveolo di ridursi senza collassare durante l’espirazione.
I neonati prematuri soffrono spesso di sindrome da insufficienza respiratoria a
causa della scarsità del surfactante. Vengono mantenuti in vita con ventilazione
artificiale finché non sono in grado di respirare in modo autonomo.
Respiro o ventilazione = processo meccanico per il quale l’aria entra
(inspirazione) e esce (espirazione) dai polmoni. Un adulto effettua
normalmente circa 15-20 respiri al minuto.
VOLUMI E CAPACITA’ POLMONARI
Queste
grandezze si
misurano
con lo
spirometro
TV (Tidal (marea) Volume) = quantità di aria che entra o esce dai polmoni durante il respiro normale
TLC (Total Lung Capacity) = quantità di aria contenuta nei polmoni dopo l’inspirazione massima
VC (Vital Capacity) = massima quantità di aria che può essere espirata dopo inspirazione per TLC
RV (Residual Volume) = quantità di gas rimasta nei polmoni dopo l’espirazione massima
IRV (Inspiratory Reserve Volume) = quantità di gas che può essere inspirata dopo aver inspirato durante il
respiro normale
ERV (Expiratory Reserve Volume) = quantità di gas che può essere espulsa dopo un’espirazione massima dopo
il respiro normale
IC (Inspiratory Capacity) = massima quantità di aria che può essere inspirata dopo un’espirazione normale
FRC (Functional Residual capacity) = quantità di aria che rimane nei polmoni dopo IC
Esercizio
La capacità polmonare totale di un
paziente è 5.9 litri. Se la capacità
inspiratoria
determinata
con
uno
spirometro è 3.3 litri, qual è la capacità
funzionale residua del paziente? Cosa è
necessario conoscere per calcolare il
volume residuo del paziente?
Soluzione:
La capacità polmonare totale (TLC) è data
dalla somma della capacità inspiratoria
(IC) e della capacità funzionale residua
(FRC):
TLC = IC + FRC
5.9 litri = 3.3 litri + FRC
FRC = 2.6 litri
Per calcolare il volume residuo (RV) sono
necessari TLC e Vital Capacity (VC):
TLC – VC = RV
TLC non si può misurare con lo spirometro
(si usa la tecnica della diluizione del gas),
mentre VC sì.
ALVEOLI
Ci sono circa 3.5 x 108 alveoli in un
polmone di individuo adulto, che
danno luogo ad una superficie di circa
60-70 m2 per gli scambi gassosi.
Gli alveoli hanno lo spessore di una
cellula, per cui lo scambio gassoso
implica il passaggio attraverso uno
spessore di due cellule, quella
dell’alveolo e quella del capillare, pari
a circa 2μm. La pressione
dell’ossigeno nell’alveolo è maggiore
di quella nel capillare, per cui
l’ossigeno passa dall’alveolo al
capillare. Viceversa avviene per
l’anidride carbonica, che quindi
transita dal capillare all’alveolo.
RESPIRAZIONE ARTIFICIALE
I ventilatori meccanici possono essere elettrici o pneumatici e possono
essere controllati da microprocessori.
• Ventilatori a pressione negativa: circondano la cavità toracica e
forzano l’aria nei polmoni creando una pressione negativa intorno al
torace.
• Ventilatori a pressione positiva: immettono aria ad alta pressione
nei polmoni in base ad un idoneo ciclo di controllo.
• Ossigenazione extracorporea: il sangue viene fatto circolare
all’esterno del corpo in un polmone artificiale dove avviene lo
scambio ossigeno-biossido di carbonio. Questa tecnica consente di
non utilizzare i polmoni e viene usata anche in neonati con problemi
polmonari reversibili.
APPARATO FONATORIO
Le corde vocali (destra
e
sinistra)
sono
costituite da muscoli
ricoperti da uno strato
sottile di tessuto, detto
mucosa.
La
velocità
di
vibrazione delle corde
vocali
dipende
principalmente
dalla
loro massa e tensione.
L’apertura fra le corde
vocali è detta glottide.
PRODUZIONE DELLA VOCE
Laringe
(F0)
Tratto vocale
(formanti)
Periodo T=1/F0 (F0=1a armonica)
Bocca
Armoniche = componenti spettrali in rapporto di frequenza intero
con quella a frequenza più bassa, detta fondamentale o prima
armonica.
Frequenza fondamentale F0 :
Adulti: 60HzF0 350Hz
Neonati: 400Hz F0 800Hz
Canto: 50Hz F0 1200Hz
DAL SEGNALE AL MODELLO
/a/ post-surgical
Normalised amplitude [arb.units]
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
1
2
3
4
5
6
Time [s]
7
8
9
10
11
-3
x 10
Scopo: descrivere il segnale vocale con
un modello (equazione) più semplice
possibile, ma al tempo stesso accurato.
SISTEMA NERVOSO
Comprende il sistema nervoso centrale
(CNS) ed il sistema nervoso periferico
(PNS).
CNS: tessuto nervoso incluso in parti ossee
(cervello e midollo spinale)
PNS: tessuto nervoso non incluso in ossa,
consente al corpo di percepire e rispondere
a stimoli sia interni che esterni. E’ costituito
da 12 paia di nervi cranici e 31 paia di nervi
spinali dotati di neuroni afferenti (sensoriali)
ed efferenti (motori).
Il sistema nervoso può anche essere
suddiviso in sistema nervoso somatico
(neuroni sensoriali) e sistema nervoso
autonomico (regolazione involontaria di
muscoli) ognuno dei quali comprende sia
nervi del CNS che del PNS.
NEURONI, DENDRITI, ASSONI
Neurone=cellula conduttrice di impulsi elettrici
Dendrite=parte maggiormente recettiva del neurone, riceve segnali da
centinaia di punti di contatto con gli altri neuroni, detti sinapsi
Assone=conduce il segnale nervoso ad
altre cellule nervose nel cervello o nel
midollo spinale, o a muscoli del corpo
Vescicola=si sposta verso la sinapsi e
rilascia neurotrasmettitori nello spazio fra
l’assone e la cellula vicina (dendrite di un
altro neurone, fibra muscolare,
ghiandola). I neurotrasmettitori si
diffondono nella sinapsi e stimolano la
risposta della cellula vicina.
L’ ENCEFALO
Massa di tessuto nervoso, costituito da:
cervello, diencefalo, midollo allungato,
cervelletto.
Cervello: è diviso in due emisferi, consiste
di numerosi “gyri” e “sulci” con una superficie
complessiva di circa 2,25m2. Lo strato più
esterno, detto corteccia cerebrale, contiene
più di 50 miliardi di neuroni. Il lato sinistro
gestisce il controllo motorio e sensoriale del
lato destro del corpo, il lato destro quello del
lato sinistro del corpo. Il corpo calloso
collega i due emisferi
Insula: ancora poco conosciuta, sembra
legata alle attività gastrointestinali
Talamo: sistema sensoriale e motorio,
emozioni, creatività, capacità di lettura e
ascolto
Ipotalamo: regolazione temperatura, vegliasonno, emozioni, sessualità
Lobi frontali: movimenti volontari dei
muscoli scheletrici, esperienza sensoriale,
personalità, memoria, emozioni,
ragionamento,parola.
Lobi parietali: recettori della pelle e dei
muscoli
Lobi temporali: centro udito, conserva
esperienze sensoriali, di memoria, visive
Lobi occipitali: integrano e coordinano i
movimenti oculari
L’ENCEFALO
Midollo allungato:
comprende il mesencefalo,
il ponte, e la medulla
oblongata. Regola funzioni
vitali quali il respiro.
Mesencefalo: movimenti
oculari, dilatazione pupille
Ponte: funzioni respiratorie
Cervelletto: contrazioni muscolari,
impulsi per movimenti muscolari
volontari, equilibrio, postura,
precisione dei movimenti
Medulla oblongata: battito
cardiaco, pressione
sanguigna, deglutizione,
tosse
SISTEMA SCHELETRICO
Scheletro adulto
206 ossa.
Scheletro
assiale: 80 ossa
( cranio, osso
ioide, colonna
vertebrale, gabbia
toracica)
Scheletro
appendicolare:
126 ossa
(cinto pettorale,
cinto pelvico,
estremità superiori
e inferiori)
Protegge e sostiene il corpo, produce cellule sanguigne e immagazzina minerali
importanti. Esistono ossa lunghe, corte, piatte, irregolari. Le ossa costituiscono il 18%
della massa del corpo e hanno una densità di 1,9g/cm3.
E’ in continuo rinnovamento (3 volte durante la vita): ossa vecchie vengono rimosse
dagli osteoclasti, ossa nuove sono ricostituite dagli osteoblasti. Osteoporosi: l’osso
vecchio si distrugge prima che venga ricostituito quello nuovo.
SISTEMA SCHELETRICO
Le ossa sono unite fra loro da giunture fibrose (tessuto connettivo
fibroso), in genere rigide, cartilaginee (consentono movimenti limitati) o
sinoviali (giunzioni con cavità riempite di fluido, cartilagini di copertura e
legamenti)
Gli ingegneri biomedici (biomeccanici)
sviluppano giunture artificiali che vengono
usate per rimpiazzare quelle originali in
caso di lesioni all’anca, alla spalla, alle
ginocchia. Problemi nascono per il diverso
modulo elastico dei materiali (es: 110 GPa
per il titanio e 20 GPa per l’osso)
Anca
Ginocchio
SISTEMA MUSCOLARE
E’ composto da 600-700
muscoli scheletrici e costituisce
il 40% della massa del corpo.
Consente di mantenere la
postura, genera calore per
mantenere la temperatura del
corpo fornisce la forza motrice
per muovere ossa e giunture e
la pelle facciale.
Muscoli agonisti: hanno un
ruolo fondamentale nel
compiere i movimenti;
Muscoli antagonisti: si
oppongono al movimento;
Muscoli sinergici: assistono
gli agonisti nel produrre un
movimento.
SISTEMA MUSCOLARE
Un sistema di leve fa funzionare i
muscoli. Le ossa costituiscono i
bracci della leva, le giunture il fulcro.
La resistenza da vincere è il peso
della parte del corpo da far muovere.
La forza applicata è data dalla
contrazione del muscolo.
Leva di I classe (fulcro posto fra la
forza E e resistenza L): contrazione
del bicipite
Leva di II classe (resistenza L posta
fra la forza E e il fulcro F):
sollevamento da terra
Leva di III classe ((forza E fra
resistenza L e fulcro F): sollevamento
peso.
SISTEMA MUSCOLARE
Tessuto connettivo
avvolge e separa i
muscoli da organi e
tessuti vicini. Altre fibre
connettive dividono il
muscolo in “fascicoli”,
ciascuno contenente
fasci di fibre muscolari.
Sarcolemma:
membrana plasmatica
Tubuli trasversi:
coordinano la
contrazione (rilascio di
ioni di calcio)
Sarcoplasma: contiene cilindri di diametro 12μm, detti miofibrille
Miofilamenti: filamenti di proteine sottili
(actina) o spessi (miosina)
OMEOSTASI
Omeostasi = processo tramite il quale le condizioni chimiche e fisiche
all’interno del corpo sono mantenute entro livelli tollerabili anche quando
le condizioni esterne cambiano.
La temperatura corporea, la pressione del sangue, la respirazione ed il
battito cardiaco sono alcune delle funzioni controllate dai meccanismi
omeostatici che coinvolgono diversi organi che lavorano insieme.
Il fluido extracellulare ha un ruolo importante nel mantenimento
dell’omeostasi: circola nel corpo e trasporta materiale verso e dalle
cellule, regola temperatura e pressione, l’equilibrio fra acidi e basi, la
concentrazione di ossigeno, anidride carbonica, acqua, nutrienti, ecc.
che si trovano nel sangue.
OMEOSTASI
Tre componenti interagiscono per mantenere l’omeostasi: i recettori sensoriali, gli
integratori e gli effettori:
Recettori: recepiscono lo stimolo (=cambiamento nel loro stato) e inviano informazioni su di
esso agli integratori
Integratori: punti di raccolta di informazioni da più recettori (es: il cervello). Inviano la risposta
agli effettori
Effettori: rispondono alle informazioni, che ritornano ai recettori, tramite i quali viene
modificato l’effetto dello stimolo.
Feedback positivo: lo stimolo iniziale viene rinforzato dalla risposta ricevuta (es: incremento
contrazioni uterine nel parto)
Feedback negativo: risposta in direzione opposta allo stimolo (es: riduzione del diametro dei
vasi della pelle se la temperatura è troppo bassa)
FEEDBACK NEGATIVO
Regolazione del glucosio nel pancreas
Livelli alti di glucosio (stimolo): le
cellule β negli “isolotti” pancreatici
(recettori) producono insulina
(messaggio) che facilita il trasporto
del glucosio attraverso le membrane
plasmatiche ed aumenta la
conversione di glucosio in glicogeno
che viene depositato nel fegato
(effettore).
Livelli di glucosio bassi (stimolo):
le cellule α negli “isolotti” pancreatici
(recettori) producono glucagone
(messaggio) che stimola il fegato
(effettore) a trasformare il glicogeno
in glucosio.