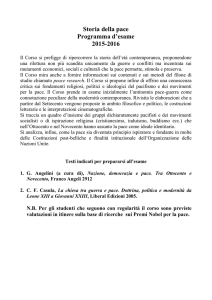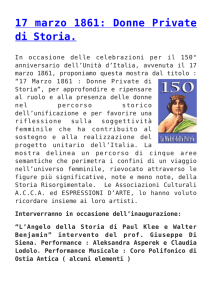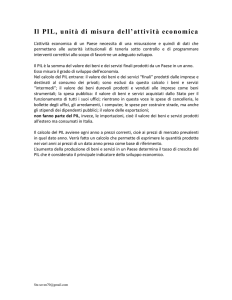APPUNTI DI STORIA ECONOMICA ITALIANA POSTUNITARIA
INTRODUZIONE
Il caso dell’Italia: un successo con luci e ombre
Ha scritto F. Braudel che “il passo dello storico è sicuro e disinvolto soltanto nella storia del suo
paese, di cui comprende quasi d’istinto le deviazioni, i meandri, le originalità, le debolezze”.
1
Tuttavia, la ragione dell’interesse nei confronti del caso italiano, certamente uno fra i più
significativi degli ultimi due secoli di storia economica, non deriva unicamente dal fatto che si
tratta del nostro paese. Una serie di fattori, economici e non solo, rende la penisola italiana – e lo
Stato unitario, dopo il 1861 – un caso riconosciuto come meritevole di studio da parte della
comunità scientifica nazionale e internazionale. L’Italia fu per due volte al centro delle relazioni
internazionali, soprattutto nel quadro geo-politico dell’Europa centro-occidentale e del Vecchio
Mondo gravitante sul bacino del Mediterraneo: dapprima nell’età dell’impero romano e,
successivamente, dal Tardo Medio Evo al Rinascimento, ossia dal XIII alla prima metà del XVI
secolo. Per due volte, la posizione egemonica fu seguita da altrettanti periodi prolungati di
declino,fino al ritorno fra le maggiori potenze economiche del mondo negli ultimi decenni del XX
secolo; un approdo reso evidente, nel 1975, dall’inserimento del paese nel G7 – poi G8, composto
da Usa, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Canada e più tardi anche dalla Russia ossia nel gruppo dei più industrializzati del mondo. Una vicenda che conferma, fra l’altro, come la
decadenza o la rinascita di uno stato e di una economia rientri sempre nel novero degli esiti
possibili. Non si è trattato solo di uno sviluppo economico particolarmente accelerato nel corso
della seconda metà del Novecento, ma anche di trasformazioni
sociali complesse e persino
contraddittorie, che si sono manifestati anche attraverso:
. il rovesciamento dei flussi migratori. Si stima che nel secolo compreso fra gli anni settanta dell’
Ottocento e gli anni sessanta del Novecento, circa 25-26 milioni di italiani siano emigrati all’estero.
Nel volgere di un tempo brevissimo, già a partire dagli anni settanta del secolo scorso, da paese di
emigranti, l’Italia cominciò a diventare terra di immigrazione;
. la rapida eclisse della civiltà contadina. Gli oltre sei milioni di occupati nel settore primario del
1951 si ridussero a 2,5 nel 1971; sono un milione oggi. Attraverso quella che Pier Paolo Pasolini
definì la “mutazione antropologica” degli italiani, insieme alle lucciole, scomparve una civiltà
secolare. La precedente struttura sociale, accentuatamente piramidale, a causa delle rigide
stratificazioni di classe e di censo, lasciò spazio a una struttura sociale più articolata, grazie a una
1
F. Braudel, L’identità della Francia. Spazio e storia, Milano 1995, p.9
1
nuova mobilità territoriale, sociale e professionale. In pochi decenni alle due culture, urbanoindustriale da un lato e contadina dall’altro si sostituì un unico stile di vita, quello urbano dei blue e
dei white collars, fino al prevalente modello di vita attuale, espressione di una società in cui i ceti
medi sono diventati largamente maggioritari;
. il crollo della natalità. Nell’arco di poche generazioni, l’Italia, paese contrassegnato da una elevata
fecondità femminile fino all’immediato secondo dopoguerra - si pensi alle politiche fasciste a
sostegno della natalità – negli ultimi decenni si è distinta per uno dei più bassi tassi di fecondità: 1,3
figli per donna. Anche in questo caso la svolta più significativa si registrò negli anni settanta del
Novecento: nel 1970 il tasso era di 2,43 figli per donna in età fertile; dieci anni più tardi era già
sceso a 1,68, con un conseguente accelerato invecchiamento della popolazione.
Così come la Germania e il Giappone, l’Italia rientra nel novero dei paesi late comers; nella nostra
storia economica è riassunta tanta parte della vicenda di un paese arrivato tardi al decollo
industriale, ma che in un secolo – fra il tardo Ottocento e la fine del Novecento - è passato da un
ruolo periferico a quello di comprimario nelle assise internazionali aperte ai maggiori sistemi
economico-sociali del mondo. Quella di late comer è, comunque, una definizione che abbisogna di
una breve digressione perché appare ormai datata, incapace di rappresentare compiutamente la
realtà; significante e significato non coincidono più, se non in maniera approssimata e sfocata, frutto
di una visione del mondo in chiave eccessivamente occidentale. Dopo i late comers vennero i New
industrialized countries e oggi è la volta di alcuni giganti emergenti: Cina, India, Brasile, ma anche
Messico, Indonesia. Continuare ad appendere bandierine sulla scala del tempo, via via che un paese
riesce a sollevarsi fino a far sentire la sua presenza, misurando il distacco temporale fra il primo e
l’ultimo arrivato potrebbe, forse, essere considerata ancora una condizione necessaria, ma senz’altro
non sufficiente. Al tramonto del XX secolo, il delinearsi di un mondo-villaggio suggerì il ricorso a
un altro tipo di terminologia di carattere, questa volta, non più temporale, ma spaziale: centro e
periferia. In realtà, dovrebbe apparire evidente - dopo che nel 2007 per la prima volta nella storia la
popolazione urbana del pianeta ha superato anche numericamente quella rurale – che non di mondovillaggio dovremmo continuare a parlare, ma di un mondo-metropoli, di cui i singoli paesi
costituiscono i quartieri. Come in tutte le metropoli, i quartieri, tuttavia, sono dotati di una vita
propria, oltre che essere condizionati dall’appartenenza al più vasto contesto urbano comune;
ciascuno caratterizzato da una propria mobilità che lo solleva o lo defila, rispetto agli altri, dal punto
di vista economico, sociale e culturale. Abbiamo di fronte, quindi, più che una linea del tempo, uno
spazio dal quale nessuno è più escluso, anche nel caso delle posizioni più marginali e periferiche.
Non basta la storia economica, ovviamente, per spiegare una storia tanto complessa, cadenzata da
dominazioni straniere, da divisioni e rivalità che per secoli furono accompagnate anche da appelli
2
a sovrani stranieri affinché scendessero nella penisola per risolvere questioni interne. E’ stato scritto
che “dopo il 1860 l’Italia, paese periferico dell’economia-mondo occidentale, costituitosi in stato
unitario che aspira a giocare un ruolo di potenza in un contesto geopolitica conflittuale, subisce tutto
l’impatto delle rivoluzioni industriali”.2 La tesi sottolinea implicitamente un tratto profondo del
quadro culturale e filosofico che orienta i fini e l’agire della società civile e di quella politica: in
virtù della sua storia e della sua cultura insofferente dei limiti nazionali– si pensi alle eredità di
Roma antica e a quella della Chiesa, romana, all’umanesimo e al Rinascimento – l’Italia non riesce
a essere paese chiuso in se stesso, che guarda il mondo
dal balcone; anche nei periodi di
debolezza, quali furono i decenni postunitari. Essa si porta sempre addosso velleità da attore non di
rincalzo, che stentano comunque a tradursi in ambizioni nazionali. Si tratta di una Weltanschaung
che orienta la politica estera, ma anche quella economica in misura non inferiore.
Ogni disciplina storica è la manifestazione del bisogno di semplificazione da parte dell’uomo; una
necessità riconducibile alla complessità delle vicende storiche che ne impone approfondimenti
segmentati. La storia economica, quindi, costituisce per certi versi una sorta di astrazione, in quanto
immagina un uomo - meglio sarebbe parlare di una società oeconomica - artificiosamente risotto a
una sola dimensione, ovviamente parziale, che riacquista un significato pieno solo nel momento
della ricomposizione della parte nel tutto, così come suona astratto il riferimento a un homo
philosophicus, a un homo faber e così via. E’ un angolo visuale particolare, dal quale cerchiamo,
comunque, di cogliere il tutto di cui la parte è espressione, condizionante e condizionata al tempo
stesso, strettamente intrecciata con la storia generale, attraverso relazioni biunivoche di
interdipendenza, causali e funzionali.
Vale la pena ricordare, infine, che se ogni disciplina storica – per sua natura settoriale - è parte di
un insieme più vasto, così la storia è, a sua volta, la tessera di un mosaico al quale appartengono
altre scienze sociali e dell’uomo (antropologia, sociologia, diritto, filosofia, storia dell’arte, ecc.)
che forniscono contributi essenziali allo storico, come allo storico dell’economia, della politica,
della cultura e così via. E’ questa la ragione per cui ogni riflessione sulla storia economica mai
prescinde dal complesso quadro storico nel quale si inserisce e dal quale riceve un senso compiuto.
Si è giustamente ricordato che “ogni paese è (anche) la sua geografia”3, nel senso che nei caratteri
ambientali – posizione geografica, orografia e morfologia, idrografia, clima, risorse naturali – va
individuata la radice forse più profonda, insieme alla lingua, dell’identità collettiva di un popolo e
della sua cultura. Nel medesimo tempo, quali agenti e agiti, i fattori naturali assumono valenze
differenti, storicamente mutevoli a seconda dello sviluppo economico-sociale di una società, del suo
livello tecnologico, del modo in cui è organizzata una società e degli assetti istituzionali dominanti
2
3
F. Amatori, La grande impresa, in Storia d’Italia. Annali 15. L’industria, Torino 1999, p. 693.
E. Galli della Loggia, L’identità italiana, Bologna 1998, p. 9.
3
in ogni periodo storico, delle relazioni con il contesto internazionale. Se facciamo particolare
riferimento all’età contemporanea, due elementi soprattutto meritano di essere sottolineati a
proposito della geografia dell’Italia: la accidentata morfologia che ha privato la penisola di pianure
vaste e fertili, nonchè le scarse risorse minerarie ed energetiche. Un sesto appena della superficie
territoriale è pianeggiante e, oltre tutto, a causa dell’orografia e dell’idrografia naturali, per secoli
molte terre di pianura restarono semisommerse dalle acque stagnanti, portatrici di malaria. Solo
grazie a lavori di bonifica, protrattisi dal Medio Evo al primo Novecento, fu reso possibile
l’insediamento stabile nelle pianure costiere; per gran parte, dunque, fu con una natura antropizzata
o ancora da antropizzare che si dovettero fare i conti nei decenni del decollo industriale e ancora
oggi. Spesso questa geografia poco generosa ha frapposto ostacoli seri allo sviluppo e, per esempio
nel campo delle infrastrutture viarie, continua a comportare costi relativamente più elevati, rispetto
ai principali concorrenti europei, come dimostrano i costi chilometrici comparati delle linee
ferroviarie ad alta velocità; Francia e Germania, infatti, sopportano costi inferiori nella costruzione
delle loro reti in virtù della morfologia più pianeggiante dei loro territori, meno segnati da rilievi
montuosi.
Ciascun paese – una considerazione analoga vale, comunque, anche per ogni individuo – è in
qualche modo prigioniero non solo della sua geografia, ma anche della sua storia che contribuisce a
delinearne limiti e potenzialità, a prescindere dalla forza di volta in volta messa in campo per
superare tali limiti ed esprimere le proprie potenzialità. Nel suo celebre studio intorno a L’etica
protestante e lo spirito del capitalismo, edito nel 1904, il grande sociologo tedesco Max Weber
(1864-1920), dedicò grande attenzione al peso esercitato dalla religione protestante sull’etica
economica capitalistica nei paesi che avevano sperimentato la Riforma luterana, riflettendo più in
generale sul rapporto fra le grandi religioni mondiali (induismo, buddismo, confucianesimo,
ebraismo, cristianesimo e islam) e l’etica economica. Egli giunse alla conclusione che ogni culturale
e ogni sistema di valori culturali e religiosi condiziona l’agire dell’individuo e quello della società.
Negli ultimi decenni la tesi sostenuta da Weber di una influenza dell’etica protestante sullo sviluppo
originario del capitalismo è stata confutata; alcuni hanno sottolineato che gli albori dell’economia di
mercato vanno individuati addirittura nel sistema economico affermatosi nei Comuni italiani; il
capitalismo avrebbe, dunque, trovato un humus favorevole nel quadro di una cultura cattolica e non
protestante. Resta, comunque, il valore della sua intuizione relativa all’importanza del ruolo dei
sistemi culturali e filosofici, come dei modelli di organizzazione sociale nei processi di sviluppo
economico-sociali. Il sistema di valori affermatosi nei paesi protestanti a partire dal XVI secolo
differiva dal sistema di credenze che lo Stato della Chiesa diffuse nella nostra penisola con la
Controriforma, ossia con la risposta che il concilio di Trento diede alla Riforma luterana. Al rigore
4
morale protestante e soprattutto calvinista, la Chiesa cattolica contrappose una propria architettura
di valori. Attraverso il Barocco, prima forma di comunicazione di massa della storia, la Chiesa di
Roma espresse la sua magnificenza e rivendicò un orgoglioso primato che si affermarono ovunque
nel mondo cattolico, ma in maniera affatto particolare all’interno dei confini della penisola. Qui, la
presenza di uno Stato della Chiesa, la conseguente convivenza millenaria di un duplice potere, laico
ed ecclesiale, l’influenza esercitata dal papato sulle vicende politiche, sociali ed economiche della
penisola, condizionarono in maniera profonda l’identità nazionale e la storia italiana.
Se pervasivo risultò la secolare influenza culturale, molecolarmente diffusa sul territorio ed entro
ogni strato sociale, capace di sedimentarsi in ogni interstizio delle vicende pubbliche e private della
società, il potere temporale condizionò altrettanto profondamente il processo che si concluse con
l’Unità del paese dopo la metà dell’Ottocento. Solo la Germania, fra le grandi potenze europee,
approdò con tanto ritardo (1870) a un traguardo che Spagna, Francia, Regno Unito, Russia avevano
raggiunto con grande anticipo. Anche la formazione della coscienza civile nazionale ne fu
condizionata, poiché il nuovo Stato unitario non venne riconosciuto dal papa, mentre nei decenni
successivi i sacerdoti diffidarono i potenziali acquirenti delle terre dell’asse ecclesiastico messe in
vendita dal compiere un simile gesto.
Dopo aver individuato uno dei capisaldi dell’identità nazionale e della storia italiana in generale
nell’intersecarsi dei rapporti fra i molti poteri laici regionali in cui per secoli rimase frammentata la
penisola, nella presenza di uno Stato della Chiesa, nel ruolo giocato dalla religione cattolica che, a
sua volta, si servì della cultura greco-latina come suo veicolo di espressione, bisogna ora che
l’attenzione si sposti verso i fattori più specificamente economico-sociali che hanno caratterizzato
lo sviluppo del nostro paese negli ultimi due secoli.
La prima ondata di industrializzazione e le successive dovettero fare i conti, come si è detto, con
una geografia avara di risorse naturali: sia energetiche, sia minerarie Furono le scarsissime fonti
energetiche, a condizionare molte scelte degli imprenditori italiani che, nel tardo Ottocento,
cercarono di compensare soprattutto la mancanza di carbone, indirizzandosi verso l’energia idroelettrica e compiendo in questo settore passi in avanti significativi. La scelta condizionò la
geografia del decollo industriale, poichè la catena alpina diventava per forza di cose il luogo
privilegiato per lo sfruttamento di questa risorsa, con la conseguente localizzazione obbligata di
molti insediamenti industriali nell’area di Nord-ovest, dove la catena è più elevata e ricca di acque.
Conseguenza diretta delle scarse risorse naturali fu lo strutturarsi del nostro sistema produttivo sul
modello di una economia di trasformazione; una economia che ha conquistato i migliori successi
nei periodi di maggiore apertura commerciale e, al contrario, penalizzata dalle fasi di chiusura
protezionistica dei mercati o di autarchia. Il ruolo dell’Italia, nel quadro del commercio mondiale,
5
declinò nella seconda metà dell’Ottocento, passando dal 3,1% del 1866-8 al 2,6% del 1913, mentre
si rafforzò progressivamente nella seconda metà del Novecento con una successiva nuova flessione
dall’inizio del XXI secolo: l’import-export italiano, pari al 4,5% del totale mondiale nel 1995 è
sceso al 3% nel 2004, contro il 5% della Francia e l’11,5% della Germania.
Nel primo secolo di vita dello stato unitario, dall’intreccio fra la modesta estensione territoriale, la
limitata disponibilità di superfici pianeggianti e la dimensione della popolazione presente all’interno
dei confini nazionali scaturiva non solo una elevata densità abitativa, ma soprattutto un forte
squilibrio fra
braccia da lavoro e terra fertile disponibile. A causa dell’eccessivo carico
demografico l’introduzione delle macchine agricole risultò lenta, con conseguenze sulla dinamica
dell’esodo dalle campagne e, quindi, sulla produttività del settore primario rimasta troppo a lungo
inadeguata. L’elevata densità di popolazione determinò a lungo una offerta di lavoro molto elastica
e compresse il livello medio dei salari agricoli, mortificando i consumi.
Lo sviluppo economico dell’Italia si è realizzato nel quadro di un dualismo regionale – Nord/Sud –
tuttora irrisolto. Altri disequilibri territoriali lasciati in eredità dalla storia pre-unitaria, furono in
gran parte o del tutto colmati in tempi più o meno rapidi, come dimostra l’esperienza del Nord-Est,
il cui ritardo determinava ancora negli anni cinquanta del secolo scorso un flusso migratorio verso il
triangolo industriale – Milano, Torino e Genova – all’interno del quale si era concentrato il primo
decollo industriale del paese. A partire dagli anni ottanta del Novecento si rafforzò un ulteriore asse
di sviluppo, che ha coinvolto la fascia adriatica, fino ad alcune zone pugliesi e lucane; un
dinamismo che ancora oggi stenta a contagiare altre realtà del Mezzogiorno. La irrisolta questione
meridionale testimonia un fallimento che, a dispetto degli innumerevoli studi in merito, resta di
difficile spiegazione.
Un altro tratto di fondo dell’identità italiana consiste nella assenza o quantomeno nella debolezza
storica dello Stato, del suo apparato amministrativo e di alcune sue istituzioni che si manifesta
nell’incerto senso della legalità e della convivenza civile intrecciato con una democrazia non
sempre liberale. Ne deriva una coscienza non sempre inadeguata delle proprie responsabilità sociali
e del proprio ruolo, da parte dei soggetti economico-sociali e politici: partiti, rappresentanze
istituzionali degli imprenditori e dei lavoratori. Lo dimostra anche
il sistema delle relazioni
industriali che è stato ripetutamente caratterizzato, nel lungo periodo, da una forte conflittualità,
spia del radicalizzarsi del confronto fra parti che faticano a dialogare e, in alcuni momenti, persino
a riconoscersi e legittimarsi reciprocamente. Nell’arco dell’intera storia post-unitaria sono apparse
complessivamente deboli, in ogni strato sociale, sia l’idea di patria e di nazione, sia la convinzione
della condivisione di un sistema comune di regole, la fiducia nelle istituzioni, il senso
6
dell’appartenenza a un sistema sociale dal quale scaturiscono non solo diritti, ma anche doveri
sociali, civici.
Non è ininfluente il fatto che in diversi momenti della storia comunitaria europea, dalla firma del
Trattato di Roma nel 1957, alla nascita dell’Unione Europea, nel 1992 e poi fino a oggi, l’Unione
abbia acceso più speranze e che in essa si sia riposta più fiducia di quanto talune istituzioni
nazionali siano state capaci di suscitare. In rare occasioni i governi e le istituzioni centrali sono stati
in grado di configurarsi quali solidi punti di riferimento per l’intera nazione. L’incerto senso dello
stato ha fatto velo al consolidarsi di un senso patriottico, alla identificazione dei diversi gruppi
sociali in un’ unica comunità nazionale, alla capacità di cogliere le esigenze e gli interessi collettivi,
oltre alle legittime rivendicazioni di parte, individuali o di gruppo che siano. Poche le eccezioni, da
questo punto di vista; accadde per esempio all’atto della inaugurazione della politica della
concertazione fra le diverse parti sociali – sindacati dei lavorati e confindustria - promossa nel 1993
dal governo allora guidato da Carlo A. Ciampi.
Rientra in questa cornice la tolleranza a lungo accordata ad alcuni tipi di reati (evasione fiscale,
abusi, falso in bilancio) all’indirizzo dei quali raramente si è levata una voce ferma, ingenerando la
implicita convinzione che si tratti di reati minori, mentre vale la pena ricordare il rigore della
legislazione in materia di altri paesi, fra i quali gli Stati Uniti, che considerano, per esempio, il falso
in bilancio alla stregua di un reato molto grave, in quanto disgregatore della fiducia collettiva. Non
sempre è stata netta l’intransigenza nei confronti di forme di sopruso – basterebbe pensare ai
molteplici poteri mafiosi - con i quali si è data l’impressione di una possibile convivenza, minando
in tal modo il senso della giustizia. Si aggiunga, inoltre, la tolleranza ripetutamente manifestata
verso i cosiddetti poteri forti e, al contrario, una certa arroganza manifestata a lungo dallo Stato,
attraverso sue istituzioni, nei confronti dei cittadini che sino dall’Unità del paese hanno fatto fatica a
vedere nei pubblici poteri e nei corpi deputati alla tutela dell’ordine costituito - polizia, carabinieri,
guardia di finanza – organi con il compito istituzionale di proteggere il cittadino stesso. La
diffidenza ha coinvolto inevitabilmente anche il mondo delle imprese.
Il progresso economico è stato troppo a lungo accompagnato da uno sfocato progresso sociale,
culturale, politico e civile della società italiana, contrassegnato – sembrerebbe quasi in maniera
costituzionale - da luci e ombre. Ancora oggi appena il 55% dei giovani consegue un diploma di
scuola media superiore; nel 2001 solo il 12% della popolazione disponeva di una laurea; un dato
pari a meno della metà di quello europeo ( 29%). D’altra parte, nel nostro paese gli studi superiori,
che pure garantiscono livelli di reddito superiori alla media4, permettono di conseguire incrementi
di reddito pari solo al 2,4% per ogni anno di istruzione universitaria, contro il 10% degli Usa.
4
Cfr. Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2000, “Supplementi al Bollettino Statistico”, a. XII
Numero 6, 18 gennaio 2002.
7
Ancora all’inizio del XXI secolo, i lavoratori appartenenti alle categorie scientifiche e creative
rappresentavano appena il 13% del totale degli occupati, contro una media pari al 30% nella Europa
a 15 del 2001.
I successi economici, in particolare nella seconda metà del secolo scorso, si sono intrecciati con
contraddizioni e limiti tuttora irrisolti. Nel 2005, il quotidiano francese “Le Monde” parlò di opacità
del sistema economico-sociale italiano;5 una definizione condivisa da G. Rossi che l’ha mutuata per
il titolo di un suo libro: Capitalismo opaco, appunto.6 Ancora una volta va ribadito che, se di opacità
è giusto parlare, un simile carattere del nostro sistema economico affonda le sue radici non solo
nella storia economica del paese, ma anche nella storia italiana tout court. Un capitalismo opaco
perché imprigionato in corporativismi – evidenti nella sopravvivenza di ordini professionali
piuttosto chiusi - in intrecci non sempre limpidi fra banche e imprese; in un capitalismo di Stato che
ha generato relazioni anch’esse non sempre limpide fra mondo economico e politico; in un sistema
di strutture piramidali, di scatole cinesi e patti di sindacato che alimentano situazioni di monopolio
o di oligopolio, ossia una economia protetta, non sufficientemente concorrenziale, ostile alla
trasparenza del mercato e alla libera concorrenza, a danno dei cittadini consumatori.
Il ruolo della piccola impresa. Lo sviluppo economico italiano è stato costruito per tanta parte
sulla piccola e la piccolo-media impresa. Nel 2001 furono stati censiti quattro milioni di imprese, su
una popolazione di 58 milioni di abitanti e di queste oltre il 98% contava meno di venti addetti e
occupava il 59% della forza lavoro attiva; solo il 15% degli addetti lavora in imprese con oltre 500
dipendenti. Nello stesso tempo, il fatturato delle multinazionali italiane copre il 13% del Pil, contro
il 32% di quello tedesco e una media del 27,7% in ambito UE. La tendenza al predominio del micro
si accentuò nel corso dei primi anni del XXI secolo, contrariamente a quanto stava avvenendo nel
mondo globalizzato. In Italia, nel 1991 la media degli addetti per impresa era pari a 4,4; nel 2001
scese a 3,8. Se è convinzione piuttosto diffusa e condivisa che l’Italia sia un paese di piccole
imprese e di distretti industriali, l’opinione va almeno stemperata da un dato che non può essere
trascurato, sostanzialmente non dissimile da quello di altre economie occidentali, che suggerisce l’
immagine di un sistema industriale polarizzato: all’inizio dell’ultimo decennio del secolo scorso il
40% della produzione industriale era fatturato dalle cento maggiori imprese del paese.
Alla classe imprenditrice è stata spesso riconosciuta una indubbia abilità nell’adottare tecnologie
sviluppate da imprese estere, ma nel medesimo tempo alcuni indicatori – primo fra tutti
l’ammontare degli investimenti in ricerca e sviluppo rispetto al Pil – rivelano una
insufficiente
propensione all’innovazione tecnologica e scientifica solo in parte spiegabile con le contenute
5
5
“Le Monde”, 11 agosto 2005. L’articolo di fondo portava come titolo “L’opacité presistante du capitalisme italien”.
G. Rossi , Capitalismo opaco, a cura di F. Rampini, Roma-Bari, 2005
8
dimensioni della grande maggioranza delle imprese italiane e con le inadeguatezze del sistema
scolastico. Le debolezze in questo campo dipendono anche dal manchevole sostegno da parte della
spesa e delle politiche
pubbliche, testimoniato pure dal numero elevato di ricercatori che si
trasferiscono all’estero .
I distretti industriali, nei quali sono geograficamente agglomerati insiemi locali di piccole e medie
imprese costituiscono una delle peculiarità del sistema produttivo italiano, oggetto di studio anche
all’estero e frutto della tendenza di molte piccole imprese ad aggregarsi in ambiti territoriali
circoscritti. Anche se negli ultimi anni, i distretti sembrano aver perso parte della loro forza
propulsiva, essi restano una realtà significativa, caratterizzata da:
.concentrazione spaziale di imprese, prevalentemente di piccole e piccolo-medie dimensioni,
operanti nello stesso settore merceologico;
. forte integrazione verticale e orizzontale fra le imprese industriali, di servizi e bancarie;
. intervento dei pubblici poteri, mediante creazione di istituti professionali, infrastrutture, ecc.;
. ruolo importante delle relazioni sociali (imprese-società civile).
Storicamente, l’intervento dello stato nell’economia si è concretizzato nell’adozione di sistemi
protezionistici, nella concessione di agevolazioni e sovvenzioni, nella politica delle commesse
affidate a imprese industriali private considerate strategiche, come nel caso della Terni, fondata nel
1884, la cui produzione siderurgica veniva in parte assorbita, appunto, da commesse statali,
finalizzate allo sviluppo della marina da guerra. In Italia, l’intervento statale ha assunto una
connotazione peculiare, non solo dal punto di vista quantitativa, ma anche per una peculiarità:
quella dei ripetuti salvataggi di imprese, soprattutto industriali e bancarie, da parte dei governi,
indipendentemente dalla loro connotazione politica, al fine di scongiurare il fallimento delle
imprese in difficoltà. Ne derivò una sorta di capitalismo di stato che, fra gli anni trenta e ottanta del
secolo scorso, diede vita a una economia mista, con lo Stato produttore quale attore co-protagonista
anche nel campo economico. Anche nel caso delle privatizzazioni, avviate nel corso degli anni
novanta del secolo scorso, lo Stato non rinunciò a un ruolo di primo piano, sia privandosi solo in
parte, delle proprietà, sia attraverso il ricorso alla golden share, persino con qualche forzatura delle
normative comunitarie in materia.
Dal diritto romano a quello comunitario molteplici tradizioni e culture giuridiche ( si pensi ai codici
napoleonici) si sono intrecciate, dando vita a un singolare rapporto fra economia e diritto. E’
capitato ripetutamente, però, che il diritto, invece di controllare il mercato, vi si è adattato e la
farraginosità dei codici e dei quadri normativi ha talvolta ostacolato lo sviluppo, in quanto fattore di
quella opacità del nostro sistema economico-sociale di cui si è detto.
9
I - Dall’Unità alla Prima guerra mondiale
A partire dalla metà dell’Ottocento, in seguito alla scoperta di nuovi, ingenti giacimenti di oro in
Australia e negli Stati Uniti, un flusso di capitali si riversò sulle principali piazze europee dove in
breve venne superata la precedente penuria di moneta aurea. Fino alla metà degli anni settanta i
prezzi aumentarono e le opportunità di investimento mobilitarono i risparmi che presero soprattutto
la via degli investimenti nelle ferrovie, nei settori industriali legati alla produzione di materiale
ferroviario e nei lavori pubblici connessi: linee, ponti, gallerie, stazioni, scali merce. Gli enormi
fabbisogni finanziari erano collegati alla costituzione di società anonime di grandi dimensioni, che
andavano prendendo il sopravvento su quelle tradizionali, a base individuale o familiare, e di
nuovi, moderni istituti di credito, al posto dei precedenti banchieri privati, di cui la Société Générale
de Crédit Mobilier dei fratelli Péreire, sorta a Parigi nel 1852, rappresentò sorta di precursore.
Parigi divenne la prima piazza finanziaria del continente e alla sua borsa facevano usualmente
ricorso gli stati europei, dall’Italia alla Russia, per la collocazione dei rispettivi debiti pubblici. Ciò
spiega perché fu con capitali, ma anche con società prevalentemente francesi che furono realizzate
alcune grandi opere, fra le quali il canale di Suez. In pochi decenni, la crescita prodigiosa dei
trasporti ferroviari – i convogli presto in grado di trainare 30 vagoni alla velocità, stupefacente per
l’epoca, di cento chilometri orari nelle pianure nordamericane, con i quali si ridussero le distanze
sulla terraferma, e della navigazione a vapore con la quale furono avvicinati fra loro i continenti
separati dagli oceani - diede un impulso notevole alla mondializzazione degli scambi.
Grazie anche al suo impero coloniale smisurato, Londra assurse al ruolo di prima piazza mercantile
mondiale nella fissazione dei prezzi e nelle contrattazioni delle materia prime minerarie e vegetali,
dai metalli alla lana. La produzione industriale dell’Europa occidentale cominciò a crescere
sensibilmente. I fusi installati nelle fabbriche cotoniere più che raddoppiarono fra il 1834 e il 1861
e nei decenni successivi altre potenze economiche si inserirono fra i first comers della rivoluzione
industriale, a partire dalla Germania e, nell’estremo Oriente, del Giappone, della cui ascesa il
mondo cominciò a rendersi conto all’inizio del Novecento, quando la flotta nipponica sconfisse
quella russa:
Fusi installati nell’industria cotoniera (in migliaia)
1834
1861
1913
31.000
55.600
2.500
5.500
7.400
626
2.235
10.920
Regno Unito 10.000
Francia
Germania
10
Stati Uniti
1.400
11.500
30.600
Nella installazione di forza motrice si registrò un trend analogo; dato che confermava l’ascesa
impressionante della Germania: un late comer che, in pochi decenni dopo l’unificazione politica del
paese, riuscì a colmare gran parte del ritardo che la separava dal Regno Unito e a superare la
Francia.
Potenza delle macchine a vapore installate (migliaia di HP)
1840
1860
1880
1896
620
2.450
7.600
13.700
Francia
90
1.120
3.070
5.920
Germania
40
850
5.120
8.080
Italia
10
50
500
1.520
Russia
20
200
1.740
3.100
760
3.470
9.110
18.060
Regno Unito
Stati Uniti
Verso la metà degli anni settanta una Great Depression investì il mondo intero, interrompendo per
circa un ventennio il precedente ciclo espansivo che aveva segnato il trionfo della borghesia7 oltre
che del capitalismo. Alla metà degli anni novanta, l’oro delle miniere sudafricane contribuì a
innescare una nuova fase di sviluppo tanto straordinario da segnare il passaggio dalla prima alla
seconda rivoluzione industriale, interrotto dallo scoppio della guerra mondiale. Un ventennio
conosciuto come Belle époque.
I progressi nel campo tecnico e scientifico realizzati nell’ultimo scorcio del XIX secolo, fatti propri
dalla produzione agricola e industriale – basterebbe pensare al motore a scoppio che rivoluzionò i
trasporti, introducendo quello individuale, con quanto ne derivava pure sul piano della cultura e
degli stili di vita -
determinarono un intreccio fra innovazione tecnologica ed economia – che si
manifestava nel rapporto fra politecnici, istituti di ricerca, grandi imprese, e nel delinearsi di nuove
tipologie di management, nelle cui file entravano ingegneri e chimici - i cui effetti, cumulandosi,
aprirono la strada alla seconda rivoluzione industriale. Ne furono espressione il nuovo modo di
produrre, imperniato sulla organizzazione scientifica del lavoro
introdotta nella grande fabbrica
fordista-taylorista; la diversificazione dei settori produttivi che ampliò il ventaglio merceologico
precedente: siderurgia dell’acciaio, chimica, cemento, elettricità, elettromeccanica furono i più
significativi; le nuove tecniche di vendita imperniate sulla vendita a rate, la pubblicità e i grandi
magazzini. A sorreggere la nuova fase espansiva, delineatasi alla fine dell’Ottocento, contribuirono
non solo l’estrazione e l’impiego di una nuova, straordinaria fonte energetica, come il petrolio, e la
discesa in campo di alcuni grandi paesi late comers, ma anche il ciclo di alti prezzi apertosi con la
7
Cfr. E. Hobsbawm, Il trionfo della borghesia 184/1875, Laterza, Roma-Bari, 1976.
11
scoperte delle miniere di oro dell’Alaska e con la conseguente immissione sui mercati di una
maggiore massa monetaria.
L’economia italiana nel primo cinquantennio post-unitario
I governi guidati dalla Destra storica che presero in mano le redini dell’Italia unita si trovarono a
fare i conti con un paese povero di risorse minerarie ed energetiche, dalle condizioni naturali poco
favorevoli soprattutto dal punto di vista morfologico, nel quale le attività industriali vere e proprie
erano ben poca cosa e dotato di un settore primario che solo per un quinto poteva essere considerato
efficiente, grazie alle conduzioni capitalistiche avviate; per il resto, l’agricoltura non era in grado di
garantire consistenti accumulazioni di capitali. Le pesanti eredità lasciate nelle regioni centromeridionali accentuavano l’inadeguatezza del mercato interno, ragione per cui molti osservatori
erano convinti che si dovesse far leva sulla esportazione di prodotti agricoli e del suolo per coprire
le importazioni di materie prime e di prodotti industriali. Uno stato di necessità sembrava rafforzare
le propensioni ideologiche liberiste della classe dominante che fece propria l’opzione
liberoscambista sulla quale basò la propria politica per circa un quindicennio: esportare prodotti del
suolo con il cui ricavato importare a basso prezzo manufatti e materie prime. Partire in ritardo sulla
strada delle industrializzazione significava confrontarsi con sistemi economici che avevano avuto il
tempo di attrezzarsi e quindi subirne la concorrenza. Non pochi erano convinti di una presunta
vocazione naturale della penisola per la produzione agricola e i commerci. Si sosteneva che la
posizione geografica, apparentemente valorizzata dall’apertura del canale di Suez nel 1869, avrebbe
fatto dell’Italia un ponte commerciale fra l’Europa continentale e l’Oriente, e che il paese non
avrebbe dovuto impegnarsi in processi di industrializzazione estranei alla sua vocazione naturale.
Una simile concezione, ovviamente sbilanciata a favore degli interessi agrari e penalizzante per
quelli industriali, sembrava rafforzata da considerazioni di opportunità politica, giacchè una parte
del mondo politico riteneva di avere un debito di riconoscenza da saldare con Parigi e Londra per
l’aiuto offerto nelle vicende risorgimentali. Né va sottovalutato il pressante fabbisogno di capitali
esteri per risanare la disastrata finanza pubblica italiana. Così, l’evidente vantaggio concesso alla
Francia con il trattato commerciale del 1863, oltre a configurarsi di fatto quasi alla stregua del saldo
di un debito, mirava ad attrarre al di qua delle Alpi capitali e investimenti.
Se nel 1861 il sistema di fabbrica era confinato entro una ristretta cerchia di pochi stabilimenti
cotonieri e lanieri e un settore come quello metalmeccanico poteva contare unicamente su un
pulviscolo di botteghe artigianali, mezzo secolo più tardi il panorama industriale aveva cambiato
volto in maniera radicale. Le distanze rispetto alle maggiori potenze industriali erano ancora
ragguardevoli e lo dimostrano alcuni settori, primo fra i quali il siderurgico, la cui produzione di
12
acciaio, inferiore al milione di tonnellate era cinque volte inferiore a quella francese, un nono di
quella inglese e addirittura un ventesimo di quanto usciva dagli altiforni tedeschi. Tuttavia, il
settore industriale non soffriva più dei vuoti di un tempo, tanto da suscitare più di una velleità di
potenza in alcuni settori politici, militari e industriali. Nonostante gli squilibri territoriali, alcuni dei
quali aggravatisi nella seconda metà dell’Ottocento, quasi tutti i comparti poggiavano su
fondamenta sufficientemente robuste e articolate e in alcuni, tecnologicamente strategici, i divari
non erano drammatici, come rivelano alcune produzioni chimiche. Analogamente, nel campo
dell’energia elettrica, la produzione italiana eguagliava quella francese, era pari ai tre quarti di
quella inglese e solo la Germania appariva lontana con oltre quattro volte l’energia elettrica elettrica
prodotta nella penisola.
Se è indubbio che nel corso di quei decenni, si passò dal sistema artigianale a quello della grande
fabbrica industriale, resta da chiedersi attraverso quali scelte e vicende, secondo quali scansioni
temporali si delinearono le trasformazioni economico-sociali del paese.
All’inizio degli anni settanta dell’Ottocento, secondo stime attendibili, il dato relativo al Pil procapite di alcune delle principali economie del tempo metteva in evidenza l’evidente ritardo del
nostro paese:
Pil pro-capite a parità di potere d’acquisto. 1871-5 (Italia = 100)
Italia
100
Regno Unito
213
Stati Uniti
183
Francia
130
Danimarca e Norvegia 122
Germania
113
Spagna
72
Giappone
49
Nei decenni compresi fra l’Unità del paese e la I Guerra mondiale, il prodotto interno lordo italiano
raddoppiò, ma a quel risultato si approdò dopo aver attraversato due fasi distinte. La prima coincise
con il periodo 1861-1896, caratterizzato da una crescita lenta, pari a uno 0,8% in più all’anno,
mentre il ventennio successivo registrò una crescita sostenuta, pari a un 2,4% medio annuo. Assai
più lento risultò l’incremento del prodotto interno lordo pro-capite, a causa della forte crescita
demografica che, in pratica, bloccò ogni aumento fino al 1896. Solo negli anni del periodo
giolittiano, fra la fine dell’Ottocento e la vigilia della I guerra mondiale anche il pil pro-capite
risentì del decollo industriale in atto e crebbe alla media dell’1,8% all’anno.
13
Pil e Pil pro-capite fra il 1861 e il 1913. Indici sulla base di prezzi costanti
Pil
Pil Pro-capite
Pil per settore produttivo
Agricoltura
1861
100
100
1896
131
104
1913
198
140
Industria
Servizi e P.A.
46,1%
18,4%
35,5%
37,6%
24,9%
37,5%
Le fasi di crescita e di rallentamento o stagnazione attraversate dai settori primario e secondario non
coincisero. Per quanto riguarda l’agricoltura, il primo cinquantennio postunitario fu contrassegnato
da una crisi iniziata negli anni ottanta e i cui effetti si protrassero fino alla metà degli anni novanta;
tanta grave da rappresentare una sorta di spartiacque fra due fasi distinte della storia agraria di quel
periodo. Se il prodotto lordo interno raddoppiò, la produzione agraria lorda vendibile aumentò assai
meno, con un modesto incremento del 50%, nello stesso periodo, di poco superiore a quello
demografico. Solo all’inizio del Novecento è possibile parlare di una crescita decisa del settore
primario che fino al chiudersi del secolo precedente aveva sperimentato una sostanziale
stagnazione, soprattutto sul versante della produttività, troppo modesta per riuscire ad alimentare
una sostenuta accumulazione di capitali. Nel 1911, l’occupazione nel settore primario si aggirava
ancora intorno al 59% della forza lavoro complessiva e solo il 23,6%
risultava occupato
nell’industria, ma l’agricoltura forniva appena il 37,6% del prodotto interno lordo.
Agricoltura: produzione lorda vendibile (PLV)
PLV
PLV per Ha.
1861-65
100,0
100,0
1879-83
110,9
110,8
1895-99
112,6
111.3
1909-13
152,7
148,4
I margini di incertezza che connotano le fonti quantitative a nostra disposizione, ci costringono a
formulare ipotesi prudenti anche in merito alla dinamica dello sviluppo industriale nel periodo che
stiamo considerando. E’ realistico affermare che nei primi venti anni la crescita si sia aggirata
mediamente intorno a un 2% annuo; un incremento modesto se confrontato con i progressi in atto
altrove, imputabile anche all’orizzonte culturale prevalentemente locale entro il quale si muovevano
molti imprenditori, ancora timidi nel compiere il salto di mentalità imposto dalla rivoluzione
14
industriale e dall’unità del paese che richiedeva di confrontarsi con un mercato ormai non più solo
nazionale, ma in misura crescente di tipo internazionale.
Maggiore incertezza avvolge l’interpretazione dello sviluppo nei decenni successivi che ci appaiono
caratterizzati da una crescita più che doppia e che quindi potremmo definire complessivamente
intensa, ma contrassegnata da un andamento ciclico, a onde. A un vivace decollo fra il 1881 e il
1888 fecero seguito un rallentamento fino al 1896, imputabile a cause endogene ed esogene, e
quindi una ripresa, fra il 1896 e il 1908, tanto marcata da configurare un balzo in avanti che
successivamente andò rallentando prima della guerra, pur attestandosi intorno a valori superiori al
2% annuo.
Il confronto fra il prodotto interno lordo, per settore produttivo di provenienza, nel 1861 e alla
vigilia della I Guerra mondiale consente di cogliere alcune trasformazioni avvenute in quel lasso di
tempo:
Pil per settore produttivo. 1861-1913: valori percentuali
Primario Secondario Terziario
1861
46,1
18,4
35,5
1913
37,6
24,9
37,5
Si trattò di cambiamenti non solo economici, ma anche sociali e culturali. Nel 1880, Alessandro
Guiccioli scriveva nelle pagine del suo diario: “lo sviluppo delle industrie e del credito ha fatto
passare in seconda linea come ricchezza e potenza i possessori delle terre; ha quindi detronizzato la
vecchia aristocrazia per crearne una nuova”. Il fenomeno, colto con acutezza da quel conservatore
alla corte di re Umberto I, si rafforzò nei decenni successivi, tanto che alla vigilia della I Guerra
mondiale la proprietà della terra, pur conservando un alone di prestigio sociale, non era più la
sorgente del potere e anche della ricchezza, almeno nell’Italia centro-settentrionale.
Sul piano territoriale, lo sviluppo disomogeneo. Il divario fra il Nord – soprattutto il triangolo
industriale - e il Sud si accentuò. Il Nord-ovest sperimentò una crescita sostenuta, tanto che nel
1911 non solo il 55% del valore aggiunto nazionale prodotto dal settore secondario veniva dalla
regione a cavallo fra Piemonte, Lombardia e Liguria, ma in quel triangolo la diversificazione dei
settori industriali era ormai sfociata nella presenza di quasi ogni comparto merceologico. All’inizio
del Novecento, grazie anche alla vicinanza alle fonti idroelettriche alpine, ai mercati dell’Europa
centro-occidentale grazie ai primi valichi ferroviari, nel Nord-ovest stavano irrobustendosi processi
di agglomerazione capaci di calamitare nuove imprese e di innescare lo sviluppo di nuovi settori. La
presenza dell’industria avanzata diventava occasionale nel resto del paese, dove prevaleva quella
tradizionale, di tipo artigianale, mentre il territorio del Nord-est e dell’Italia centrale, tolte poche
15
eccezioni era ancora sede di un’industria prevalentemente intermedia, con piccole concentrazioni
che permettevano di delineare in qualche caso la tipologia del distretto industriale.
I costi dell’Unità
Già nel 1864, molti entusiasmi che avevano accompagnato la formazione del nuovo stato unitario si
erano dissolti, sia all’interno, sia all’estero dove i giudizi sulle capacità economiche dell’Italia non
erano certamente lusinghieri, tanto che diversi osservatori esprimevano il dubbio di una possibile
bancarotta italiana. Molti avevano creduto che l’unità politica sarebbe stata in grado di suscitare un
rinnovato fervore di iniziative, ma ci si dovette ricredere e, infatti, appena tre anni dopo alcuni
decreti ministeriali
provvidero ad annullare le concessioni precedentemente accordate per lo
sfruttamento di giacimenti minerari, sia perché rivelatisi di modesta ricchezza, sia per la riluttanza a
investire da parte degli imprenditori. Nel 1866 un grande economista, Francesco Ferrara, diventato
ministro delle Finanze l’anno successivo, si domandava “perché mai tanto fuoco nell’animo, tanta
luce nell’intelletto, e poi tanto languore d’industria? La ragione di tutto questo è l’incertezza, la
mancanza di speranza nell’avvenire” e non solo a causa di difficoltà contingenti, quali il fortissimo
aumento del costo del cotone importato, dovuto alla guerra di secessione scoppiata nel 1861 negli
Stati Uniti.
I costi sostenuti per combattere la vittoriosa Seconda guerra di indipendenza, insieme alle indennità
dovute all’Austria, avevano lasciato una eredità gravosa sul bilancio del nuovo stato unitario; un
fardello appesantito, negli anni successivi, dagli oneri derivanti dalla Terza guerra di indipendenza,
che nel 1866 portò all’annessione del Veneto, dalla conquista di ciò che restava dello Stato
Pontificio nel 1870, dal duplice spostamento della capitale da Torino a Firenze e quindi a Roma,
dopo la breccia di Porta Pia. Costi comunque giustificati perché solo l’antica capitale dell’impero
romano e il millenario ruolo svolto, in quanto sede del papato, facevano di Roma l’unica città in cui
si potessero riconoscere tutti gli italiani; qualunque altra avrebbe fomentato rivalità. Anche le
resistenze al processo unitario, esplose soprattutto attraverso il fenomeno del brigantaggio
prolungatosi dal 1861 al 1865, gravarono sul bilancio pubblico con le spese sostenute per venire a
capo del problema, cui si aggiunse una scia di lutti e una sorda contrapposizione fra lo Stato e vaste
masse popolari meridionali.
Il primo compito dei governi guidati dalla Destra storica consistette nella costituzione dello Stato
stesso, in tutte le sue articolazioni territoriali e amministrative, oltre che nella creazione di un
tessuto sociale e culturale davvero nazionale; era stata fatta l’Italia, aveva detto D’Azeglio, ma ora
bisognava fare gli italiani. Occorrevano istituzioni, apparati amministrativi e di polizia, un sistema
fiscale unico, a partire dai catasti così diversi al Nord e al Sud. Quello geometrico-particellare,
16
chiamato teresiano dal nome dell’imperatrice asburgica e introdotto nel primo Settecento nello Stato
di Milano, registrava fedelmente ogni particella catastale permettendone una tassazione equa, basata
sulla sua reale capacità di rendita. Ben diverso appariva il catasto descrittivo borbonico, in vigore
nel Mezzogiorno, realizzato sulla base di un’autodenuncia da parte del singolo possessore e che,
quindi, presentava vistosi margini di infedeltà. Fino a quando il paese non avesse potuto fare
affidamento su un unico, rigoroso sistema di catastazione, la giustizia fiscale sarebbe risultata
impossibile, con evidenti ripercussioni negative sulla fiducia dei cittadini nello Stato.
Nel 1862 furono unificati i sistemi monetari, anche se restarono in circolazione, nel Veneto, il
fiorino austriaco fino al 1866, e lo scudo romano nello Stato Pontificio, fino all’annessione di
Roma. Occorrevano una legislazione comune e la creazione di un mercato nazionale, da conseguire
attraverso la soppressione delle precedenti dogane interne che intralciavano e rincaravano le merci
in viaggio lungo la penisola. Nell’intero paese si decise di applicare la tariffa piemontese la quale,
dal 1° gennaio 1861, sostituì tutti gli accordi doganali sottoscritti dagli Stati preunitari. La tariffa del
Regno Sardo si distingueva da quasi tutte le altre per la scarsa protezione offerta alle produzioni
interne, per la totale esenzione applicata alle materie prime e ai cereali in ingresso e per la quasi
completa assenza di dazi all’esportazione. Il governo decise di varare il nuovo sistema daziario, che
aboliva quelli interni e abbatteva considerevolmente quelli esterni, senza ricorrere a fasi intermedie,
le quali avrebbero permesso alle economie più protette, come quella meridionale, di adattarsi
progressivamente.
Molti osservatori del tempo attribuirono le difficoltà degli anni successivi proprio alla modalità con
cui era stata introdotta la nuova tariffa nazionale, di tipo liberista, che aveva incontrato il favore dei
mercati francese e inglese, ma esponendo alla concorrenza le imprese impreparate a un simile
confronto. A soffrirne non furono le economie settentrionali e toscana, ma quelle meridionali. I
precedenti dazi, alcuni dei quali pari all’80% del valore delle merci importate, avevano protetto la
già fragile industria del Mezzogiorno che solo gli imprenditori più coraggiosi, come gli svizzeri,
seppero riconvertire per essere in grado di affrontare la concorrenza estera e delle imprese
settentrionali. Se, tuttavia, l’industria cotoniera meridionale riuscì ad attrezzarsi e a superare le
difficoltà, non altrettanto riuscì a fare quella laniera, tecnicamente arretrata, che si avvaleva di lane
locali di scarsa qualità e presto messa in ginocchio dalle importazioni inglesi.
Poche le eccezioni previste, fra le quali la tariffa a favore dell’industria meridionale della carta
ricavata dagli stracci, per la quale fu tenuto in vita il dazio all’esportazione, anche interna alla
penisola, della materia prima. Non rientrarono fra le eccezioni i privilegi di cui avevano goduto i
porti franchi di Livorno e di Ancona e, in parte, di Genova e Messina, sottoposti alla medesima
17
normativa degli altri e, dopo di allora, Livorno perse il ruolo che aveva detenuto nei due secoli
precedenti, senza riuscire a risollevarsi.
Nel 1863 venne poi firmato un trattato commerciale con la Francia che abbassò ulteriormente le
tariffe sui beni e le materie prime importate. Si trattò di una sorta di cambiale pagata all’alleato
transalpino non solo per i rapporti politici molto stretti fra i due paesi, ma anche per l’appoggio che
Parigi aveva fornito a Vittorio Emanuele II prima e durante la II guerra di indipendenza. Penalizzate
dalle tariffe liberiste furono le attività estrattive e siderurgiche di quasi ogni località italiana –
escluse l’isola d’Elba e poche altre - che, anche a causa delle tecniche arretrate in uso, non furono in
grado di contrastare i bassi prezzi del ferro e del carbone di importazione.
Dal 1862 al 1866, le entrate fiscali dello Stato ascesero a 2.842 milioni – circa 550 milioni all’anno
che coprivano le sole spese militari e i costi del debito pubblico - mentre le uscite superarono i 5
miliardi, con un deficit pari a 2.187 milioni: quasi 440 all’anno. Il tentativo di inasprire le imposte,
per riuscire ad avviare un piano di opere pubbliche, imperniato soprattutto sugli investimenti
ferroviari, non portò a un sostanziale incremento del gettito, ragione per cui l’incremento delle
entrate dovette essere cercato in altre direzioni: l’alienazione dei beni demaniali e delle ferrovie
statali, la cessione a privati di entrate future e l’emissione di prestiti redimibili e irredimibili, di cui,
cioè, lo Stato non garantiva il rimborso, ma il solo pagamento degli interessi.
L’emissione di titoli pubblici rappresentava il mezzo più rapido per raccogliere i capitali di cui lo
Stato aveva bisogno, ma la scarsa fiducia del mercato nei confronti del soggetto debitore rendeva
poco allettanti i titoli agli occhi dei potenziali sottoscrittori, ragione per cui bisognò emetterli sotto
la pari: in media a meno di 70 lire, rispetto alle cento di valore nominale. Ne scaturiva ovviamente
una duplice conseguenza negativa: innanzi tutto, il lievitare del tasso reale di interesse, che dal 5%
sul prezzo nominale superò il 7%, nel 1862-3, per salire al 7,4% nel 1864 e al 7,67% nel 1865-6;
secondariamente, il fatto che
in un quinquennio l’introito derivante dalle diverse emissioni
assommò a soli 1.800 milioni, contro i 2.660 del valore nominale. L’effetto negativo sul debito
pubblico fu inevitabile: approdato a una soglia di poco inferiore ai 2.500 milioni del 1861, cinque
anni dopo superò i 5.100. Nello stesso periodo l’onere dell’indebitamento pubblico, ossia gli
interessi gravanti sul bilancio dello Stato passarono da 125 a 300 milioni. Un ulteriore effetto, non
così evidente, ma non meno grave, discendeva da quella misura: una remunerazione tanto elevata
dei risparmi sollecitava molti detentori di capitali a dirottarli verso un impiego tranquillo come
quello dei titoli di stato, invece di rischiarli in investimenti produttivi.
L’acquisto da parte di investitori, sui mercati di Parigi e di Londra, di circa i due quinti dei prestiti
emessi dallo Stato, nel 1866 - anno in cui si pagarono all’estero quasi cento milioni di interessi su
un totale di 300 – favorì l’afflusso di capitali stranieri stimati allora in 1.170 milioni , ma in ultima
18
analisi, un indebitamento tanto pesante non poteva non esercitare effetti distorcenti sull’intero
quadro macroeconomico del paese.
La seconda strada imboccata per fronteggiare il debito pubblico fu quella della alienazione del
patrimonio immobiliare ereditato dagli precedenti stati e dei beni confiscati alla Chiesa che
formavano un cospicuo demanio pubblico, composto da terreni, miniere, saline, fabbriche, ferrovie,
porti, canali, stabilimenti termali. Intorno al problema dell’alienazione del patrimonio immobiliare e
soprattutto delle terre coltivabili – queste ultime ammontavano a poco meno di un milione di ettari,
circa il 4% del totale nazionale, concentrate nel centro-sud - si confrontarono due ipotesi. La prima,
che aveva nel ministro Quintino Sella il suo principale esponente, mirava ad affrettare la vendita
all’incanto, finalizzandola alla copertura del deficit di bilancio; la seconda si poneva un secondo
obiettivo, oltre al riordino dei conti pubblici: la graduale dismissione secondo modalità tali da
favorire il formarsi di piccole proprietà, soprattutto contadine e meridionali, evitando che ad
accaparrarsi dei terreni e degli immobili fossero esclusivamente i grandi possidenti che, in tal modo,
avrebbero ampliato le rispettive proprietà.
Nel 1862 fu emanata una legge che veniva incontro ai fautori della seconda ipotesi, ma pressato
dalle urgenze del bilancio, nel 1864 il governo stipulò una convenzione con una società privata alla
quale fu dato incarico di curare gli appalti per la vendita di 130.000 ettari, dietro il versamento
anticipato di 150 milioni, oltre agli interessi, a una commissione del 2% su quanto ricavato e al 20%
della differenza fra il prezzo d’asta e quello realmente introitato. Si trattava di una clausola perversa
che induceva la società a fissare prezzi d’asta artificiosamente bassi, garantendole elevati profitti, e
che solo in apparenza veniva incontro ai piccoli risparmiatori, indotti a partecipare dal basso
prezzo. Dal 1861 alla fine del secolo furono alienati complessivamente 900.000 ettari, per un
importo che si avvicinò al milione di lire.
Il demanio minerario e industriale, invece, venne appaltato a società private: le miniere di ferro
dell’isola d’Elba e quelle sarde; le fabbriche siderurgiche e metallurgiche toscane raggruppate nelle
Regie Miniere e Fonderie del Ferro in Toscana; le fonderie di Torino, Genova e Napoli, l’altoforno
della Mongiana, in Calabria, dove si fondeva il ferro estratto nella Sila con il carbone di legna
ricavato dai boschi della zona; gli arsenali e i cantieri navali di Genova, Venezia (dopo il 1866), La
Spezia, Livorno, Napoli e Castellammare; le fabbriche d’armi localizzate a Brescia, Gardone in val
Trompia, Torino e Torre Annunziata, oltre a una ventina di officine militari. Con capitali in gran
parte inglesi fu costituita nel 1862
la Società del Canale Cavour che ottenne dallo Stato la
concessione per la realizzazione di un’ opera irrigua fra le più importanti, dietro versamento allo
Stato di 20 milioni. Nel 1868 fu appaltato anche il monopolio del tabacco alla Società Anonima per
19
la Regia Cointeressata, cui partecipavano anche capitali stranieri e che assicurò entrate cospicue, a
partire da una anticipazione di 150 milioni.
Nel 1866, una nuova crisi finanziaria si abbattè sulle borse europee, dopo quella di due anni prima
che aveva coinvolto soprattutto il mercato parigino. Per l’Italia le ripercussioni più pesanti
derivarono dalle difficoltà del mercato parigino, sul quale venivano collocate quote rilevanti del
debito pubblico nazionale, che precludevano la possibilità di farvi ricorso per ulteriori emissioni. In
quello stesso anno, però, agli usuali, ingenti fabbisogni di cassa, si aggiunsero i costi della III
Guerra di indipendenza contro l’Austria che il parlamento dichiarò, alleandosi con la Prussia, per
strappare il Veneto all’Impero asburgico. Le prospettiva di una guerra aggravarono la situazione
finanziaria a causa del rientro precipitoso, a valori sviliti, di titoli italiani collocati all’estero, con la
conseguenza di una emorragia di moneta aurea. In simili condizioni, il ministro delle Finanze,
Antonio Scialoja, si vide costretto a chiedere una anticipazione di 250 milioni alla Banca Nazionale
del Regno che la accordò, ma con l’obbligo di introdurre il corso forzoso, ossia la non convertibilità
dei biglietti di banca in monete metalliche: oro o argento che fosse. La sfiducia stava coinvolgendo
anche i risparmiatori italiani, con il rischio di un affollamento agli sportelli bancari per il ritiro dei
depositi e, dunque, di crolli bancari che avrebbero potuto concludersi con una bancarotta dello
Stato. Fino a quell’anno la massa cartacea in circolazione aveva rappresentato meno di un quarto
della circolazione metallica, pari a circa 1.100 milioni, nel 1865, quando era in uso un sistema
bimetallico, basato su un rapporto di valore fra argento e oro di 15,5 a 1, e la sproporzione fra
cartamoneta e moneta metallica tradiva la propensione indubbia per il conio metallico da parte di
gran parte della popolazione.
Altri paesi avevano fatto ricorso allo strumento del corso forzoso – quest’ultimo, in pratica,
equivaleva a una sorta di svalutazione della carta-moneta, rispetto alle monete auree o argentee,
nazionali o estere che fossero, così da far parlare di un aggio dell’oro sulla moneta cartacea- ma
restava il fatto che la sua adozione equivaleva a una implicita dichiarazione di debolezza della
carta-moneta; misura che costituiva comunque l’unico rimedio alla fuga da quest’ultima e alla corsa
alla sua conversione in moneta metallica. Ovviamente il governo si affrettò a dichiarare che una
simile misura veniva adottata in via temporanea e che la sua politica sarebbe stata finalizzata a un
pronto ritorno alla convertibilità.
In realtà, l’emissione cartacea, da parte della Banca Nazionale del Regno, passò dai cento milioni
circa del 1865 agli 800 del 1870, per riuscire a fronteggiare le continue, pressanti richieste di
anticipazioni da parte dei governi, costretti a colmare i perduranti disavanzi di bilancio. Nel 1866, il
20
deficit toccò la soglia dei 620 milioni, per scendere a 215 nel 1870. L’emissione di carta-moneta,
finalizzata alla copertura di un saldo negativo di bilancio non può essere annoverata fra le politiche
finanziarie e monetarie rigorose; l’unica alternativa praticabile sarebbe stata una politica fiscale più
severa nei confronti dei redditi medio-alti, ma era una strada che i governi ritennero di non
imboccare, sulla base di considerazioni tecniche, a causa della aleatorietà del gettito, e politiche.
Bisognava comunque perseguire l’obiettivo del pareggio, cui si pervenne nel 1875.
Bilancio dello Stato. 1862-1875 (in milioni di lire correnti)
Entrate
Uscite
Saldo
1862
486
926
-440
1863
524
906
-382
1864
576
944
-368
1865
645
916
-271
1866
617
1.238
-621
1867
714
928
-214
1868
748
1.014
-266
1869
871
1.019
-148
1870
866
1.081
-215
1871
966
1.013
- 47
1872
1.010
1.094
- 84
1873
1.047
1.136
- 89
1874
1.077
1.090
- 13
1875
1.095
1.082
+ 13
L’aumentata circolazione cartacea avrebbe potuto innescare processi inflazionistici che furono
scongiurati per via
della contemporanea diminuzione della circolazione metallica – comunque in misura
proporzionalmente assai inferiore – ma soprattutto perché proprio a partire dal 1867 il diminuito
afflusso di oro dalle miniere australiane e californiane comportò una contrazione dei prezzi su tutti i
mercati mondiali fino alla metà degli anni novanta.
L’aggio dell’oro sulla cartamoneta crebbe fino al 20% per scendere poi intorno al 6% fino al 1882,
anno in cui il corso forzoso venne abolito; quella svalutazione di fatto, anche se sotto mentite
spoglie, ebbe la conseguenza di rendere più onerose le importazioni e più competitive sui mercati
esteri le esportazioni italiane. In effetti, il saldo della bilancia commerciale, che aveva registrato un
21
passivo di 407 milioni nel 1865, migliorò e il passivo si contrasse fino ai 110 milioni del 1868: un
quarto appena rispetto a pochi anni prima. Al miglioramento, tuttavia, si pervenne anche in virtù di
due altre cause: l’annessione del Veneto e i positivi raccolti cerealicoli che per alcuni anni
limitarono il fabbisogno di grano estero.
Il sistema creditizio e gli investimenti pubblici
La raccolta del risparmio, effettuata grazie alle banche di credito ordinario e soprattutto attraverso
le Casse di Risparmio, risultava insufficiente, rispetto agli investimenti necessari; lo testimonia la
principale piazza italiana del tempo, Torino, dove nel 1863 i depositi arrivavano appena a 50
milioni di lire del tempo. Un flusso di risparmio inadeguato contribuiva a mantenere elevati sia i
tassi di interesse, sia quelli di sconto che in alcuni momenti giunsero a toccare il 9%, più del doppio
di quanto pagato dagli imprenditori britannici, con ripercussioni negative sul costo del denaro per le
imprese.
Ai nove istituti di credito ordinario operanti nel 1862, se ne aggiunsero altri 13 nei quattro anni
successivi, diversi dei quali aperti con l’apporto di capitali francesi, inglesi, svizzeri, belgi. Fu il
caso della Banca Anglo-Italiana di Torino, della Società Generale di Credito Mobiliare - trasferita
nel 1865 a Firenze e che presto diventò, e tale rimase per alcuni decenni, la principale banca di
credito ordinario del paese - nonchè della Banca di Credito Italiano, sorte sempre a Torino, ed
entrambe nel 1863, con capitali italiani e transalpini. Oltre alla sottoscrizione di parte del debito
pubblico italiano, dunque, capitali stranieri, per un valore complessivo di un centinaio di milioni,
trovarono occasione di investimento in istituti di credito della penisola e alle banche si aggiunsero,
come vedremo, gli investimenti industriali, soprattutto ferroviari.
In alcuni casi, l’interesse nei confronti del settore creditizio si tradusse in iniziative avventate e,
talvolta persino fraudolente, incapaci di reggere le speculazioni di borsa che squassarono il mercato
finanziario di Parigi nel 1863-4 e le cui ripercussioni sul mercato nazionale si tradussero presto nel
crollo di alcuni istituti di nuova costituzione.
Nel 1865, alle banche ordinarie e alle casse di risparmio si affiancarono le banche popolari, il cui
ispiratore, Luigi Luzzatto, si era rifatto all’esperienza delle cooperative di credito tedesche
promosse in Germania da Shulze-Delitzsch. Anche se ideate anch’esse, come le casse di risparmio,
avendo quale punto di riferimento privilegiato il ceto piccolo-borghese – artigiani, commercianti,
operai specializzati, impiegati - le banche popolari se ne differenziavano in quanto ambivano a
fare del risparmiatore un piccolo proprietario attraverso la sottoscrizione di una o comunque di
poche azioni della banca. Grazie al modesto capitale sottoscritto, all’occorrenza il depositante-
22
azionista acquisiva il diritto di chiedere prestiti per un valore di solito doppio rispetto a quello delle
azioni possedute.
Per non mortificare le identità e gli interessi locali, dopo l’Unità restarono in vita i precedenti istituti
di emissione: la Banca Nazionale del Regno d’Italia di Torino - ossia la precedente Banca
Nazionale degli Stati Sardi, costituitasi con la fusione della Banca di Torino e di quella di Genova la Banca Nazionale Toscana, che era nata dalla fusione delle due banche di Firenze e di Livorno; il
Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. In realtà, solo la Banca Nazionale del Regno d’Italia, presente
in tutti i capoluoghi di provincia, assunse le vesti di vero istituto nazionale, poiché gli altri, cui nel
1863 si era aggiunta la Banca di Toscana di Credito per l’Industria e il Commercio, continuarono a
svolgere una funzione prevalentemente regionale. Questa gerarchia si consolidò con l’introduzione
del corso forzoso, nel 1866, quando solo i biglietti della Banca Nazionale poterono circolare
liberamente su tutto il territorio del paese, mentre il corso legale dei biglietti emessi dai quattro
istituti venne circoscritto ai rispettivi ambiti territoriali. Fino all’anno prima, complessivamente,
circa il 45% dei biglietti di banca erano stati emessi dalla Banca Nazionale del Regno d’Italia.
Sul versante delle uscite, il bilancio dello Stato fu contrassegnato da spese che per una parte
rilevante erano assorbite dai lavori pubblici: strade, soprattutto nel Sud e nelle pianure semimalariche affacciate sul Tirreno; rete telegrafica; servizio postale nazionale; marina nazionale;
canali di irrigazione, porti e ferrovie. Mentre la costruzione delle grandi reti ferroviarie nelle
regioni dell’Europa nord-occidentale, presto interconnesse fra loro, fu l’espressione di un intenso
sviluppo industriale che faceva emergere nuovi bisogni anche nel campo dei trasporti, la decisione
di dotare l’Italia di una rete analoga precedette il decollo, di cui avrebbe dovuto rappresentare una
premessa, invertendo il rapporto causale. D’altra parte, più che in altre realtà del continente, il paese
aveva bisogno di essere unito da una rete ferroviaria in grado non solo di creare un unico mercato
nazionale, ma anche di collegare fra loro ambiti territoriali che le vicende politiche avevano tenuto
più distanti di quanto non fossero sul piano geografico. Il programma formulato dai primi governi
prevedeva la costruzione in un decennio di almeno seimila chilometri di linee, molte delle quali a
un binario unico, che si sarebbero aggiunte ai duemila già esistenti al momento dell’Unità, per un
costo stimato di circa 1.500 milioni di lire: 150 all’anno. In realtà fra il 1861 e il 1866 furono
ultimati solo duemila dei seimila chilometri progettati. Poiché il disavanzo strutturale del bilancio
pubblico lasciava nessuno o ben poco spazio agli investimenti ferroviari, non restò che rivolgersi a
società private, le quali si convinsero a scendere in campo solo dopo che lo Stato ebbe assicurato
un tasso di interesse in grado di remunerare il capitale investito nel corso dell’intera durata dei
lavori, oltre a un introito minimo garantito a chilometro, una volta entrate in esercizio le linee. Il
23
rischio era forte: se nel breve periodo le casse pubbliche sopportavano oneri relativamente modesti,
nel lungo periodo l’esborso avrebbero potuto assumere dimensioni rilevanti nel caso in cui i volumi
di traffico si fossero assestati troppo sotto il break even point.
I capitali stranieri si rivelarono essenziali nella realizzazione della rete italiana cui concorsero
molteplici società, alcune delle quali si rivelarono finanziariamente poco solide, tanto che presto
non furono in grado di rispettare gli impegni assunti. Bisognava, inoltre, sventare il rischio di avere
tratte scollegate fra loro, ragione per cui nel 1865 si procedette a un riordino della materia,
attraverso l’accorpamento di concessioni minori e il rinnovo per 99 anni di precedenti concessioni;
una operazione che fruttò all’erario entrate preziose. Con la legge del 1865, la rete ferroviaria
italiana risultava così ripartita:
- alla Società delle Strade Ferrate dell’ Alta Italia, costituita con forte apporto di capitali francesi,
venne affidata in gestione la rete dell’Italia settentrionale , nella quale fu incluso il Veneto, dopo il
1866 ;
- alla Società delle Strade Ferrate Romane, il cui capitale nel 1861 era passato nelle mani della
Société de Crédit Industriel di Parigi, furono date in concessione le linee dell’Italia centrale, oltre
alla Roma-Napoli;
- la Società per le Strade Ferrate Meridionali, conosciuta anche come Bastogi dal nome del suo
fondatore livornese - costituita con capitali livornesi, appunto, e di banche torinesi, milanesi, ma
anche stranieri - controllava la linea strategica compresa fra Bologna e Bari, con le diramazioni
Foggia-Napoli e Bari-Taranto;
- la Società Vittorio Emanuele, a capitale francese, dopo la cessione della Savoia alla Francia da
parte del Regno di Sardegna, in cambio delle linee della Savoia stessa ottenne la concessione delle
ferrovie calabro-sicule, le cui prime tratte entrarono in esercizio nel 1863. Cinque anni dopo, per
evitare il fallimento, la società fu ceduta a una impresa di costruzioni, la Vitali-Charles, Picard & C.
Il fatto di aver avviato inizialmente i tronchi principali, che assorbivano i maggiori volumi di
traffico, già nella seconda metà degli anni sessanta, quando si inaugurarono tratte meno
remunerative, determinò un appesantimento dei bilanci delle società ferroviarie.
Gli investimenti erano finanziati per lo più con l’emissione di prestiti obbligazionari che, come
succedeva per i titoli del debito pubblico, venivano collocati alla metà del loro valore nominale,
ragione per cui si dimezzava la raccolta e raddoppiava il tasso di interesse che dal 3% nominale
passava al 6% effettivo. Negli anni della crisi finanziaria più grave, ossia nel 1865-7, le
obbligazioni emesse dalla Bastogi al valore nominale di 500 lire erano quotate a 130, con un onere
per il pagamento degli interessi che toccava il 13%. Ulteriori ricorsi al credito, mediante la
sottoscrizione di nuove obbligazioni, erano di fatto preclusi e per riuscire a ultimare le linee in
24
costruzione non restava che chiedere allo Stato l’anticipazione delle sovvenzioni previste dai
contratti di concessione.
Complessivamente, i volumi di traffico e quindi i ricavi furono meno brillanti del previsto e, anzi, si
poteva parlare di una effettiva delusione. Il prodotto chilometrico lordo restò a lungo sotto le soglie
preventivate, tanto che, per fare un esempio, nella seconda metà degli anni sessanta la Società per le
Strade Ferrate Meridionali registrò un prodotto chilometrico inferiore alle diecimila lire contro le
29.000 garantite dallo Stato, con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio pubblico. Negli
stessi anni, nell’Italia settentrionale ci si aggirava intorno a un prodotto di 23-24.000 lire al
chilometro: la metà di quello inglese.
Gli esiti insoddisfacenti degli investimenti ferroviari dipendevano anche da un’altra causa. Se le
società estere coinvolte nelle costruzioni assicurarono capitali impossibili da mobilitare nel nostro
paese, è altrettanto vero che esse trovavano più conveniente importare buona parte dei binari e del
materiale rotabile – locomotive, carrozze e carri merce - mortificando così le opportunità di
investimento delle imprese nazionali del settore. Solo in alcuni casi si riuscì a imporre – successe
con la Società per le strade Ferrate Meridionali e con la Società delle Strade Ferrate Romane – che
le concessionarie si rifornissero di materiale rotabile prodotto dalla napoletana Società Nazionale
Industrie Meccaniche di Pietrarsa, fondata nel 1865. La Società Alta Italia, per esempio, fino al
1878 acquistò sul mercato nazionale solo 39 locomotive, quasi tutte costruite dall’Ansaldo di
Genova, contro le 500 importate.
III - L’agricoltura nel primo cinquantennio post-unitario
Nei decenni compresi fra l’Unità del paese e la I Guerra mondiale, il prodotto interno lordo italiano
raddoppiò, ma a quel risultato approdò dopo aver attraversato due fasi distinte. La prima coincise
con il periodo 1861-1896, caratterizzato da una crescita lenta, pari a uno 0,8% in più all’anno; il
ventennio successivo registrò una crescita sostenuta, pari a un 2,4% medio annuo. Assai più lento
risultò l’incremento del prodotto interno lordo pro-capite, a causa della forte crescita demografica
che, in pratica, bloccò ogni aumento fino al 1896. Solo negli anni del periodo giolittiano, fra la fine
dell’Ottocento e la vigilia della I guerra mondiale anche il pil pro-capite risentì del decollo
industriale in atto e crebbe alla media dell’1,8% all’anno.
Pil e Pil pro-capite fra il 1861 e il 1913. Indici sulla base di prezzi costanti
Pil
Pil Pro-capite
Pil per settore produttivo
25
Agricoltura
1861
100
100
1896
131
104
1913
198
140
Industria
Servizi e P.A.
46,1%
18,4%
35,5%
37,6%
24,9%
37,5%
Il primo cinquantennio postunitario fu contrassegnato dalla grave crisi agraria degli anni ottanta, i
cui effetti si protrassero fino alla metà degli anni novanta; una sorta di spartiacque fra due fasi
diverse della storia economia italiana di quel cinquantennio.
Se il prodotto lordo interno raddoppiò, la produzione agraria lorda vendibile aumentò assai meno,
con un modesto incremento del 50%, nello stesso periodo, di poco superiore a quello demografico.
Pure in questo caso, intravediamo due fasi distinte e solo per gli anni prebellici che coincisero con il
cosiddetto periodo giolittiano, è possibile parlare di una crescita decisa del settore primario che fino
al chiudersi dell’Ottocento aveva sperimentato una sostanziale stagnazione.
Agricoltura: produzione lorda vendibile (PLV)
PLV
PLV per Ha.
1861-65
100,0
100,0
1879-83
110,9
110,8
1895-99
112,6
111.3
1909-13
152,7
148,4
Negli anni settanta le condizioni in cui viveva gran parte della popolazione rurale nelle campagne
italiane avevano richiamato l’attenzione anche del Parlamento che promosse la famosa Inchiesta
agraria, protrattasi per diversi anni e affidata a uno dei massimi esperti del settore, il senatore
Stefano Jacini, proprietario terriero lombardo. L’inchiesta, composta da numerose monografie e
relazioni sulle varie realtà regionali della penisola si concluse con una relazione generale che, pur
nella prosa di un uomo moderato come il senatore, rivelò sia l’arretratezza complessiva del settore
primario, sia le condizioni economico-sociali delle popolazioni rurali. Altre inchieste, fra le quali
quelle di L. Franchetti sulle province napoletane, sulla Calabria e la Basilicata e dello stesso
Franchetti e Sonnino sulla Sicilia, sempre negli anni settanta, confermarono il quadro delineato
dall’Inchiesta Jacini e che la crisi del decennio successivo aggravò.
La crisi non investì la sola penisola, ma l’intero continente e la sua causa va ascritta in modo
particolare alla rivoluzione dei mezzi di trasporto. Sino ad allora, l’incerta navigazione a vela, che
26
esponeva i bastimenti ai capricci dei venti, e l’ancor più problematico trasporto via terra, lungo
strade non asfaltate, su carri dalla modesta capacità di carico e penalizzati dai cambi dei cavalli e
dalle intemperie, l’assenza di sistemi di refrigerazione, avevano sostanzialmente impedito il
trasporto oceanico delle derrate agricole, a partire dai cereali. In pochi anni, i progressi assicurati
dall’applicazione sui mezzi di trasporto delle caldaie a vapore i tempi di trasporto dei cereali, come
di ogni altra merce, si ridussero sensibilmente. Con l’introduzione degli scafi in ferro, mossi dai
motori, e delle linee ferroviarie sulle quali già negli anni settanta i convogli merci sferragliavano
attraverso le pianure americane a cento chilometri orari, mossi da locomotive in grado di trainare
30 vagoni, i noli crollarono
Costo di trasporto di un bushel di frumento (in centesimi di $)
Chicago-New York
New York-Liverpool
Chicago-Liverpool
1868
22,8
14,4
37,2
1880
15,7
11,8
27,5
1885
9,0
6,8
15,8
Gli elevati costi di trasporto avevano agito alla stessa stregua dei dazi sulle importazioni,
proteggendo la produzione agricola europea dalla concorrenza statunitense, canadese, argentina,
australiana. L’effetto fu rovinoso non solo per i cerealicoltori italiani, poiché a partire dai primi anni
ottanta i prezzi di tutte le derrate agricole subirono una forte flessione, mettendo in crisi l’intero
settore primario.
Perché aumentassero la produzione agraria globale e la produttività dei suoli come del lavoro
sarebbe stato necessario investire maggiori capitali e imboccare con maggiore convinzione la strada
dell’high farming. Invece, la già insufficiente accumulazione originata dalla terra fu dirottata verso
l’investimento fondiario che assorbì negli anni sessanta circa 200 milioni, sotto la forma
dell’acquisto di beni demaniali e dell’asse ecclesiastico. I dati sulle produzioni agro-alimentari
lasciano adito a più di un dubbio, ma integrati con quelli dell’import-export permettono comunque
di cogliere alcuni trend di fondo, una volta considerati l’incremento demografico e la sostanziale
staticità dei livelli e dei modelli di consumo dei generi alimentari. Le produzioni cerealicole, che
costituivano l’asse portante dell’agricoltura, rimasero sostanzialmente stabili e non permisero di
colmare quel deficit cronico dal quale derivava il bisogno di importare annualmente una media di
tre milioni di quintali di frumento, con punte anche più elevate negli anni di cattivo raccolto.
La pebrina che colpì il baco da seta e crittogama della vite acuirono le difficoltà del settore, anche
se le due malattie furono vinte con capacità e in tempi abbastanza rapidi. Ai lievi progressi registrati
27
nel primo ventennio unitario, seguì la grave crisi di cui si è detto, dalla quale si uscì grazie all’
effetto concomitante di due fattori: una prima modernizzazione, cui proprietari e conduttori posero
mano con convinzione in alcune regioni del paese e una più vivace domanda urbana, sulla scia dei
processi di industrializzazione e di inurbamento che si erano timidamente messi in moto.
Alcune novità stavano vivacizzando le campagne dell’Europa occidentale: l’introduzione della
chimica e della meccanica in agricoltura e una certa diffusione dell’istruzione, sia attraverso le
scuole, sia con la comparsa di apposite istituzioni agrarie, fra i quali meritano di essere ricordati i
Comizi agrari e le Cattedre ambulanti di agricoltura. Nel 1866, con il decreto Cordova, erano stati
creati i Comizi agrari che avevano il compito di razionalizzare la produzione agricola, di coordinare
gli interessi dei proprietari e dei grandi fittavoli e di farsene portavoce presso il governo affinché
quest’ultimo si facesse promotore di iniziative finalizzate al progresso del settore. Sebbene di
ispirazione governativa, i comizi non si diffusero in maniera omogenea sul territorio nazionale, ma
in maniera selettiva, rispecchiando il divario fra le aree a economia agricola forte e debole. Negli
anni ottanta ne funzionavano circa 250, il 54% dei quali nell’Italia settentrionale; solo il 30% nel
Sud. I Comizi - il cui numero si ridusse a 160, alla vigilia della I Guerra mondiale, in parallelo al
diffondersi delle cattedre tecniche e universitarie di agricoltura che ne accelerarono la scomparsa furono l’espressione degli interessi proprietari e diffusero il progresso agronomico soprattutto
attraverso le conferenze, i concorsi, le esposizioni: strumenti tipici di una classe sociale che poteva
permettersi di spostarsi con la carrozza, per raggiungere la sede degli incontri e abituata a
frequentare certi ambienti. Mai un contadino avrebbe osato avvicinarsi a quelle sale, troppo distanti
geograficamente e culturalmente dalla sua cascina; dove trovare il tempo libero per farlo, come
venire a sapere di quelle conferenze e come capire il conferenziere che parlava l’italiano, invece del
suo dialetto. Di rompere quella barriera culturale si incaricarono le cattedre ambulanti che – nomina
sunt consequentia rerum – rovesciarono il rapporto fra l’esperto e il mondo contadino. Erano,
infetti, i cattedratici ambulanti a recarsi nei paesi e spesso si fermavano nelle osterie, dove, in
dialetto, avvicinavano i contadini timorosi, per far conoscere loro i progressi della scienza
agronomica, le ultime novità in fatto di prodotti chimici e di meccanica agraria.
Le inchieste e la crisi ebbero, fra i loro effetti, una rinnovata attenzione verso le questioni
economiche e sociali che riguardavano l’agricoltura, alla cui soluzione cercò di dare una risposta
soprattutto il Movimento sociale cattolico. Lontani dalla politica a causa del non expedit pontificio,
meno capaci di cogliere quanto stava maturando nel mondo industriale e urbano, che i socialisti
erano stati in grado di capire con maggior prontezza e cui dimostravano di saper dare risposte
concrete più efficaci, i cattolici erano ideologicamente e culturalmente più attrezzati a confrontarsi
con il mondo delle campagne, permeato fortemente da una dimensione religiosa. Questa vicinanza
28
operativa e non solo ideale al mondo contadino si espresse attraverso la creazione delle cattedre
ambulanti; delle Unioni agricole che provvedevano a effettuare acquisti collettivi di attrezzi,
sementi, concimi per i contadini, garantendo loro prezzi inferiori; delle cucine popolari che
distribuivano minestre ai pellagrosi; degli uffici che si occupavano degli emigranti, cui fornivano
assistenza anche nel disbrigo delle pratiche burocratiche.
Nel 1892, fra le iniziative promosse dai cattolici si inserirono le Casse rurali che in pochi anni
diventarono migliaia; diffuse quasi ovunque, persino in paesi con poche migliaia di abitanti, esse
colmavano il vuoto lasciato dai Monti frumentari che, sotto pressioni interessate di parte, stavano
chiudendo quasi ovunque per essere trasformati nelle nuove casse di risparmio, indifferenti alle
esigenze di credito dei piccoli coltivatore diretti. A promuovere le nuove, minuscole banche, in
paesi talvolta di poche centinaia di abitanti, era spesso il parroco: l’unico che riscuotesse la fiducia
dei contadini tanto da indurli a depositare le poche lire risparmiate. Le casse, tuttavia, più che a
incentivare il risparmio, mirarono a diffondere il piccolo credito per sottrarre i contadini all’usura e
fornire loro i piccoli prestiti necessari per l’acquisto di un aratro, di un sacco di sementi o di
concime, di un attrezzo e una piccola macchina agricola.
Se misurate attraverso il volume dei risparmi raccolti e dei prestiti erogati, le casse non svolsero un
ruolo di primo piano nell’economia italiana a cavallo fra Otto e Novecento, ma il significato della
azione va individuato altrove; nel ruolo che esse svolsero nel promuovere l’emancipazione
economica, ma anche sociale e culturale del mondo contadino che imparò poco a alla volta a
varcarne le soglie, rompendo un velo di diffidenza e di separatezza rispetto alla novità rappresentata
dal mondo del credito.
Le inchieste avviate confermavano il quadro fosco, già delineato da Jacini in un suo studio
sull’agricoltura lombarda che risaliva al 1957, delle condizioni alimentari e abitative in cui versava
la grande maggioranza del mondo rurale, afflitto da sottoccupazione e disoccupazione soprattutto
invernale, costretto a vivere in case indecenti che, nel Sud, si riducevano a una stanza in cui
famiglie di dieci persone vivevano insieme agli animali, infestate dagli insetti e dai topi, senza
acqua e luce, con il pavimento in terra battuta.
In Italia, i prodotti chimici anticiparono le macchine sia perché i fertilizzanti comportavano un
esborso monetario di gran lunga inferiore e, quindi, alla portata di un maggior numero di contadini,
sia perché il ritorno dell’investimento avveniva nel breve periodo: una buona concimazione chimica
manifestava i suoi effetti subito, con il primo raccolto. All’investimento nelle macchine, ancora a
trazione animale e assai più oneroso, si convincevano pochi grandi proprietari e affittuari, a causa
del basso costo del lavoro cui faceva da contrappunto non solo un costo elevato delle macchine, ma
la ancora inadeguata rete di officine e di distributori dei pezzi di ricambio. Nella seconda metà
29
dell’Ottocento, in gran parte della Pianura padana si diffusero gli ultimi modelli di aratro in ferro,
capaci di arare più in profondità e di rivoltare la terra in modo da sfruttare meglio l’humus;
apparvero le prime macchine per il taglio dei foraggi e le grosse, sbuffanti trebbiatrici a vapore,
spostate da un’aia all’altra con i cavalli. Nel Sud, però, si era quasi sempre fermi agli aratri in legno
e ferro e persino in solo legno, che risalivano ad alcuni secoli prima.
Nel 1882, con la legge Baccarini lo Stato si fece promotore di grandi opere di bonifica che nei
trenta anni successivi permisero la messa a coltura regolare di circa 770.000 ettari, di cui oltre
300.000 nel Sud e 400.000 nella pianura Padana fra i capoluoghi di Ferrara, Rovigo, Ravenna e
Modena. I risultati dell’intervento pubblico furono incoraggianti – i suoli mai sfruttati prima in
modo intensivo davano rese unitarie superiori alla media – tanto che nel primo Novecento alla legge
Baccarini fecero seguito diversi provvedimenti in materia di bonifica e di sistemazioni idrogeologiche e forestali, fra le quali spiccarono le due leggi sulla Basilicata del 1904 e sulla Calabria,
approvata due anni dopo, che prevedevano forme di bonifica integrale, ossia accompagnate dalla
realizzazione di reti viarie e acquedotti, nonché dall’appoderamento delle superfici sottratte al
degrado. In tal modo, alla vigilia del primo conflitto mondiale la quota della superficie agraria
utilizzabile destinata a seminativi e alle colture legnose (vite, ulivo, frutteti ) era cresciuta fino al
57-58% contro uno scarso 50% del 1861. Nello stesso cinquantennio la produzione di frumento
crebbe di un 50%, passando da poco più di 40 milioni di ettolitri a oltre 62, ma non in modo
graduale e progressivo, visto che all’inizio degli anni novanta dell’Ottocento si era ancora fermi
intorno ai 45 milioni di ettolitri; fu nel quindicennio prebellico che si compì un vero balzo in
avanti.
La nascita delle relazioni industriali
I secoli che avevano preceduto la prima rivoluzione industriale erano stati punteggiati da tumulti –
il più famoso fu quello dei Ciompi, a Firenze - e da un ribellismo, soprattutto nelle campagne,
lontano dall’esperienza sindacale dell’età industriale, che introdusse l’idea della lotta consapevole,
laddove prima non c’era stato che spontaneismo. La Rivoluzione francese e il liberalismo avevano
rivalutato il cittadino, riscattandolo dalla precedente subalternità implicita nello status del suddito,
ma la cittadinanza era stata costruita sui diritti del singolo, dell’individuo, appunto. Con la fabbrica
30
si delineò un differente modo di essere dei singoli individui sul luogo di lavoro, perché la nuova
esperienza accomunava, facendo emergere la condivisione di condizioni e di bisogni simili, se non
uguali. Con la fabbrica entrò in scena il gruppo che diventò il protagonista della concezione
socialista e che fu rivalutato anche dal movimento sociale cattolico, mentre l’individualismo aveva
permeato la cultura borghese.
Le prime organizzazioni dei lavoratori assunsero la forma della Società di Mutuo Soccorso che
poteva abbracciare sia i lavoratori, sia i datori di lavoro. Inizialmente, queste associazioni sorsero su
basi corporative, interclassiste, per lo più municipale e persino di fabbrica. Nacquero quasi
esclusivamente nelle città e ad esse rimase quasi estraneo il mondo rurale. L’obiettivo primo
consisteva nella difesa e ci concretava nell’accantonamento di piccole quote per proteggersi nel
caso di malattia, infortunio, disoccupazione. Il fatto stesso di organizzarsi comportava l’affermarsi
di identità e spesso anche di un orgoglio di mestiere. L’orgoglio della propria condizione
professionale era tanto più sentito, quanto maggiore era la specializzazione richiesta, come nel caso
delle nuove figure che venivano affermandosi: tipografi e ferrovieri, innanzi tutti.
La nuova solidarietà, che si esprimeva nel fatto stesso di riconoscere la condivisione di un
medesimo status e di interessi comuni, contribuì ad arricchire il tessuto sociale, inserendo le Società
e, più tardi, i sindacati come i partiti dei lavoratori, fra lo Stato e il singolo individuo, rafforzando
nel medesimo tempo la coscienza dell’ essere cittadino, con diritti e doveri. Proprio attraverso
quella appartenenza solidale, professionale o di classe maturò l’ingresso a pieno titolo del lavoratore
organizzato nella dimensione della cittadinanza e lo educò alla democrazia, come apparve
chiaramente in occasione del I Congresso delle Società di Mutuo soccorso tenutosi ad Asti, nel
1853. Dieci anni dopo le 443 società che risultavano attive, raccoglievano già 120.000 soci che
diventarono 331.500 nel 1878.
Presto emerse la divisione fra i fautori del primo mutualismo interclassista, che voleva tenere uniti
in maniera solidale i datori di lavoro e gli operai, e chi rifiutando la collaborazione fra le classi,
propugnava organizzazioni di soli lavoratori, che escludessero i padroni.
Il sindacato vero e proprio rappresentò una soluzione di continuità rispetto al precedente
mutualismo poiché il nuovo modello associativo mirava non solo alla difesa dei lavoratori dai
rischi, ma a trasformare i bisogni in diritti: al lavoro, alla salute, a migliori condizioni di lavoro in
fabbrica, alla tutela della maternità e infanzia, più tardi all’istruzione e alla casa. Se all’inizio il
mutualismo aveva preso il posto delle corporazioni di mestiere e aveva svolto il ruolo che per secoli
era appartenuto agli enti caritativi, il sindacato sostituì la beneficenza con la rivendicazione, bandì
progressivamente il timore reverenziale nei confronti dei datori di lavoro e non si sottrasse di fronte
al conflitto fra capitale e lavoro, accettando la pratica e l’idea dello sciopero, in alternativa alla
31
collaborazione fra le classi. A Firenze, nel 1861, in occasione del IX Congresso delle società
operaie e ancora a Roma, nel 1874, dove si tenne il XIII Congresso delle Società operaie
mazziniane, l’astensione dal lavoro era stata sconfessata come funesta scissura fra operai e
imprenditori. Un primo segno di cambiamento si potè cogliere nel 1882, quando il XV Congresso
delle Società operaie affratellate, di ispirazione mazziniana, per la prima volta accettò lo sciopero
come male “talvolta inevitabile…imposto da forza maggiore”.
Un anno prima, il I Congresso della neonata Confederazione operaia lombarda, costituita non a caso
nella regione economicamente più vivace, si era spinta nelle sue formulazioni fino all’esplicito
appoggio alle agitazioni operaie. In quella sede, quello che andava definendosi come l’embrione del
nuovo sindacalismo inserì fra i propri obiettivi, l’impegno di ottenere leggi che garantissero “i diritti
del lavoro”. La Confederazione aveva un primo obiettivo fondamentale: farsi accettare come
interlocutore riconosciuto dai datori di lavoro – il padrone, come allora veniva usualmente definita
la controparte - la maggioranza dei quali negava agli operai non solo il riconoscimento come
associazione, ma prima ancora il diritto a qualsivoglia rivendicazione.
L’organizzazione del lavoro e le macchine impiegate nella grandi fabbriche moderne del tempo –
Terni, Pirelli, Lanificio Rossi, Ansaldo, Cantieri Orlando, Cotonificio Cantoni, Lanificio e
Canapificio Nazionale – modificavano il rapporto fra l’operaio e gli strumenti del suo lavoro,
facendo affiorare una coscienza di mestiere e di classe difficilmente compatibile con l’idea del
mutualismo affermatasi sino ad allora. Negli anni ottanta, la crisi agraria sradicò dalle campagne
una massa consistente di braccia, pronte a farsi assumere nelle fabbriche o a prendere la strada
dell’emigrazione. Nel corso degli anni ottanta, tuttavia non si interruppe la parabola ascendente del
mutualismo e, superate le 4500 associazioni con circa 700.000 soci, la crescita proseguì fino al
primo decennio del Novecento: nel 1904 si censirono 6535 società con 926.026 soci. Ciò significa,
dunque che per circa un ventennio coesistettero le due forme dell’associazionismo operaio: quella
che imboccò la strada del sindacalismo moderno e il più tradizionale e conservatore mutuo
soccorso, la cui la crisi, contrassegnata dalla perdita di soci e dallo scioglimento di centinaia di
società, dipese dalla sempre più incisiva messa in discussione del controllo che padronato, filantropi
borghesi, uomini e associazioni di chiesa avevano esercitato sui lavoratori.
L’evoluzione del mutualismo verso il sindacato moderno fu complessa e passò attraverso le Leghe
di resistenza, basate sul mestiere, che rimasero sempre piuttosto deboli proprio a causa della angusta
base professionale, comunale o persino di fabbrica, che favoriva una estrema parcellizzazione.
Nacquero, infatti, leghe di tornitori in metallo e affini, dei tagliatori in lime, dei cappellai in bianco
e nero, dei cappellai in fantasia, dei lavoranti in berrette e affini. Lo sviluppo
dell’industrializzazione e i primi scioperi sfociarono nel superamento delle leghe di resistenza a
32
base aziendale; l’unione dei lavoratori appartenenti al medesimo settore fu un passo quasi obbligato
con il quale si approdò alle federazioni di mestiere che si diffusero a cavallo fra l’Ottocento e il
Novecento.
Gli scioperi nell’industria:
Numero
Aderenti
1881-5
334
85.159
1886-90
531
132.676
1891-5
617
143.447
1896-1900 1.325
332.374
La federazione dei metallurgici (1901), con molti aderenti ma debole; la federazione dei tessili
(1901); la federazione degli edili e delle arti murarie (1886) e quella dei ferrovieri (1900), lavoratori
specializzati e dal reddito superiore alla media, raccolsero almeno inizialmente il maggior numero
di adesioni e furono fra le meglio organizzate. I cappellai si costituirono in federazione nel 1901,
dopo che nel 1899, a Monza, avevano conquistato uno dei primi veri e propri contratti collettivi che
prevedeva limitazioni di orario, incrementi salariali, regolamentazione dell’apprendistato, del lavoro
a domicilio delle guarnitrici, l’introduzione del regolamento aziendale, l’iscrizione alla Cassa di
previdenza e il riconoscimento delle commissioni interne aziendali. La Federazione nazionale dei
lavoratori della terra (Federterra) si costituì a Bologna nel 1901, anno in cui si erano registrati 629
scioperi nelle campagne con oltre 222.000 aderenti e la sua fondazione contribuì a ridurre in
maniera drastica il numero degli scioperi spontanei, che si dimezzò fra il 1901 e il 1902. Alla
Federterra avevano aderito 695 leghe locali del Nord, ma appena 29 del Centro-sud. Lo scarto
fortissimo era lo specchio della complessiva situazione economico-sociale del paese: al divario fra i
livelli di sviluppo delle due aree geografiche non poteva non corrispondere una analoga distanza fra
i livelli di sindacalizzazione. Dove quest’ultima era fragile continuavano a imporsi forme di
ribellismo esasperato, come era accaduto nel 1883, nella piana di Catania, dove i mietitori uccisero
sette proprietari terrieri che rifiutavano di aumentare le paghe.
Forte era la federazione di tipografi/litografi, lavoratori specializzati che percepivano un reddito
superiore alla media e quindi disposti a versare quote associative più elevate che compensavano il
numero non elevato. Se le società di mutuo soccorso spesso si erano appoggiate a contributi dei
datori di lavoro che compensavano la esiguità delle quote versate dai lavoratori, ma che per ciò
stesso ne minavano l’autonomia, le successive forme di sindacalizzazione, invece, fecero leva sulle
sole forze economiche operaie. La quota di iscrizione implica una apertura agli altri con i quali si
condividono medesime condizioni di lavoro e di vita e, quindi, il superamento della propria
33
condizione individuale. Sa da un lato, però, questa forma di autofinanziamento generava orgoglio e
garantiva maggiore autonomia alle associazioni, dall’altro ne rendeva più zoppicante il cammino in
quanto le modeste retribuzioni comprimevano le quote che solo una parte dei lavoratori riusciva a
sottoscrivere, penalizzando l’organizzazione e le sue possibilità di azione.
Questo tipo di organizzazione rivelava comunque una sostanziale fragilità e, nel 1904, solo fra i
ferrovieri la quota dei lavoratori sindacalizzati superava il 50% , ma con forti oscillazioni annuali,
segno che l’adesione alle leghe era ancora il frutto di impulsi contingenti, più che di una scelta
consapevole. La comune base di mestiere sulla quale erano nate le società di mutuo soccorso e le
leghe di resistenza, con le rispettive federazioni, potrebbe suggerire l’idea di non sostanziali
differenze fra le due forme associative, ma una diversità di fondo le distingueva: le prime erano
associazioni chiuse; le seconde si aprirono presto al proselitismo, e di fatto portarono alla sconfitta
dell’angusto orizzonte corporativo, di fabbrica.
L’esperienza delle federazioni di mestiere si intrecciò presto con un’altra forma di associazionismo
di tipo orizzontale: le Camere del Lavoro, che si organizzarono e apparvero a partire dal 1891. Il
loro compito iniziale consistette nel collocamento, gestito dagli stessi lavoratori, nonché la
mediazione nelle vertenze e la raccolta di dati statistici sul mondo del lavoro. Con quest’ultimo
obiettivo si compiva un salto di qualità rilevante, poiché la Camera del Lavoro, che si poneva
oggettivamente come una sorta di contraltare delle Camere di commercio, dandosi un compito di
indagine, riconosceva l’importanza della conoscenza come mezzo di emancipazione delle classi
lavoratrici. Nei momenti di crisi economica più acuta, ossia nella prima metà degli anni novanta, le
Camere del lavoro mirarono soprattutto a contenere la disoccupazione, ma presto i loro orizzonti si
dilatarono e parallelamente si ampliò il ventaglio delle rivendicazioni che andarono oltre le
condizioni di lavoro nelle fabbriche, investendo altri interlocutori. Successe a Milano dove, nel
1897, la Camera chiese al Comune la refezione scolastica, la riduzione delle tariffe tranviarie per i
lavoratori e la presenza di loro rappresentanti nelle commissioni di vigilanza sull’igiene.
Analogamente, nel 1896 la Camera del lavoro di Roma e di Firenze si impegnarono per controllare
il prezzo del pane. Proprio per la loro natura che superava i confini della fabbrica, l’impegno delle
Camere del lavoro andava oltre la figura dell’operaio o del contadino che vedeva come lavoratorecittadino per la cui dignità si batteva.
All’inizio del Novecento, F.S.Nitti affermava che “nessuno dei grandi paesi d’Europa ha una
legislazione sociale più povera, più manchevole, più difettosa della legislazione italiana”. In effetti,
nel primo quarantennio post-unitario erano state emanate pochissime leggi a protezione del lavoro:
minorile (1873 e 1886), contro gli infortuni sul lavoro per i quali fu prevista una assicurazione
(1883 e 1898), contro l’invalidità e vecchiaia (1898), l’istituzione di probiviri per dirimere le
34
vertenze industriali (1883). Si trattava, comunque, di leggi per lo più fumose, che sembravano fatte
apposta per essere aggirate a causa della loro genericità Il ritardo, rispetto ai sistemi economicosociali dell’Europa Nord-occidentale, era forte. Solo in Italia il lavoro festivo non era proibito, né
veniva tutelato il lavoro femminile, quello notturno degli uomini e neppure il lavoro nocivo; i
ragazzi potevano entrare in fabbrica a 9 anni e dopo i 12 potevano essere costretti a lavorare di
notte; dopo i 15 anni li si considerava idonei al lavoro nocivo. Nel 1903, la Francia disponeva di
278 ispettori del lavoro contro gli appena tre dell’Italia.
In Italia giunse abbastanza presto l’eco dei movimenti operai che venivano organizzandosi in
contesti industriali più avanzati e l’elaborazione delle idee progredì con passo più spedito rispetto
allo sviluppo produttivo. In altre parole, il sindacato era in anticipo rispetto alla prevalente
organizzazione del lavoro e questo fatto, insieme alla mentalità di buona parte della classe
imprenditoriale, contribuì ad acuire le tensioni e non aiutò lo sviluppo di una fisiologica dialettica
nelle relazioni industriali. Agli occhi degli imprenditori, la fabbrica rappresentava una sorta di
feudo personale, così come lo era stata la terra per gli agrari; si sentivano arbitri assoluti delle
rispettive proprietà e autorizzati a pretendere dai lavoratori qualsiasi tipo di prestazione, senza
riconoscere loro alcun diritto. Gli imprenditori rifiutavano l’ipotesi che lo Stato potesse legiferare in
materia di relazioni industriali in quanto consideravano ogni forma di legislazione sociale alla
stregua di una intromissione in una sfera di loro esclusiva competenza. Persino quelli più aperti –
era il caso dei Crespi alla cui fabbrica aperta nel 1878 in provincia di Bergamo venne affiancato a
partire dal 1890 un villaggio operaio che all’inizio del Novecento delineò compiutamente il volto
della company town, come successe a Schio intorno al lanificio dei Rossi e a Collegno intorno al
cotonificio Leumann - guardavano con fastidio alla legislazione sociale, in quanto la avvertivano
come una offesa alle loro politiche filantropiche. L’asprezza delle relazioni industriali – come
avviene in qualsiasi tipo di relazione personale o sociale che sia – dipende anche dal grado di
reciproca considerazione e accettazione fra le parti; l’apertura o la chiusura pregiudiziale di una
parte non può non condizionare la modalità della risposta dell’altra.
Con la comparsa del sindacato, soprattutto con il suo riconoscimento di fatto e di diritto, come
interlocutore istituzionale dei datori di lavoro e del governo, prese il via la storia delle moderne
relazioni industriali. Queste ultime, come una sorta di Giano bifronte, hanno sempre presentato un
duplice volto, di conservazioni e di modernità. Il sindacalismo è per sua natura conservatore, in
quanto finalizzato alla difesa dei diritti acquisiti, come dimostrano le lotte contro forme di
riorganizzazione del lavoro che comportano licenziamenti. Nel medesimo tempo, il sindacalismo
funge da promotore di modernità, in quanto fornisce un contributo alla innovazione sia attraverso
l’esperienza accumulata dai lavoratori, che suggerisce perfezionamenti da introdurre nei processi
35
lavorativi, sia costringendo i datori di lavoro a effettuare investimenti, innovativi appunto, per
migliorare la produzione stessa e le condizioni di lavoro.
Durante l’ultimo quindicennio del XIX secolo, in coincidenza con i governi guidati da F. Crispi
(1887-1891 e quindi dal 1893 al 1896 - la libertà i sindacale fu seriamente limitata e il capo del
governo giunse fino alla messa al bando delle associazioni operaie, allo scioglimento d’imperio
delle Camere del lavoro. L’impiego ripetuto dei carabinieri e della magistratura contro gli
scioperanti e quindi in difesa dei datori di lavoro, esasperava le tensioni e faceva sì che lavoratori
percepissero questi corpi dello Stato come nemici, al soldo di un unico blocco di potere formato
dallo Stato e dai datori di lavoro, con il risultato di allontanare i cittadini dallo Stato, invece di
operare affinché si riconoscessero in quello Stato stesso. Fino ai moti del 1898 – quando il generale
Bava Beccaris mise Milano in stato d’assedio e represse sanguinosamente la sommossa popolare
scatenata dalla fame, ottenendo una benemerenza per il comportamento - il padronato e lo Stato
agirono nei fatti in maniera tale da emarginare le classi lavoratrici dalla vita pubblica, democratica,
determinando una situazione di oggettivo antagonismo. Il clima sindacale mutò durante il governo
Zanardelli (1901-3), un uomo politico di Brescia che aveva esperienza del vivace clima industriale
lombardo e con il quale si inaugurò la stagione di apertura liberale proseguita dai governi guidati
da G. Giolitti.
Al III congresso delle Camere del lavoro, tenutosi a Milano nel 1900, parteciparono 18 camere, che
salirono a 57 l’anno dopo e a 76 nel 1902, di cui una ventina ottenevano finanziamenti comunali per
la loro riconosciuta utilità pubblica. Alla vigilia della guerra gli iscritti erano oltre 620.000, di cui
154.000 nel Sud. In tutte le regioni, fatta eccezione per la Basilicata, si erano costituite Camere del
lavoro; qualche piccola distanza fra il Nord e il Sud era stata colmata. Durante il periodo giolittiano
queste associazioni territoriali raccolsero più adesioni rispetto alle federazioni di mestiere,
diversamente da quanto stava accadendo negli altri paesi industrializzati. La doppia natura – la base
territoriale e quindi orizzontale, che abbraccia le federazioni di mestiere, queste ultime a base
verticale e settoriale - costituisce una delle peculiarità del sindacalismo italiano e ne rappresenta
ancora oggi l’ossatura e lo spirito. Gelose della loro conquistata autonomia le camere si
dichiaravano apolitiche e vietavano che nelle loro sedi si facesse politica.
Ogni Camera del lavoro si modellava secondo le specificità della realtà locale e in questo stava un
loro punto di forza. Agli occhi dei lavoratori, un ulteriore punto di forza derivava dal fatto che pur
rifiutando di configurarsi come organismi di classe, nei fatti mettevano in secondo piano la
composizione delle controversie – anche se proprio per questo ruolo di pubblica utilità ottenevano
finanziamenti da diversi comuni – per assumere la veste di organismi di resistenza nella direzione e
nel controllo delle lotte o delle rivendicazioni sindacali, sostituendosi alle federazioni di mestiere.
36
Ne derivavano anche frizioni con queste ultime, in particolare con quelle più forti dei lavoratori
qualificati che tendevano a un certo corporativismo, mentre ricevevano il consenso dei lavoratori
generici, non iscritti alle federazioni di mestiere e quindi poco o per nulla sindacalizzati, di cui
finivano per controllare la spontaneità, impedendo le esplosioni di ribellismo. In altre parole,
possiamo affermare che le Camere rappresentavano il mondo del lavoro, mentre nelle federazioni si
riconoscevano le categorie. Le prime promossero la solidarietà fra le seconde e, contribuendo a
sviluppare una comune coscienza del lavoro, resero il sindacalismo italiano più politico di quello
anglosassone. D'altronde, l’arretratezza delle relazioni industriali e la rigidità della classe
imprenditoriale italiana inducevano spesso le Camere del lavoro a varcare il confine fra il terreno
economico e quello politico; il distacco fra le classi lavoratrici e lo Stato, nel quale faticavano a
riconoscersi, contribuì a fare delle camere un punto di riferimento per i lavoratori e, nel medesimo
tempo, una occasione di crescita democratica.
37