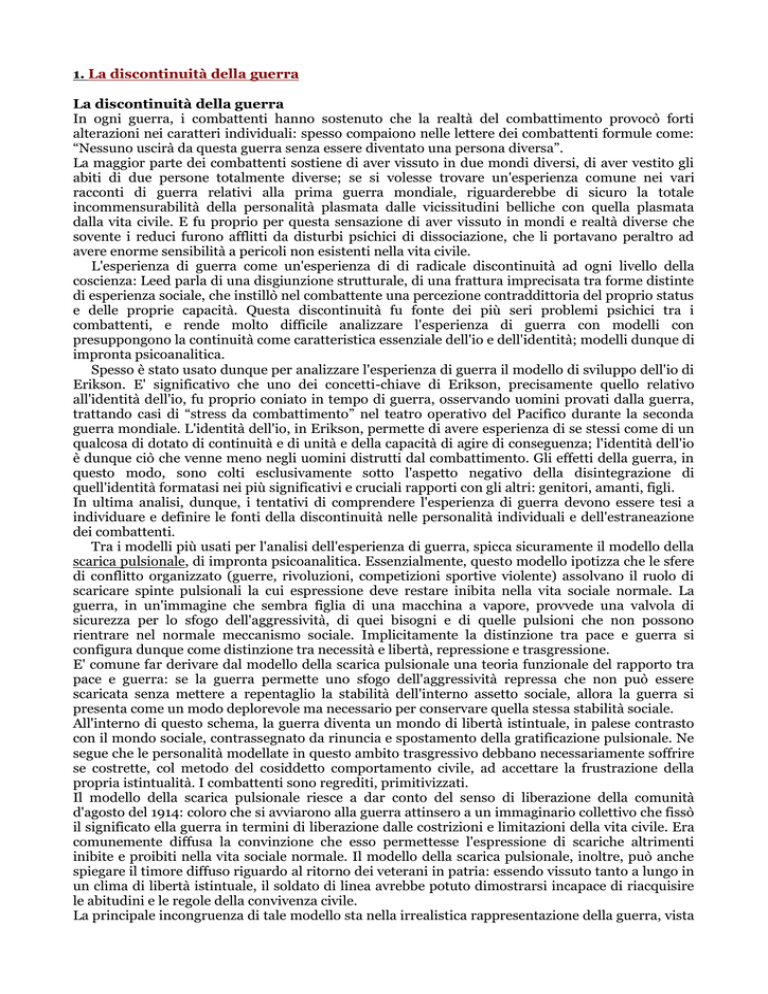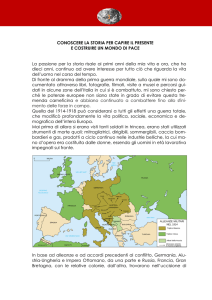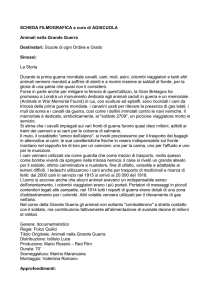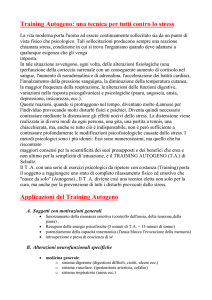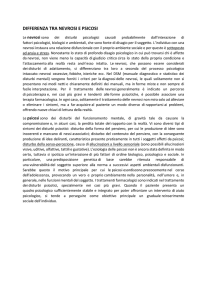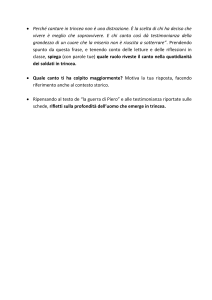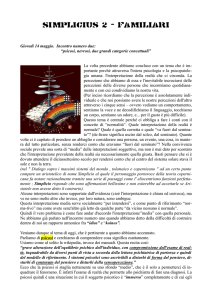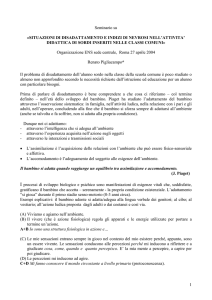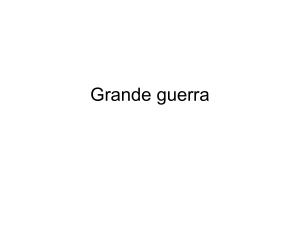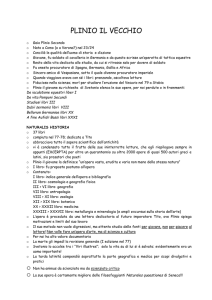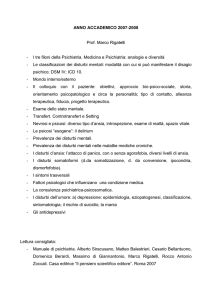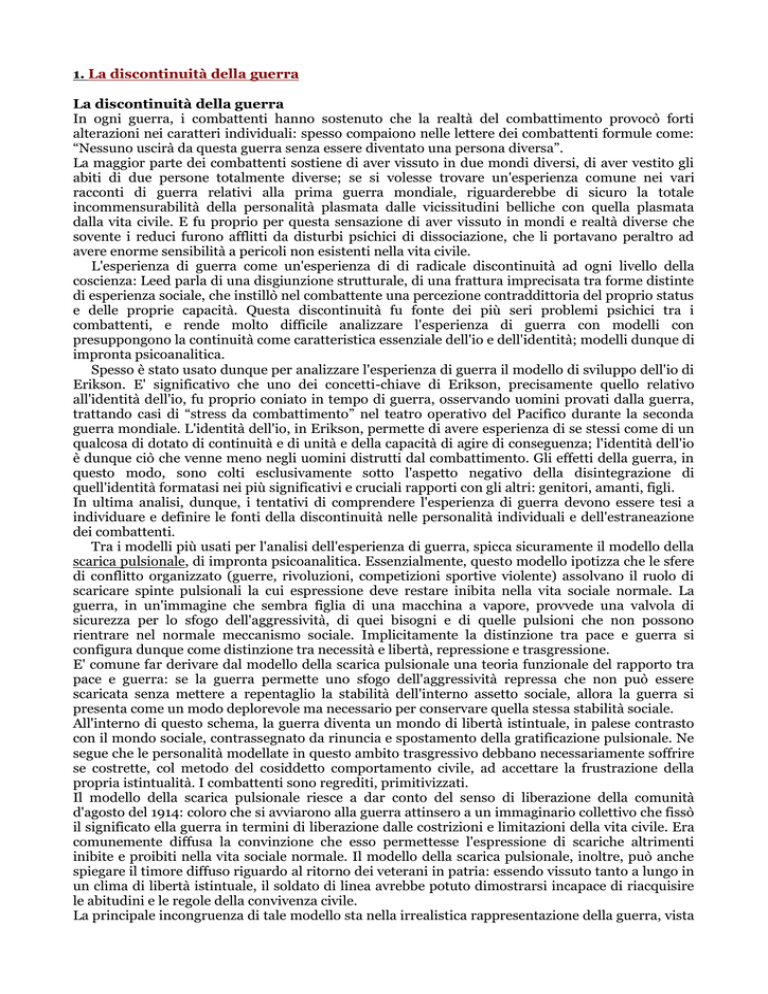
1. La discontinuità della guerra
La discontinuità della guerra
In ogni guerra, i combattenti hanno sostenuto che la realtà del combattimento provocò forti
alterazioni nei caratteri individuali: spesso compaiono nelle lettere dei combattenti formule come:
“Nessuno uscirà da questa guerra senza essere diventato una persona diversa”.
La maggior parte dei combattenti sostiene di aver vissuto in due mondi diversi, di aver vestito gli
abiti di due persone totalmente diverse; se si volesse trovare un'esperienza comune nei vari
racconti di guerra relativi alla prima guerra mondiale, riguarderebbe di sicuro la totale
incommensurabilità della personalità plasmata dalle vicissitudini belliche con quella plasmata
dalla vita civile. E fu proprio per questa sensazione di aver vissuto in mondi e realtà diverse che
sovente i reduci furono afflitti da disturbi psichici di dissociazione, che li portavano peraltro ad
avere enorme sensibilità a pericoli non esistenti nella vita civile.
L'esperienza di guerra come un'esperienza di di radicale discontinuità ad ogni livello della
coscienza: Leed parla di una disgiunzione strutturale, di una frattura imprecisata tra forme distinte
di esperienza sociale, che instillò nel combattente una percezione contraddittoria del proprio status
e delle proprie capacità. Questa discontinuità fu fonte dei più seri problemi psichici tra i
combattenti, e rende molto difficile analizzare l'esperienza di guerra con modelli con
presuppongono la continuità come caratteristica essenziale dell'io e dell'identità; modelli dunque di
impronta psicoanalitica.
Spesso è stato usato dunque per analizzare l'esperienza di guerra il modello di sviluppo dell'io di
Erikson. E' significativo che uno dei concetti-chiave di Erikson, precisamente quello relativo
all'identità dell'io, fu proprio coniato in tempo di guerra, osservando uomini provati dalla guerra,
trattando casi di “stress da combattimento” nel teatro operativo del Pacifico durante la seconda
guerra mondiale. L'identità dell'io, in Erikson, permette di avere esperienza di se stessi come di un
qualcosa di dotato di continuità e di unità e della capacità di agire di conseguenza; l'identità dell'io
è dunque ciò che venne meno negli uomini distrutti dal combattimento. Gli effetti della guerra, in
questo modo, sono colti esclusivamente sotto l'aspetto negativo della disintegrazione di
quell'identità formatasi nei più significativi e cruciali rapporti con gli altri: genitori, amanti, figli.
In ultima analisi, dunque, i tentativi di comprendere l'esperienza di guerra devono essere tesi a
individuare e definire le fonti della discontinuità nelle personalità individuali e dell'estraneazione
dei combattenti.
Tra i modelli più usati per l'analisi dell'esperienza di guerra, spicca sicuramente il modello della
scarica pulsionale, di impronta psicoanalitica. Essenzialmente, questo modello ipotizza che le sfere
di conflitto organizzato (guerre, rivoluzioni, competizioni sportive violente) assolvano il ruolo di
scaricare spinte pulsionali la cui espressione deve restare inibita nella vita sociale normale. La
guerra, in un'immagine che sembra figlia di una macchina a vapore, provvede una valvola di
sicurezza per lo sfogo dell'aggressività, di quei bisogni e di quelle pulsioni che non possono
rientrare nel normale meccanismo sociale. Implicitamente la distinzione tra pace e guerra si
configura dunque come distinzione tra necessità e libertà, repressione e trasgressione.
E' comune far derivare dal modello della scarica pulsionale una teoria funzionale del rapporto tra
pace e guerra: se la guerra permette uno sfogo dell'aggressività repressa che non può essere
scaricata senza mettere a repentaglio la stabilità dell'interno assetto sociale, allora la guerra si
presenta come un modo deplorevole ma necessario per conservare quella stessa stabilità sociale.
All'interno di questo schema, la guerra diventa un mondo di libertà istintuale, in palese contrasto
con il mondo sociale, contrassegnato da rinuncia e spostamento della gratificazione pulsionale. Ne
segue che le personalità modellate in questo ambito trasgressivo debbano necessariamente soffrire
se costrette, col metodo del cosiddetto comportamento civile, ad accettare la frustrazione della
propria istintualità. I combattenti sono regrediti, primitivizzati.
Il modello della scarica pulsionale riesce a dar conto del senso di liberazione della comunità
d'agosto del 1914: coloro che si avviarono alla guerra attinsero a un immaginario collettivo che fissò
il significato ella guerra in termini di liberazione dalle costrizioni e limitazioni della vita civile. Era
comunemente diffusa la convinzione che esso permettesse l'espressione di scariche altrimenti
inibite e proibiti nella vita sociale normale. Il modello della scarica pulsionale, inoltre, può anche
spiegare il timore diffuso riguardo al ritorno dei veterani in patria: essendo vissuto tanto a lungo in
un clima di libertà istintuale, il soldato di linea avrebbe potuto dimostrarsi incapace di riacquisire
le abitudini e le regole della convivenza civile.
La principale incongruenza di tale modello sta nella irrealistica rappresentazione della guerra, vista
come sfogo di impulsi aggressivi. La prima guerra mondiale si configura invece come repressione
generalizzata, portata da una parte dai regolamenti e dalla disciplina tipici dell'istituzione militare,
dall'altra dalle inedite e sormontabili limitazioni del movimento imposte dalla Materialkrieg, la
guerra tecnologica, che fecero della guerra un conflitto essenzialmente difensivo.
Il modello della scarica pulsionale definisce la guerra come un'attività aggressiva, offensiva, e in
base a questo, si possono spiegare, in termini di introiezione di “colpa”, i numerosi collassi nervosi
sofferti nella guerra moderna da uomini che uccidono, violando così le regole che governano la
concezione di se stessi in tempo di pace. Secondo Maxwell, fu la frustrazione dell'aggressività
(nemici invisibili → Orizzonti di Gloria) a spingere il combattente a rivolgere l'ostilità verso
obiettivi impropri.
Un secondo modello spesso usato nell'analisi della guerra è il modello della continuità culturale.
Anche questo modello vede la guerra come scarica di istinti aggressivi; ma evidenzia come la
repressione dell'aggressività acquisita del processo di socializzazione non è costituita solo da
esteriorità di cui ci si può privare senza problemi in guerra. Posto che la rimozione dell'aggressività
sia un fatto realmente acquisito, essa diventa elemento costitutivo della personalità del cittadinosoldato; nel modello della continuità culturale, l'aggressività individuale è quindi funzione di valori
e regole che governano l'aggressività in pace, e l'individuo che va in guerra teme la propria
aggressività tanto quanto quella dei nemici, per quanto possa allentare i freni delle inibizioni
culturali che porta seco.
Tutto questo è in linea con le analisi Marshall per cui solo un quarto dei soldati di prima linea
avevano impiegato le armi individuali. Il modello della continuità culturale rappresenta quindi un
correttivo all'opposizione eccessivamente radicale tra guerra e pace propugnata da coloro che
vedono la guerra in termini di scarica dell'aggressività repressa.
Tuttavia, esso non riesce a spiegare perché l'esperienza di guerra fu radicalmente differente da
quella di pace, perché molti veterani sostengano di aver vissuto in due mondi radicalmente diversi;
non spiega nemmeno perché alcuni veterani sentirono come un'attrazione verso il disordine e verso
la distruzione.
La liminarità della guerra
Molti veterani insistettero, dopo la fine della guerra, a considerare la loro esperienza alla stregua di
un'iniziazione; Carrington scriveva di far parte di una generazione di iniziati, in possesso di segreti
non comunicabili. La guerra può dunque essere considerata come un rito di passaggio,
un'iniziazione.
Il tema della liminarità è un tema antichissimo. Quando gli uomini abbandonano la loro vita
civile per combattere contro altri uomini, evocano tradizionalmente un mondo di simboli per
rappresentare la loro mutata condizione: gli uomini paiono trascendere le categorie puramente
sociali, o sprofondare al di sotto di esse; si mescolano con figure sacre o animali, assumono
sembianze divine o zoomorfe. In combattimento, il mutamento del loro essere è sempre stato
tradizionalmente rappresentato alla stregua di un'alterazione febbrile, di un'ebbrezza, di una
violenza di sapore orgiastico. Dopo il suo rientro in società, il combattente che ha ucciso in
combattimento sarà considerato come pericoloso, diverso, contaminato, fino a che non si
sottoporrà a un processo rituale di purificazione.
Il guerriero, nella cultura indoeuropea, è un personaggio anomalo, e tale anomalia è legata alla sua
stessa funzione: per difendere sicurezza e stabilità delle norme e delle regole del gruppo, deve
violare proprio quelle norme e regole che stanno alla base della stabilità della società: il maggior
pericolo che qualsiasi società possa temere risiede proprio nella possibilità che il guerriero possa
indirizzare contro amici e parenti le attività che da lui ci si attende solo contro nemici e stranieri.
Queste pericolo riceve un correttivo nella definizione rituale del guerriero come uomo che venga
momentaneamente separato dalle sue radici sociali, e tuffato insieme col nemico, con lo straniero,
in una sorta di intervallo della morale quotidiana.
L'uomo che va in guerra deve dunque sottostare ad alcuni riti di passaggio. Van Gennep divide i
riti di passaggio in tre fasi: riti di separazione, che trasferiscono gruppi di individui dal loro luogo
di vita abituale, riti liminari, che simbolicamente fissano l'identità del passeggero come dimorante
fra due stati, riti di riaggregazione, con i quali l'individuo è riaccolto nel gruppo di origine.
L'identità che connota i veterani di guerra può essere vista come funzione del passaggio dalla
sicurezza della vita sociale alla guerra, come definizione di un tipo di vita “sul confine”: non a caso,
per molti veterani il più vivo ricordo della guerra è la Terra di nessuno, ciò che “sta fra”; essa riesce
a catturare l'essenza di essere stati inviati oltre i limiti della vita sociale, tra noto e ignoto. L'
esperienza di guerra fu esperienza liminare, e i mutamenti d'identità vissuti dal combattente
possono essere definiti proprio come marginalizzazione.
Victor Tuner nota che i riti di separazione e i loro simboli peculiari possano essere attuati per
rappresentare movimenti di una società intera da una condizione o stato precedente: basti pensare
ai riti stagionali. Nella mobilitazione per la guerra del 1914 si possono scorgere due processi di
separazione tanto chiaramente distinti quanto palesemente legati: il primo allontana la società nel
suo complesso dalle abituali condizioni di vita sociale; il secondo allontana il cittadino-soldato dal
suo normale stato civile.
Il secondo stato del passaggio iniziatico, quello della liminarità, definisce una situazione formale
strettamente analoga a quella del soldato in guerra. Un giovane che affronti l'iniziazione non è più
quello che era, ma nemmeno quello che deve diventare: si lui parla come di un morto rispetto alle
cose del suo passato, e può essere trattato proprio come la sua società tratta un cadavere: è
strutturalmente invisibile. L'iniziando è infatti identificato con la decomposizione, la
contaminazione, intesa come risultato di qualsiasi contatti tra sostanze o categorie che
normalmente sono tenuti separati e distinti da regole e tabù.
Al pari della contaminazione, l'invisibilità non era solo un simbolo in guerra, ma una necessità
insopportabile. Le caratteristiche della guerra di trincea imposero al soldato di cercare rifugio nella
e sotto la terra, e questo trincerarsi significò la fine della guerra tradizionale come spettacolo di
umanità duellante; l'invisibilità del nemico esasperò l'importanza del senso acustico e ciò parve
rendere l'esperienza di guerra particolarmente soggettiva e impalpabile.
2. La comunità d'agosto e la fuga dal moderno
Molti antropologi europei hanno constatato che l'antitesi tra guerra e pace non è universale nella
cultura umana: “le guerre nella società primitiva mancano di eccezionalità e grandezza; sono
semplici intermezzi: pericolosi, ma la continuità le priva di qualsiasi connotato di eccezionalità” (R.
Caillois). Questa integrazione di guerra e scambio economico, di guerra e normale vita sociale nelle
società pre-industriali contrasta con il quadro che gli antropologi europei delinearono della propria
cultura, caratterizzata da un'implicita antitesi tra guerra e vita sociale.
Quest'antitesi fu alla base dei temi dominanti nell'esperienza d'agosto: l'esperienza della
comunità e la fuga da tutto ciò che era connesso alla nozione di moderna città industriale.
La guerra fu vista in opposizione assoluta alla vita sociale e come antipodo alla normale esistenza
nella moderna società industriale. Questa polarità tra pace e guerra permise ai contemporanei di
sentire la dichiarazione di guerra come un momento di passaggio da una vita “normale” a una
alternativa e totalmente differente: si avrebbe abbandonato la civiltà industriale coi suoi problemi
per entrare in un nuovo universo d'azione.
La logica comunitaria dell'agosto 1914
Per tantissimi, l'agosto del 1914 rappresentò l'ultima grande incarnazione del popolo come
entità morale unitaria. I giorni di agosto sarebbero stati universalmente ricordati come quelli
“vissuti più profondamente” nelle vite individuali dei partecipanti alla guerra: il senso comunitario
che spinse le folle nelle strade delle città d'Europa e legò gente fino ad allora estranea con una sorta
id magica coesione, ben di rado aveva un movente intellettuale.
Moltissimi furono convinti che la dichiarazione di guerra avesse attualizzato valori venerabili: i
valori della comunità rispetto a quelli della società, dell'unità nazionale opposti al conflitto di
classe, dell'altruismo opposti all'egoismo del puro interesse economico. Molti insistettero convinti
che la guerra avrebbe portato a a una trasformazione strutturale della società, l'abbandono del
vecchio ordine e la creazione di uno nuovo.
Agosto fu una celebrazione della comunità, e non qualcosa che si possa comprendere
razionalmente; tra le testimonianze che Leed riporta, colpiscono quelle di Zuckmayer, Hirschfeld,
Baumer.
In generale, l'esperienza comunitaria fu dominata dalla sensazione che la guerra alterasse le
relazioni tra uomini e classi sociali, e logicamente, nell'accantonare tale mondo sociale strutturato
in base a ricchezza, status, età, sesso, professione, si diede per scontato che anche i singoli individui
cambiassero. La dichiarazione di guerra istituì un'unanimità di destino e un'anonimità di
obbligazione in cui parve che le convenzioni di classe sociale non dovessero più identificare
l'individuo; la guerra superava i limiti dell'individualità e del privato, rendendo così possibile una
socievolezza più intensa e immediata.
Famosa è una descrizione di Zweig dell'entusiasmo di agosto. “Centinaia di migliaia di persone
sentivano di appartenere a una grande unità; ciascun individuo era chiamato a gettare nella grande
massa ardente il suo io piccolo e mischino per purificarsi da ogni egoismo; tutte le differenze di
classe, di lingua, di religione furono sommerse dalla grande corrente della fraternità” (Zweig).
Due particolari della descrizione di Zweig colpiscono: in primo luogo” tutte le differenze di classe,
lingua e religione” furono messe di lato, in sottordine; non però furono superate né abolite; in
secondo luogo il momentaneo accantonamento delle differenze di classe permette a Zweig di
abbandonare le proprie difese, il proprio ego e il senso di isolamento sociale.
La comunità di agosto può essere considerata come esito di sommovimenti nell'ambito degli
ingranaggi istituzionali; all'interno di tali sommovimenti, si palesarono e divennero percepibili
aspirazioni e desideri abitualmente soffocati nella vita quotidiana, ed in particolare un malcontento
di fondo nei confronti delle istituzioni che incasellavano e frazionavano gli individui: non fu
dunque un mutamento effetto di condizioni psichiche o sociali. La dichiarazione di guerra mutò
“solamente” l'angolo prospettico dal quale gli individui erano soliti guardarsi, e ciò produsse forti
sentimenti d'eguaglianza: una nuova relazione tra l'”io” e il “tu” (Buber), una “communitas
esistenziale” (V. Turner).
In definitiva, l'esperienza dell'agosto del 1914 portò a una “resa dell'io” in favore della
collettività. Questo può essere visto come esito di quel postulato culturale per cui la guerra significa
lo spostamento degli individui da uno stato definibile in termini di conflitto sociale, sessuale,
politico (uno stato, quindi, in cui l'ego era un meccanismo essenziale di autodifesa), ad un altro
stato. La “mobilitazione” avrebbe poi portato gli individui in una condizione di “flusso” in cui classi,
età e sessi normalmente mantenuti distinti sarebbero stati riuniti, non da una nuova condizione ma
da una comune direzione.
L'analogia più calzante con l'agosto del 1914 non sta nel rovesciamento rivoluzionario
dell'ordine costituito, ma nel disordine o rovesciamento momentaneo dell'ordine sociale che ha
luogo nelle feste. Roger Caillois equipara le guerra moderna alle feste pre-moderne, che
sradicavano il singolo individuo dal suo privato e dal suo mondo personale e familiare.
Sono paradigmi d'esperienza collettiva che si attua al di fuori, o fra, i distinti livelli di status
sociale in cui gli individui generalmente vivono.
La sensazione di vivere un processo, un interregnum senza una precisa struttura, fu una costante
nell'esperienza d'agosto: “il passato rimane indietro, il futuro esita, il presente poggia sul nulla”
(Rilke). Proprio tale carattere amorfo intensificò aspettative e curiosità. Thomas Mann condivideva
l'universale convinzione che la guerra avrebbe portato enormi cambiamenti: si configura dunque
come un momento liminare, precario.
Organizzano un consumo di risorse su scala non economica (“orge nel dispendio”;
Sono bene accolte come vie d'uscita dal privato.
Una metafora ricorrente è quella di fluidità, flusso, corrente elettrica (Zuckmayer). Treni e
stazioni ferroviarie furono luogo di moltissime conversioni all'entusiasmo di agosto, conversioni
invariabilmente definite come una “resa” al flusso di sentimento quasi palpabile.
Csikszentmihaly nota che molti campioni usano la metafora del flusso per cercare di spiegare cosa
trovino di piacevole in ciò che praticano, e definisce queste esperienze “stati di fluttuazione”, in cui
viene meno l'importanza della logica di agire, non vi è necessità di riflessione. Non è una
liberazione dalle regole o da un ordine, ma presume anzi l'esistenza di un copione, che restringa
l'arco di possibilità dell'attore. Gli stati di fluttuazione sono prodotto di sistemi di regole tali da
rendere l'azione, anziché contraddittoria, addirittura automatica.
La fuga dal privato fu la motivazione recondita per tanti che si tuffarono nella guerra. La vita
militare fu ben accetta come esistenza rigidamente strutturata, standardizzata, che semplificava
sistematicamente la miriade di scelte contraddittorie con cui l'individuo giornalmente si doveva
confrontare: si configura dunque come un'esperienza di perdita della paralizzante “libertà” civile.
Nella comunità cameratesca il senso dell'io come qualcosa che media tra fini ed esigenze
contraddittorie è sostituita da quella che è stata definita “eguaglianza sotto costrizione”.
Questi uomini “giocavano al gioco della struttura” (V. Turner): la struttura in questo senso
assolve il compito di incorporare e significare certi valori e desideri, anziché fornire i mezzi concreti
per realizzarli: ha un valore espressivo (dar forma a valori comunitari e fornire una via d'uscita dal
privato), anziché strumentale
Alfreg Vagts distingue tra militarismo e modo militare. Nel modo militare rientrano tutte le
cose che abitualmente gli eserciti fanno: consta dello spirito razionale, efficientistico, tecnologico,
traslato in termini razionali.
Il militarismo è un sistema di immagini, simboli, rituali designato a esprimere il personaggio del
guerriero e il carattere della comunità di cui fa parte; le vicissitudini di una vita vissuta in un
ordinamento economico differenziato e frammentato provvidero la spinta che catapultò tanti verso
la guerra, il militarismo fornì la trazione finale. Questi simboli erano intrinsecamente moderni e
borghesi.
La fuga dal moderno
L'entusiasmo per la guerra nel 1914 deve essere compreso all'interno del più ampio universo
storico ed ideologico della critica alla modernizzazione, e, in Germania, in termini di decennale
reazione, portata avanti soprattutto dai movimenti giovanili tedeschi, contro la società guglielmina.
Per Zuckmayer, la guerra significava liberazione dalla schioccheria e dalla pochezza della famiglia
borghese. Per molti intellettuali tedeschi, la guerra significò una rottura assoluta col mondo
borghese degli agi, del profitto e della sicurezza.
La guerra divenne contenitore per ideali di un ordinamento morale e di valori non utilitaristici, e
rappresentò la possibilità di riattualizzare quei valori che la vita moderna rendeva sempre più
anacronistici e che pure erano generalmente sentiti come degni di essere difesi e sostenuti.
In tanti nell'agosto del 1914 pensarono di essersi finalmente liberati dal materialismo, da un mondo
di cose concrete diventato estremamente problematico. Fuggivano verso una guerra concepita in
senso bucolico, che assumeva in sé tanto la semplicità quanto il disagio, l'insicurezza, l'avventura,
che era un salubre tuffo nel passato. La liberazione della guerra era dunque liberazione da
abitazioni civili affollate di cose ormai prive di funzione o significato.
Fu proprio la diffusa convinzione che la guerra avesse liberato la società intera dalla normalità
borghese che portò a quell'intensa identificazione con la nazione tipica dei primi mesi di guerra:
una Germania giovane e straripante d'entusiasmo metteva alla prova, contestandole, tutte le
restrizioni convenzionali che la borghese e fatiscente Inghilterra le aveva imposto a livello
internazionale. Queste emozioni eran più intense, e più intensa era l'identificazione con la nazione,
nei gruppi più isolati e alienati all'interno della società guglielmina: ebrei, giovani, marxisti,
intellettuali (Mann).
Per von Krockow, il movimento giovanile, nato nell'ambito sia della borghesia agiata sia della
piccola borghesia, fu essenzialmente un momento particolare della storica “fuga da se stessa” della
borghesia tedesca, la proiezione verso l'esterno di una frustrazione recondita maturata verso se
stessa; la guerra esternò il dilemma interiore, la schizofrenia ideologica che aveva impedito alla
borghesia tedesca di assumere quei ruoli, valori e carattere politico, generalmente assunti dalla
borghesia nelle società industriali avanzati.
Secondo Hafkesbrink, la guerra fu accolta e salutata come una liberazione perché si pensava
significasse la distruzione di un ordinamento economico, in quanto conflitto pre-economico e antieconomico. Questo fece della guerra un fenomeno “morale” in diretto contrasto con l'amoralità del
mercato.
Secondo Veblen, la crisi dei valori in Germania fu tanto più sofferta e intensa in virtù del fatto
che l'industrializzazione pretese di riunire tecnologia moderna e modi di pensare pre-industriali: il
risultato fu l'emergere di lotta di classe, oggetti d'uso replicati senza limite, nuovi livelli di consumo
e nuovi valori. L'industrializzazione produsse nuove classi sociali e conflitti tra di esse; ma
produsse anche pressioni importanti sulle classi possidenti. Per costoro, il processo di
industrializzazione produsse una crisi in quelli che Veblen chiama “livelli morali di vita”: non erano
più impegnati a strappare maggior valore possibile dai pochi beni disponibili, ma a consumare
l'eccedenza generata dall'enorme crescita del potenziale produttivo, a sostituire l'etica del
risparmio con l'estetica del consumo. Il mondo materiale di merci, e non la tecnologia in se stessa,
divenne fonte di disagio morale.
In Clausewitz, la guerra “è la prosecuzione della politica con altri mezzi”. La guerra è un secondo
universo, un'esistenza alternativa, dotata di una sua alterità, che sarà essenziale nell'entusiasmo
dell'agosto 1914
L'idealismo della generazione della Grande Guerra non era funzione dell'inesperienza, ma di una
convinzione che attingeva all'arcaico: esistevano due mondi di esperienza, e due livelli su cui la vita
poteva essere vissuta.
Il persistere delle aspettative
Leed dunque rifiuta l'interpretazione della guerra sulla base del modello di “scarica pulsionale”,
per cui le cause della guerra stessa vanno individuate in tensioni endemiche inerenti alla società in
fase di modernizzazione. Ciò è corretto, ma porterebbe a pensare che la guerra era sentita come
uno spazio libero per lo sfogo istintuale, mentre essa era elemento di violenza bene strutturato. Il
modello di scarica pulsionale è uno strumento valido nell'analisi di ciò da cui pensavano di
sottrarsi coloro che avallavano la guerra: ma non di ciò verso cui pensavano di fuggire: la volontà
d'affermazione di valori culturali sovente considerati anomali o obsoleti rispetto a ciò che siamo
abituati a definire cultura borghese.
L'abbandono dell'individualismo, la ricerca di un'uscita dal privato, l'accettazione id una vita di
obbedienza e eguaglianza sotto comando e costrizione non significavano una fuga nella libertà, ma
dalla contraddizione. La guerra non era vista come contraddittoria: non richiedeva un io, e
permetteva un contatto autentico tra volontà umane.
3. Il labirinto della guerra e le sue realtà
E' comune reperire un'equazione tra esperienza di guerra e rituali di passaggio nella maggior parte
della letteratura di guerra. Quest'equazione è però assurda: i riti d'iniziazione non uccidono o
storpiano i novizi.
1. Ma in guerra, così come nel rituale, gli individui non apprendono semplicemente attraverso
lo strumento linguistico, ma attraverso la loro immersione nella struttura drammatica
dell'evento fisico: l'esperienza di guerra è un'esperienza di apprendimento non verbale,
concreta, molteplice, “maestra silenziosa che insegna a divenire silenziosi”.
2. Inoltre, la conoscenza ottenuta in guerra è raramente ritenuta alienabile, cioè qualcosa che
può essere insegnato, uno strumento o un metodo: più spesso è descritta come qualcosa di
integrato al corpo del combattente.
Le metafore nella guerra e il labirinto delle trincee
La metafora essenziale della guerra di trincea è quella del labirinto. Queste metafore divennero
veicolo di spiegazione delle esperienze e dei sentimenti più profondi di uomini invischiati in un
groviglio inestricabile di contraddizioni fisiche e psichiche. La metafora del labirinto è idonea a
simboleggiare la natura frammentata, disintegrata e disgiuntiva del paesaggio in cui erano inseriti i
combattenti della guerra di trincea.
Carrington scrive che il soldato che si sposta nelle trincee avendo in mente una destinazione
precisa, si troverà davanti una sconcertante profusione di possibilità, tutte potenzialmente erronee
e fuorvianti, e questo creerà una forte ansia nell'individuo. Lo scrittore sottolinea anche gli effetti
della “storicità” del complesso di trincee: un sistema che inizialmente era stato costruito secondo
un progetto, ma in cui, dopo un certo periodo di tempo, dopo distruzioni e riparazioni senza fine,
non vi saranno più passaggi diretti a determinate destinazioni, ma solo sequenze di tronchi
disorientati; l'effetto finale sarà la sensazione di vivere in un'allucinante precarietà che produce
confusione ed esaurimento psichico.
Mentre Carrington ha sottolineato che le caratteristiche del labirinto di trincee ponevano di
fronte a un'apparente, ma in realtà paralizzante, libertà di scelta, nella descrizione di Barbusse
anche tale illusione di scelta svanisce. Il labirinto di trincee annulla ogni speranza di uscita; è un
modo completamente chiuso, sotterraneo, che appare come una sorta di struttura iniziatica che
conduce il combattente in prossimità del “cuore terribile di tutte le cose”; per giungere al centro, il
combattente novizio dovrà superare una serie di prove, la sopravvivenza alle quali apporta un
mutamento irreversibile al suo status esistenziale.
La metafora del labirinto, dunque, è una rappresentazione della realtà in cui si inquadra
l'esperienza dei combattenti; ma è un rappresentazione che può essere impiegata per definire una
guerra in cui l'intelligibilità dell'essere umano sta per essere sconvolta, per essere il simbolo del
destino degli uomini in guerra, una guerra iniziata per realizzare il destino delle nazioni coinvolte,
ma divenuta poi un nodo, un groviglio di direzioni incrociati che esauriva le energie di coloro che vi
incappavano.
Classe sociale e disillusione: il volontario e l'operaio
Coloro che si presentarono come volontari provenendo da classi medio-alte trascorsero non più
di un anno nei ranghi, quindi ebbero accesso alle scuole allievi ufficiali per tornare al livello della
loro classe d'origine. I volontari di classi medio-alte, all'incontro con i soldati di classi inferiori,
appresero due cose: che la loro attitudine verso la portata sociale della guerra, verso la nazione e la
patria era ben di rado condivisa dai portuali, contadini, operai, minatori loro commilitoni; ed
inoltre conclusero che la loro concezione della guerra come comunità di destino in cui si sarebbero
dovute riconoscere tutte le classi sociali erano solo un'illusione, frutto del loro idealismo ed
innocenza iniziali. Questo non è un effetto necessario di tutte le guerre, ma della particolare guerra
del 1914-1918, caratterizzata dall'incapacità delle ideologie dominanti fossero di integrare il soldato
semplice nell'ambito di un progetto comunitario e nazionali.
Molti volontari trasformarono la guerra in un movimento popolare, nell'espressione di un senso
comunitario di sacrificio di sé. L'atto del volontariato, per costoro, fece dell'entrata in guerra una
scelta liberatoria. L'entrata volontaria in guerra fu un atto che aprì una durissima contrapposizione
tra volontario e soldato semplice: agli occhi di quest'ultimo, il volontario rappresentava un
giocatore, un irresponsabile, una personalità dubbia.
Le differenze di classe sociale stavano a significare i diversi modi di accesso all'esperienza di guerra
(coscrizione o volontariato): ma questa diversità comportava anche differenze d'attitudine nei
confronti della guerra. Per il soldato operaio, la guerra significò un nuovo insieme di mansioni
contrassegnate da fatica, sporco, coercizione; per il soldato giocatore, invece, offriva la possibilità
di realizzare virtù ormai obsolete nella moderna civiltà industriale.
Ma in guerra, a differenza che in tempo di pace, gli operai potevano colpire direttamente il
padrone, demolendole le aspettative. Zuckmayer sostiene regolarmente i soldati-operai
prendevano ferocemente di mira quei giovani. Rappresentanti di una certa condizione, che
beneficiavano di ricchezze, vantaggi, possibilità di consumo fuori dalla portata del soldato-operaio
stesso; eppure, si crucciava Zuckmayer, questi privilegi erano precisamente cose che aveva voluto
ripudiare all'atto di arruolarsi volontario.
Zuckmayer percepiva di essere umiliato per il suo status sociale di provenienza, e canzonato
proprio per aver ripudiato tale status; la sua scelta di arruolarsi, da lui intesa come atto di
liberazione, veniva dai camerati intesa come una conferma della libertà dalle necessità goduta dalla
gente della sua classe.
La differenza fondamentale tra lo “spirito ludico” del volontario e gli altri soldati stava nelle
attitudini contrapposte riguardo la vita al fronte; per il volontario, la vita era qualcosa che
acquistava valore attraverso il sacrificio; per il lavoratore, era qualcosa da preservare ad ogni costo.
Il volontario era odiato e disprezzato non solo perché rappresentava una classe sociale più alta, ma
anche perché la sua etica del sacrificio e la sua abnegazione potevano scatenare reazioni che
avrebbero messo in pericolo l'esile tregua su cui si bava la possibilità di sopravvivenza dei più.
L'essenza della disillusione del volontario fu l'accorgersi che la guerra era lavoro, e il
cameratismo dei soldati poco aveva di diverso dalla comune soggezione quotidiana alle necessità
del lavoro manuale. La guerra non era luogo di eroismo; il mutamento d'identità esperito in guerra
è sinonimo di “imparare a diventare uno qualsiasi”, una proletarizzazione militarizzata:
“cambiammo presto il mantello luminoso dell'eroismo con la sporca tuta dell'operaio”.
Nella prima guerra mondiale la disillusione portò ad avvilimento sociale e spirituale. In questa
guerra i soldati persero i loro ideali, il loro senso morale, i loro più nobili e alti propositi: si videro
costretti a rassegnarsi all'onnipotenza di quelle realtà materiali che erano già note alla classe
operaia industriale. In guerra disillusione significò perdita di status sociale ed esistenziale, un
processo di auto-ridefinizione attraverso realtà che possedevano una valenza morale ed esistenziale
notevolmente inferiore alle aspettative iniziali.
La guerra fu quindi esperienza di vita formalmente “senza classi” in cui però le differenze e le
tensioni di classe erano acutamente sentite da e tra gli individui; il termine “cameratismo” cambiò
di significato nel contesto della guerra di trincea. In agosto, si credeva che la dichiarazione di
guerra avrebbe cancellato le basi materiali del sentimento di classe, verso la creazione di una
Gemeinschaft. Questo sentimento comune si rivelò completamente illusorio. Lo stesso entusiasmo
e le stesse aspettative dei volontari li bollarono, agli occhi dei soldati-operai, come membri di una
società che godeva di una particolare libertà dalle necessità.
Tale bruciante disillusione del volontario medio-borghese può essere vista come espiazione di
un senso di colpa sociale da tempo accumulatosi. Junger, alla fine della guerra, la percepiva come
una Materialkrieg in cui il soldato era vittima della liberazione sulla sua testa di milioni di ore di
lavoro di operai industriali oggettivate in milioni di tonnellate di bombe; la guerra industrializzata
puniva i figli per i peccati dei padri.
La prima guerra mondiale non fu solo lavoro, ma lavoro alienato, una guerra che invalidò
l'osservazione di Marx secondo cui la società capitalistica avrebbe comportato la distruzione di
uomini al fine della produzione di merci: nelle trincee l'unico scopo della guerra era di distruggere
uomini e merci. La presa di coscienza della guerra come lavoro portò al sollevarsi con nuova
intensità quelle questione che si erano credute risolte con la sua dichiarazione: il rapporto tra classi
sociali sfruttatrici e sfruttate, il rapporto degli uomini con i mezzi di produzione, il rapporto tra
padroni e operai della guerra.
La realtà tattica del caos
La guerra porto alla constatazione di quanto la potenza della tecnologia paralizzasse le
possibilità di movimento umano: “la tirannia della tecnologia regnava in modo ancora più
onnipotente in guerra che in tempo di pace”, e la guerra di trincea altro non era che il prodotto
diretto di un secolo di sviluppo tecnologico, che aveva portato, in particolare, all'incremento della
portata e del volume di fuoco del fucile moderno.
La contraddizione centrale della guerra di trincea sorse quindi da problemi inerenti la tecnologia
di guerra: i mezzi per ottenere specifici obiettivi militari apparvero non funzionali: causavano più
problemi di quanti ne risolvessero. Generalmente, dopo il fuoco preparatorio di sbarramento
dell'artiglieria, gli attacchi si spegnevano sul filo spinato, sotto il fuoco di una mitragliatrice e di
pochi fucilieri. Ma anche quando un attacco iniziale aveva successo, non era seguito da un'offensiva
generale: più pesante era il bombardamento impiegato per creare una breccia nelle linee
avversarie, più difficile diveniva muovere le masse di fanteria e gli equipaggiamenti necessari:
l'artiglieria rendeva infatti il terreno impercorribile ed accidentato, impedendo alle riserve di
consolidare il risultato ottenuto nell'attacco; il nemico riusciva così a trincerarsi su di una nuova
linea difensiva.
I soldati della Grande Guerra erano comunque dotati di una precisa e concreta concezione della
guerra reale, quella che ha sintetizzato Clausewitz. Lo studioso definisce la realtà di guerra come
attrito, qualcosa ovvero che non può essere raffigurato perché sta alla base di ogni raffigurazione
della guerra. Tutti questi attriti che frustravano la realizzazione di un piano – maltempo, incidenti,
affaticamento, problemi nelle comunicazioni – sono definibili come “realtà di guerra”. La guerra si
configura quindi come “movimento in un mezzo resistente”, che nella prima guerra mondiale fu il
fuoco; l'esistenza di un soldato di linea è “attrazione gravitazionale nel regno del fuoco” (Junger).
Le condizioni della guerra di trincea affrettarono una trasformazione nell'ambito della tattica
difensiva.
All'inizio del periodo della guerra di trincea, si pensò che difesa significasse tenere la prima
linea di trincee; la seconda e la terza linea avrebbero funzionato come rifugio in cui i
difensori battuti avrebbero potuto ritirarsi, e punto di concentramento per le riserve che
avrebbero dovuto rimpiazzare le perdite subite. Questa rigida concentrazione sulla prima
linea si rivelò irrazionale e omicida. Questa fissazione sulla prima linea era incomprensibile
in senso tattico; può essere compresa però facendo riferimento alla tradizione militare.
La linea era la più chiara rappresentazione di un confine, riassumeva l'elemento agonale della
guerra.
Nel 1916 nacque la “difesa elastica”, che puntava su una maggiore flessibilità nella guerra di
trincea. La prima linea doveva essere tenuta con minore ostinazione, e abbandonata nel
caso il nemico fosse riuscito a raggiungerla; la posizione sarebbe poi stata riconquistata
mediante contrattacco di forze fresche dalla seconda e terza linea. Junger paragonò la difesa
elastica a un nerbo d'acciaio che si sarebbe teso all'indietro sotto l'urto dell'attacco nemico,
per poi schioccare in avanti spazzando via gli avversari; era però per Junger
“psicologicamente debilitante”, perché lo “scansare” l'attacco nemico era profondamente
contrario alla natura della guerra.
Verso la fine della guerra si delineò una concezione difensiva più adeguata, quella della
“difesa in profondità”, che rinunciava a ogni teorizzazione della linea; significava
frammentazione della coerenza di qualsiasi struttura geometrica e dissoluzione della
compagnia in piccole squadre indipendenti. L'immagine corretta è invece quella di una rete,
in cui il nemico sia in grado di penetrare qua e là e poi essere immediatamente avvolto dalla
resistenza delle maglie su tutti i lati.
Da tutte le descrizioni delle maggiori battaglie, emerge la stessa percezione: la battaglia moderna è
la frammentazione delle unità spaziali e temporali, un sistema senza centro né periferia, in cui tutti
i soldati sono smarriti. Schauwecker deifica coloro che sopravvivono alle battaglie di materiali,
vedendoli come uomini passati attraverso una sorta di selezione artificiale. L'eroe di questa guerra
non incarnava una personalità dunque offensiva, ma difensiva.
La personalità difensiva
Ashworth sostiene che la guerra non sia necessariamente un'esperienza “alienante”. Se infatti
validamente propagandata dallo stato, forte dell'appoggio della società e diretta ad un nemico che
rimane odioso ed estraneo, la violenza non porta ad autoestraneazione, e non esiste disgiunzione
tra sfera emotiva e attività pratica. L'ufficiale addestratore tratterà il soldato nello stesso modo in
cui pretende che il soldato tratti il nemico in battaglia; in caso di successo, il procedimento indurrà
la recluta a una regressione psicologia durante cui il suo carattere verrà ristrutturato in personalità
offensiva, e sparare ed uccidere sarà percepito come morale e legittimo.
La guerra di trincea erose le concezioni universalmente diffuse del soldato come personalità
offensiva, come aggressore, e produsse un tipo di personalità, quella della personalità difensiva. In
una guerra in cui tutti i combattenti erano vittime indiscriminate della violenza dei materiali, in cui
la tecnologia era l'autentico aggressore, l'identificazione con il nemico e la sua motivazione
dominante, la sopravvivenza, erano logiche, necessarie (fraternizzazioni, taciti accordi tra nemici
che stabilivano e mantenevano “settori tranquilli”).
Le restrizioni al comportamento ostile imposte al fronte, che ritualizzavano la violenza, non
nacquero da tradizioni militari di rispetto o da attitudini umanitarie, ma dalle stesse condizioni di
quella guerra, in cui lo “spirito offensivo”, che avrebbe dovuto caratterizzare i rapporti tra i nemici,
si configurava come chiaramente suicida. Non si parla dunque di etica pre-bellica, ma della
semplice prossimità con il nemico, quei “russi dalle barbe rosse” di Kreisler (Austria-Russia).
L'abbassarsi della soglia ostile nella guerra di trincea ebbe per effetto l'intensificazione dell'odio
delle truppe di linea per lo stato maggiore, che continuava a pretendere comportamenti di
“molestia continua”, denotanti spirito offensivo. L'estraneazione dalle norme offensive di
combattimento, dal ruolo di soldato-guerriero, inoltre, implicava estraneazione dai valori e dalle
convinzioni che dovrebbero sostenere una nazione in guerra: valori di coraggio, onore, sacrificio,
eroismo apparivano ormai attinenti al mondo delle illusioni, distante, esterno al sistema di trincea.
Nel penetrare il labirinto della guerra, il volontario s'accorse innanzitutto del carattere illusorio
della concezione di se e dei propri camerati come attori di una causa nazionale; nella disillusione
iniziale, smarrì la concezione trascendente di se stesso e del proprio ruolo, e perse il contatto
ideologico che lo legava alla patria.
Ma nel contesto della guerra di trincea avvenne un'altra estraneazione ben più radicale: il soldato
di linea si sentì sempre più avulso da ogni fonte professionale, militare: fu privato di tutti i simboli
di “casta, fede e convinzione” del “militarismo” di Vagts.
Il soldato di linea acquisì in guerra un carattere ben definito. Per difendersi dall'imposizione di sé
come di un latore d'offesa per conto di una volontà nazionale, il soldato si vide costretto ad
assumere interiormente l'abito di anonimo operaio, sminuendo fortemente il proprio status bellico.
4. Mito e guerra moderna
Dopo la guerra, fu molto diffusa la credenza che la guerra fosse stata per milioni di uomini scuola
nell'arte della violenza; ben pochi sospettarono però che le realtà di questa guerra avessero
frustrato l'aggressività al punto da trasformarla in ostilità interiorizzata. Le condizioni di guerra
generarono nel soldato una repressione dell'io aggressivo che spesso assunse forme fantastiche; ma
dopo la fine del conflitto, ebbero modo di manifestarsi nella relativa sicurezza nella vita politica e
sociale.
Mito e realtà
Paul Fussel nota il paradosso tra la realtà di questa guerra e il tipo di coscienza che generò. Si
tratta della prima guerra moderna, industrializzata, tecnicizzata, eppure essa produsse miti,
fantasie e leggende che sono riconducibili a mentalità più arcaiche: la produzione immaginaria dei
combattenti, i miti, le fantasie e i rituali originati dalla guerra di trincea sembrano in stridente
contrasto con la modernità della guerra stessa.
In generale, i miti di guerra vanno considerati come necessarie articolazioni delle realtà
fenomeniche da parte dei combattenti, e non semplici ricezioni false di tali realtà. Nei miti più
significativi, infatti, si può intravvedere un'interpretazione di quelle costrizioni che
immobilizzarono le vite dei fanti nelle trincee, che suscitarono concezioni desuete della guerra e del
combattente. I miti e le fantasie di guerra tentarono di far rivivere queste concezioni in un nuovo
ordine di realtà: cercarono insomma di colmare il gap tra le aspettative iniziali e la sconcertante
realtà di fatto.
L'impatto della guerra sull'apparato sensorio dei combattenti è il punto da cui è necessario
prendere le mosse per comprendere la necessità dell'immaginazione, delle fantasie, del mito.
L'invisibilità rese l'udito dei combattenti più utile della loro vista nell'individuare le fonti di
pericolo, e l'immobilismo fece del movimento una potenzialità fantastica, magica, qualcosa cui dar
forma in sogni, leggende e miti.
Molti psicologi han sostenuto che la guerra effettuò una regressione psichica nei combattenti, verso
un luogo ove non operino realtà coattive; miti e fantasie sarebbero dunque vie d'uscite dalle realtà
coattive moderne e militari. Si parlerebbe dunque di una “primivitizzazione” dei combattenti;
questa ipotesi però è ritenuta da Leed eccessivamente semplificante.
Levi-Strauss vede il mito come una “speculazione” inconscia che intrattiene una relazione
complessa con la cultura che lo genera, alleviando le contraddizioni attraverso una ristrutturazione
degli elementi di conflitto della realtà. Il mito isola focalizza e inquadra uno o più degli aspetti del
contesto sociale per mostrarne le virtualità latenti, come per riconoscerne, d'altro canto,
l'impossibilità e l'irrealtà di quello stesso aspetto se spinto agli estremi.
Per quanto riguarda la guerra, le dimensioni aeree e sotterranee fornirono i particolari di uno
schema che permise ai combattenti di selezionare la loro esperienza, evidenziarne certi aspetti e
ricombinarli in sequenze in grado di effettuare la modificazione delle aspettative della guerralavoro.
E' anche presente l'articolazione orizzontale del fronte in zone di pericolo: retrovie, trincee di
riserva, prima linea, Terra di nessuno. Le retrovie fornivano numerosi spunti per lo sviluppo di
temi bucolici, e le linee avanzate invece per l'evocazione del carattere demoniaco del mondo
tecnologico. I miti di guerra sono sempre legati al tema della mobilità, la cui impossibilità per i
soldati trova una soluzione appunto nel mito.
Sia il mondo bucolico che il tecnologico forniscono strumenti idonei al passaggio mitologico,
fissando diverse immagini della mobilità; il soldato che trascorre il proprio turno di riposo nelle
retrovie si trova immerso in un universo non resistente, in cui la mobilità è forzatamente oziosa ed
è mezzo per riflettere sulla propria esperienza. Ma la relazione tra pastorale e tecnologico non è di
antitesi pura e semplice: esiste un'immagine bucolica positiva e una negativa. L'eroe del bucolico
non è sempre un Titiro, ma a volte è anche un bruto, un villico, istupidito dalla fatica del proprio
lavoro.
La frammentazione della coscienza visiva e la fantasia del volo
Le condizioni di guerra nell'ambito del sistema di trincea produssero un grande disorientamento
nella maggior parte di coloro che vi presero parte. Questa crisi di orientamento produrrà il bisogno
di una visuale complessiva coerente, quella attribuita all'aviatore.
L'invisibilità del nemico, la necessità di trovare riparo nella terra, il frastuono del fuoco di
sbarramento concorsero a sconvolgere quelle strutture stabili che normalmente sono impiegate
nella definizione della sequenzialità. Molti veterani che tornarono sui luoghi dove avevano
combattuto furono colti da un'impressionante sensazione d'incongruità spaziale: le trincee
apparivano più piccole di quanto non fosse loro sembrato durante la guerra. I veterani, così come
coloro che rivisitano i luoghi della loro infanzia, furono impressionati dall'abisso tra come le cose
apparivano ora e come se ne aveva fatto esperienza un tempo: in guerra i ristretti spazi di vita
erano stati ampliati dalla fantasia.
Nella sua analisi delle organizzazioni sensoriali che pare distinguano la cultura moderna da
quella pre-moderna, Carothers sostiene che suono e magia siano compatibili, così come vista e
demistificazione. Nelle culture alfabetizzate, dunque, l'orecchio diverrebbe organo puramente
secondario. In base a questa tesi, lo sconvolgimento della possibilità di sintesi visiva tipico dei fanti
della guerra di trincea creò un clima di ansia e paura che introdusse molti soldati alla pratica
magica, alla superstizione: i soldati cominciarono a vedere se stessi e il loro mondo come vittime di
forze malefiche che avrebbero dovuto essere propiziate attraverso formule e rituali magiche.
Le circostanze della guerra, il dominio acustico e l'impossibilità di una difesa attiva efficace,
produssero un concetto del rapporto tra individui e forze che li sovrastavano molto più vicino allo
spirito magico che a quello tecnologico, in cui la scaramanzia era necessaria ai soldati per
mantenere un minimo di controllo sulle forze che lo dominavano e funzionale nella misura in cui lo
scongiuro riesce ad alleviare ansie che paralizzerebbero capacità d'azione. Qui è chiaramente
evidenziata la contraddizione di cui parla Fussell. L'affidamento alla scaramanzia può essere visto
quindi come risultato di un profondo senso di impotenza individuale di fronte alla violenza
governata dalla tecnologia.
Leed nota inoltre come in molta letteratura di guerra appaia che il frastuono dello sbarramento
d'artiglieria sconvolgesse ogni modello razionale di causa ed effetto, di coerenza logica e
sequenzialità temporale, permettendo il ricorso alla pratica scaramantica.
Ulrich Neisser divide le forme di organizzazioni di pensiero in “sequenziali” (in cui ogni idea segue
alla precedente, necessaria, in modo non contraddittorio) e “parallele” (prive di sequenzialità
coerente, in cui molte attività vengono svolte indipendentemente l'una dalle altre.
Tornando alla dicotomia di Fussell, si può affermare che la magia operi attraverso processi di
pensiero paralleli, mentre la tecnologia su processi sequenziali (basti pensare al metodo
scientifico). Per Leed, il deteriorarsi del campo visivo caratteristico della guerra di trincea portò a
una sorta di malfunzionamento dei processi di pensiero sequenziale. Anche nell'etnomusicologia
appare come il fracasso del tamburo faccia precipitare nella dissociazione, nella trance, nel
pensiero quindi parallelo.
Questo, secondo Leed, può dar conto di alcune connessioni tra il frastuono del bombardamento e
l'alterazione del proprio stato di coscienza descritto dai combattenti. La limitazione visiva eliminò
la maggior parte di quei segni che permettono agli individui di elaborare la loro esperienza in
termini di problemi risolubili in una sequenza razionale; il frastuono pazzesco che dominava il
fronte portò effetti di disorientamento assoluto, che favorirono il pensiero parallelo privando gli
individui della loro facoltà di pensare in modo razionale e sequenziale.
Uno dei miti più significativi della guerra fu la prospettiva aerea, quella comunemente attribuita
all'aviatore. La necessità di questo mito risiede precisamente nella frammentazione delle percezioni
e delle finalità del soldato di linea: il mito del volo viene visto come l'ultima sponda del
comportamento cavalleresco, è chiaramente un concetto compensatorio. L'aviatore era una figura
reputata ancora in grado di destreggiarsi tra le aspettative annientate dalle condizioni della guerra
di trincea: assumendo la prospettiva dall'alto, avrebbe potuto distanziarsi psichicamente dalle
schiaccianti condizioni di guerra, dagli angoli e le giravolte del labirinto delle trincee.
L'aviatore combatteva una guerra pre-industriale con armi della tecnologia più moderna,
ereditando i valori – mobilità, onore, visibilità personale, capacità visiva complessiva, che
caratterizzavano un tempo la cavalleria corazzata medievale, e che erano stati smarriti dalla
fanteria di trincea.
Nelle circostanze di guerra, qualcosa che era servito come metafora letteraria, ovvero la
contrapposizione tra cielo e terra, assunse una valenza psichica. In Freud, il sogno di morte del
sognatore viene interpretato come rappresentazione di una dissociazione della coscienza; il
sognatore osserva sempre la propria morte come uno spettatore, sopravvivendo come osservatore.
La stessa facoltà di immaginare una prospettiva esterna alla propria morte agisce come garanzia di
sopravvivenza, assicurando che la propria morte altro non è che un sogno.
Le realtà di guerra imposero ai combattenti di assumere un rapporto introspettivo nei confronti di
se stessi; questa facoltà generò un tipo di prospettiva che Junger definisce “stereoscopica”, che
permetteva all'individuo, come persecutore, di osservare se stesso come vittima. Il cielo, così, viene
caricato di un intenso significato: deve essere la residenza di un osservatore che assiste alla propria
lotta nell'incubo della guerra, perché solo in queste condizioni l'occhio può sopravvivere allo
smembramento del corpo; la creatura fantastica è un'identità proiettata, una persona mitica
chiamata “La Guerra”.
Molti si convinsero dunque dell'esistenza di un occhio semi-divino che superasse la loro
limitatissima prospettiva, che nn soffrisse nulla, una creatura con volontà e scopi precisi in
contrasto con la loro impotenza.
Guerra sottoterra
I fanti definirono se stessi come moderni cavernicoli. L'esperienza che era stata inizialmente
acclamata come liberazione dalle convinzioni sociali e come inizio di una vita più semplice, più
naturale e più sana era divenuta, con la guerra di trincea, un'esistenza in una dimensione inedita di
follia, una vita sotterranea in cui l'immobilità non aveva mai pace. Nei romanzi di Barbusse, un
soldato scoprirà un'ascia dell'età della pietra mentre lavora ad una trincea di collegamento, e la
adotta come arma bianca supplementare; è quindi chiaro come l'esperienza di trincea sia
equiparabile al combattimento primitivo.
Ma sotto la superficie era credenza comune che l'elemento terragno rafforzasse la statura umana
e le virtù militari, anziché svilirle. La guerra di gallerie e mine rappresentò il condensato di quanto
di più oppressivo offrisse la guerra di trincea. Il silenzio, il buio, la mancanza d'orientamento e la
pressoché insopportabile tensione psichica sofferti dai soldati del genio costituirono
l'intensificazione dell'esperienza ordinaria di guerra di trincea. Lo scopo della guerra di mine
consiste nel portarsi sotto al nemico, interrompere le gallerie che egli sta sviluppando contro
l'avversario, e cercare di far saltare le sue stesse trincee. Proprio come l'aviatore poteva sorvolare il
regno del fuoco, lo zappatore poteva scivolarci sotto: questo fece dello zappatore una figura di
alternativa immaginaria per coloro che popolavano la superficie.
La guerra sottoterra solleva un complesso di simboli convenzionali, antichi e moderni, che sono
stati connessi ai concetti di cambiamento e trasformazione più come ricombinazione di elementi
che come loro trascendenza. La funzione della mina, sia come simbolo che come realtà, è di
annullare ogni speranza di fuga, liberazione o trascendenza; il lavoro di miniera, come quello di
fucina o di officina, è luogo di operazioni meccaniche e tecniche che conferiscono uno statuto
sociale ambiguo a chi le pratica.
Eliade sottolinea come minatori, fabbri e fonditori siano sempre stati considerati praticanti
professionisti delle trasformazioni della materia, attività viste come ambigue, potenzialmente
pericoloso; i minatori vedono se stessi non come violatori della terra materna, ma come assistenti
delle trasformazioni materiali oggettive; i canti, le formule e i rituali dei fabbri identificano la
fornace come grembo artificiale che affretta con il suo fuoco la gestazione dei metalli puri; gli
alchimisti vedono nelle proprie operazioni il perfezionamento sia della materia che di loro stessi.
Eliade nota che i simboli che accompagnano il lavoro di minatori e fonditori sono uguali a quelli
che accompagnano i riti di passaggio in generale – simboli di morte, sessualità, rinascita.
Molto spesso fabbri, minatori e alchimisti sono accostati agli stregoni, proprio perché venivano
identificati con le stesse trasformazioni che praticavano; erano considerati una razza a parte.
Lewis Mumford indica la maniera e l'attività del minatore molto prossime al contesto della guerra;
e la miniera è il simbolo perfetto dell'età paleotecnica dell'industrializzazione, ovvero di un periodo
di sviluppo dell'industria pesante, caratterizzato dallo sfruttamento di quantità, massa e potenza al
di là di ogni proporzione funzionale.
Il parallelo tra l'età paleotecnica e la guerra di trincea trova massima realizzazione nel caso di
guerra di mine sottoterra. Le descrizioni di questo tipo rievocano tutti i temi di proiezione,
mancanza di spazio e perdita d'orientamento richiamati da Mumford nella sua descrizione delle
miniere: si parla dunque di “immagini di terrore”, paure arcaiche, timore di star violando un essere
vivente, madre o mostro che sia, stimolata dalla totale preclusione visiva e dal comprendere di
trovarsi immersi nella “immensità della materia inerte”.
Caratteristica essenziale dell'ambiente della miniera è la distinzione tra il dentro e il fuori, la
chiusura totale. Questo fa sì che le domande rimbalzino tutte su chi si pone, e che l'ambiente della
miniera diventi lo scenario perfetto delle trasformazioni interiori, della ristrutturazione della
psiche e del guerriero trasformato e perfezionato.
In Junger, è proprio nel sottosuolo che si forma un uomo nuovo, colui che sarebbe diventato il
tipo rivoluzionario nella politica post-bellica, un personaggio che già in sé stesso è “continuazione
della guerra con altri mezzi”.
Questo uomo nuovo non ha scopo alcuno, né immediato né futuro. Ciò che lo distingue è la
durezza, l'invulnerabilità ai territori della sua immaginazione temprata nel sottosuolo. Proprio
come l'uomo nuovo venne generato dalla pressione della guerra sotto la superficie del fronte, così
l'élite rivoluzionaria degli anni venti trovava collocazione sotto la superficie della vita politica, ed
era in grado di lavorare sia a livello militare, sia, in un secondo tempo, a livello politico.
5. Un'uscita dal labirinto: guerra e nevrosi
Oltre alla quantità, alla varietà e all'insistenza dei sintomi nevrotici, le autorità mediche
trovarono ben poco di nuovo o inedito nelle nevrosi di guerra. La guerra, se non altro, aveva offerto
abbondante conferma della teoria psicoanalitica della nevrosi: la nevrosi di guerra, al pari della
nevrosi in tempo di pace, era la fuga, attraverso la malattia, da una realtà percepita come
intollerabile e distruttiva.
Ma se la nevrosi di guerra ha poche sorprese da offrire agli psichiatri, per tutta una serie di motivi
non può che destare la più viva attenzione degli storici sociali e culturali. La nevrosi fu un effetto
psichico non tanto della guerra in particolare, quanto della guerra industrializzata: il dominio
assoluto dell'artiglieria, della mitragliatrice, del filo spinato aveva reso immobile la guerra, e
l'immobilità imponeva un atteggiamento passivo del soldato di fronte alle forze del massacro
tecnicizzato.
La causa della nevrosi stava dunque nel dominio dei materiali sulle possibilità di movimento del
soldato; concretamente, le nevrosi di guerra furono un prodotto diretto del rapporto sempre più
alienato del combattente rispetto ai mezzi di distruzione; combattente che era costretto a erigere
difese sempre più spesse e complesse contro la sua stessa paura.
Eppure, l'incremento dell'incidenza delle nevrosi non deve essere visto semplicemente come una
risposta ai mutamenti nella “struttura” della guerra, ma anche come risposta a trasformazioni nella
“sovrastruttura”, come risposta a nuove tecniche di disciplina, controllo, dominio. Essa non fu però
funzionale solo alla fuga del combattente dalla guerra attraverso la malattia, ma anche agli sforzi
delle autorità, il cui interesse era di mantenere i soldati in prima linea.
La politica della nevrosi
La maggior parte degli ufficiali all'interno e all'esterno del corpo medico considerò la nevrosi come
condizione propria del soldato in combattimento, e il riconoscimento di essa come una soluzione
politica. Molti insistettero che il concedere alla nevrosi lo statuto e i privilegi di malattia avrebbe
aperto una breccia nelle maglie della disciplina; pretendevano che la nevrosi non fosse da
considerarsi una malattia, quanto una ridefinizione del comportamento indisciplinato o codardo
“tradizionale”.
Fu immediatamente chiaro che la nevrosi di guerra era un disturbo “funzionale” per i soldati: li
toglieva dal fronte e proprio questo era lo scopo conscio o inconscio del sintomo; la base psicologia
delle nevrosi di guerra (e di pace) è di fuggire da una situazione reale intollerabile a una situazione
resa tollerabile dalla nevrosi.
Ma continuando la guerra, fu sempre più chiaro che le nevrosi erano funzionali alle autorità
militari tanto quanto ai soldati. La prima guerra mondiale fu una guerra in grado di offrire pochi
sbocchi reali all'aggressività e all'ostilità delle truppe combattenti. Questo fece sì che tale fondo di
ostilità fu diretto verso obiettivi impropri, come autorità, stato maggiore, politici in patria. Tale
aggressività repressa trovò espressione nel sintomo nevrotico, ed in particolare nel mutismo;
secondo Simmel, mutismo e disturbi del linguaggio furono tra i più comuni disturbi in guerra
perché il soldato, piuttosto che offendere o uccidere i suoi ufficiali, mutilava il proprio linguaggio o
perdeva la facoltà di parola. Dunque, tramite il sintomo il soldato incapace di tollerare
ulteriormente i disagi della guerra si spostava dalla sfera dell'obbedienza militare alla sfera
dell'obbedienza medico-terapeutica. Simmel sostiene che la nevrosi dovette essere riconosciuta per
motivi profondamente politici, nel suo carattere di fuga dalla guerra: era meglio conservare il
potere di gestire sintomi individuali piuttosto che trovarsi di fronte a casi di ammutinamento.
La nevrosi fu funzionale alle autorità perché rappresentava una categoria di comportamento
fondamentalmente ambigua in termini etici e legali. In questa categoria, i desideri inconsci dei
soldati e gli imperativi del potere potevano essere negoziati con minor rispetto per la statura
morale dei soldati, e, soprattutto, senza rimettere in discussione la legittimità della guerra; lo
stesso respiro e le ambiguità della categoria (che poteva comprendere tanto disturbi psicosomatici
quanto indisciplina e ribellione) ne fecero un mezzo efficace per la definizione di problemi morali e
disciplinare, per l'isolamento e il trattamento del deviante in sede medica e non giudiziaria. I
dottori dovevano dunque non semplici medici, ma portavoce ed esecutori dell'autorità e della
concezione militaristica ufficialmente propagandata.
Vi era tuttavia un alto grado di disaccordo su come il soldato che avesse scelto la fuga nella
nevrosi andasse riacculturato in un ruolo che il buon senso e l'esperienza di guerra gli avevano
imposto di respingere.
La terapia disciplinare e l'inquadramento morale della nevrosi
I medici che privilegiarono le terapie disciplinari agivano istituendo scenari terapeutici molto simili
a situazioni giudiziarie, processuali; erano infatti molto attenti nel mantenere la distinzione tra le
nevrosi che avessero una causa fisica e quelle che avevano un fondamento puramente psichico.
Solo le turbe commozionali erano trattate coi diritti e le prerogative della malattia: le turbe emotive
avrebbero dovuto essere invece affrontate col sistema disciplinare.
Il compito del terapeuta consisteva nel rendere angoscianti le conseguenze del sintomo e nel
persuadere il paziente a recedere dal sintomo stesso e riacquisire il proprio ruolo maschile,
ufficiale, di soldato.
Inoltre, coloro che privilegiavano l'inquadramento morale della nevrosi di guerra erano inclini a
leggere il sintomo alla stregua di degenerazione biologica o tara ereditaria. Il sintomo nevrotico,
che la guerra si limitava a rendere manifesto, era quindi considerato come radicato in anomalie
ereditarie. Questo aveva una doppia funzione: marcava il soldato nevrotico con un segno
d'inferiorità morale, come un “invalido morale”, e permetteva di rimuovere il sintomo dal contesto
della guerra, dal momento che questo contesto appariva solo come una prova radicale che faceva
emergere delle anomalie già latenti. In seguito, tuttavia, anche i moralisti furono costretti a
riconoscere che le condizioni di combattimento nella guerra industrializzata non tenevano conto
degli adattamento o disadattamenti precedenti.
La differenza più profonda tra l'impostazione analitica e quella morale può essere colta in merito
alla simulazione. Dal punto di vista dei moralisti, la nevrosi non era altro che un'evasione dal
dovere manifestatasi con sintomi fisici: la sola differenza tra il volgare simulatore e il nevrotico
stava nella capacità di quest'ultimo di conservare il proprio sintomo anche sotto il trattamento più
duro e doloroso – in breve, una differenza nella forza di volontà che il vero nevrotico investiva nel
progetto di fuggire la guerra. La linea di demarcazione tra simulazione e nevrosi, ovvero il grado di
simulazione connesso alla nevrosi, veniva di fatto determinato nel corso del trattamento
disciplinare. Secard distinse due tipi di simulatore: simulateur de creation, che fingeva un sintomo
per scappare alla morte, e simulateur de fixation, che assumeva e manteneva il sintomo nevrotico
iniziale anche dopo che le condizioni di pericolo erano superate.
Le tecniche utilizzate dai moralisti si basavano su principi derivati dall'addestramento degli
animali: dolore con apparati elettrici, comandi urlati, isolamento, restrizioni alimentari con la
promessa di un alleviamento della pena in cambio dell'abbandono del sintomo.
L'obiettivo della terapia non era dunque tanto il sintomo in sé, quanto la volontà che il paziente
aveva investito nel presunto ripudio del suo ruolo pubblico, e lo strumento elettrico era considerato
il più idoneo a verificare il grado di fissità del sintomo e a determinare in che misura il paziente
fosse irrimediabilmente arroccato nella difesa della propria sopravvivenza: il conflitto di base, in
questa terapia, era concepito come conflitto morale tra l'io privato e l'io pubblico, conflitto su cui il
terapeuta agiva come responsabile della totale e incondizionata affermazione delle richieste del
dovere.
Il trattamento analitico
La critica rivolta dagli analisti al trattamento disciplinare era centrata non tanto sull'efficacia
quanto sulla disumanità dei procedimenti; la guarigione conseguita dai moralisti sortiva un effetto
distruttore sul paziente stesso.
Lo scopo centrale della terapia analitica, in guerra come in tempo di pace, consisteva nel
rimuovere il sintomo dall'ambito morale. La nevrosi non era dunque intesa come risultato di una
decisione conscia presa dal paziente; al contrario, il nevrotico era considerato come incapace di
prendere decisioni, cioè non più in grado né di rinunciare al suo desiderio individualistico di
sopravvivenza né agli ideali e agli imperativi morali che lo legavano al fronte. Simmel considera il
soldato nevrotico colui che stava in mezzo tra l'eroe e il lavativo, ovvero l'uomo comune. Dove i
terapeuti disciplinari individuavano una debolezza nell'attaccamento al dovere nel nevrotico, gli
analisti tendevano invece a sottolineare la forza di tale attaccamento, e l'intensità del conflitto che
esso imponeva su chi desiderasse fuggire dalla guerra. Non a caso, fu notato che tra i “feriti senza
ferite” predominassero i volontari, di forte attaccamento all'onore nazionale e sovente caratterizzati
da aspettative idealistiche rispetto la guerra.
Il sintomo era dunque visto non come espressione della volontà del paziente ma come segno di
conflitti che rimanevano inconsci. Nella terapia analitica, l'ipnosi prendeva il posto dell'apparato
elettrico; era uno strumento di controllo comportamentale tanto autoritario e irresistibile quanto i
sistemi di tortura moralisti. La finalità tipica dell'ipnosi stava nel permettere al paziente di
“regredire” sotto ipnosi fino all'evento o all'insieme di eventi che avevano fatto precipitare il
sintomo. L'evento sarebbe stato reinscenato alla presenza del terapeuta in tutta la potenza della
scena originaria, e questa ripetizione avrebbe chiarito al paziente quelle motivazioni che gli erano
divenute inaccessibili attraverso la rimozione dell'esperienza. Il sintomo era visto dunque come un
frammento mimetico, imitazione di un'azione di grande importanza emotiva per l'attore.
Ferenczi e altri obiettarono nei confronti di questo tipo di equazione semplificatrice tra sintomo ed
evento: raramente il sintomo può essere ricondotto ad una singola istanza traumatica, ma è
rappresentazione di un conflitto permanente inerente alle condizioni di vita, alle condizioni
ambientali del nevrotico.
Sia analisti che moralisti, dunque, tentarono, tramite la terapia, di riportare il soldato alla
consapevolezza delle sue responsabilità come cittadino e come militare, pur con l'impiego di diversi
metodi. L'unica differenza fondamentale tra i due modelli fu che gli analisti impiegarono un
approccio alla devianza scevro da imperativi morali: così il problema morale cessava di essere
elemento centrale in fase terapeutica, per essere proiettato, in quanto tale, sul contesto di guerra in
generale.
Immobilismo, nevrosi, regressione
In molti, tra terapeuti e soldati di linea, si convinsero che la guerra meccanizzata spingesse gli
uomini oltre i normali limiti della loro resistenza; la nevrosi era dunque da considerarsi come
logico e necessario risultato delle inaudite condizioni di combattimento. Le difese psichiche dei
combattenti erano quindi demolite essenzialmente dai livelli inediti di violenza impersonale,
tecnologica. Ma altrettanto demolitrice era la consapevolezza che la guerra non fosse un fenomeno
naturale, ma una “creazione umana”, e che erano uomini quelli che stavano dietro ai meccanismi
implacabili che immobilizzavano il soldato. Questa combinazione di casualità della morte,
impersonalità e volontà umana dietro la violenza tecnologizzata della guerra rappresentava il
fattore demolitore delle difese psichiche dei combattenti.
La variabile più significativa nell'incidenza della nevrosi non era dunque il carattere del soldato,
bensì il carattere della guerra. Quando infatti con le offensive tedesche del 1918 la guerra tornò ad
essere guerra di movimento l'incidenza della nevrosi di guerra crollò clamorosamente, ed è stato
riscontrato che i piloti annoveravano il tasso minore di crolli mentali.
Venne dunque ritenuto universalmente che la nevrosi fosse sorella della guerra di trincea e dei
peculiari stati emotivi generati dalla guerra di posizione; fu essenzialmente l'immobilismo della
guerra ad essere assunto come realtà di base sottesa al sintomo nevrotico. L'immobilismo fu causa
non solo di patologie manifeste come la nevrosi, ma anche di una latente regressione psichica
osservabile anche nei soldati “normali”.
Rivers dimostra che l'antidoto più razionale agli stati ansiosi sta in un qualsiasi tipo di attività
manipolatoria: è attraverso questa attività che l'uomo acquista il senso della propria autonomia in
un mondo di mezzi meccanici; se la facoltà dell'individui di intervenire nel mondo delle cose è
ostacolata, il senso d'autonomia dell'individuo stesso diminuisce radicalmente e si ha la condizione
ottimale per l'incidenza della nevrosi sotto qualsiasi forma. E' un paradosso che proprio la guerra
tecnologica creasse condizioni in cui gli uomini si trovarono di fatto privi delle difese più razionali e
manipolatorie contro la paura; e fu una perdita che comportò necessariamente una regressione
nella magia, nell'animismo, nella nevrosi.
Secondo Simmel, la durezza e l'indifferenza dei soldati sembravano patologie acquisite in guerra,
descritte come una “limitazione e soppressione della coscienza”, derivante dal fatto che la guerra
costringe il ritiro della libido dal mondo oggettuale, l'interiorizzazione dell'io e l'incremento in
libido narcisistica, nel senso di una regressione, che porterà però a vedere l'ambiente di guerra
come irreale e magico, e da affrontare dunque parimenti con magia e scaramanzia.
La nevrosi di guerra nella società post-bellica
Durante la guerra i terapeuti giunsero alla conclusione che la nevrosi di guerra fosse una nevrosi
funzionale con uno scopo limitato, quello ovvero di allontanare i soldati da una realtà intollerabile.
Effettivamente, lo scoppio della rivoluzione vanificò l'esigenza del complesso nevrotico come
protesta da parte del soldato, “proletario in divisa”, lo rese non più funzionale. Adesso non era più
infatti il soldato ad essere vulnerabile, ma l'apparato di comando che aveva precipitato il conflitto
tra il desiderio di sopravvivenza del soldato e l'adempimento dei suoi obblighi morali.
Ma nei successivi otto anni le autorità mediche si accorsero di essere state troppo frettolose nel
dichiarare la fine delle nevrosi di guerra. Le turbe psiconevrotiche si dimostrarono più tenaci del
previsto. Fu infatti del tutto inaspettato che numerosi soldati mai ricoverati durante la guerra
crollassero dopo la fine delle ostilità.
La nevrosi di guerra che si manifestava in tempo di pace era qualcosa di più che non una
semplice trasposizione di scopi, che portava dalla ricerca di fuga dalla guerra alla ricerca di
compensazione affettiva e sicurezza. L'impatto iniziale dei veterani nella patria fu spesso deludente,
e questa disillusione poteva precipitare turbe nervose anche gravi. Il soldato aveva infatti in guerra
spesso idealizzato la patria, che costituiva come un appiglio contro le dissonanze e le umiliazioni di
guerra, tali da consentirgli di mantenere il senso di una possibile continuità. Queste idealizzazioni,
a volte, crollarono sotto l'impatto della smobilitazione, della disoccupazione, della povertà,
dell'estraneità assoluta a quanto gli era famigliare; questo scatenò quegli stati ansiosi tenuti sotto
controllo durante la guerra stessa. Non se ne andava solo una visione piacevole, ma l'immagine
stessa di un io sicuro e di un'identità solida; il crollo dell'idea di patria significava la rimozione di
ciò che era in realtà stato il soldato in quella guerra.
Ma la rottura definitiva con la realtà non fu però la normale risposta di coloro che avevano visto
scosso in guerra il senso della propria identità: molto più comune fu la risposta di coloro che
ripudiarono la loro esperienza di guerra, cercando di dimenticarla. Rivers si convinse che i più
penosi sintomi della nevrosi di guerra non fossero necessariamente risultato di pesanti traumi,
quanto più spesso il tentativo di cancellare dalla mente i ricordi di guerra; la rimozione
dell'esperienza di guerra, infatti, procrastinò il ricordo della guerra stessa, conservandone il peso,
impegnando tutto il tempo i veterani a non udire i cannoni.
I segni della rimozione dell'esperienza di guerra sono riscontrabili nella grande scarsità di memorie
di guerra pubblicate negli anni Venti: Pfeiler considerò questo tempo come un “periodo di latenza”
in cui un'esperienza troppo distruttrice a livello di io individuale e collettivo viene dimenticata per
poi riemergere sotto forma più accettabile.
Negli anni Trenta ci fu un nuovo fiorire di letteratura di guerra; Carrington spiega questo con il
fatto che la Grande Depressione aveva colmato tra il civile e il reduce un divario che era rimasto
insuperabile per tutti gli anni venti: adesso la popolazione nel complesso era vittima come dopo la
guerra (e durante) lo era il soldato.
6. Il veterano tra fronte e patria
La prima guerra mondiale va dunque vista come un'esperienza della condizione moderna,
un'esperienza in cui uomini che già sapevano cosa voleva dire vivere in epoca industriale appresero
ciò che significasse in termini militari; essa fu modernizzate perché alterò in modo fondamentale le
tradizionali fonti di identità, le tradizionali concezioni della guerra e degli uomini in guerra. Da un
lato, la guerra merita il titolo di prima guerra veramente moderna perché in essa e tramite di essa
la natura e la dimensione dell'industria moderna furono ribadite nei termini più violenti e chiari;
dall'altro canto, fu una guerra che mobilitò una logica profondamente radicata nella cultura
europea, una logica che asseriva l'alterità sociale ed esistenziale della guerra come alternativa
benefica alla vita nella società civile. Questo fu l'ingrediente principale che portò alla comunità
d'agosto 1914.
Ma la disillusione che accompagnò l'accorgersi da parte dei militari dell'intima analogia tra le
società industriali e le Materialkrieg che conducono contorse ed inaridii la logica su cui erano
basati il significato morale della guerra e la figura del guerriero stesso. La prima guerra mondiale
segnò la negazione dell'esistenza di due realtà distinte: in guerra si apprese che esiste solo il mondo
industriale, e che esso plasmasse l'esistenza degli individui molto di più in pace che in guerra.
Questo scontro tra le tradizionali concezioni della guerra e le condizioni reali di guerra continuò nel
carattere e nel comportamento dei veterani.
Il veterano è una figura tradizionale; convenzionalmente è un iniziato che porta in sé la
conoscenza, esperita personalmente, della fragilità dell'umanità e sua propria. La figura del
veterano è una sottocategoria del tipo liminare: deriva le sue caratteristiche dal fatto di avere
attraversato il confine tra due mondi sociali disgiuntivi, fra pace e guerra, ed essere riuscito a
tornare. In questo viaggio ai margini della civiltà il veterano ha assunto un nuovo carattere, dopo
aver affrontato cose solamente immaginabili da quelli che rimasero a casa.
I lineamenti che definiscono tradizionalmente il veterano sono gli stessi ascritti, nella memoria
popolare di tutto il mondo, a tutti i professionisti nomadi: l'attore itinerante, il fabbro ambulante, il
prestigiatore, il mercante, il mendicante. Sono tutte figure che vivono negli spazi di giunzione delle
società figure che praticano trasformazioni su se stesse, su ruoli metalli, valori, stati spirituali e
fisici: la gente teme il potere generato in queste trasformazioni, e allo stesso tempo desidera
attingevi per beneficiarne. Il tipo liminare ha sempre fornito il terreno su cui la gente comune
proietta la propria ambivalenza nei confronti dell'ordine sociale in cui vive: la paura del disordine e
la paura della fossilizzazione. Il veterano al pari delle altre figure liminari, incorpora le ansie, si
carica delle colpe e attenua la noia generate dalla quotidianità della gente comune.
In sostanza, la figura del veterano è tradizionalmente derivata da tutto ciò che si presume stia al
di là dei limiti dell'esistenza civile.
Coloro, socialisti o conservatori che fossero, che concepivano la società moderna in termini di
privatizzazione, alienazione e lotta di classe vedevano il veterano come un uomo comunitario,
formatosi nell'agone della solidarietà naturale che soggiace alle artificiali divisioni di classe e
status, rappresentando così la migliore speranza per una soluzione delle tensioni che caratterizzano
la società capitalistica.
D'altra parte, coloro che concepivano la società in termini di limitazioni etiche indispensabili,
inibizioni, coercizioni sugli istinti primitivi, vedevano la guerra come arena di liberazione
istintuale, e il veterano dunque come un primitivo, barbarizzato e regredito, incline alla violenza.
Entrambe le immagini erano funzionali; i reduci potevano usare l'immagine dell'uomo comunitario
per asserire la loro superiorità sui meccanismi della politica civile, vista come mezzo per
raggiungere interessi individuali. Potevano anche assumere l'immagine di uomo violente,
intollerante nei confronti di qualsiasi restrizione sociale.
La più comune versione del veterano come “compagno” stava nella convinzione che i reduci dal
fronte costituissero un nuovo proletariato di socialisti “istintivi”, altamente disciplinato ed
addestrato a combattersi. Il soldato proletarizzato, legato ai suo camerati e alienato nei confronti
della società borghese, era visto dunque talvolta come un socialista istintivo, non perché avesse
familiarità con i classici del socialismo, ma per il suo profondo internazionalismo e per la sua fame
di terra (Lussu).
Braun sottolineò la natura negativa, “reazionaria” di questo socialismo: l'esperienza di guerra non
fornì a chi vi prese parte una nuova visione della comunità, sulla base della quale tentare di
trasformare positivamente assetti politici e sociale; non erano dotati di un'ideologia che fornisse
loro un terreno comune. Junger stesso, quando esortava i soldati a prendere parte alla vita politica
attiva, li vedeva come nient'altro che strumenti di un destino misterioso. Le caratteristiche
socialiste tradizionali dell'esperienza di guerra (eguaglianza, cameratismo, proletarizzazione,
uniformità) furono infatti prodotte dall'impotenza assoluta di fronte all'autorità e alla tecnologia, in
uomini divenuti incapaci di collegare l'esperienza sociale della guerra a problemi sociali e politici
del periodo post-bellico; non a caso, coloro che desideravano fare dell'esperienza di guerra la base
per un attacco contro l'ordinamento liberale borghese, ricorsero alle definizioni più contraddittorie,
come “nazional-socialismo”.
Il soldato di linea, molto più spesso, si distinse come uomo di violenza piuttosto che come uomo
comunitario. La sua violenza veniva considerata spesso come espressione della sua estraneazione
alle norme sociali, e conseguenza dell'aver vissuto in ambiti in cui contavano solo gli istinti animali;
veniva dunque vista come ripudio della politica borghese e dell'”aria fritta” della politica.
L'economia del sacrificio e il suo collasso
Il cittadino-soldato è sempre stata una figura chiave in quella che potrebbe essere chiamata
un'economia del sacrificio o della colpa sociale. Egli è creditore di un debito di sangue nei confronti
della società che ha difeso, e può legittimamente chiedere il saldo sia per il sacrificio di se stesso sia
per quello dei suoi camerati caduti. Anche lo scambio dei ruoli richiesto al cittadino-soldato è
comunemente compreso nel linguaggio del sacrificio; nell'ambito delle ideologie che dominavano
nel 1914, il civile scambiava il suo io privato e il proprio interesse personale per un'identità
pubblica e comunitaria, e per questa temporanea perdita della propria identità il soldato poteva
chiedere un compenso sotto forma di onori, prestigio, o ricompense monetarie. E' facile vedere
come il linguaggio che impone l'onere del “sacrificio di sé” a carico dei figli, in nome della salvezza
della patria, sia in sintonia con il normale esito della situazione edipica, in cui il bambino è
costretto ad accettare il fallimento delle proprie ambizioni sessuali allo scopo di mantenere la
struttura della famiglia.
Ma non è tanto l'economia del sacrificio quanto la sua infrazione che genera rabbia, senso di
ingiustizia. In agosto, la morte civile del soldato, la sua estraneazione dalla società, furono
suffragate dal senso che la società e il mercato dei ruoli fossero rimpiazzati dai valori della
comunità; ma l'atteggiamento del soldato verso la nazione e verso il proprio status pubblico mutò
significativamente dopo il labirinto delle trincee; qui la liberazione dalla società borghese cominciò
ad essere vista come morte. Ma il fattore più significativo che concorse alla rabbia e all'amarezza
dei veterani fu l'accorgersi che in quattro anni di guerra la nazione del 1914 era tornata ad essere un
mercato di ruoli e status, non più una comunità, dove di conducevano “affari come al solito”;
l'esperienza di guerra finì per essere comprensibile solo in termini di ingiustizia sociale.
Ma era sovente l'incontro con il “pescecane” che recideva in modo definitivo il legame morale tra
fronte e patria: il pescecane era il simbolo di coloro che incrementavano il mezzo di scambio (il
sangue) per il loro personale profitto; non solo la guerra ingrassa chi sta a casa, non solo il
combattente soffre di una verticale diminuzione di status, ma può anche succedere che non esista
più alcuna collocazione in cui il soldato possa essere reinserito una volta terminata la guerra.
Inequivocabilmente il pescecane rappresenta la conversione dell'economia del sacrificio ad un
mercato in cui lo status sociale viene negoziato insieme alle cambiali.
La massima delusione fu proprio il fatto che la società capitalistica non aveva cessato di essere tale
per virtù della guerra, nonostante l'iniziale soverchiante senso comunitario che l'accompagnò.
Non c'era dunque da sorprendersi che dopo la fine della guerra i gruppi di veterani si
organizzassero intorno a richieste di risarcimento, e che la violenza dei veterani fosse uno degli
argomenti più convincenti nei confronti della società; non perché il premio richiesto fosse sentito
come guadagnato, ma perché era una rivalsa nei confronti della società, e quindi una prova
dell'affetto della patria per coloro che erano usciti umiliati dalla guerra.
Il carattere tradizionale del guerriero come uomo che abbia vissuto ai margini della società, come
essere extrasociale, mezzo uomo, mezza bestia, ha un preciso significato nelle società tradizionali
dove lo status è fissato da legge, consuetudine e rituale; ma la marginalizzazione “temporanea” di
milioni di uomini significa un'altra cosa in una società dopo lo status non è fisso, ma premio per il
successo conseguito nella competizione per la ricchezza. Coloro che sono esterni al mercato dello
status patiscono una perdita netta del proprio posto: diventa dunque impossibile per il soldato
reintegrare se stesso in società senza esperire quotidianamente il peso della perdita subita.
L'interiorizzazione della guerra
L'alterità della guerra si estinte nelle battaglie di materiali, e con essa tutto ciò che fino ad allora
aveva definito il significato del sacrificio di sé del soldato;ora la guerra era diventata solo
proletarizzazione, il cui unico portato positivo era il cameratismo. Eppure questo rivolgersi al
fronte e ai propri camerati in sostituzione della patria perduta doveva avere conseguenze
psicologiche disastrose; L'unità era un'entità instabile, e continuamente decimata dal fuoco, fino ad
assumere le sembianze di un lutto senza fine.
In guerra sono ovvi i rischi psichici connessi all'identificazione con gli uomini della propria unità,
eppure era questa una reazione pressoché necessaria data la cesura effettiva rispetto all'ambiente
in patria. Questa identificazione permetteva di leggere la morte di ogni camerata come perdita di
una parte di se stessi. La morte di un amico non poteva più esser giustificata con la consolazione
che questa perdita preservasse la vita della società intera: ogni scomparsa poteva essere
compensava ormai solo dall'intensificazione dei legami con chi rimaneva. Alla fine di questo
processo la propria stessa morte poteva essere bene accolta come soluzione di un intollerabile
stato di perdita luttuosa e continua.
L'interiorizzazione della guerra comincia con la perdita dell'astrazione che ha preso il posto
dell'oggetto d'amore. Il sostituto di questa astrazione, la patria, divenne il fronte, i propri camerati.
Ma questa reazione narcisistica che consistette nell'assumere a livello dell'io la ristretta cerchia dei
propri camerati causò immancabilmente una fissazione sul morto e sul vivente, un insieme di
identificazioni che perdurarono in tempo di pace. Il cordoglio dei soldati per i morti fu ribadito e
rafforzato in parate, commemorazioni e associazioni. La funzione non meno importante di questi
gruppi era quella di movimento di rivendicazione nei confronti della patria, in cui le vittime di
guerra divenivano simbolo del culto della sofferenza e del sacrificio di sé.
Questo cordoglio organizzato, al pari della rimozione dell'esperienza di guerra, rappresentò il modo
più comune in cui la guerra continuò a definire l'identità dei combattenti. Molto più pericolosa fu la
reazione di coloro che aderirono a leghe combattentistiche; era possibile per il veterano prendere
atto dell'offesa psichica e morale ricevuta, accettarla come segno distintivo, affermare la propria
precarietà sociale come stato permanente, e organizzare questa ambiguità di status in un gioco di
estorsione politica e morale.