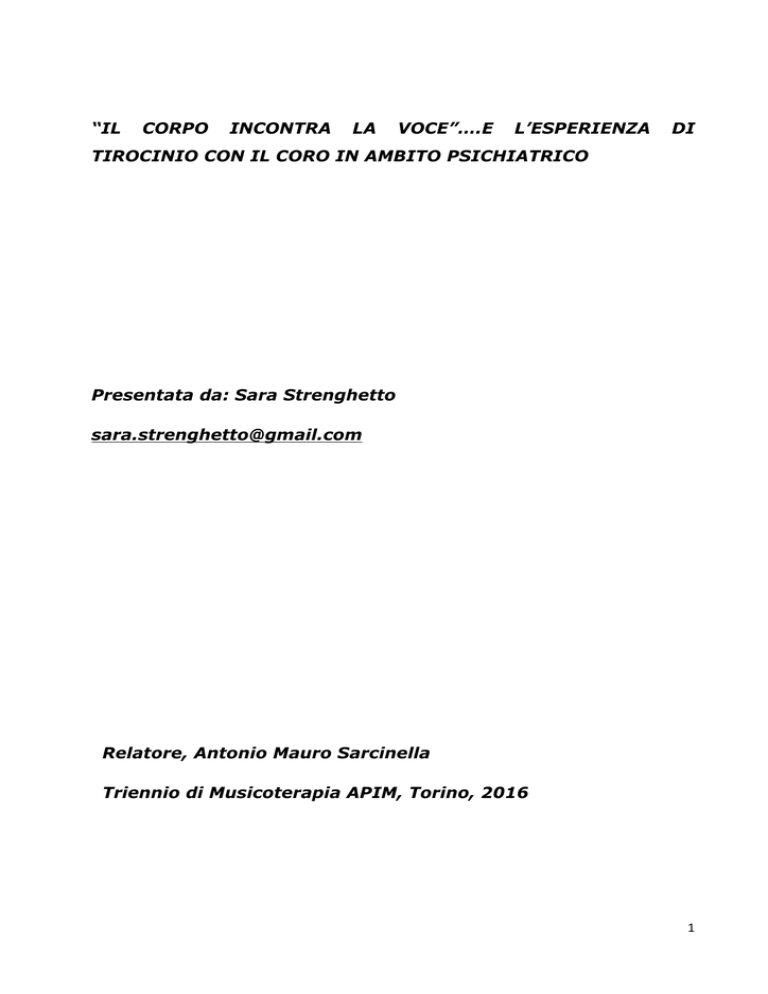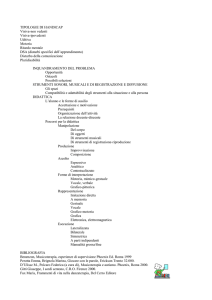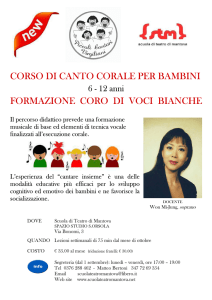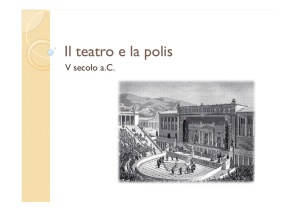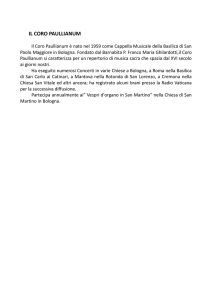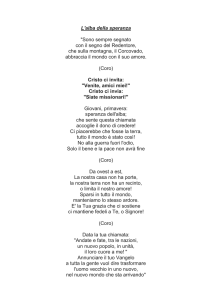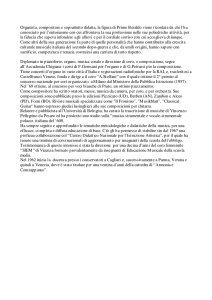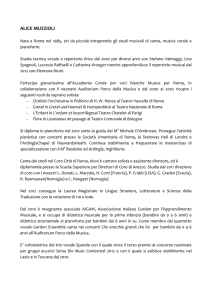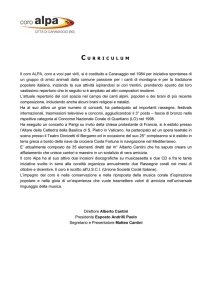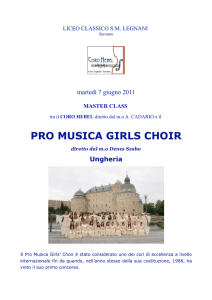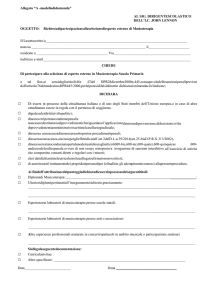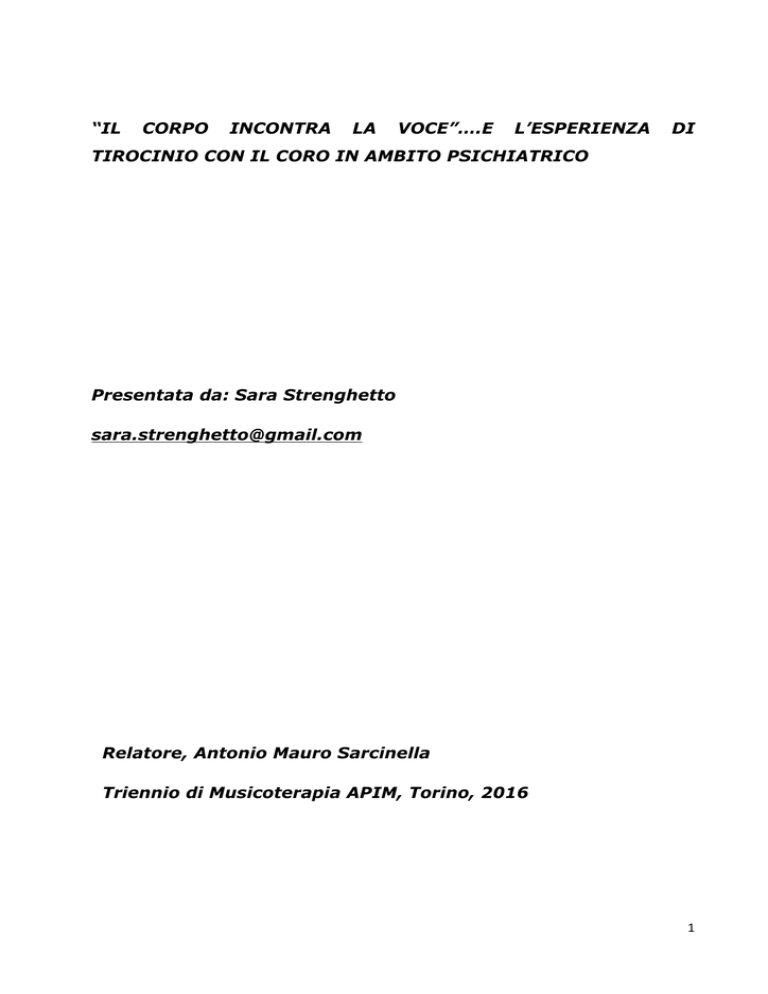
“IL
CORPO
INCONTRA
LA
VOCE”….E
L’ESPERIENZA
DI
TIROCINIO CON IL CORO IN AMBITO PSICHIATRICO
Presentata da: Sara Strenghetto
[email protected]
Relatore, Antonio Mauro Sarcinella
Triennio di Musicoterapia APIM, Torino, 2016
1 Dedicato a mia madre,
madre di tutte le madri,
nutrimento sonoro,
culla vocale…
Dedicato a chi sa ascoltare…
2 Sommario
PREMESSA ............................................................................................................................................ 5 1. La VOCE come mezzo di espressione e condivisione ............................................... 9 1.1 LA VOCE E LA VOCALITA’: BASI FISIOLOGICHE E FISICHE DELLO
STRUMENTO CORPO-VOCE ............................................................................................................ 9 La voce attraverso l’atto fonatorio, il respiro e la postura ................................................. 9 1.2 LA VOCE ATTRAVERSO L’ORECCHIO e L’ASCOLTO ............................................... 19 Studi e ricerche ................................................................................................................................ 19 1.3 LA VOCE COME IDENTITA’: TRA L’ARCAICO E IL MATERNO ............................... 25 Le origini psicologiche della voce .............................................................................................. 25 1.4 LA VOCE COME CANALE EMOZIONALE ........................................................................ 29 Studi e ricerche sulle emozioni ................................................................................................... 29 1.5 LA VOCE E LA BIOENERGETICA ..................................................................................... 37 La bioenergetica e la mia esperienza vocale attraverso il lavoro corporeo ............... 37 1.6 IL CORO ................................................................................................................................... 43 ASPETTI RELAZIONALI E FUNZIONALI DI UN CORO ......................................................... 43 A) LA POLIFONIA NELLA STORIA ........................................................................................ 43 B) LE FUNZIONI DEL CORO IN AMBITO PSICHIATRICO ............................................. 46 2. IL GRUPPO .............................................................................................................................. 53 2.1 Cos’è un gruppo e le sue dinamiche : premesse storiche .................................. 53 2.2 Il gruppo e la sua analisi - Il percorso storico del gruppo attraverso la
terapia .................................................................................................................................................. 57 3. L’ESPERIENZA ....................................................................................................................... 62 3.1 IL TIROCINIO NEL GRUPPO-CORO “LA VOCE DEI COLORI” ................................ 62 3.2 GLI OBIETTIVI DEL GRUPPO-CORO: ............................................................................ 66 3.3 - GLI INCONTRI .................................................................................................................... 67 3.4 LA STANZA DEL CORO O IL SETTING .......................................................................... 68 3.5 LE FIGURE DI RIFERIMENTO E LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO-CORO ...... 69 3.6 IL REPERTORIO: ................................................................................................................... 70 3.7 ALCUNI COMPONENTI DEL GRUPPO E I LORO BENEFICI ..................................... 71 3.8 L’ESPERIENZA PRATICA .................................................................................................... 74 4. MUSICOTERAPIA:RIFERIMENTI TEORICI ................................................................... 79 3 5. ARTICOLO IL CANTO CORALE SINCRONIZZA… I CUORI! – MUSICA &
PSICOLOGIA ID Articolo: 34003 - Pubblicato il: 18 settembre 2013 .......................... 90 4 PREMESSA
In questi anni di esperienza come cantante e nel percorso con la
musicoterapia, ho sempre avuto la percezione di entrare in contatto
con qualcosa di profondamente potente e indefinibile: la musica, il
suono…la VOCE.
In passato, dopo vari tentativi di frequentare scuole di canto per
poter utilizzare al meglio la mia voce, ho capito che addestrare la
voce serve solo a creare maggiori tensioni e paure, e ho intrapreso
ormai da diverso tempo la ricerca di “me stessa” attraverso la voce,
ed è lei che mi ha guidato in questi anni a sperimentare vari percorsi
tra cui: la meditazione, l’analisi bioenergetica e il percorso di
musicoterapia. Nel percorso di tirocinio con il coro “Le voci dei colori”
ho
cercato
di
osservare
e
approfondire
una
diversa
visione
dell’esperienza vocale, non solo come semplice atto fonatorio ed
estetico, ma anche come cura del se’ e soprattutto come mezzo di
relazione e socializzazione.
La tesi è divisa in cinque capitoli che ho sviluppato attraverso diverse
domande che mi sono posta:
Il punto focale è la voce
e la totalità della persona attraverso lo
strumento corporeo; in secondo luogo è la voce nella collettività del
coro come canale espressivo e relazionale.
Nel primo capitolo, viene presentata la voce attraverso vari aspetti
teorico-scientifici: le definizioni nel significato letterale , brevi cenni
sulle basi fisiologiche dell’apparato fonatorio, funzionali, psicologici,
emozionali e attraverso la storia della polifonia e le sue funzioni nel
coro in ambito psichiatrico. Vengono analizzate alcune teorie come
quella di Alfred Tomatis sull’ascolto e quella di Alexander Lowen sul
lavoro con il corpo in analisi bioenergetica, per comprendere l’aspetto
fonatorio nella sua funzione globale.
5 Nel secondo capitolo, viene presentato il gruppo attraverso i
contributi dei diversi teorici: il gruppo nella storia, le sue dinamiche e
attraverso la terapia.
Nel terzo capitolo, viene presentata la mia esperienza di tirocinio,
attraverso la storia del coro “ La voce dei colori” del DSM ASL TO2,
per approfondire il tema della vocalità
in un ambito a me
completamente sconosciuto e che mi ha permesso di superare i miei
pregiudizi nei confronti del “malato psichiatrico”.
Nel quarto capitolo, vengono citati alcuni riferimenti che mi hanno
permesso di orientarmi nel complesso mondo della musicoterapia.
Nel quinto capitolo intitolato “Conclusioni” presento una riflessione di
quanto l’esperienza vocale ha un valore importante nell’ambito
relazionale e di come il corpo è il canale principale per esprimere al
meglio il potenziale di ognuno di noi attraverso il “gesto” vocale.
Troviamo inoltre un interessante articolo che parla di una recente
ricerca che si è occupata di analizzare gli effetti positivi del canto
corale sul corpo e in particolare sul cuore, grazie alla capacità di
stimolare la comunicazione neurobiologica.
Concludendo, la tesi ha
l’intento di offrire spunti di riflessione sul
percorso della voce e della vocalità attraverso il corpo. Sia come atto
fonatorio
che
nel
lavoro
musicoterapico,
ritengo
la
voce
un
importante canale relazionale attraverso il quale può passare tutto il
nostro mondo personale, le nostre emozioni e i nostri stati d’animo.
Non è una conclusione, ma il punto di partenza di un affascinante
percorso in un mondo così articolato come quello della musicoterapia,
attraverso il nostro strumento principale:la voce.
6 7 Il segreto del canto
risiede tra la vibrazione della voce di chi canta
e il battito del cuore di chi ascolta.
Khalil Gibran
8 1. La VOCE come mezzo di espressione e condivisione
1.1
LA VOCE E LA VOCALITA’: BASI FISIOLOGICHE E
FISICHE DELLO STRUMENTO CORPO-VOCE
La voce attraverso l’atto fonatorio, il respiro e la postura
Da dove ha origine la voce?
Come si genera il suono vocale?
LA VOCE DAI VOCABOLARI:
- Suono prodotto dalla vibrazione delle corde vocali.
-Suono emesso dagli esseri umani attraverso gli organi di fonazione,
prodotto dall’aria espirata che incontra, nella laringe, le corde vocali
facendole vibrare.
- Suono che, nel parlare o nel cantare , è prodotto dalla laringe nel
momento in cui il flusso espiratorio incontra le corde vocali
mettendole in vibrazione; anche, il timbro di questo suono, dovuto
alla conformazione delle cavità (faringe, fosse nasali, ecc.) che
fungono da risuonatori: il volume, il tono, l’intensità della voce.
- Insieme di suoni, prodotto dalla laringe con il concorso dell’apparato
respiratorio e delle cavità naturali, proprio dell’uomo nel parlare e nel
cantare, caratterizzato da altezza, intensità e timbro: il volume, il
tono, l’intensità della voce.
La voce è uno dei più importanti mezzi di comunicazione dell’essere
umano, il più spontaneo e universale e rappresenta anche lo
strumento musicale più immediato che abbiamo a disposizione. Essa
è il suono generato per mezzo del fiato attraverso la vibrazione delle
9 corde vocali e viene timbricamente modulata nel percorso del canale
vocale.
Nella produzione sonora vocale, sia parlata che cantata, avviene la
coordinazione di una serie di meccanismi che controllano la sua
regolazione: la respirazione , l’emissione vocale e la risonanza.
“Nella
descrizione
dell’apparato
vocale
vengono
comunemente
distinte tre aree anatomo funzionali ( Moruzzi 1975)1:
1.In primo luogo deve essere considerato il mantice formato dai
polmoni, dai bronchi e dalla trachea. Il mantice fornisce la corrente
d’aria espirata.
2.Quest’ultima è veicolata attraverso una stretta fessura, la glottide,
delimitata da strutture in grado di vibrare: le corde vocali.
3.La vibrazione delle corde vocali si trasmette dall’aria espirata che
passa in uno spazio aereo di risonanza formato dalla faringe e dalle
attività buccali e nasali.
La fonazione si divide quindi in tre funzioni che compongono un unico
e importante fenomeno:la produzione del fiato, la generazione del
suono e la modulazione dello stesso.
Dal punto di vista fisiologico gli organi fonatori che fanno parte
integrante
dell’apparato
respiratorio
e
formano
l’apparato
di
risonanza, sono:
1) Laringe, 2) Faringe, 3) Cavità nasali e paranasali, 4) Bocca, 5)
Polmoni.2
1
Videscott Maria e Elena Sartori.,La voce in musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2008 p. 22
2
Juvarra A., Il canto e le sue tecniche, Ricordi,Milano, 1987 p. 23-24 10 Anche il diaframma, i muscoli addominali e determinati muscoli
facciali intervengono nella funzione fonatoria e hanno un ruolo
importante nel controllo dell’emissione vocale.
Il principale organo coinvolto nella produzione della voce è quello
laringeo: è molto complesso, si presenta nella sua forma esterna
come un’impalcatura di cartilagini, posizionata nella parte anteriore
del collo, la cartilagine tiroidea , che è la più voluminosa ed è situato
come uno scudo davanti alle altre cartilagini.
11 “La laringe è il “generatore della vibrazione, del suono primario,
trasformatore dell’energia aerea in energia acustica, essa garantisce
la funzione fonatoria, ma in quanto valvola (glottide) concorre anche
all’esplicarsi della funzione respiratoria e sfinterica 3 e attraverso
l’epiglottide
antiche).
di
quella
nutritiva
4
(funzioni
filogeneticamente
più
5
All’interno della cavità laringea troviamo le due corde vocali che
costituiscono la glottide; quest’ultima si chiude quando le corde
vocali, entrando in vibrazione, e generano la funzione fonatoria.
3
La funzione sfinterica implica un’azione di controllo della pressione, attraverso cui il corpo svolge, alcune importanti attività di espulsione, come il parto, la defecazione, il tossire, il vomitare. 4
Nella deglutizione l’epiglottide si abbassa deviando il bolo alimentare verso l’esofago , mentre la glottide si chiude per proteggere le vie aeree. 5
Tosto Ida Maria, la voce musicale: Orientamenti per l’educazione vocale, EDT, Torino,2009, p.33-­‐34 12 La vibrazione delle corde vocali mette in oscillazione la colonna d’aria
che le attraversa e le onde sonore si propagano attraverso i
risuonatori del corpo ( la faringe, la cavità toracica, la bocca, le cavità
nasali) che hanno la funzione di cassa armonica, amplificano e
trasformano le onde sonore, permettendo così diversi timbri vocali
che identificano la voce di ogni individuo ma anche le diverse
possibilità espressive di ciascuno.
I
suoni
formati
trovano
la
loro
amplificazione
nell’apparato
risuonatore, costituito dalla bocca, dalla faringe, dalle cavità nasali e
paranasali.
La respirazione
Per la fonazione, è fondamentale la respirazione
e ovviamente
i
polmoni che si trovano sospesi all’interno della cassa toracica, che ne
determina le dimensioni, attraverso l’allargamento delle costole. La
respirazione è la nostra prima fonte di energia. Le cellule per
rigenerarsi hanno bisogno di ossigeno e soprattutto le cellule nervose
sono sensibili alla carenza di ossigeno. Possiamo vivere pochi minuti
senza respirare e le cellule sono in grado di lavorare in modo
adeguato e rigenerarsi solo se ricevono l’ossigeno sufficiente. Ogni
nostra parte del corpo influenza la respirazione e a sua volta ne è
influenzata: la struttura scheletrica, l’elasticità toracica, il tono
muscolare, le attività viscerali, il livello di energia e come vedremo
anche la postura e lo stato psichico.
Il flusso d’aria permette di generare il suono vocale attraverso i
muscoli addominali, il petto e la schiena che aiutano a generare la
forza necessaria per un adeguato e controllato flusso d’aria. Nel canto
è
essenziale
la
respirazione
diaframmatica,
dove
avviene
lo
spostamento laterale delle costole inferiori , ed è costituita: dal
13 diaframma, le costole inferiori e i muscoli intercostali e addominali. Il
diaframma è il principale protagonista della respirazione ed è ,una
parte muscolare a forma di cupola, che separa la cavità toracica da
quella addominale.
Con l’inspirazione il torace aumenta facendo abbassare il diaframma
che preme sulle pareti dell’addome facendolo sporgere; mentre
nell’espirazione avviene il contrario.
La discesa del diaframma nell’inspirazione è causata dalla contrazione
della sua muscolatura, per farlo risalire nell’espirazione è necessario
l’intervento dei muscoli addominali, che premono contro di esso i
visceri contenuti nell’addome.
14 Una respirazione lenta e calma induce ad uno stato di rilassamento
generale, mentre un respiro breve e affannoso crea stati di ansia.
Come spiega Antonio Juvarra nel suo trattato sul canto e le sue
tecniche “Quando s’incomincia lo studio del canto, la conoscenza
della voce è localizzata nell’area della gola, dove si concentrano tutti i
tentativi di modificazione dell’emissione. Al contrario, un cantante
avanzato nella tecnica sperimenta la voce come un fenomeno che
interessa e coinvolge tutto il corpo, a eccezione della laringe, che
rimane soggettivamente al riparo in un centro di quiete paragonabile
all’occhio del ciclone. Questo gli permette di cantare forte per lunghi
periodi senza stancarsi.”
6
La fonazione, richiede quindi un complesso sistema di interazione tra
i vari organi corporei e la laringe; il suono viene prodotto dalla
vibrazione delle corde vocali nella laringe, per mezzo dell’aria che
arriva dai polmoni. In questo complesso meccanismo, l’atto cantato è
condizionato fortemente dalle varie tensioni muscolari corporee che
influenzando l’emissione vocale.
La postura
La postura nel canto influisce in maniera decisiva nella qualità
dell’emissione, essa permette di sfruttare al meglio le risonanze
naturali del corpo e determina una corretta impostazione di tutto il
sistema fonatorio. Essa è condizionata dalla posizione del corpo ,
dalla respirazione
e dall’atteggiamento psicologico. Questi fattori si
influenzano fra loro, in quanto una postura eretta, un buon appoggio
6
Juvarra Antonio., Il canto e le sue tecniche, Ricordi,Milano, 1987 p. 9
15 su entrambe le gambe divaricate e leggermente flesse, permettono
una respirazione facilitata, un buon equilibrio e un atteggiamento
psicologico di sicurezza , di benessere e di tranquillità.
La posizione del corpo ha quindi una funzione determinante per la
buona emissione vocale, in particolare quella cantata è un processo
che coinvolge mente e corpo.
“Non c’è parte o livello del corpo che non partecipi al gesto vocale. La
materia che costituisce lo strumento è dotata di grande elasticità e
dunque capace di partecipare alla vibrazione sonora[…]. Essa si
avvale infatti di membrane a tensione regolabile e di valvole e di
pressione come gli strumenti a fiato. L’organizzazione della vocalità
comporta
la
coordinazione
di
l’interazione di molteplici funzioni.”
più
livelli
strutturali
e
implica
7
A questo proposito è interessante la posizione del metodo funzionale
della
voce
di
Gisela
Rohemert,
che
attraverso
il
lavoro
sull’ergonomia8, evidenzia come gli organi della fonazione regolano
innanzitutto funzioni vitali come il respiro, l’equilibrio nello spazio,
l’alimentazione, poi il linguaggio e la comunicazione ed infine le
funzioni espressive ed estetiche del canto. Il metodo funzionale della
voce nasce nel 1979 in Germania, grazie alle ricerche svolte
dall’Istituto di Ergonomia di Lichtenberg 9 , sull’impegno fisico e
psichico del cantante durante l’atto vocale. Lo scopo di questi studi,
anche attraverso l’approfondimento degli affetti di tecniche corporee,
che ottimizzano le funzioni corporee (il metodo Feldenkrais, lo yoga,
lo shiatsu, la terapia craniosacrale), ha avuto l’obiettivo di elaborare
una pedagogia vocale, con l’analisi delle frequenze e la misurazione
7
Tosto Ida Maria, la voce musicale: Orientamenti per l’educazione vocale, EDT, Torino,2009, p.20-21
ERGONOMIA: si occupa dei problemi relativi al lavoro umano in rapporto ai vari ambienti di lavoro. I principali
compiti dell’ergonomia consistono nell’analizzare, nel misurare, nel valutare e nel realizzare, al fine di organizzare
armonicamente e produttivamente le funzioni che vengono attivate in qualche lavoro umano.
9
L’istituto di Lichtenberg è un’istituzione pedagogica musicale dove un gruppo di collaboratori stabili sviluppano e
sperimentano nuove idee orientate alla pratica vocale e strumentale.
8
16 fisica dell’onda sonora, per permettere al cantante e in seguito al
musicista, di ottenere con il minimo sforzo il massimo risultato.
La svolta decisiva delle ricerche è avvenuta quando l’attenzione è
passata nell’analisi dal corpo al suono, anziché sullo spettro delle
frequenze della voce, permettendo la scoperta di un’ infinita serie di
connessioni tra corpo, psiche, organi sensoriali, ambiente e suono.10
La Rohmert parla del “sistema-cantante”, identificando il suono
vocale
come
potenziale
ordinatore,
che
prodotto
dall’azione
coordinata degli elementi del sistema, diventa un’entità autonoma
capace di guidare e organizzare il sistema stesso, ottimizzandone le
risorse. ”Il suono della voce , riflesso dalle pareti delle cavità di
risonanza, retroagisce sulla laringe, la quale, sollecitata nella sua
attività vibrazionale, lo alimenta a sua volta ed esso acquista in
qualità e potenza con un dispendio energetico minimo[…]la laringe
tramite il feedback acustico, può utilizzare l’energia del suono stesso
per
organizzare
il
proprio
meccanismo
di
produzione
sonora,
economizzando così l’energia muscolare e aerea.”11
Il concetto di brillantezza, o qualità timbrica ed energetica, è
associato alle formanti12 del cantante, in quanto secondo la Rohmert
un’energia sonora permanente è garantita solo da un ambito di
frequenze che rimane stabile, ossia da frequenze di gruppi armonici
collocati intorno ai 3000, 5000 e 8000 Hz, che hanno una
corrispondenza
con
le
frequenze
di
risonanza
delle
cavità
dell’orecchio, che come vedremo nel prossimo capitolo gioca un ruolo
fondamentale nella fonazione; richiamando alcuni aspetti in comune
con il pensiero di Alfred Tomatis. Attraverso la brillantezza, il suono
organizza la sua struttura interna, integrando gli altri parametri
10
Videscott Maria e Elena Sartori.,La voce in musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2008 p. 64-65-66
Tosto Ida Maria, La voce musicale: Orientamenti per l’educazione vocale, EDT, Torino,2009, p.10-11-12 12
Le formanti del canatnte sono un insieme di frequenze che generano qualità timbrica ed energetica, definite brillantezza di suono. 11
17 acustici
(suono
positivamente
respiratoria,
fondamentale,
vocale,
sull’organizzazione
articolatoria,
vibrato)
corporea,
psicologica
e
sulla
influendo
funzione
conseguentemente
sull’espressione musicale.
Il suono vocale permette l’accesso all’orecchio e attraverso esso al
sistema nervoso e di conseguenza a tutto il corpo, quindi tutti i livelli
funzionali sono ordinati con un meccanismo di autoregolazione.
Il
meccanismo
fonatorio,
è
dunque
un
complesso
sistema
d’interazione che avviene grazie alla sofisticata attività dei vari organi
e con la partecipazione di tutto il corpo.
18 1.2
LA VOCE ATTRAVERSO L’ORECCHIO e L’ASCOLTO
Studi e ricerche
“Il silenzio è la musica che amo maggiormente. Ritengo che
non ci sia nulla di più musicale che il silenzio! Sia perché il
silenzio totale non esiste (se non in una camera anecoica), sia
perché il silenzio è carico di suoni sia interiori che esteriori
<<non fatti da mano d’uomo>>.(…) Ci sono persone che
sembra abbiano paura del silenzio. Io certamente no. Quanto
amo le pause! Anche in una composizione innica o
acclamatoria, una serie di pause prende un valore particolare,
perché dà senso all’attesa dell’esplosione che seguirà. Quanti
silenzi pregni di vera <<musica>>!
Giovanni Maria Rossi
Abbiamo visto nel capitolo precedente come la voce, il canto in
particolare, è il risultato di un complesso meccanismo non solo
muscolare che coinvolge l’organo laringeo, ma è anche un fenomeno
generato e condizionato da altri organi e di conseguenza da
componenti ambientali, emotive e psicofisiche.
Un’altra funzione fondamentale per la fonazione è quindi quella
dell’udito, che garantisce altre funzioni fondamentali come l’equilibrio
corporeo
e
la
funzione
vocale-linguistica,
grazie
alla
stretta
connessione con il sistema nervoso.
19 “L’udito
rispetto
alla
vista,
offre
una
percezione
diffusa,
tridimensionale e capace di cogliere l’evolvere temporale, permette
quindi di orientarsi nello spazio e di regolare l’equilibrio e l’andatura.
Se l’occhio può essere distolto o chiuso, l’apparato uditivo rimane
pervio al mondo esterno ed anzi, durante il sonno, mantiene il
contatto con l’ambiente circostante" (Wulf, 2002)13.
L’udito ha quindi la funzione di tenerci in contatto con l’ambiente
esterno, decifrando i continui segnali che ci arrivano continuamente
dall’esterno, possiamo percepire lo scorrere del tempo e lo spazio.
Per
quanto
riguarda
l’apparato
uditivo,
anatomicamente
e
fisiologicamente l’orecchio è suddiviso in tre parti, ognuna con una
propria funzione principale: l’orecchio esterno, l’orecchio medio e
l’orecchio interno:
L’orecchio
esterno
raccogliere
e
(padiglione auricolare) ha la funzione di
convogliare
le
onde
sonore;
l’orecchio
medio
(collegato al retrobocca attraverso le trombe di Eustachio) ha la
funzione di trasmettere l’energia sonora (vibrazioni) che si infrange
sulla membrana del timpano, all’orecchio interno (organo del corti
e nervo acustico) , il quale a sua volta trasforma l’energia sonora in
impulsi
elettrici
che
percezione del suono.
raggiungono
il
cervello
determinando
la
14
Il compito principale del nervo acustico è quello di codificare lo
stimolo per conservare le informazioni sulle frequenze, i tempi e le
ampiezze. Il nervo acustico trasforma così il messaggio sotto forma di
un segnale nervoso che contiene tutti i dettagli utili per capire che
cosa l’orecchio ascolta in in dato momento.15
13
ManaroloGerardo.,Manuale di musicoterapia, Cosmopolis,Torino p. 132
ManaroloG.,Manuale di musicoterapia, Cosmopolis,Torino p. 132
15
BencivelliS.,Perché ci piace la mucica , Orecchio, emozione, evoluzione., Sironi,Milano, 2007,p .47 14
20 Come accennato nel capitolo precedente c’è un collegamento tra
laringe e orecchio, il collegamento è molto stretto in quanto
entrambi gli organi: sono formati dalle stesse materie organiche
(legamenti,
mucosa,
muscoli,
cartilagini,
ossa);hanno
nessi
neurologici e inoltre nell’orecchio avviene lo stesso fenomeno di
risonanza che avviene nella laringe.
16
Tra i vari ricercatori, che hanno avuto come oggetto di studi la
connessione del meccanismo fonatorio a quello uditivo, troviamo
Afred Tomatis (1920-2001), medico e otorinolaringoiatra, negli anni
cinquanta si è occupato della discussa teoria che ha approfondito il
rapporto tra la qualità dell’ascolto e la qualità dell’emissione vocale:
16
Videscott Maria e Elena Sartori.,La voce in musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2008 ,p.66 21 secondo la sua teoria la modificazione dell’ascolto può portare alla
modificazione dell’emissione vocale ( effetto “Tomatis). Ipotizzò
l’esistenza
di
l’esperienza
un
legame
tra
lo
dell’ascolto,facendo
sviluppo
nascere
della
personalità
e
“l’audiopsicofonologia”,
disciplina che studiava e applicava la rieducazione dell’orecchio, per
accrescere la capacità di ascolto di un individuo. Secondo Tomatis,
bisogna ripercorrere le tappe dello sviluppo dell’ascolto dell’individuo,
andando a stimolare le frequenze a cui l’orecchio si è chiuso, per
cause traumatiche e psicologiche. Per lo studioso
solo l’orecchio
destro è in grado di assicurare lo specifico ruolo per cui è deputato :
questa specificità consiste nell’essere l’organo che capta tutti i
controlli fonatori e vocali. Tra l’orecchio destro e il cervello avviene
quindi un continuo e fondamentale
nell’atto cantato
scambio di informazioni, e
tutto il corpo è coinvolto nella sua interezza,
predisponendosi in funzione di questa azione. L’emissione della voce
è quindi fortemente influenzata dalla funzione uditiva, che permette
di regolarne l’espressione. Attraverso la vocalità
ogni cellula del
nostro corpo si attiva e partecipa ad un ascolto che và al di là della
semplice
funzione
fisiologica
dell’udito,
ma
un’attenzione interna ed esterna al nostro corpo.
che
ci
richiede
Anche “l’ascolto
richiede un silenzio esterno, ma altresì un silenzio interno, è
necessario creare dentro di noi un vuoto di senso e di ordine dove
accogliere il senso e l’ordine dell’altro (Fausto Petrella ,1996, 1997).17
Attraverso la voce e l’ascolto, noi percepiamo la nostra esistenza e
quella dell’altro. “L’essere umano ha bisogno sia di ascoltare, sia di
percepire e quindi di credere di essere ascoltato e soprattutto capito.
Come il bisogno di nutrimento e di amore , anche l’essere ascoltato è
17
ManaroloGerardo.,Manuale di musicoterapia, Cosmopolis,Torino,2011, p. 172
www.tomatis-­‐italia.ovh
22 un bisogno originario del bambino che concorre a definire l’essenza
umana”(Fausto Petrella, 1996,1997).18
Sentire e ascoltare sono due funzioni diverse: nel primo caso si
prende coscienza di un suono attraverso il circuito orecchio-cervello,
il nostro udito è sensibile a ciò che viene pronunciato e ai rumori che
ci circondano, sentire una voce non significa ascoltarla, per farlo è
necessario capire il tono e le differenze di
pronuncia, con cui si
esprime una persona, dare attenzione al suo discorso; mentre nel
secondo caso c’è la “volontà” di tutto il corpo a percepire, la nostra
mente viene coinvolta per captare e capire le parole che ci vengono
dette. Il nostro sistema uditivo entra in gioco in entrambe le azioni,
ma con la differenza che nell’atto di sentire è solo l’udito a essere
coinvolto nel processo ; mentre nell’ascolto sia l’udito che le funzioni
cognitive vengono coinvolti nell’ azione. Dunque nell’ascolto avviene
un processo psicologico e fisico che il nostro corpo traduce in
sensazioni, emozioni e nozioni e crea un’apertura con l’ambiente che
ci circonda, alla relazione con gli altri e con il mondo. Di conseguenza
l’ambiente influenza ed è influenzato nell’ascolto e nella produzione
fonatoria. Tomatis attraverso i suoi studi ha valorizzato la ricchezza
dell’ascolto che porta ad uno stato di benessere a tutta la persona,
tramite l’atto cantato: “Si canta con il proprio corpo[…] Il corpo viene
messo in azione a tutti i livelli, grazie ai collegamenti sapienti del
sistema nervoso[…] L’uomo altro non è se non un orecchio che parla
e che canta[…] Tutto è canto e armonia nel nostro corpo. Tutto è
musica se solo ci si lascia condurre dalla sua natura, la quale è
accordata con il canto stesso della creazione[…]basta ricordare che
tutto è vibrante. Come tutto è vivente. E una delle manifestazioni del
corpo umano consiste nell’entrare in sintonia, in armonia, in simpatia
18
ManaroloGerardo.,Manuale di musicoterapia, Cosmopolis,Torino,2011, p. 173
23 con l’ambiente circostante. Così l’atto cantato permette di stabilire un
dialogo con lo spazio. Crea un movimento di comunicazione mediante
l’ambito vibrante a cui dà
forma con l’aiuto dell’aria vitale che
penetra ogni individuo[…]. 19 Il canto è quindi una vera e propria
funzione umana che coinvolge ogni parte del nostro corpo e
l’ambiente circostante.
Da queste teorie che vedono coinvolto il nostro corpo nella sua
totalità, ho trovato anche interessante l’esperienza di Giovanni Maria
Rossi, compositore, organista, direttore di coro e musicoterapista
(1929-2004),
che
ha
teorizzato
la
metodologia
della
“VOCE-
PERSONA”, riportata da Marina Mungai, musicista, direttore di coro e
musicoterapista
,nella
pratica
dell’introduzione
alla
vocalità
e
nell’integrazione corale.20
Secondo questa metodologia , che dà importanza all’armonia tra
corpo -voce- persona, la voce è considerata come lo strumento di
comunicazione per eccellenza e lo studio della vocalità,attraverso vari
approcci (yoga, training autogeno, ecc) e tecniche vocali, parte dalla
distensione psicofisica e dalla coscienza della respirazione come
“grande regolatore” del corpo. Questo tipo di approccio, con un taglio
musicoterapico, mira a portare miglioramento all’espressione della
propria personalità, all’inserimento in un gruppo, come quello corale,
attraverso il cammino di scoperta della propria voce, con una
consapevolezza maggiore alla respirazione e al corpo.
Per cantare è, quindi, necessario
mondo
interiore
e
dell’ambiente
un lavoro di ascolto del proprio
esterno,
per
permettere
una
maggiore consapevolezza di sé, attraverso il canale vocale.
19
TomatisAlfred.,L’orecchio e la voce, Baldini &Castoldi, Milano p. 32-33
20
www.coronoteblu.net -­‐ La voce persona 24 1.3
LA VOCE COME IDENTITA’: TRA L’ARCAICO E IL
MATERNO
Le origini psicologiche della voce
“Nella lingua che parlo, risuona la lingua di mia madre, meno
linguaggio che musica, meno sintassi che canto di parole…C’è
una lingua che io parlo, o che mi parla in tutte le lingue. Una
lingua, al tempo stesso unica e universale, che risuona in ogni
lingua nazionale quando sono i poeti a parlarla. In ogni lingua
fluisce latte e miele. E in questa lingua, lo so, io non ho
bisogno di entrarci: essa sgorga da me, fluisce, è il latte
dell’amore, il miele del mio inconscio”
Helene Cixous
Come nasce il nostro legame con la musica e la vocalità?
Perché la voce ha un ruolo così importante nella nostra vita?
La voce umana nasce nel momento in cui nasce un essere umano, ed
è unica per ogni individuo. Abbiamo analizzato precedentemente
come attraverso il respiro, che è il soffio vitale che anima il nostro
corpo e attraverso la ritmicità e la pulsazione dell’inspirazione e dell’
espirazione, che mostrano il mutare di molte condizioni fisiologiche e
psichiche , nasce il suono della voce, quella voce che ci rende unici, ci
identifica e ci mette in relazione con il mondo, in ogni epoca e in ogni
cultura. La voce è lo strumento più antico, e permette di creare un
ponte tra la nostra interiorità e il mondo che ci circonda, mettendoci
in relazione con l’altro. La nostra
esperienza sonora precede la
nascita: già nel grembo materno il bambino entra in contatto con i
25 suoni del corpo della madre e del mondo esterno, che determinano
un impronta non-verbale. Nel corso della gestazione “ vi è un
apprendimento uterino delle caratteristiche delle vocalizzazioni e di
altri movimenti che segnalino emozioni affettuose; vi è la preferenza
per forme dinamiche di comunicazione; questa sottile abilità di
ricezione dell’espressività umana deve affondare le proprie radici in
strutture cerebrali dedicate alle emozioni e ai loro mutamenti
dinamici” (Trevarthen, 1998).21
Daniele Schon ci spiega come diverse ricerche hanno mostrato che il
feto comincia a rispondere a suoni e rumori a partire dal terzo
trimestre della gravidanza. I neonati riconoscono innanzitutto la voce
della propria madre.[…] .Questo dimostrerebbe il funzionamento
percettivo e cognitivo prima della nascita. Ancora nell’utero, il futuro
nato è estremamente sensibile alla struttura acustica del suono: il
tono della voce , il suo contorno che sale e scende, la sua intensità, i
respiri e le pause”[…].
22
Il feto discrimina la voce della mamma preferendola alla voce di una
donna estranea, e questo permetterà al neonato, dopo la nascita di
riconoscere e instaurare il legame tra madre e figlio.
Il bambino si trova quindi immerso in un mondo sonoro già nel
grembo materno, dove entra in contatto e struttura la sua identità
attraverso vari suoni. A tal proposito Rolando Benenzon ci parla delle
identità sonore, chiamate anche
Iso;
in particolare: “il battito
cardiaco, con la sua struttura di ritmi binari, i suoni di inspirazione ed
espirazione, i suoni dell’acqua, del vento, il ritmo del camminare,
certe sonorità come i sistemi dei messaggi degli animali, in
particolare delle balene e dei delfini, sono tutti suoni che fanno parte
21
ManaroloGerardo.,Manuale di musicoterapia, Cosmopolis,Torino, 2006 p. 40
22
Schon D., Akiva-Kibiri L., Vecchi T.,Psicologia della musica, Carocci, Roma, 2007 p.15
26 di un mosaico genetico ereditato” e rappresentano
l’iso universale
plasmato da archetipi sonori.[…]. Mentre “Il sussurro della voce della
madre, il fruscio delle pareti uterine, il flusso sanguigno, le variazioni
delle pulsazioni, che saranno vitali per la vita dell’embrione, fanno
parte integrante dell’iso gestaltico”.23
La voce rappresenta la nostra essenza, ma è anche il veicolo sonoro
privilegiato che ci consente di entrare in relazione con gli altri esseri
umani; la voce materna è la nostra prima esperienza vitale e
relazionale, il nostro primo vero legame psichico perché è il
nutrimento sonoro insieme a quello alimentare, attraverso il cordone
ombelicale, che avrà in seguito un ruolo fondamentale per la
strutturazione soggettiva del bambino.
L’espressione primaria della voce dell’essere umano è il pianto del
neonato, con il quale il bambino inizia ad interagire con il mondo
esterno e ad esprimere i propri bisogni alla madre. La voce del
bambino entra in contatto con la voce materna, le due voci si
alternano e si mescolano creando la prima importante relazione. Per
Benenzon“ La base della relazione tra il ritmo e l’essere umano va
ricercata nel contatto sonoro del feto e la musica è l’evocazione della
madre, una riedizione della relazione con lei e con la natura.”24 In
questa relazione tra madre e bambino ha origine la “ninnananna”, il
canto che la mamma crea attraverso
l’imitazione dei suoni della
natura , per calmare e relazionarsi con il suo bambino. In tutte le
culture e le società, le ninnananne
sono da sempre uno dei primi
canali di intrattenimento per i bambini e le mamme utilizzano
semplici melodie per attrarre l’attenzione del bambino, favorirne il
sonno, comunicare emozioni. Essa permette un valore adattivo.25 La
comunicazione vocale della mamma con il bambino, viene chiamata
23
BenenzonR.,Manuale di Musicoterapia, Borla, Roma, 2011 p.52-53
24
BenenzonR.,Manuale di Musicoterapia, Borla, Roma, 2011 p. 33 25
Bencivelli Silvia., Perché ci piace la musica, Orecchio, emozione, evoluzione, Sironi, Milano, 2012,p. 149 27 mammese o baby talk,
e consiste in un linguaggio musicale,
cantilenante caratterizzato da molte ripetizioni, ritmo lento, tonalità
acuta, segmentazione più chiara nei confini tra le parole e l’aumento
della qualità espressiva della voce.26 Inoltre un’altra caratteristica di
questo linguaggio è l’utilizzo delle espressioni del volto e della
gestualità del corpo per accompagnare i contenuti sonori.
Stern ci spiega come le modificazioni del comportamento vocale
materno hanno, fra le altre, finalità di facilitare il bambino nel
compito di analizzare e dare significato all’universo sensoriale che lo
circonda.
Nel lavoro in ambito musicoterapico si parte da queste premesse per
cercare di integrare e rafforzare i punti deboli messi in luce dagli
studi sulla relazione primaria.
La nostra voce rappresenta quindi la nostra identità, ci riporta alla
simbiosi con la voce materna che è qualcosa di ancestrale che tutti ci
portiamo dentro e il fatto di riconoscere la nostra voce ci riporta alle
prime percezioni sonore, prima all’interno dell’utero e poi nei primi
mesi di vita. Scoprire la propria voce , significa scoprire il nostro
patrimonio di sensoriale e percettivo, che ci portiamo dentro.
26
Bencivelli Silvia., Perché ci piace la musica, Orecchio, emozione, evoluzione, Sironi, Milano, 2012,p. 114
28 1.4
LA VOCE COME CANALE EMOZIONALE
Studi e ricerche sulle emozioni
Forse la musica è la cosa più vicina all’amore. Ti eleva.
Personalmente mi dà le emozioni più vicine a quelle che provo
quando mi sento innamorato.
Ludovico Einaudi
Da dove arrivano le emozioni?
Diversi pensatori si sono interrogati sull’influenza della musica sulle
nostre emozioni e i nostri stati d’animo. Il principale motivo che ci
spinge ad ascoltare la musica o a cantarla è proprio l’emozione che
essa ci procura, rendendola sempre di più anche un mezzo
terapeutico. La complessità delle emozioni dipende dal fatto che esse
hanno profonde radici neurobiologiche nel nostro organismo, sono
un’esperienza
soggettiva
con
importanti
significati,
hanno
una
valenza sociale nelle relazioni con gli altri e sono definite dalla
cultura di appartenenza.
Per emozione s’intende uno stato affettivo intenso e di breve durata
determinata da stimoli ambientali, e la sua comparsa provoca una
modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico27.
Le reazioni possono essere:
• Fisiologiche: in una situazione emozionante si investono le
funzioni vegetative come la circolazione, la respirazione, la
digestione e
la secrezione, le funzioni motorie tramite
un’ipertensione muscolare , e le funzioni sensorie con svariati
disturbi alla vista e all’udito.
27
Galimberti U., Psicologia, Garzanti,Torino, 1999,p. 358 29 • Viscerali: si manifestano con una perdita momentanea del
controllo
neurovegetativo
con
conseguente
incapacità
di
astrazione dal contesto emozionale.
• Espressive: riguardano la mimica facciale, gli atteggiamenti del
corpo , le abituali forme di comunicazione.
• Psicologiche: si manifestano come riduzione del controllo di sé,
difficoltà
ad
articolare
logicamente
azioni
e
riflessioni
,
diminuizione delle capacità di metodo e di critica.
I greci consideravano le emozioni giudizi irrazionali sugli eventi, dopo
diversi secoli di silenzio, il primo a occuparsi dal punto di vista
scientifico delle emozioni fu Charles Darwin nella seconda metà del
1800,
che considerò le espressioni facciali, quelle gestuali e quelle
vocali, e la capacità di leggerle nel prossimo come selezione
evolutiva, perché necessarie alla comunicazione tra gli individui della
stessa specie. 28 Darwin basandosi sulla sua teoria evoluzionistica,
teorizza che le espressioni facciali siano l’indicatore primario per la
comunicazione del nostro stato emotivo. Negli esseri umani questo è
frutto di un lungo processo evolutivo, che evidenzia un’ universalità
dei segnali espressivi anche attraverso le culture o specie differenti.
Secondo la teoria evoluzionistica di Darwin, nell’emozione ci sono
componenti biologiche primitive tra cui il controllo esercitato su di
essa dalle parti più antiche del cervello. Attraverso le espressioni del
viso si possono appunto distinguere le diverse emozioni come : la
paura, la felicità, la tristezza e possono essere lette in modo
universale da tutti gli uomini e da tutti i popoli.
La teoria di James-Langhe (1884) o teoria periferica fà riferimento
ai processi neurofisiologici: l’evento emotigeno determinerebbe una
serie di reazioni viscerali e neurovegetative
che sono avvertite dal
soggetto e la percezione di queste modificazioni fisiologiche sarebbe
28
Bencivelli Silvia., Perché ci piace la musica, Orecchio, emozione, evoluzione, Sironi, Milano, 2012p. 135 30 alla base dell’esperienza emotiva. L’emozione soggettiva viene
riconosciuta come conseguenza di una risposta fisiologica, in questo
modo” non si scappa perché si ha paura , ma si ha paura perché si
scappa”, “non tremiamo perché abbiamo paura, ma abbiamo paura
perché tremiamo”.
Contrapponendosi alla teoria periferica di James,
Cannon (1927)
elabora e propone una teoria centrale delle emozioni. Secondo
Cannon
il
sistema
nervoso
centrale
gioca
quindi
il
ruolo
fondamentale nel meccanismo dell’emozione: i centri di attivazione,
di controllo e di regolazione dei processi emotivi non sono in sedi
periferiche come i visceri, ma sono localizzati centralmente nella
regione
talamica,
dove
i
segnali
nervosi
da
essa
provenienti
sarebbero in grado sia di indurre le manifestazioni espressivo motorie delle emozioni, sia di determinare le loro componenti
soggettive attraverso le connessioni con la corteccia cerebrale.
Nel 1937 Papez
parte dal contributo di Cannon, per avanzare
l’ipotesi secondo cui i centri di elaborazione e di controllo delle
emozioni sono situati lungo il circuito composto dall’ipotalamo, dal
talamo anteriore, dal giro cingolato e dall’ippocampo (circuito di
Papez). Mac Lean nel 1949 integrò il circuito di Papez con altre
regioni,
tra
cui
l’amigdala,
denominando
queste
strutture
neuroanatomiche con il nome di sistema limbico, considerato la
sede di elaborazione e di regolazione dell’emozionalità. Tra le
strutture che formano il sistema limbico, le più importanti in
riferimento alle emozioni sono l’ipotalamo e l’amigdala: L’ipotalamo è
la
sede
della
regolazione
centrale
dell’ambiente
interno
dell’organismo e la stimolazione di specifici siti dell’ipotalamo nella
zona mediale
produce configurazioni di risposte emotive complete;
l’amigdala è stata ritenuta come una sorta di computer dell’emotività,
per la sua posizione strategica nel centro della rete emozionale,
31 dovuto a molteplici sistemi di connessione con le altre strutture
nervose, essa “interpreta” lo stato del soggetto rispetto all’ambiente
esterno, regolando il comportamento di conseguenza.
Dal punto di vista psicologico Schatcher (1964) ideò la teoria
cognitivo-attivazionale o teoria dei due fattori:l’emozione è frutto
dell’interazione tra percezione dello stimolo, reazione fisiologica
dell’organismo (aurosal
29
) e codifica di quest’ultima a livello
cognitivo. Tale teoria è detta dei due fattori, in quanto lo psicologo
lega l’aspetto cognitivo individuato dalla teoria di James; per lo
studioso il fattore fisiologico non è emozione ma, lo stato
di
attivazione è generato dal SNA (sistema nervoso centrale), questo
fino a quando non lo interpretiamo a livello cognitivo legandolo ad
un’emozione (es. SENSAZIONE DI PAURA-MINACCIA).
Da
questa
concezione
dell’Appraisal (1980)
30
di
Schachter
prendono
avvio
e
sociale.
profondamente
l’elaborazione
teorie
, secondo cui le emozioni dipendono da come
ogni individuo valuta e interpreta gli stimoli del proprio
fisico
le
Viene
intrecciate
cognitiva
evidenziato
con
della
i
che
processi
situazione
le
emozioni
cognitivi,
dipende
ambiente
in
sono
quanto
dall’esperienza
emotiva del soggetto. Le emozioni non appaiono all’improvviso o
casualmente, sono la conseguenza di un’attività di conoscenza e
valutazione della situazione in riferimento alle sue implicazioni per il
29
Aurosal: il termine indica lo stato di attivazione neurovegetativa dell’organismo ed è legato a cambiamenti
dell’assetto fisico e psicologico di ogni individuo. Sul piano fisico questo sistema di attivazione coinvolge diversi
sistemi biologici, quali sistema nervoso autonomo e sistema endocrino, mentre sul piano psicologico orienta le
nostre capacità di memoria, attenzione, presa di decisioni, espressione delle emozioni e messa in atto dei
comportamenti.
30
La teoria dell’Appraisal: le emozioni sono il risultato di come l’individuo struttura e dà significato ad uno stimolo.
Due individui possono reagire in maniera diversa davanti allo stesso stimolo. Con questa teoria viene messo in
evidenza la connessione tra le emozioni e gli stati cognitivi.
32 benessere dell’individuo
e il soddisfacimento dei suoi interessi e
scopi.
Le teorie psico-evoluzionistiche, a partire da Tomkins (1960), si
rifanno alla teoria evoluzionistica di Darwin , ritenendo le emozioni
strettamente associate alla realizzazione di scopi universali, connessi
alla sopravvivenza della specie e dell’individuo. Gli studiosi Ekman e
Izard avanzarono l’ipotesi tra emozioni primarie ( la gioia, la
tristezza, la collera, la paura) e emozioni miste o secondarie(
l’imbarazzo, la colpa, la vergogna, l’orgoglio) che sono una sorta di
miscela tra le diverse emozioni primarie, secondo i quali le
espressioni facciali delle emozioni primarie vengono espresse in
maniera universale e riconosciute in ogni cultura del
mondo, tra
primati e esseri umani poiché il viso è la parte più espressiva del
nostro corpo e per mezzo di esso esprimiamo tutta la gamma delle
emozioni. Le espressioni facciali sono quindi una parte costitutiva
delle emozioni. Nelle società primitive come nelle società più
avanzate le espressioni del viso
hanno un impatto comunicativo
molto più rapido delle parole.
L’esperienza emotiva oltre ad avere aspetti di valutazione della
situazione e la comparsa di modificazioni corporee,
processo
interno
che
viene
manifestato
è quindi un
all’esterno
attraverso
specifiche espressioni facciali, vocali, posturali e motorie in generale,
e che non è possibile
nasconderlo in quanto esiste una forte
connessione tra emozione ed espressione. Esiste inoltre una stretta
connessione fra emozione e AZIONE, l’esperienza emozionale spinge
l’individuo
all’azione:
le
emozioni
non
sorgono
soltanto
come
conseguenza diretta di un comportamento, ma sono a loro volta
all’origine di azioni e modificazioni del proprio comportamento. Infatti
la radice della parola emozione deriva dal verbo latino MOVEO,
33 “muovere”, con l’aggiunta del prefisso “e” (“movimento da”), per
indicare che in ogni emozione è compresa la tendenza ad agire.
Attualmente, con grande ritardo, si parla di Competenza emotiva,
una funzione complessa costituita da otto componenti o abilità
principali:
1)La consapevolezza del proprio stato emotivo.
2)La capacità di riconoscere le emozioni altrui.
3)La capacità di usare il vocabolario delle emozioni solitamente
disponibile nella propria cultura.
4) La capacità di coinvolgimento simpatetico nelle esperienze emotive
di altre persone.
5) La capacità di comprendere che lo stato emotivo interiore non
corrisponde necessariamente alla manifestazione esteriore, sia in se
stessi, sia in altre persone.
6) La capacità di affrontare in maniera adattiva le emozioni negative
e angoscianti.
7) La consapevolezza che le relazioni sono definite in larga misura dal
modo in cui le emozioni sono espresse e dalla reciprocità delle
emozioni al loro interno.
8) La capacità di autocontrollo emotivo, in altri termini, avere il
controllo delle proprie esperienze emotive e saperle accettare
(Saarni 1999).31
In ambito scientifico gli studi sul rapporto tra voce ed emozione sono
piuttosto recenti, nonostante nelle scuole dell’antica Grecia e di Roma
veniva enfatizzato il ruolo fondamentale delle capacità vocali per
esprimere le emozioni.
Un valido contributo, in Italia, è stato dato
dagli psicologi Luigi Anolli e Rita Ciceri, mettendo in evidenza come
31
SchafferH.Rudolph, Psicologia dello sviluppo, Raffaello Cortina,Milano, 2005,p.167
34 attraverso la voce la comunicazione emozionale viene modulata dal
ritmo, dall’intonazione, dall’intensità e dalla qualità articolatoria della
fonazione.
La collera e la paura sono emozioni caratterizzate da un incremento
dell’intensità della voce, mentre la tristezza da un basso tono e un
ritmo articolare rallentato. In particolare negli studi sull’ encoding
vocale delle emozioni emerge la capacità del canale vocale non
verbale nel trasmettere, indipendentemente dal contenuto verbale,
precise informazioni sugli stati affettivi ed emotivi dell’interlocutore.
L’evento emotigeno crea quindi reazioni fisiologiche che condizionano
i parametri della respirazione, della fonazione e l’articolazione
dell’eloquio.
Dunque gli stati emotivi sono efficaci solo se vengono calibrati in
funzione dei contesti e degli avvenimenti. Il controllo o la repressione
delle emozioni rappresentano sia un problema nel rapporto con sè
stessi che con gli altri e a livello fisiologico causano attivazioni
organiche . Nel lavoro fonatorio l’espressione emozionale gioca un
ruolo di fondamentale importanza, in quanto il corpo e
la mente
sono strettamente coinvolti nell’atto emotivo e la voce ne è un
importante fattore integrante. Tuttavia il dialogo interno non avviene
sempre in modo facile, emozione e ragione a volte mandano ordini
contrastanti al corpo generando azioni confuse e arrivando a
manifestarsi con sintomi di disagio psicofisico.
Lo stress
e l’ansia oltre ad avere effetti negativi sul sistema
cardiovascolare, abbassano anche la risposta immunitaria, causando
indebolimento fisico o delle vere e proprie patologie.
Lo psicologo Robert Ader nel 1974, attraverso i suoi studi scoprì
come anche il sistema immunitario come il cervello e il sistema
nervoso centrale, è in grado di apprendere e rispondere all’esperienza
35 modificando il proprio comportamento. 32 Questi studi sulla biologia
hanno permesso di dimostrare come la mente, le emozioni e il corpo
non sono entità separate, ma intimamente interconnesse. Il sistema
nervoso centrale e il sistema immunitario comunicano fra loro in
diversi modi, tanto da poter influenzare le funzioni immunitarie
dell’organismo.
Il sistema immunitario è quindi profondamente influenzato dal nostro
sistema psichico, che raccoglie e analizza le nostre emozioni e dal
nostro sistema nervoso, che mette in comunicazione le parti del
nostro corpo.
Nel mio percorso con l’analisi bioenergetica ho potuto sperimentare il
valore della scarica emozionale e dell’espressione emotiva, attraverso
il lavoro con il corpo. Le emozioni sono appunto impulsi, movimenti
interiori che partono dal centro di ogni individuo e se riusciamo a
costruire un accordo tra corpo, emozioni e ragione possiamo
esprimere al meglio il nostro potenziale.
Il canto è uno dei modi più importanti per comunicare le nostre
emozioni ed è il canale per trasformare i sentimenti in suono.
32
Goleman D.,Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 1996,p.114 36 1.5
LA VOCE E LA BIOENERGETICA
La bioenergetica e la mia esperienza vocale attraverso il
lavoro corporeo
“La vita di un individuo è la vita del suo corpo”.
Alexander Lowen
Abbiamo visto come il corpo è
composto da un’insieme di strutture
in stretta relazione tra loro: lo
scheletro, i muscoli, i vari organi e i
tessuti. Ma il corpo ci mette anche
in
relazione
con
l’ambiente
attraverso i sensi, il movimento,
influenza ed influenzato dai nostri
pensieri e dalle nostre emozioni ,
attraverso
le
esperienze
che
viviamo.
Nell’esplorazione della propria voce, i primi passi consistono in un
approccio consapevole al proprio corpo e al proprio respiro.
Il mio percorso con la voce, mi ha portato negli anni ad approfondire
diversi ambiti alternativi alle tecniche tradizionali di canto.
Tra i
diversi approcci che ho analizzato e sperimentato, quello che ritengo
più influenti nel
mio rapporto
voce – corpo – spirito, sono la
meditazione e l’analisi bioenergetica, entrambe mi hanno permesso
negli anni di avere una maggiore consapevolezza del mio corpo e in
particolare della mia voce.
37 Ritengo entrambe complementari l’una all’altra, in quanto per
meditare è necessario uno stato di “presenza” che può essere
raggiunto solo attraverso l’ancoraggio al corpo e in particolare al
respiro; il corpo è l’unico mezzo per restare nel presente, mentre la
mente cerca di portarci continuamente nel passato o nel futuro, cioè
nell’illusione. Il lavoro corporeo invece con l’analisi bioenergetica
allena ad un ascolto più profondo attraverso la conoscenza del
proprio corpo e del proprio stato emotivo.
In particolare, l’analisi bioenergetica nasce negli anni ’50, negli Stati
Uniti, ed è lo studio della personalità umana dal punto di vista dei
processi energetici del corpo.
Alexander Lowen (1910-2008) medico psicoanalista, ne ha coniato il
termine, basandosi sugli insegnamenti di Wilhelm Reich (18971957)psicoterapeuta impegnato nei problemi sociali e politici33, i quali
si focalizzavano sull’identità funzionale tra il carattere di una persona
e il suo atteggiamento corporeo, o armatura muscolare 34 .Questa
tecnica psicoterapeutica associa il lavoro sul corpo a quello sulla
mente per risolvere problemi emotivi ed esprimere in maniera più
ampia il proprio potenziale. Per Lowen i processi energetici del corpo
determinano
ciò
che
succede
nella
mente
esattamente
come
determinano ciò che succede nel corpo. Lo scopo della bioenergetica
è quello di rilassare le contrazioni muscolari permettendo così di far
affiorare alla coscienza le emozioni che hanno provocato blocchi
energetici ed emotivi e restituire alla persona uno stato naturale di
carica energetica, attraverso la consapevolezza di sé, la capacità di
auto-espressione e la padronanza di sé.
33
VegettiFinziS.,Il bambino nella psicoanalisi, Zanichelli,Bologna, 1976 p.43 34
Armatura o corazza: indica lo schema globale delle tensioni muscolari croniche del corpo. Vengono
definite così perché servono a proteggere l’individuo contro le esperienze emotive dolorose e minacciose.
Fungono da schermatura contro gli impulsi pericolosi della sua stessa personalità e contro gli attacchi da
parte degli altri. 38 “ La voce quando è libera, viene dal cuore: allora l’individuo parla col
cuore. Ciò significa che il canale di comunicazione tra cuore e il
mondo è aperto e non ostruito”.35
Lowen, parla della voce in ambito bioenergetico, partendo dalla
radice della parola Personalità, che ha due radici con due diversi
significati: la prima è persona, in quanto maschera, che apre al
lavoro teatrale dell’attore sulla scena, e rappresenta il ruolo che un
individuo assume nella vita; la seconda è per-sona , che significa
attraverso i “suoni”, e rappresenta la personalità che si riflette nel
suono di un individuo.
La maschera è inanimata e non può
trasmettere, a differenza della voce, la vibrazione dell’organismo
vivente. Il corpo e di conseguenza la voce , non mentono.
Nonostante una persona possa cercare di nascondere i propri
sentimenti o le proprie emozioni attraverso una determinata postura
artificiale, il corpo la smentisce attraverso le varie tensioni che si
vengono a creare nel corpo. Ad esempio una voce ricca ha armonici
alti e bassi che la arricchiscono con un suono pieno, mentre una
voce piatta, senza profondità , può essere bassa, senza energia,
oppure esile e senza corpo. Ciascuna di queste qualità vocali ha un
certo rapporto con la personalità dell’individuo. Per Lowen i tremiti
sono vibrazioni e l’assenza di vibrazioni indica la presenza di stress o
di un freno, nel corpo o nella voce, provocando in quest’ultima una
perdita di risonanza, di conseguenza il blocco di un qualsiasi
sentimento
influisce
sull’espressione
vocale,
questo
porta
a
considerare ognuno dei tre elementi che entrano in gioco nella
creazione del suono: il flusso d’aria sotto pressione che agisce sulle
corde vocali per produrre una vibrazione,
le corde vocali che
35
Lowen A., Bioenergetica, Feltrinelli, Milano, 2014, p. 243
39 funzionano come strumenti vibratori, le cavità di risonanza che
aumentano il volume del suono.
Lowen considera tre aree in cui le tensioni croniche possono formare
degli anelli di costrizione, restringendo il canale vocale e impedendo
l’espressione dei sentimenti.
36
-Il primo anello può formarsi intorno alla bocca: una bocca serrata o
chiusa può bloccare ogni comunicazione di sentimenti, come premere
le labbra e irrigidire la mascella.
-Il secondo anello di tensione si forma all’articolazione del capo con il
collo, dove troviamo la zona di transizione dal controllo volontario a
quello involontario. La faringe e la bocca sono sulla parte anteriore di
questa
zona,
l’esofago
e
la
trachea
sulla
parte
posteriore.
L’organismo ha un controllo cosciente su tutto ciò che è in bocca o
nella faringe; mentre non si ha più la possibilità di controllo nella
zona dell’esofago.
-Il terzo anello di tensione è situato all’articolazione fra collo e
torace: la tensione che si sviluppa
è anche funzionale in quanto
protegge l’apertura che porta alla cavità toracica e dunque al cuore.
Quando
la
contrazione
è
cronica,
questi
muscoli
elevano
e
immobilizzano le costole superiori, restringendo l’apertura che porta
al
petto,interferendo
con
la
respirazione
e
influenzando
di
conseguenza la produzione della voce.
Per Lowen il nucleo della terapia è giungere al cuore:”il cuore è
probabilmente l’organo più sensibile del corpo. La nostra esistenza
dipende dalla sua attività costante e ritmica. Quando questo ritmo si
altera anche solo momentaneamente, ad esempio quando il cuore
perde un colpo o si mette a battere all’impazzata, proviamo un senso
di ansia nel più profondo del nostro essere. Chi abbia provato questa
36
Lowen A., Bioenergetica, Feltrinelli, Milano, 2014, p. 238-239-240-241-242
40 ansia precocemente svilupperà molte difese per proteggere il cuore
dai pericoli che ne possono disturbare il funzionamento. Non
permetterà che il suo cuore venga toccato e le sue reazioni al mondo
non verranno dal cuore. Queste difese vengono elaborate nel corso
della vita e infine formano una potente barriera contro qualsiasi
tentativo di raggiungere il cuore.”37
Come analizzato già in precedenza le posture e il movimento si
influenzano
a
vicenda
e
possono
rappresentare
anche
delle
disfunzioni organiche e dispendio energetico. Le posture sbagliate
limitano l’efficienza respiratoria, costringono i muscoli a sviluppare
tensioni, favoriscono la comparsa di stati mentali negativi. Quando
alteriamo una postura, nel tempo può comportare problemi di tipo
muscolare e articolare, ma anche circolatoria, respiratoria e viscerale,
creando squilibri sul benessere generale. “La tensione muscolare
cronica in diverse parti del corpo costituisce la prigione che impedisce
la libera espressione dello spirito dell’individuo. “38 In bioenergetica i
cambiamenti della personalità, avvengono attraverso i cambiamenti
delle funzioni corporee permettendo: una respirazione più profonda,
maggiore motilità, espressione di sé più piena e più libera.
In bioenergetica come in tante discipline psico - corporee, gli esercizi
sono molteplici e includono tutto il corpo: dal respiro all’utilizzo della
voce, al lavoro sui piedi o sul bacino. In particolare l’esercizio di
radicamento o Grounding ha una funzione molto importante; per
Lowen significa essere radicati nella propria verità, accettando se
stessi e i propri vissuti. Questo esercizio permette di stabilire un
contatto equilibrato con il suolo che ci sostiene, facendo percepire un
maggiore equilibrio psicofisico. Simbolicamente rappresenta la realtà,
e significa ristabilire il contatto dei piedi al terreno. Il concetto di
37
Lowen A., Bioenergetica, Feltrinelli, Milano, 2014, p.102
38
Lowen A. ,Arrendersi al corpo, Il processo dell’analisi bioenergetica, Astrolabio, Roma, 1994 p. 15 41 grounding , usato esclusivamente in ambito bioenergetico, si basa
sulla convinzione che il trauma fisico e psichico, riduce il contatto con
la realtà, causando lo strutturarsi di un ritiro, anche a livello
corporeo,
dovuto
conseguenza
alla
riducendo
perdita
la
di
radicamento
capacità
di
stare
a
terra
nella
e
di
realtà.
E’
rappresentato in un esercizio, dove il soggetto è in piedi con le
gambe leggermente divaricate e le ginocchia flesse: questa postura,
che troviamo in altre discipline, tra cui anche il canto, permette di
avere una maggiore stabilità, equilibrio, sostegno, radicamento alla
terra e di conseguenza genera maggiore sicurezza, consapevolezza e
libertà di espressione.39
Nei lavori delle classi di bioenergetica, come nella meditazione, il
lavoro con la voce permette di entrare in una connessione più
profonda anche con gli altri componenti del gruppo: si genera uno
stato di apertura a livello del cuore, sposta la comunicazione da un
livello verbale a un livello non- verbale, creando una sintonia
maggiore tra tutti i partecipanti. Nella mia esperienza personale mi
sono avvicinata alla tecnica bioenergetica individuale e di gruppo
perché per diverso tempo nel canto sentivo l’esigenza di esprimere
maggiormente la mia voce e le mie emozioni al di là dell’esibizione
vocale prettamente tecnica. Nel tempo ho sentito la mia voce mutare
completamente: inizialmente era quasi metallica, e risuonava nella
parte alta della testa, spesso negli esercizi di bioenergetica sentivo la
mia voce uscire e non la riconoscevo. Con il tempo ho imparato ad
integrare alcuni processi e oggi la mia voce si presenta più profonda,
con più sfumature, e risuona maggiormente nel petto…nel cuore!
39
www.bioenergeticaesocieta.it 42 1.6
IL CORO
ASPETTI RELAZIONALI E FUNZIONALI DI UN CORO
A)
Per
LA POLIFONIA NELLA STORIA
coro s’intende
un complesso di voci di vario timbro (soprano,
contralto,tenore, baritono, basso) per l’esecuzione di brani musicali
all’unisono o concertanti; anche la composizione musicale per coro.
Il
coro
è
dunque
un
insieme
di
più
voci
che
cantano
contemporaneamente, ed è una forma di espressione diffusa in tutte
le culture umane dall’antichità.
La parola” coro” proviene dal greco
khoréia, termine che originariamente significava sia la danza sia il
gruppo dei danzatori. Nella Grecia classica il coro rappresentava, la
danza unita al canto, l’insieme delle persone che la eseguivano e il
luogo stesso dell’esecuzione. I Greci assegnarono alla coralità,
presente nella tragedia, un notevole valore educativo.
Sin dall’antichità, la musica corale fu intesa come espressione dei
sentimenti di solidarietà, degli ideali di fede e di amor patrio di un
popolo, attribuendole una funzione religioso-politica.
La polifonia, o canto a più voci, si configura a partire dal IX d.c., con
lo scopo di arricchire il Canto Gregoriano monodico che era nato nel
Medioevo,come canto facile per le masse di fedeli inesperti d’arte e
che fino ad allora aveva rappresentato l’unica forma di canto.40 La
polifonia permise di riempire gli spazi acustici sempre più ampi delle
grandi cattedrali romaniche e gotiche e di solennizzare le cerimonie
liturgiche sempre più lunghe e complesse. Quella prima rudimentale
forma di doppio canto chiamata organum che consiste in due voci che
attaccano all’unisono per poi distanziarsi con intervalli di quarta o di
40
Mila M., Breve storia della musica, Einaudi, Torino, 1993, p. 39-40-41 43 quinta, ha un progressivo arricchimento delle combinazioni melodiche
nei secoli seguenti fino ad arrivare verso il XII secolo in Francia, dove
vengono elaborate le regole e le forme dell’arte contrappuntistica del
canto polifonico, a opera soprattutto dei monaci della Cattedrale di
Notre Dame a Parigi.
La loro produzione e la loro tecnica prende il nome di Ars Antiqua. In
seguito alla riforma luterana il canto degli inni da parte della gente
comune diventa il centro della liturgia,
dove la religione cristiana
viene per così dire “desacralizzata”, permettendo la traduzione della
Bibbia e la preghiera in lingua corrente, perché fosse compresa da
tutti. La grande rivoluzione per quello che riguarda l’attività corale,
ma anche musicale e culturale,avvenne in particolar modo nel
Romanticismo nella prima metà del 1800, dove la poetica prenderà il
posto di quegli aspetti che prima erano attribuiti unicamente alla
cultura religiosa, cioè al desiderio di trascendenza
attraverso
l’espressione artistica.
Grazie al Romanticismo avviene il recupero dell’attività corale e
dell’identità culturale popolare; in alcuni paesi nascono le corali che
si dedicano al repertorio
di musica popolare. In particolare con la
musica profana, la cultura delle corali ha il compito di conservare e
trasmettere la cultura popolare del luogo in cui aveva origine. In
questi cori inizia anche la partecipazione della voce femminile che
precedentemente non era ammessa alle esecuzioni corali liturgiche e
che veniva sostituita da cantanti uomini, bambini o castrati. Si
struttura così il canto corale, com’è conosciuto oggi, dove troviamo la
presenza di più parti vocali sviluppate simultaneamente: il repertorio
si è arricchito con l’influenza di musiche di vario genere.
I cori possono
avere svariati livelli e modalità, ma quello che li
accomuna è un certo numero di persone che decidono di condividere
la musica attraverso il canto.
44 Tra i vari cori troviamo quelli amatoriali e quelli professionali:
I cori amatoriali sono la maggior parte, e i componenti possono avere
un diverso tipo di formazione musicale, in pochi o nessuno ha
competenze musicali, ed è compito del direttore
armonizzare e
organizzare le voci dei partecipanti per realizzare la resa musicale
migliore.
I cori professionali sono molto pochi, e le competenze musicali dei
partecipanti sono maggiori, anche perché nascono proprio per una
finalità puramente estetica ed economica.
Nel canto corale, come nella vocalità, avviene la fusione della propria
voce
con
la
precedentemente
voce
degli
viene
altri,
richiamata
che
come
quella
abbiamo
fusione
visto
ancestrale
dell’interazione tra la voce del bambino e la voce materna.
45 B)
LE
FUNZIONI
DEL
CORO
IN
AMBITO
PSICHIATRICO
Un coro in ambito psichiatrico può essere considerato un intervento di
musicoterapia?
Per valutare la complicata distinzione delle funzioni di un coro in
ambito psichiatrico è necessario partire da alcune definizioni e
considerazioni sviluppate da Pier Luigi Postacchini , nel suo trattato
sulla musicoterapia:
Cura:
il
termine
si
riferisce
all’insieme
dei
mezzi
terapeutici
coadiuvanti il passaggio dalla malattia alla salute.41
“[…] noi crediamo che curare debba significare ripristinare una
condizione di armonia psicofisica , se questa c’era, o costruirne una
nuova, se non c’era[…]Noi pensiamo piuttosto che sia un discorso di
armonizzazione delle varie facoltà che debba essere promosso,
poiché è quello che conferisce un maggior gradiente di benessere,
che può però appunto derivare da un equilibrio armonico delle
parti.[…].
42
Riabilitazione: termine derivante dal diritto romano dove indica il
ripristino dello stato giuridico precedente una condanna dopo la
dimostrazione di non colpevolezza;[…][…]Nell’ambito della medicina
sociale:Scopo della riabilitazione è quello di togliere il paziente dallo
stato di emarginazione in cui si trova per effetto della sua
minorazione, per inserirlo in una condizione occupazionale e sociale il
più possibile identica a quella degli altri soggetti sociali. 43 […]”è
riabilitazione qualunque intervento o costellazione di interventi che
tendano a diminuire gli svantaggi sociali di un handicap fisico o
41
Galimberti U., Psicologia, Garzanti,Milano, 1999,p.269 42
Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Carocci,Roma, 1997,p.60-62
43
Galimberti U., Psicologia, Garzanti,Milano, 1999,p. 903 46 psichico, e insieme a diminuire le barriere edificate dalla società nei
confronti di tale handicap”(Saraceno 1985).44
Secondo Postacchini l’intervento riabilitativo in ambito musicoterapico
avviene attraverso un approccio non medico all’handicap,“dal di
fuori”, nella totalità della persona,in modo che il paziente possa
assumerne gli schemi, le funzioni e l’armonia. Il riabilitatore non
lavora sui contenuti interiori del paziente, ma aiuta il paziente nel
riapprendere gli aspetti del rapporto con il quotidiano. Permette di
veicolare l’affettività attraverso
le azioni pratiche, per favorire la
sincronizzazione tra il tempo interiore del paziente e il tempo sociale,
la riacquisizione del valore del ritmo tra gli oggetti e il corpo,
l’integrazione della memoria e la progettualità. La riabilitazione è
quindi una strategia che promuove processi cognitivi-relazionali e di
socializzazione.
Terapia: il termine deriva dal greco Therapeia. Il concetto può essere
inteso nell’accezione di guarire come finalità, oppure nell’accezione di
“procedura verso la guarigione”. In ambito medico la terapia può
intendersi come il trattamento di malattie e ferite, e l’insieme dei
metodi usati per la loro guarigione e per alleviarne i sintomi. Le
terapie sono misure aventi lo scopo di riportare uno stato patologico
a uno stato sano e rendere sopportabile la manifestazione di sintomi
disagevoli.45
Sempre secondo Postacchini la (psico)terapia è una facilitazione ,“dal
di dentro”, dei processi di consapevolezza, di regolazione dell’
emotività e delle capacità comunicative.
46
”Quello dell’handicap
neuro-psichico, in cui l’aspetto strettamente clinico e tecnico della
terapia, pur senza perdere minimamente d’importanza, viene a
trovarsi inserito in un contesto molto più vasto di azioni a forte
44
Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Carocci,Roma, 1997,p.62 45
https://it.wikipedia.org-terapia 46
Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Carocci,Roma, 1997,p.67 47 significato sociale, preventivo e riabilitativo, a cui sono chiamati
operatori di svariate competenze. Infatti la complessità del problema
handicap impone che non possa mai essere praticamente una sola
persona ad affrontarlo, sia da un punto di vista tecnico che emotivo,
ma che vi sia invece un’articolata distribuzione di competenze
all’interno di un approccio multidisciplinare(Jones, 1979)47.
Secondo l’OMS( Organizzazione mondiale della sanità)la salute è “una
qualità della vita che ha una dimensione sociale, mentale, morale e
affettiva,
oltre
che
fisica;
un
bene
instabile
che
si
deve
continuamente riconquistare, difendere e ricostruire durante tutta la
vita”.48“
La musicoterapia “a seconda del tipo di contesto e di relazione che
viene stabilita, può agire tanto in senso riabilitativo, quanto in senso
terapeutico[…] L’elemento unificante tra riabilitazione e terapia è , a
nostro avviso, l’utilizzo di parametri armonizzanti per promuovere
una migliore integrazione psicofisica della personalità, restando su un
livello più concreto
e senza entrare nel merito delle dinamiche
emotive, se si interviene in senso riabilitativo, affrontando invece i
nodi conflittuali affettivi e ideativi e quindi accedendo alla dimensione
simbolica della relazione, se si interviene in senso terapeutico.”49
Kennet
Bruscia
definisce
la
musicoterapia
come
un
processo
sistematico di intervento, attraverso il quale il terapeuta aiuta il
paziente a raggiungere uno stato di salute tramite le esperienze
musicali e la relazione che si sviluppa tra loro come forze dinamiche
di cambiamento.
50
Attraverso la fiducia che viene data alla musica e all’esperienza
musicale come agente, contesto o catalizzatore dell’esperienza
47
Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Carocci,Roma, 1997,p.66 48
Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Carocci,Roma, 1997,p.65 49
Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Carocci,Roma, 1997,p.68 50
www.fabiobranco.it 48 terapeutica , la musicoterapia si differenzia da qualsiasi altra forma di
terapia.
Sempre Bruscia distingue una musica in terapia da una musica come
terapia:
A. In terapia: Nel contesto di una terapia definita dal suo modello
epistemologico di riferimento(psicoanalitico, cognitivista, ecc),
la musica sarà impiegata come supporto e ausilio per facilitare
il lavoro terapeutico.
B. Come
terapia:
Occorre
anche
un
modello
teorico
di
riferimento e una tecnica, articolati e definiti.51
Inoltre fa un’altra distinzione tra: la musicoterapia, dove la musica
assume un ruolo terapeutico, nel progetto terapeutico, in base alla
provenienza dei vari operatori; e la musicoterapia,dove la musica ha
un ruolo di facilitatore nel contesto basato sullo sviluppo relazionale.
Nel contesto ospedaliero psichiatrico i disturbi di origine neurologica
e psicologica che riguardano la voce , considerano quest’ultima dal
punto di vista patologico: nella maggior parte dei casi la voce viene
considerata come pseudo allucinazione del paziente e consiste in una
percezione sensoriale uditiva che il soggetto sente provenire dal suo
interno, e verso cui può mantenere una capacità critica; oppure le
cosiddette “voci” distinte in interne ed esterne, che sono vere e
proprie allucinazioni caratterizzate da una percezione psicosensoriale
senza stimoli esterni, proiettata nello spazio e ritenuta dal paziente
stesso proveniente dal di fuori in assenza di qualsiasi intervento
critico da parte del paziente.
52
In questo caso la voce ha una valenza
negativa e causa l’ intervento da parte degli operatori per sedare lo
sfogo o l’urlo con il fine di contenere il paziente.
51
Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Carocci,Roma, 1997,p.102 52
Galimberti U., Psicologia, Garzanti,Milano, 1999, p.1075
49 “Le voci allucinatorie che tormentano questi pazienti testimoniano la
dissociazione fra voce e corpo, elementi che non costituiscono più
un’identità, una sola persona. Le voci si rivolgono al soggetto
colpendolo nella sua esistenza vitale nella sua individuale egoità,
rammentandogli, indicandogli o alludendo a difetti, caratteristiche e
contenuti che sono in relazione affettivi di ordine conflittuale[…]”.53
In ambito musicoterapico e nel coro del DSM, il lavoro con la voce
assume invece una valenza potente, catartica,liberatoria e permette
di esprimere le emozioni,anche le più violente, attraverso il canale
vocale.
I coristi che appartengono ad un coro del DSM non hanno una grande
preparazione musicale, ma entrano in un coro e ci restano non tanto
per il repertorio o l’aspetto musicale, ma maggiormente per la
valenza socializzante che avviene all’interno del gruppo corale.
Nelle sue riflessioni riguardo la creazione e l’attività corale in ambito
psichiatrico Alice Isabella Gibelli, musicoterapista considera il coro
come
“un
contenitore
spazio-temporale”
definito,
che
prevede
l’incontro tra individui che partecipano ad un esperienza collettiva,
comune, in questo caso musicale, consistente nell’acquisire una
preparazione vocale – musicale sufficiente ad affrontare un repertorio
di brani corali, e forse anche nell’impegnarsi in obiettivi comuni come
l’organizzazione
e/o
la
partecipazione
a
rassegne
e
concerti,
incontrando altri cori e cantando per altre persone […]. Nel coro, sin
dall’inizio le persone, vanno incontro ad una sorta di identificazione,
dipende dalla qualità della propria voce, che li definirà di volta in
volta come soprano, contralto, tenore o basso e determinerà, almeno
in parte, il ruolo che svolgeranno e la collocazione che avranno nel
coro stesso”[…] L’attività corale, se ben indirizzata, può restituire un
53
Manarolo G. e Borghesi M., Musica &Terapia,Quaderni italiani di musicoterapia, Cosmopolis, Torino,2004,p.110 50 senso di autoefficacia, così come può diventare un luogo di
allenamento per migliorare la propria resistenza alla frustrazione”.54
Attraverso l’attività corale, l’individuo mette in gioco capacità
relazionali, come l’inserimento e l’adattamento nel gruppo, attraverso
i diversi processi che avvengono nell’interazione:
- Lo sviluppo delle capacità di stringere e intrattenere relazioni con
gli altri
- Integrare il proprio comportamento con quello degli altri
- Affrontare e risolvere eventuali conflitti, attuando abilità di
contrattazione e negoziazione
- Assumere, riconoscere e rispettare ruoli diversi- Rispettare le regole
di ogni ambiente e saperle contraddire in maniera socialmente
adeguata
- Capacità di condivisione
- Capacità di comunicare con gli altri in modo efficace
- Esprimere in maniera adeguata le proprie emozioni
- Entrare in empatia con gli altri
“L’attività corale diventa quindi una pratica, un’esperienza sociale e
relazionale
vissuta
attraverso
la
vocalità.
Anche
il
repertorio,
strutturato tendenzialmente su modelli di musica popolare, di
tradizione contadina o di musiche di canto sociale di protesta,
contiene il significato intrinseco del desiderio di fratellanza e unione
attraverso il canto, superando ogni pregiudizio”.55
Bernardino Streito, fisico e musicista e direttore di coro, considera il
coro come “un’ insieme di identità individuali che perseguono il
progetto collettivo di raggiungere un esito artistico attraverso
54
ManaroloG,Le cure musicali,Applicazioni musicoterapiche in ambito psichiatrico,Cosmopolis,Torino, 2012p.267
Albano Fabio,Rivista, Musica e terapia, N°20,Articolo, Il canto sociale della corale Cavallini di Modena
55
51 l’impiego della voce[…]. Il cantare in coro presuppone da parte di
ciascuno il senso del servizio e della partecipazione al progetto
secondo le possibilità e abilità personali.[…]. Il cantore impara innanzi
tutto ad entrare in rapporto con la propria voce, cioè con se stesso,
scoprendo,considerando e sviluppando la propria identità vocale; tale
condotta, che possiamo tranquillamente chiamare training, conduce
all’autovalutazione, al rispetto di sé e quindi all’autostima[…]. 56
In
un
ambito
come
quello
psichiatrico,
dal
punto
di
vista
musicoterapico la formazione di un un gruppo coro, ha come finalità
quelle di sviluppare delle relazioni attraverso l’esperienza musicale,
favorire l’integrazione del paziente nei contesti sociali, permetterne
una maggiore autonomia, favorire il superamento della condizione di
isolamento sociale dovuta al forte pregiudizio nei confronti del
“malato psichiatrico”. Il coro può avere quindi diverse valenze proprio
per il fatto che nell’attività vocale di gruppo vengono attivati
molteplici processi. Attraverso le relazioni e il confronto con gli altri
possiamo apprendere modelli di comportamento utili ad affrontare la
vita con maggiore equilibrio.
L’obiettivo del gruppo coro da un punto di vista musicoterapico, come
intervento si propone di sviluppare le relazioni attraverso l’esperienza
musicale, che permette di attivare processi di cambiamento nei
partecipanti e prevenire eventuali complicanze del disturbo psichico ,
sia attraverso il recupero di funzioni compromesse ma anche
attraverso la lotta all’isolamento.
56
Videscott M. e Sartori E.,La voce in musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2008 p. 35
52 2. IL GRUPPO
2.1
Cos’è un gruppo e
le sue dinamiche : premesse
storiche
Per gruppo s’intende “quell’insieme di individui che interagiscono fra
loro influenzandosi reciprocamente e che condividono più o meno
consapevolmente,
interessi,
scopi,
caratteristiche
e
norme
comportamentali. L’influenza reciproca tra i vari membri del gruppo è
tanto più intensa quanto più il gruppo è ristretto e diminuisce via via
che questo si allarga[…]”.57
Il concetto di “dinamica di gruppo” fu introdotto a livello scientifico da
Kurt Lewin, psicologo statunitense di origine tedesca (1890-1947)
per indicare le relazioni che interessano un gruppo e che ne
influenzano lo sviluppo e la condotta.
apparteneva alla corrente di pensiero
Lo studioso, che in origine
della teoria della Gestalt
(psicologia della forma), vede il gruppo come una totalità dinamica
dotata di un’unità che trascende i singoli , e non come un insieme di
persone. Il gruppo è quindi un sistema dinamico di interdipendenza
reciproca. Attraverso questa analisi, la dinamica di gruppo diventa
uno strumento di intervento sociale rivolto al cambiamento e alla
soluzione dei problemi della vita sociale.
Prendendo spunto dagli studi sulla fisica, Lewin elaborò “la teoria del
campo”, la quale prevede l’esistenza di uno spazio psicologico vitale
dove sono presenti dei comportamenti (C), che sono in funzione degli
spazi di vita delle persone (S),formati dalle persone (P) e dagli
ambienti (A).
57
Galimberti U., Psicologia, Garzanti,Milano, 1999, p. 483
53 Il comportamento è quindi il risultato della relazione tra l’ambiente e
le
persone.
Da
qui
nasce
la
formula
C
=
F
(PA),
cioè
COMPORTAMENTO = FUNZIONE
L’individuo, include una personalità interiore e una personalità
percettivo – motoria , che si rivolge verso l’ambiente esterno, e che
viene a collocarsi all’interno di un campo di forze ambientali che lo
modificano e ne vengono modificate.58
Il comportamento dell’individuo è funzione dello spazio vitale e
dell’individuo stesso, quindi della sua interazione con l’ambiente
psicologico, di cui ha un’esperienza soggettiva, può essere più o
meno cosciente.
La teoria del campo, si occupa del “qui e ora”, non considera la storia
del soggetto e ha come elemento fondamentale la percezione, in
quanto sostiene che l’aspetto percettivo di qualsiasi cosa varia in
base all’individuo che la osserva.
La dinamica di gruppo è dunque utilizzata per indicare le relazioni
dinamiche che avvengono all’interno di un gruppo e che ne
determinano il comportamento e il cambiamento.
Tra i meccanismi di interazione troviamo una serie di caratteri
generali comuni a ogni gruppo . I principali sono59:
1-Appartenenza
:
ogni
membro
prova
un
sentimento
di
appartenenza a un gruppo, ed essa dipende e si modifica in base alla
frequenza dei contatti, i vissuti e le relazioni tra i soggetti.
2-Interdipendenza : ogni membro che appartiene a un gruppo
determina
un
interdipendenza
fra
elementi
soggettivi
e
intersoggettivi.
58
Galimberti U., Psicologia, Garzanti,Milano, 1999, p..600 59
Galimberti U., Psicologia, Garzanti,Milano, 1999, p. 484 54 3-Coesione : rappresenta il grado di solidarietà che è presente tra i
membri del gruppo, ed agisce come rinforzo per i singoli membri nel
raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si propone.
4-Polarizzazione : avviene quando le divergenze all’interno del
gruppo non possono venire eliminate, per cui si formano due
sottogruppi.
5-Differenziazione dei ruoli : avviene in modo spontaneo o
prestabilito in base al tipo di gruppo, o in tempi diversi.
6-Istituzione del leader : è la scelta dei ruoli e dipende dalle
caratteristiche, dagli scopi e dalle interazioni tra i membri del gruppo.
Al capo gruppo vengono richiesti determinati requisiti: la leadership
democratica non crea particolare dipendenza e aggressività, e
permette una buona collaborazione da parte di tutti i membri del
gruppo.
7- Rendimento : dipende dalla buona efficienza del singolo membro.
8- Socializzazione : la dinamica di gruppo “è l’analisi del processo
di socializzazione esaminato nei suoi dettagli, cioè nel suo interno,
nella sua direzionalità e dal punto di vista dei fini cui esso
tende”(Spaltro 1972).
Questi fini, sono descritti precisamente da Umberto Galimberti, e
sono:
a.
Il
raggiungimento
di
un
livello
di
sicurezza
garantito
dall’appartenenza al gruppo che consente, con la sua protezione, di
rischiare senza troppa ansia anche in terreni mai esperiti.
b. Il controllo della dinamica della colpa perché il Super-io paterno si
trasforma in Super-io di gruppo più facile da controllare.
c. L’accelerazione dei processi di apprendimento perché il gruppo
serve da feed-back continuo mediante il paragone con gli altri, e
quindi come mezzo per conoscere continuamente i risultati raggiunti.
55 d. L’aumento dell’efficienza e della funzionalità delle difese perché,
seguendo la legge del successo all’interno del gruppo, verranno a
essere potenziati quei meccanismi che hanno determinato un effetto
positivo, e verranno abbandonati quelli che al contrario avevano
fallito il loro scopo.
e. L’influenza sul ritmo dello sviluppo intellettivo per il rapporto che
esiste tra processi intellettivi e linguaggio, e tra il linguaggio e la
comunicazione che nel gruppo è potenziata.
f.
La
maturazione
affettiva
facilitata
nel
gruppo
rispetto
alla
condizione isolata, e controllata nelle manifestazioni delle pulsioni che
l’individuo può anche non saper regolare da solo.60
Le diverse ricerche sull’importanza del gruppo, hanno permesso di
riscontare una serie di caratteri comuni all’interno del gruppo; in
particolare: il senso di appartenenza, la coesione e la socializzazione.
Ogni individuo nell’ambito gruppale cerca di trovare uno stato di
sicurezza
e di conformarsi agli altri membri del gruppo, con il
desiderio di conoscere cose nuove che gli permettano di affermare la
propria individualità e identità.
Ritengo importante l’approccio gruppale nei contesti terapeutici e
nell’ambito musicoterapico, in quanto ogni cambiamento che avviene
all’interno del gruppo coinvolge tutti i membri e permette lo scambio
emozionale e percettivo.
60
Galimberti U., Psicologia, Garzanti,Milano, 1999, p.486 56 2.2
Il gruppo e la sua analisi - Il percorso storico del
gruppo attraverso la terapia
L’analisi di gruppo è un metodo psicoterapico in cui più pazienti, alla
presenza di uno o più terapeuti vengono trattati con l’impiego della
dinamica di gruppo per dare indicazioni diagnostiche e terapeutiche
che non si rivelano nel contesto analitico fondato sulla dualità del
rapporto analista-paziente.
L’analisi di gruppo in ambito terapeutico nasce agli inizi del XX
secolo. Nel 1907 Joseph Pratt, medico presso il Massachusset General
Hospital di Boston, introdusse la terapia gruppale per aiutare dei
pazienti tubercolotici ad affrontare la propria malattia, attraverso la
condivisione e il sostegno reciproco. Il gruppo aveva prevalentemente
un obiettivo educativo, ma prevedeva anche supporto psicologico e
l’impegno
personale
reciproco
tra
i
vari
membri.
In
ambito
psicoanalitico, lo studioso Burrow (1927), con premesse freudiane, fu
il primo ad applicare la terapia di gruppo a pazienti nevrotici, facendo
nascere la psicoanalisi di gruppo.
Il
gruppo
psicoterapeutico
a
orientamento
analitico
prende
riferimento dalle esperienze e teorizzazioni rilevanti di Bion e di
Foulkes, che nella metà degli anni cinquanta si trovarono impegnati a
supportare le truppe inglesi durante la seconda guerra mondiale,
sperimentando delle forme d’intervento con piccoli gruppi di soldati
traumatizzati.
In ambito psicoanalitico, lo psicoanalista inglese Wilfred Bion, ha dato
un importante contributo allo studio delle dinamiche di gruppo in
terapia, apportando importanti contributi alla teoria psicodinamica
della personalità. Si dedicò allo studio dell’insorgenza della psicosi,
approfondendo i primissimi stadi di vita e la nascita dei processi di
pensiero; mentre durante la seconda guerra mondiale organizzò dei
57 gruppi di riabilitazione occupazionale per militari, dove sviluppò la
sua teoria dei gruppi.
Secondo Bion il gruppo è un “insieme”, per cui quando degli individui
entrano a far parte di un gruppo i loro pensieri si uniscono per
costruire una modalità differente di pensiero. La prima volta che gli
individui hanno a che fare con il gruppo si verifica una regressione a
stadi precedenti dello sviluppo. Egli ipotizza nel gruppo l’esistenza di
emozioni intense e primitive, impulsi irrazionali e inconsci, che
costituiscono la “mentalità di gruppo”, che influenza la struttura,
l’organizzazione razionale ostacolando il lavoro da realizzare.
Lo studioso considera l’esperienza emotiva centrale nella vita
dell’individuo; parte dallo studio delle tensioni del gruppo dove la
relazione tra i vari elementi costituisce il nido di emozioni e il punto
focale della dinamica relazionale.
Secondo Bion i gruppi si possono differenziare in gruppi “primitivi” o
gruppi basici che funzionano in base a tre modalità fondamentali
denominate assunti
di
base: dipendenza, attacco e fuga e
accoppiamento.
A - L’assunto di base di dipendenza: il gruppo è riunito per essere
accudito dal capo, da cui il gruppo dipende in maniera assoluta;
B - L’assunto di base di attacco e fuga: il gruppo sente di doversi
difendere o di fuggire da qualcosa o qualcuno.
C - L’assunto di base di accoppiamento: in cui il gruppo, esprime un
sentimento
speranza, ponendosi nella magica aspettativa di un
salvatore esterno.
Gli
assunti
di
base
sono
quindi
modalità
che
paralizzano
il
funzionamento del gruppo, che rimane intrappolato in meccanismi
difensivi arcaici
e primitivi. In opposizione ai gruppi primitivi
58 troviamo i gruppi di lavoro, che sono più maturi in quanto centrati
sulla cooperazione e la capacità di assumersi la responsabilità di
prefiggersi e raggiungere un obiettivo.
Sigmund Foulkes, psichiatra inglese di origine tedesca, è stato negli
anni Quaranta l’ideatore del ”gruppo analitico”, ponendo il contesto
sociale al centro della propria indagine e sottolineando l’emergere di
dinamiche inconscie nelle psicoterapie di gruppo. Rispetto alle teorie
precedenti è maggiormente equilibrata.
Egli utilizza il concetto di
“matrice”(mater), considerando la presenza di un forte legame di
dipendenza tra l’individuo e il gruppo che lo nutre e lo mantiene
“mentalmente vivo”. Secondo Foulkes il gruppo è “concepito” e
tenuto insieme da un terapeuta capace di dare un significato a ciò
che avviene al suo interno, creando uno spazio dove avviene la
produzione di catene simboliche accessibili a tutti i membri e in uno
spazio protetto.61
Emerge quindi nell’approccio psicoanalitico ,l’importanza da parte del
terapeuta di prendersi cura delle relazioni dell’individuo attraverso
l’analisi
del
sintomo
e
del
disagio,
ma
anche
attraverso
la
trasformazione delle dinamiche relazionali del soggetto.
La natura del legame individuo-gruppo, rappresenta una riedizione
del rapporto bambino-genitore, in quanto attraverso movimenti
transferali , gli affetti della vita infantile vengono spostati su oggetti
diversi da quelli primari, permettendo la rielaborazione ed il lavoro
analitico.
In ambito musicoterapico , Edith Lecourt ,psicologa, psicoanalista e
musicista,
attraverso
spunti
sugli
autori
di
orientamento
psicoanalitico che come abbiamo visto concepiscono la dimensione
gruppale costituita dalla vita psichica, analizza nelle sue esperienze
d’improvvisazione musicale, le funzioni psichiche e sociali del gruppo.
61
Galimberti U., Psicologia, Garzanti,Milano, 1999, p.483
59 Nell’analisi di gruppo, la Lecourt, sostituisce la parola setting , con la
nozione di cornice, assimilata da José Bléger : la cornice
ha una
funzione di supporto e di sostegno, comprende il ruolo dell’analista,
la tecnica e la dimensione spazio temporale degli incontri. La cornice
rappresenta il processo stesso.
All’interno della cornice e grazie alla cornice stessa, inizia quindi il
“processo” di cambiamento da parte di tutti i partecipanti, attraverso
il funzionamento psichico che viene proiettato su di essa.
“Intonazione è la ricerca di un primo aggiustamento su cui fondare lo
slancio musicale (e i cambiamenti di tonalità potranno accompagnare
ulteriori movimenti di trasformazione). Per l’individuo l’esperienza di
un gruppo […]rappresenta una sorta di nuova intonazione nel corso di
un processo di integrazione rispetto a se stesso, al gruppo, alla
società e…alla musica[…].62
“Attraverso il gruppo emerge e si sviluppa un’esperienza sensoriale e
emotiva, condivisa da tutti i membri. Il lavoro in gruppo permette
quindi di sperimentare nella relazione, un processo di integrazione
interno ed esterno, dove avviene una strutturazione di elementi
ansiogeni e frustranti come il confronto con gli altri ma fortificanti
come l’autostima, l’aggregazione e l’espressione individuale che si
fonde
e
trova
equilibrio
con
quella
collettiva.
Per un lavoro terapeutico, formare e mantenere uno “spazio
comune”, dà la possibilità di esprimere e tollerare
le proprie
emozioni e quelle degli altri membri del gruppo”.63
Dagli studi citati in questo paragrafo si è portati a riflettere sul
compito del terapeuta che ha la responsabilità analizzare,distinguere
e gestire le caratteristiche di ogni individuo e rispettarne i tempi del
percorso terapeutico.
62
Lecourt E., Analisi di gruppo e musicoterapia,Cittadella, Asssi,1993, p.201
63
Giberti-Rossi, Manuale di psichiatria, Piccin,Padova,2009,p.536 60 Nella mia esperienza personale mi è capitato diverse volte e in vari
ambiti
di
sperimentare
la
dimensione
gruppale:
nei
lavori
di
meditazione, in analisi bioenergetica, e nel tirocinio con il coro del
DSM; in ognuna di queste esperienze ho trovato diversi elementi in
comune. In particolare l’uso della vocalità nelle esperienze di gruppo
mi ha sempre fatto provare uno stato di profonda connessione con
me stessa e con le persone con cui ho condiviso l’esperienza. In
ambito terapeutico, in musicoterapia in particolare, ritengo sia
importante l’intervento di gruppo, proprio per la ricchezza che ogni
individuo
può
apportare
all’esperienza
e
per
il
lavoro
di
“intonazione”e modulazione del proprio comportamento che avviene
all’interno del gruppo.
61 3. L’ESPERIENZA
3.1
IL TIROCINIO NEL GRUPPO-CORO “LA VOCE DEI
COLORI”
La storia
Il coro la Voce dei colori del Centro Diurno del DSM ( Dipartimento di
Salute Mentale) dell’USL 2 di Torino, nasce con
la funzione di
socializzazione nel percorso terapeutico - riabilitativo del paziente
psichiatrico. Il gruppo è composto da coristi adulti che provengono
da storie, ambienti e età differenti, che frequentano il centro
hanno
e
l’interesse comune a coltivare la propria espressione e
condivisione attraverso la loro vocalità. La proposta del DSM di Torino
ha tra i suoi obiettivi la socializzazione e l’integrazione nel territorio
delle persone con disagio psichico.
Breve storia del coro del Centro Diurno - LA VOCE DEI COLORI
“Il coro La voce dei colori è presente come attività terapeutica del
Centro Diurno del DSM (Dipartimento di Salute Mentale) dell’ASL 2 di
Torino dall’autunno del 1999. Nella sua primissima forma, il gruppo
era
molto
diverso
da
quello
attuale:
il
repertorio
era
quasi
completamente formato da brani gospel, come Oh Happy Day ,
eseguiti con l’accompagnamento delle sole tastiere, i vari componenti
del gruppo durante i concerti indossavano dei costumi creati da altri
utenti del Centro Diurno. La prima importante esibizione, avvenne,
dopo diversi mesi di prove, all’interno del convegno della Società
Italiana di Psichiatria (Auditorium del Lingotto di Torino, 16-21
Ottobre 2000).L’ evento diedeuna grossa spinta all’autostima del
gruppo, che continuò quindi con rinnovato entusiasmo per poi esibirsi
62 al Festival della Creatività tenutosi nei giorni 25,26 e 27 Settembre
2002 a Melfi. Il primo grosso cambiamento è avvenuto con l’arrivo
del maestro Oto Perillo, formatosi presso il Conservatorio di Torino
con specializzazione in musica corale, Direttore di coro e maestro di
Pianoforte. Sotto la sua direzione , il gruppo si è indirizzato verso una
più alta forma di preparazione tecnica, sono apparse le varie voci che
compongono i cori polifonici (soprano, contralto, tenore e basso) e il
repertorio si è di conseguenza modificato con l’inserimento di brani
folk, classici, pop e rock. E’ in questo momento che iniziano a essere
eseguiti alcuni dei brani che diventeranno nel tempo dei cavalli di
battaglia del gruppo: Tourdion , Past Time, Napule è, We are the
Champions,
Spunta
la
luna
dal
monte.
Più
avanti
verranno
ulteriormente inseriti Cherokee Moorning Song, Knockin’onHeaven’s
door, Domo mea.
Molti di questi brani sono parte integrante del
repertorio del gruppo e vengono eseguiti con buona regolarità.
E’anche ricchissima l’attività live : il coro viene invitato in molti degli
eventiorganizzati dall’ASL TO 2(ex ASL 3); si canta soprattutto per
favorire i momenti di socializzazione e , in occasione delle festività
natalizie, nelle strade del centro di Torino e in altri servizi di cura.”Nel
2006 viene richiesto al coro di esibirsi al Convegno di Musicoterapia
di Alba(CN) e molti sono i concerti a cui si partecipa per reperire fondi
sia per il gruppo stesso, sia per aiutare l’Associazione Sorriso, creata
dagli stessi pazienti e presente ormai da diversi anni nel territorio
dell’ASL
TO2.Dalla
collaborazione
con
gli
studenti
del
Liceo
Psicopedagogico”D. Berti” di Torino, che hanno curato la parte
strumentale, nel maggio del 2008, è nata la registrazione e la
realizzazione del primo CD del gruppo La Voce dei Colori, esperienza
per il gruppo assolutamente nuova e arricchente. Altri momenti
importanti per la crescita della autostima sono state le partecipazioni
al festival letterario Collisioni Festival a Novello (CN) e al festival
63 Apparenti Stonature, organizzato dal gruppo-coro Coralmente Abili di
Volterra dell’U.S.S.L. di Pisa, entrambi tenutisi nel 2009. Quest’ultimo
è un festival che si tiene con cadenza (quasi) annuale e vede la
partecipazione
di
vari
gruppi
corali
provenienti
dai
vari
D.S.M.(Dipartimento di Salute Mentale) di tutta Italia (e non solo,
dato che era presente anche un gruppo spagnolo). Il festival
Apparenti
Stonature
è
stato
indubbiamente
ricco
di
momenti
stimolanti:per la prima volta è stato possibile confrontarsi con altri
gruppi, ricevendo tantiattestati di stima e condividendo il palco del
bellissimo Teatro Persio Flacco. La chiusura del festival ha anche visto
la partecipazione del cantautore EugenioFinardi con tutti i gruppi
partecipanti che hanno coralmente accompagnato l’artista in una
delle sue canzoni più famose: Extraterrestre.64
UN NUOVO PERCORSO
Queste esibizioni si sono ripetute nei successivi 2010 e 2011 con un
importante cambiamento nella direzione musicale: infatti, al maestro
Oto Perillo si è alternato il maestro Mauro Sarcinella, Musicoterapeuta
nonché chitarrista del gruppo folk Babelamà. Le conseguenze di tale
avvicendamento hanno portato i coristi a confrontarsi con altri generi
musicali, in particolare con la musica popolare non solo italiana.
Grazie a questa nuova collaborazione, si è creato anche uno stretto
legame con gli altri musicisti del gruppo folk Babelamà, che hanno
sostenuto non solo musicalmente il coro durante le esibizioni a cui ha
partecipato. L’accompagnamento strumentale (flauto, percussioni,
chitarra, ghironda, fisarmonica, zampogna) ha arricchito il repertorio
di
nuovi
brani
come
Barbagal,
Il
gallinaro,
Se
chanto,
Vulesseaddeventare nu brigante; il rapporto con i musicisti è stato un
64
MessagliaR.,Gentile M., Sarcinella M.,Vigliaroni G., Cantare le voci- Il canto corale come cura, Didattica
Attiva,Torino, 2015 p.67-68 64 occasione di confronto e di lavoro tra persone con cui condividiamo la
medesima passione per la musica ma che sono estranee all’ambiente
sanitario. Diverse e variegate le opportunità di sperimentarsi durante
i concerti a cui il coro ha partecipato: festa di quartiere in occasione
del 25 aprile, festa patronale a Caselle Torinese (TO), concerto
presso l’A.N.P.I. di Venaria (TO), esibizioni presso vari locali di Torino
e cintura. Ma tra tutte queste occasioni, ci piace evidenziare
l’esperienza del coro al festival I Castelli Incantati, tenutosi nell’area
dei Castelli Romani nel giugno 2012. Si è trattato di soggiornare per
alcuni giorni lontano da casa e di spostarsi seguendo le tappe del
festival lungo i comuni di Ariccia, Castelgandolfo e Frascati, nei quali
si svolgevano i concerti dei numerosi gruppi partecipanti, gruppi di
provenienza anche internazionale. Il festival era e rimane una
manifestazione
aperta
a
tutti
riconoscimento internazionale.
i
cori
e
ha
anche
un
valido
Il gruppo si è confrontato con cori
professionisti, davanti a un pubblico molto competente e numeroso.
L’esperienza
de
I
Castelli
Incantati
è
stata
di
fondamentale
importanza, perché, per la prima volta, ci si è esibiti al di fuori del
circuito “Sanità”. Questa rimane la strada da seguire in futuro senza
per questo dimenticare chi siamo e qual è stato il nostro percorso. E
sempre con la musica nel cuore.65
65
MessagliaR.,Gentile M.,Sarcinella M.,VigliaroniG.,Cantare le voci,Il canto corale come cura, Didattica
Attiva,Torino, 2015 p.. 71-72
65 3.2
GLI OBIETTIVI DEL GRUPPO-CORO:
Il lavoro con il gruppo-coro nasce con diverse finalità che cercano di
conciliare
il valore terapeutico e socializzante della vocalità, ma
anche la qualità della produzione sonora.
Tra gli obiettivi troviamo quindi una valenza terapeutica ed artistica:
Obiettivi terapeutici :
. La socializzazione
. L’integrazione in contesti sociali
. Migliorare l’autostima
. Migliorare l’autonomia nella vita
. Superare momenti di crisi come l’ansia , la tensione, la frustrazione
Obiettivi artistici:
. Capacità nella realizzazione dei brani
. Capacità di proporre e ascoltare i brani
. Capacità a rispettare il ritmo e la tonalità per eseguire i vari brani
da proporre in pubblico
. Capacità alla gestione dello spazio
Come spiega Antonio Mauro Sarcinella l’attenzione soprattutto alla
socializzazione “è alla base della proposta dell’attività del gruppo coro
del DSM, proposta partita dall’idea che all’interno di un gruppo si
stabiliscono legami soggetti a un cambiamento, punto focale di un
intervento che vuole essere terapeutico, che derivano da una
interferenza fra le condizioni individuali, caratteristiche di ciascun
66 partecipante, e quelle gruppali, dovute alle interazioni sociali e alle
percezioni interpersonali”.66
Nella dimensione artistica del gruppo, l’uso dello strumento voce
permette anche di realizzare obiettivi trasversali come:
-favorire l’instaurarsi di un clima positivo nel gruppo;
-sollecitare nuove esperienze che migliorano la percezione di sé e
degli altri;
-maturare progressivamente la capacità di ascolto, di concentrazione
e d’interazione
Inoltre il coro le Voci dei colori, si esibisce con concerti in festival,
convegni e concorsi in occasione di iniziative sul territorio, favorendo
la sensibilizzazione
del cittadino al superamento dei pregiudizi che
accompagnano da sempre la “malattia mentale”.
3.3
- GLI INCONTRI
Gli incontri del coro sono a cadenza settimanale, il martedì dalle 17
alle 19, presso lo spazio del centro diurno di Piazza Massaua (
sempre lo stesso giorno , lo stesso luogo e la stessa ora ad eccezione
di quando bisogna prepararsi per un concerto o una manifestazione).
Durante l’anno le pause dall’attività corale sono durante le festività e
nei mesi di Luglio e Agosto.
66
MessagliaR.,Gentile M., Sarcinella M.,Vigliaroni G., Cantare le voci- Il canto corale come cura, Didattica
Attiva,Torino, 2015 p..63 67 3.4
LA STANZA DEL CORO O IL SETTING
Il centro è strutturato per offrire attività diurne per soggetti
psichiatrici, senza alcuna distinzione in merito alle capacità, in modo
da favorirne l’integrazione.
Nel servizio diurno vengono proposte attività di Arti-Terapie (gruppocoro, lavorazione del legno e della creta, pittura, musica).
Per le prove ci si ritrova nella sala d’attesa del centro diurno, dove
vengono scambiate informazioni su eventuali appuntamenti per
concerti e nel frattempo si aspettano i ritardatari. Poi ci si sposta
nella stanza adibita alle prove del coro.
La stanza si trova lungo un corridoio vicino ad altre stanze adibite ad
attività manuali come la pittura, la lavorazione del legno e della
creta.
All’ingresso e di fronte alla stanza del coro si trovano le sale d’attesa.
Ad ogni incontro, prima di entrare nella stanza, vengono indossati dei
copri- scarpe di plastica per motivi igienici.
La stanza si presenta vuota, con pareti rivestite in legno e una
finestra che si affaccia sul corso Francia.
Prima di iniziare, il musicoterapista, Antonio Mauro Sarcinella,
prepara la sua postazione sedendosi su una sedia e accordando la
sua chitarra.
Gli operatori nel frattempo distribuiscono gli spartiti ad ogni utente
che possiede un quaderno con tutti i testi e gli spartiti delle canzoni.
I coristi si posizionano ad ogni incontro in piedi a semicerchio: da
una parte le voci maschili e dall’altra le voci femminili, posizionate in
ordine crescente di tonalità.
68 3.5
LE FIGURE DI RIFERIMENTO E LA COMPOSIZIONE
DEL GRUPPO-CORO
Le figure di riferimento nel gruppo-coro sono:
- Il Direttore, Antonio Mauro Sarcinella, musicoterapeuta e musicista
: dirige il Coro, suona la chitarra, sceglie il repertorio, e si occupa di
trovare i concerti, manifestazioni, ecc. nei quali far esibire il coro.
- Il coordinatore del coro, Marzia Gentile, educatrice professionale,
cantante , percussionista
e corista: oltre a partecipare al coro e
suonare le percussioni, si occupa insieme al Direttore di coordinare
l’attività del canto, curandone anche gli aspetti estetici; organizza
logisticamente le uscite, i trasporti inerenti alle iniziative pubbliche,
gestisce gli appuntamenti e i contatti .
- Gli accompagnatori del coro: Giacomo Viraglioni, educatore e Piera
infermiera professionale, fanno parte del coro, seguono la corale nelle
trasferte e danno eventuale assistenza ai partecipanti.
Il gruppo-coro è composto da circa dieci pazienti (alcuni spesso
presenti agli incontri, altri presenti saltuariamente) e dagli educatori
provenienti dal Centro Diurno dell’USL TO2, di via Sostegno 33 a
Torino, dai tirocinanti, ma è aperto a chiunque abbia il piacere di
condividere l’esperienza corale.
Per partecipare al coro è necessario un colloquio con Roberto
Messaglia, dirigente presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’USL
TO2,psichiatra, psicoterapeuta, pianista, musicoterapista e fondatore
del coro “La voce dei colori”. Dopo il colloquio, ci si presenta al primo
appuntamento, dove si viene presentati al gruppo e si ha da subito la
possibilità di partecipare al canto oppure si può solo ascoltare.
69 3.6
IL REPERTORIO:
Il repertorio è composto principalmente da canzoni tipiche della
tradizione popolare italiana e delle diverse parti del mondo, altri brani
sono rock. Il repertorio popolare, che attinge alla tradizione orale
rappresentando un metodo di trasmissione culturale di apprendimenti
motori, linguistici, musicali e modelli di relazione sociale. Dal punto di
vista musicale questo repertorio utilizza prevalentemente testi brevi,
ripetitivi, scanditi e chiari sia sul piano vocale sia ritmico; sono
caratterizzati da rime. I brani svolti nell’attività corale sono stati
anche inseriti nel cd registrato dal gruppo-coro le Voci dei colori nel
2014 e pubblicato nel libro CANTARE LE VOCI- Il canto corale come
cura e sono:
1) Pexinhos do mar canto brasiliano che racconta della resistenza agli
eserciti olandesi, spagnoli, portoghesi e francesi, di un gruppo di
schiavi di colore.
2) Barbagal una canzone di Alberto Cesa, ispirata a un’area
tradizionale anglosassone.
3) Se chanto inno della nazione occitana (zona europea che parte
dalle valli cuneesi e arriva fino ai Pirenei spagnoli).
4) La bergera o Pastora fedele un brano arrangiato da Oto Perillo,
della tradizione popolare piemontese.
5) Tourdion un’antica danza francese.
6) Oltre il ponte una canzone scritta da Italo Calvino e musicata da
Sergio Liberovici, che descrive il periodo storico della Resistenza.
7) Ipharadisi un canto tipico degli Zulù, proveniente dal Sud Africa.
70 8) Cherokee Morning song una canzone arrangiata da Robbie
Robertson della tradizione dei nativi d’America, cantata dalle donne
Cherokee.
9) Sailing un brano scritto da Gavin Sutherland e reso celebra dal
cantante Road Steward.
Nelle prove dei brani musicali con il coro sono stati curati ad ogni
incontro alcuni elementi indispensabili per l’esibizione canora:
-partire contemporaneamente
-mantenere la pulsazione
-curare l’espressività
-chiudere insieme
3.7
ALCUNI
COMPONENTI
DEL
GRUPPO
E
I
LORO
BENEFICI
E’ stato interessante confrontarmi , con gli educatori, sulla storia di
alcuni pazienti che partecipano all’attività del gruppo- coro.
Ho chiesto agli operatori di raccontarmi come ognuno di loro ha
deciso di entrare nel coro e i benefici che ognuno di loro ha avuto nel
frequentarlo.
I pazienti che partecipano al coro, sono utenti del CSM dell’USL TO2 e
sono quotidianamente in terapia farmacologica.
Per questione di privacy sono riportate solo le iniziali dei pazienti.
S. Ha sempre amato cantare e ascoltare la musica. Le piace portare
dei brani da ascoltare e proporre nuovi brani da inserire nel
repertorio.
71 Benefici: Ha creato un forte legame affettivo con l’equipe del centro
diurno, esprime la sua passione musicale ad ogni incontro.
A. Le piace cantare, ma la sua motivazione maggiore è partecipare al
coro per socializzare.
Benefici: la socializzazione , perché sola, ha creato relazioni ed è
sempre presente agli incontri.
A.M. Le piace cantare, ha avuto esperienze in passato di canto
parrocchiale. Per lei il gruppo-coro è un importante punto di
riferimento.
Benefici: Inizialmente la sua voce era bassissima, cantava con un
filo di voce, era
molto timida; partecipando al coro ha liberato la
voce, è più disinibita, e anche per lei gli incontri hanno un forte
valore socializzante.
M. E’ stato scout e cantava nel coro degli alpini.
Benefici: la socializzazione, ha creato un forte legame affettivo con
l’equipe e i partecipanti al coro, ha un maggiore autocontrollo, una
presenza costante al gruppo-coro e un forte impegno in questa
attività per lui piacevole.
M. nessuna esperienza precedente nel canto.
Benefici: la socializzazione, le RELAZIONI perché è cresciuto
completamente isolato dal mondo esterno, con la partecipazione al
gruppo-coro ha avuto grandi progressi :è maggiormente calato nella
realtà, è sempre presente agli incontri e nei soggiorni ha imparato ad
avere una maggiore autonomia nella cura personale.
D. non ha mai cantato precedentemente e non canta nemmeno al
coro ( partecipa con interesse, muove la bocca e tiene il ritmo, ma
72 non canta, la sua motivazione maggiore è partecipare al coro per
socializzare e sentirsi parte del gruppo. Da quando ha avuto un
problema fisico non partecipa più ai concerti, ma è sempre presente
alle prove settimanali del coro.
Benefici: la socializzazione, è sempre presente, ha creato un forte
legame affettivo con l’equipe e gli altri partecipanti, è collaborativo e
si dedica con molto impegno all’attività, anche se non canta.
Da questi dati si può notare come i componenti del gruppo-coro:
hanno avuto precedenti esperienze nel canto, ad esempio in chiesa o
negli scout, e volevano riproporre l’aspetto piacevole del cantare in
gruppo;
altri
si
sono
avvicinati
per
curiosità
o
bisogno
di
socializzazione. I benefici sono stati piuttosto comuni in quanto il
desiderio di tutti è socializzare, sentirsi parte del gruppo e sentirsi al
di “fuori” del contesto ospedaliero.
73 3.8
L’ESPERIENZA PRATICA
Il percorso è strutturato in due parti:
1. Il lavoro vocale nel centro diurno
2. La relazione del gruppo- coro nei contesti interni ed esterni al
centro (incontri,concerti, cene,ecc)
Ho conosciuto il coro “Le voci dei colori” nel febbraio 2015, in
occasione del primo incontro di osservazione, dove sono stata
presentata dal musicoterapista
come tirocinante di musicoterapia,
agli utenti del coro, che da subito mi hanno accolta con entusiasmo e
affiatamento. Dal secondo incontro mi sono inserita come voce
mezzo-soprano nella parte femminile del coro. L’inizio degli incontri è
dedicato ai saluti, agli aggiornamenti e comunicazioni del Direttore e
coordinatore su eventuali eventi. Poi segue la prova e la messa a
punto dei brani. L’attività si è svolta provando insieme, più volte, i
vari brani di repertorio suonati da Mauro Sarcinella e le esibizioni
presso sedi esterne con concerti e manifestazioni.
La prima uscita dal contesto dell’USL, nella quale mi sono esibita con
la corale, è stata alla Turin Choral Maraton il 13 Settembre 2015,
un’evento
organizzato
dall’Associazione
Cori
l’Assessorato dello Sport di Torino, nell’ambito
Piemontesi
con
di Torino Capitale
dello Sport, e con il Patrocinio della Regione Piemonte e del Consiglio
Regionale.67
www.associazionecoripiemontesi.com 67
74 Per l’occasione abbiamo indossato una divisa : una maglia colorata,
dei pantaloni neri e le femmine un fermaglio con una farfalla
colorata;
ognuno
aveva
il
suo
quaderno
con
gli
spartiti
e
l’organizzazione ci aveva fornito il foglio con i tre brani da cantare
insieme nel concerto finale.
La maratona si è svolta nelle piazze e nelle vie del centro di Torino
dalle 14,00 alle 19, con la partecipazione di circa
30 cori. Questa
prima edizione della Turin Choral Maraton aperta ad ogni tipologia di
Coro ( popolare, gospel, voci miste, voci bianche, giovanili, folk ecc. e
senza limiti di repertorio, di ogni epoca e tradizione), era strutturata
75 in un percorso diviso in tappe contrassegnate da totem dedicati per
l’evento, dove ogni coro si esibiva per circa 20 minuti e proseguiva
per la tappa successiva( tre in totale per ogni coro) , ad ogni coro è
stato
assegnata
una
guida
per
garantire
la
puntualità
negli
spostamenti e nelle esibizioni.
Le nostre tappe sono state: Via roma, Palazzo Madama e Piazza
Castello; i passanti si fermavano ad ascoltarci o a cantare con noi. Al
termine della maratona tutti i cori si sono riuniti in piazza San Carlo,
76 diretti da Dario Piumatti e dal
“Coro guida”, dove abbiamo unito le
nostre voci a circa 1000 persone con i brani: VOLARE, SUMER IS
ICUMEN IN, SHOSHOLOZA.
Il clima dell’esibizione si è svolta in un crescendo di gioia e
spensieratezza, fino ad arrivare al concerto finale dove tutti ci siamo
commossi ed emozionati nel cantare in mezzo a tutte quelle persone.
In circa mille abbiamo persone abbiamo cantato, ballato e battuto le
mani.
77 Il 10 Ottobre 2015 con il coro abbiamo partecipiamo ad un altro
concerto presso la struttura Cecchi Point per il concerto finale della
settimana della salute mentale, dove oltre a noi si sono esibiti altri
gruppi musicali. Anche in questa occasione abbiamo cercato di
presentarci tutti con una divisa: una camicia bianca, un pantalone
nero e foulard di tutti i colori da indossare.
L’esibizione è andata molto bene, eravamo tutti in un clima festaiolo
e al suo termine ognuno dei coristi aveva la possibilità di passare la
serata come preferiva (rimanere fino al termine del concerto, tornare
a casa in autonomia, o fermarsi a mangiare fuori).
78 4. MUSICOTERAPIA:RIFERIMENTI TEORICI
LA MUSICOTERAPIA
Definizione
Secondo la Federazione Mondiale di Musicoterapia:La Musicoterapia è
l’uso della musica o degli elementi musicali( suono, ritmo, melodia e
armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un cliente o
un gruppo, in un processo atto a facilitare la comunicazione, la
relazione,
l’apprendimento,
la
motricità,
l’espressione,
l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di
soddisfare
le
necessità
fisiche,
emozionali,
mentali,
sociali
e
cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali
e/o residue dell’individuo in modo tale che il paziente o la paziente
possano meglio realizzare l’integrazione intra e interpersonale e
consequenzialmente possano migliorare la qualità della loro vita
grazie ad un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.
Definizione
La musicoterapia può quindi essere considerata un intervento
specifico in tutti quei casi in cui esiste un disturbo qualitativo e /o
quantitativo
della
sfera
emotiva
e
delle
relative
competenze
espressive – comunicative- relazionali; la musicoterapia è in grado di
agire in modo isoformo sulle qualità innate , pre-protosimboliche , ma
anche su quelle acquisizioni simboliche , al fine di attivarle ,
regolarle, qualificarle, integrarle in una dimensione intrapersonale e
interpersonale.68
68
Manarolo G.,Manuale di Musicoterapia,Teoria, Metodo e Applicazioni della Musicoterapia,Cosmopolis,
Torino,2011, p.45 79 ROLANDO BENENZON:
Per Rolando Benenzon ( musicista, medico e psichiatra argentino) la
musicoterapia
è una tecnica psicoterapica, che utilizza il suono, la
musica, il movimento e gli strumenti corporei, sonori e musicali per
determinare un processo storico di vincolo, tra il terapeuta e il suo
paziente o gruppi di pazienti, con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita e di riabilitare e recuperare i pazienti per la società>.
Nel suo modello di musicoterapia, Benenzon parla del principio
dell’ISO e dell’OGGETTO INTERMEDIARIO:
-
ISO
significa
UGUALE
o
IDENTITA’
SONORA,
tale
principio
rappresenta il vissuto sonoro di ogni individuo, sintetizza la nozione
dell’ esistenza di un suono o di un insieme di suoni o di fenomeni
sonori
che
ci
caratterizzano
e
che
ci
individualizzano.
Troviamo:
L’iso universale: (inconscio, comprensivo dei suoni regressivogenetici:
il
battito
cardiaco,
la
respirazione,la
voce
materna)
caratterizza tutti gli esseri umani indipendentemente dal contesto
sociale, culturale e storico di appartenenza.
L’iso gestaltico:
inconscio, riassume il vissuto sonoro dalla nascita
fino all’età attuale, è il patrimonio sonoro individuale.
L’iso
culturale:
preconscio,
corrisponde
all’identità
etnica
dell’individuo, caratterizzato dal contesto culturale in cui l’individuo
cresce.
L’iso gruppale : identità sonoro-musicale propria di un gruppo di
soggetti.
80 L’iso
complementare
:
rappresenta
l’insieme
dei
quotidiani
accomodamenti dell’iso gestaltico e dell’iso culturale.
OGGETTO INTERMEDIARIO: è l’elemento fondamentale che permette
il collegamento nella relazione tra paziente e terapeuta, permettendo
di superare eventuali resistenze o angosce.
Nel mio percorso ho trovato importante fare riferimento al modello
Benenzon principalmente per gli studi sull’origine del rapporto tra
suono e individuo , che risale al rapporto tra il feto e la madre , dove
inizia
il
primo
scambio
sonoro.
Inoltre Benenzon mostra l’importanza per il terapeuta di raggiungere
e mantenere un equilibrio per entrare in relazione con il paziente. La
consapevolezza del terapeuta avviene attraverso vari elementi, in
particolare: la conoscenza del proprio ISO e l’attenzione al proprio
stato emotivo prima di ogni seduta.
EDITH LECOURT :
Edith Lecourt, psicologa, psicoanalista e musicista, ha dato un grande
contributo alla musicoterapia attraverso i suoi studi sull’utilizzo di un
mediatore sonoro -musicale nell’esperienza gruppale, approfondendo
i temi del lavoro psicoanalitico in gruppo, l’improvvisazione musicale
in
gruppo
e
la
musicoterapia
attiva
di
gruppo.
Nonostante il suo pensiero non figuri tra i modelli e le teorie
riconosciute nel congresso della WORD FEDERATION OF MUSIC
THERAPY, (Washington 1999), ho ritenuto molto interessanti i sui
interventi e il suo impegno sul lavoro gruppale.
81 ALEXANDER LOWEN:
“La vita di un’individuo è la vita del suo corpo. Poiché il corpo vivente
comprende la mente, lo spirito e l’anima, vivere la vita del corpo
significa avere una vita mentale, spirituale e sentimentale piena. Se
questi aspetti della nostra natura sono carenti , è perché non viviamo
interamente dentro o con il nostro corpo. Lo trattiamo come uno
strumento
o
come
una
macchina(…).
L’analisi bioenergetica studia la personalità umana attraverso i
processi
energetici
caratteriali
del
corpo
classificandole
e
analizza
le
diverse
strutture
in cinque tipi fondamentali: schizoide,
orale, psicopatico,masochista e rigido. Ho trovato interessante questo
tipo di classificazione, non perché è una classificazione di persone ma
perché rappresenta le varie posizioniposizioni difensive. A livello
psicologico e muscolare, ogni tipo ha un suo schema di difesa che lo
distingue dagli altri.
SCHIZOIDE:
COMPORTAMENTO:
1) tende a spaccare in due il funzionamento unitario della personalita’.
2) Perde il contatto con il mondo e la realtà esterna.
CARATTERISTICHE FISICHE:
Il corpo è contratto, il viso è simile a una maschera e gli occhi sono privi di vita. Tra le due
metà del corpo c’è una discrepanza marcata.
BLOCCHI ENERGETICI:
L’energia viene trattenuta e non fluisce negli organi che stabiliscono il contatto con il
mondo esterno, cioè nelle strutture periferiche del corpo.
ASPETTI PSICOLOGICI:
Il soggetto non si sente integrato e connesso. C’è un senso inadeguato di sé dovuto alla
mancata identificazione con il corpo.
82 ORALE:
COMPORTAMENTO:
Ha uno scarso senso di indipendenza anche se a volte manifestano un’indipendenza
esagerata che nelle situazioni di stress non regge. Tende ad aggrapparsi agli altri.
CARATTERISTICHE FISICHE:
Il corpo è lungo e sottile, e tende ad accasciarsi per la debolezza del sistema muscolare.
La respirazione è poco profonda.
BLOCCHI ENERGETICI:
La carica è ridotta, fluisce nella periferia del corpo ma è ridotta. La mancanza di energia e
di forza è più evidente nella parte inferiore del corpo.
ASPETTI PSICOLOGICI:
Il soggetto ha difficoltà a stare in piedi da solo. Ha un bisogno esagerato di contatto con
gli altri, per avere appoggio e calore. Ritiene che tutto gli sia dovuto, per la sua esperienza
precoce di deprivazione.
PSICOPATICO:
COMPORTAMENTO:
In tutti i caratteri psicopatici c’è un grande investimento di energia nella propria
immagine. Ha bisogno di potere, di dominio e di controllo, che cerca di raggiungere in due
modi:
A. Con la prepotenza e la sopraffazione
B. Con un approccio seduttivo
CARATTERISTICHE FISICHE:
il tipo prepotente ha uno sviluppo sproporzionato della parte superiore del corpo. Il tipo
seduttivo e’piu’ regolare in entrambi i casi il flusso che passa da una parte all’altra del
corpo e’ disturbato.
BLOCCHI ENERGETICI:
Il tipo prepotente: ha un marcato spostamento dell’energia nella parte superiore del corpo
per sovrastare l’altro, e concomitante riduzione della carica nella parte inferiore. Il bisogno
di controllo è diretto anche contro il proprio sè.
ASPETTI PSICOLOGICI:
Nella personalità psicopatica il bisogno di controllare è strettamente collegato alla paura di
essere controllati. La negazione dei sentimenti è una negazione del bisogno.
83 MASOCHISTICO:
COMPORTAMENTO:
La struttura del carattere masochistico è quella dell’individuo che soffre, lamentandosi, ma
rimane remissivo. Esternamente mostra un comportamento sottomesso, ma internamente
è l’opposto.
CARATTERISTICHE FISICHE:
Una delle caratteristiche più importanti è l’avanzamento del sedere tenuto in dentro, a
livello della vita. Pesantezza nelle natiche e delle cosce, con pelle scura causata dal
ristagno della carica.
BLOCCHI ENERGETICI:
La struttura masochista è tutta carica di energia, ma è costretta dentro limitando l’azione
espressiva.
ASPETTI PSICOLOGICI:
Atteggiamento cosciente di sottomissione e compiacenza, inconsciamente contraddetto da
negatività e ostilità.
RIGIDO:
COMPORTAMENTO:
Personalità ancorata alle due estremità del corpo e dotata di un buon contatto con la
realtà, però con la difesa contro l’aspirazione al piacere e all’abbandono. Carattere
inflessibile e orgoglioso.
CARATTERISTICHE FISICHE:
Il corpo è proporzionato e armonioso, vitale, con occhi brillanti e buon colorito. Queste
caratteristiche diminuiscono se aumenta la rigidità.
BLOCCHI ENERGETICI:
Il controllo è periferico consentendo il flusso dei sentimenti, ma limitandone l’espressione.
Ci sono comunque vari gradi di rigidità.
ASPETTI PSICOLOGICI:
Il soggetto ha un buon orientamento verso il mondo, competitivo e ambizioso. La passività
viene vissuta come vulnerabilità.
84 I vari tipi di carattere hanno determinate caratteristiche: lo schizoide
è caratterizzato dal rifiuto, l’orale dalla deprivazione, lo psicopatico
dalla negazione dei sentimenti, masochista è remissivo e il rigido
interagisce efficacemente con il suo mondo; questa classificazione ha
l’obiettivo di permette al terapista di capire il paziente e i suoi
problemi, senza perdere di vista il valore della persona. Il lavoro con
la bioenergetica mi ha permesso di sperimentare sia l’importanza del
lavoro sul corpo, per la ricerca di un benessere psicofisico, ma anche
come attraverso la voce la nostra personalità si può esprimere e
superare i vari blocchi.
85 CONCLUSIONI
Concludendo la tesi ha
l’intento di offrire spunti di riflessione sul
percorso della voce e della vocalità attraverso il corpo e nella coralità.
Sia come atto fonatorio che nel lavoro musicoterapico, ritengo la voce
un importante canale relazionale attraverso il quale può passare tutto
il nostro mondo personale, le nostre emozioni e i nostri stati d’animo.
Il canto rappresenta l’unico “gesto corporeo” che produce musica
senza la mediazione di un oggetto sonoro, nel gesto nasce la musica.
Attraverso il gesto si impara la consapevolezza di sé stessi e del
proprio valore, che và al di là di ogni possibile diagnosi. Più volte ho
revisionato questo trattato e mi sono resa conto di come ogni giorno
attraverso le nuove esperienze, non solo di tirocinio, il modo di
osservare e vivere le esperienze cambia. Più di tutto ho imparato il
valore che la voce ha nelle relazioni, e di come attraverso di essa
possiamo ascoltarci e raccontarci. La voce mi ha permesso di andare
oltre il pregiudizio e di scoprire mondi a me sconosciuti e nuovi modi
di vedere la vita. Di tutte le persone che ho incontrato, potrò
ricordare il suono unico
della loro voce. Non è quindi una
conclusione, ma il punto di partenza di un affascinante percorso in un
mondo così variegato come quello della musicoterapia, attraverso il
nostro strumento principale: la voce.
86 GRAZIE
Questo percorso e’ dedicato alla mia famiglia, mamma Loredana,
papa’ Massimo e fratelli Oliver e Elia che hanno accompagnato la mia
vita con le loro proposte musicali.
Grazie a Diego Iracà e ad Andrea De Ambrosis per il sostegno e per
aver creduto in me e perché senza di loro non avrei mai intrapreso
questo percorso nella “ricerca di me stessa” .
Grazie a Cosimo Morleo, che oltre ad essere un grande cantante, è un
vero artista e mi ha trasmesso la “bellezza” del canto.
Grazie a tutti i miei compagni del corso di musicoterapia che mi
hanno nutrita con la loro amicizia e il loro affetto.
Grazie a Giorgio Debernardi e a Caterina Dominelli, compagni di
chiacchere, di riflessioni, di confronti, di risate e di suoni.
Grazie ad Antonio Mauro Sarcinella, Flavio Rubatto e Silvia Pusceddu
per la disponibilità, il confronto e il tempo dedicato nei tirocini.
Infine grazie a me stessa, grazie al mio corpo e alla mia voce, perché
mi conducono sempre in un universo di meraviglia!
87 O razza nata dalla terra, in balia del destino, schiacciata dalla Forza ,
o piccoli avventurieri di un mondo infinito
prigionieri di un’umanità nana,
per quanto ancora girerete nella giostra della mente
intorno al piccolo ego e a meschine cose?
Non per un’immutabile piccolezza foste concepiti,
né fatti per una vana ripetizione…
Poteri onnipotenti sono rinchiusi nelle cellule della Natura.
Un destino più grande aspetta davanti a voi…
La vita che conducete nasconde la luce che siete.
Li ho visti attraversare l’alba di un era,
i bambini dagli occhi di sole di un’alba mirabile…
I potenti distruttori delle barriere del mondo…
Gli architetti dell’immortalità…
Corpi colmati di bellezza dalla luce dello Spirito,
che portano la parola magica, il fuoco mistico,
che portano la coppa dionisiaca della gioia…
SATPREM, SRI AUROBINDO
CONTENUTI BIBLIOGRAFICI
Albano Fabio,Rivista, Musica e terapia, N°20,Articolo, Il canto sociale della corale
•
Cavallini di Modena
Bencivelli Silvia., Perché ci piace la musica,Orecchio,emozione,evoluzione,Sironi,
•
Milano,2012
•
Benenzon R.,Manuale di Musicoterapia,Borla, Roma, 2011
•
Galimberti U., Psicologia, Garzanti,Milano, 1999
•
Giberti-Rossi, Manuale di psichiatria, Piccin,Padova,2009
•
Goleman D.,Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 1996,p.114
88 •
Juvarra A., Il canto e le sue tecniche, Ricordi,Milano, 1987
•
Lecourt E., Analisi di gruppo e musicoterapia,Cittadella,Asssi,1993
•
Lowen A. ,Arrendersi al corpo, Il processo dell’analisi bioenergetica, Astrolabio,
Roma, 1994
•
Lowen A., Bioenergetica, Feltrinelli, Milano, 2014
•
Manarolo G. e Borghesi M., Musica &Terapia,Quaderni italiani di musicoterapia,
Cosmopolis, Torino,2004,
Manarolo G,Le cure musicali,Applicazioni musicoterapiche in ambito
•
psichiatrico,Cosmopolis,Torino, 2012,
Messaglia R.,Gentile M., Sarcinella M.,Vigliaroni G., Cantare le voci- Il canto corale
•
come cura, Didattica
Messaglia R.,Gentile M.,Sarcinella M.,VigliaroniG.,Cantare le voci,Il canto corale
•
come cura, Didattica Attiva,Torino, 2015
•
Mila M., Breve storia della musica, Einaudi, Torino, 1993
•
Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M.,Musicoterapia, Carocci, Roma, 1997
•
Rivista, musica e terapia n.20
•
rivista, musica e terapia, n.21
•
Schon D., Akiva-Kibiri L., Vecchi T.,Psicologia della musica, Carocci, Roma, 2007
•
Tomatis Alfred.,L’orecchio e la voce, Baldini &Castoldi, Milano
•
Tosto Ida Maria, la voce musicale: Orientamenti per l’educazione vocale, EDT,
Torino,2009
•
Vegetti FinziS.,Il bambino nella psicoanalisi, Zanichelli,Bologna, 1976
•
Videscott M. e Sartori E.,La voce in musicoterapia, Cosmopolis, Torino, 2008
SITOGRAFIA
• A.Tenaglia,Lacoralità,www.psycomedia.it/neuro-snp/0809/tenaglia.htm
• https://it.wikipedia.org-terapia
• La voce e il canto, www.accademiaarsantiqua.net
• www.associazionecoripiemontesi.com
• www.bioenergetica.eu
89 • www.bioenergeticaesocieta.it
• www.biosofia.it
• www.coronoteblu.net - La voce persona
• www.educare.it
• www.kalycantus.com -Vocalità
• www.maurouberti.it-la voce.
• www.musicoterapia.it
• www.psichiantria.it
• www.stateofmind.it
• www.terapiacognitiva.re.it
• www.tomatis-italia.ovh
5.
ARTICOLO
IL CANTO CORALE SINCRONIZZA… I CUORI! – MUSICA
&
PSICOLOGIA
ID Articolo: 34003 - Pubblicato il: 18 settembre
2013
di Camilla Marzocchi
UNA RECENTE RICERCA SI È OCCUPATA DI PORTARE ALLA LUCE
GLI EFFETTI POSITIVI DEL CANTO CORALE SUL CORPO, E IN
PARTICOLARE SUL CUORE, GRAZIE ALLA CAPACITÀ DI
STIMOLARE LA COMUNICAZIONE NEUROBIOLOGICA TRA GLI
ESSERI UMANI.
Moltissime sono le manifestazioni di “canto corale” volte ad
incrementare la comunione, la solidarietà e l’appartenenza: gli inni, i
rituali e i canti religiosi, i mantra e il celebre “Om” della pratiche yoga.
90 Per chi non avesse avuto la fortuna di provare una qualunque di
queste esperienze, ora abbiamo la conferma che è giunta l’ora di
buttarsi!
Una recente ricerca condotta in Svezia (BjörnVickhoff, 2013) si è
occupata infatti di portare alla luce gli effetti positivi del canto corale
sul corpo, e in particolare sul cuore, grazie alla capacità di stimolare la
comunicazione neurobiologica tra gli esseri umani: uno studio da “nerd
dell’evoluzionismo”…..che offre tuttavia una spiegazione biologica a
moltissime esperienze umane, già presenti in tutte le culture dalla
notte dei tempi!
Esiste a questo proposito un filone di ricerche storicamente interessato
a questi aspetti del comportamento umano, definiti come joint action
(Sebanz et al., 2006) che sottolinea come, in sintesi, azioni di gruppo
esterne e visibili corrispondano ad azioni interne e biologiche precise,
regolando dunque il comportamento umano in modo profondo e in
alcuni casi completamente automatico.
I ricercatori dell’Università di Göteborg si sono occupati in particolare
di approfondire gli effetti del cantare in coro sul cuore, partendo
proprio dal monitoraggio di alcuni indici fisiologici correlati all’attività
cardiaca e alla regolazione delle emozioni. La frequenza cardiaca
nell’uomo è in costante mutamento nell’arco della giornata, può
accelerare o rallentare in base alle esigenze del momento e ciò ci
rende capaci di un buon adattamento in molte e diverse situazioni.
Il rapporto tra cuore e canto è mediato principalmente dalla
respirazione, o meglio dalla sincronizzazione di variabilità interbattito
(HRV)
e
respirazione,
che
in
letteratura
è
chiamata
RespiratorySinusArrhythmia (RSA): la respirazione lenta produrrebbe
una maggiore ampiezza della variabilità interbattito, per via della sua
influenza sull’attività del sistema nervoso autonomo (SNA), e dunque
una maggior regolarità del cuore.
In sintesi, quando espiriamo il SNA produce una risposta vagale
(parasimpatico) che rallenta il battito, intervenendo direttamente
sul’attività delle cellule del principale pacemaker del cuore (il nodo
sinoatriale), al contrario quando inspiriamo viene bloccata l’attività del
vago (vagal break) e il nostro battito cardiaco aumenta (simpatico).
L’RSA è il risultato di questa attività on-off del vago: più questa attività
è regolare e sincronizzata al respiro, maggiori sono i benefici per il
nostro sistema cardiocircolatorio (Porges, 2011).
Per intenderci: la meditazione, lo yoga, la respirazione guidata, la
pratica mindfulness … agiscono tutte su questo meccanismo. Ma ora
torniamo al canto!
I ricercatori hanno scelto di indagare tre forme di canto al fine di
identificare la più efficace nell’aumentare RSA e dunque il benessere
91 generale: un suono monotono (humming), un inno e un mantra. In
tutti e tre i casi è stata valutata la struttura ritmica dei brani, la
coordinazione tra questa e il respiro dei partecipanti e alcuni indici
fisiologici (HRV, conduttanza cutanea, temperatura del dito,
respirazione).
I risultati hanno mostrato come cantare all’unisono brani dalla
struttura ritmica regolare, porti alla sincronizzazione del battito
cardiaco e della respirazione dei partecipanti: l’effetto
maggiore sull’ampiezza dell’HRV si è ottenuto per il mantra e
per l’humming, mentre meno significativo è risultato l’inno.
Quel che è importante è che dopo una sessione di canto, i cuori dei
cantanti “imparano” ad accelerare e rallentare simultaneamente,
producendo una sintonizzazione emotiva e contemporaneamente
fisiologica molto benefiche per l’uomo.
Se pensiamo infine che il nervo vago arriva a regolare anche
l’attività dei muscoli della laringe, producendo quella che viene
definita “prosodia emozionale”…..ecco che la voce e la sua
espressione
attraverso
il
canto
assumono
un
ruolo
comunicativo evolutivamente fondamentale.
I risultati della ricerca spiegherebbero, potenzialmente, il ruolo del
canto collettivo nella creazione di una prospettiva congiunta e dunque
di
un’azione
congiunta..
Per saperne di più: http://www.stateofmind.it/2013/09/canto-corale/
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108