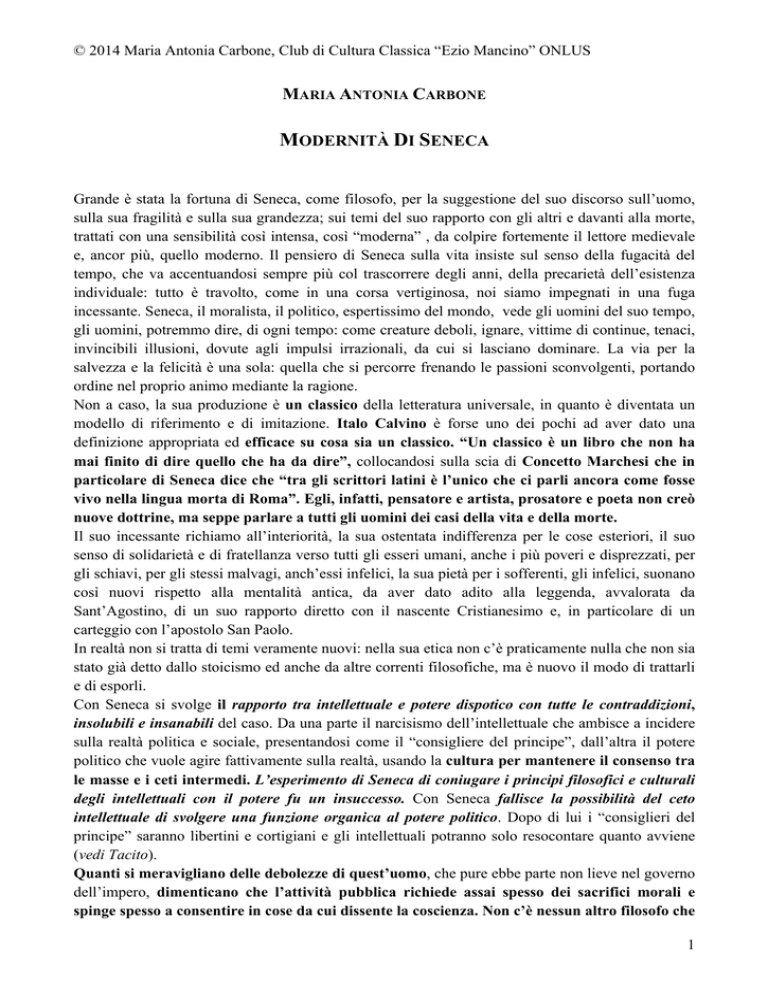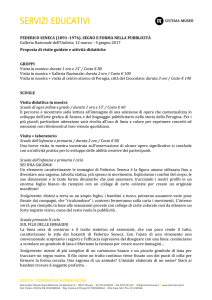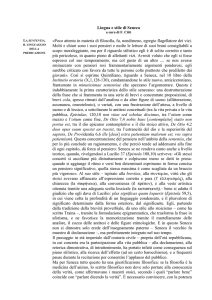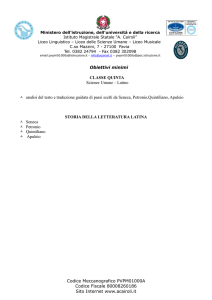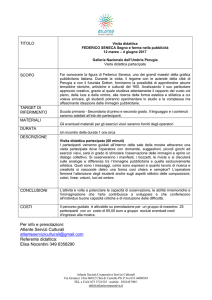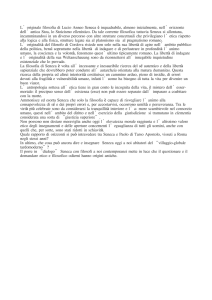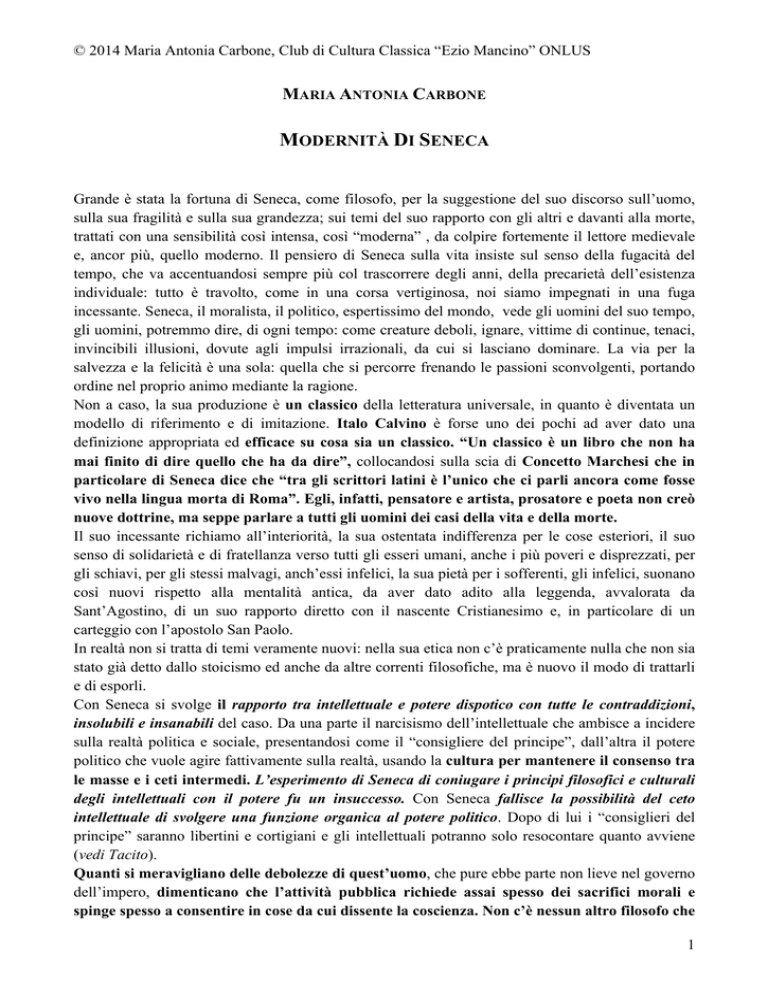
© 2014 Maria Antonia Carbone, Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS
MARIA ANTONIA CARBONE
MODERNITÀ DI SENECA
Grande è stata la fortuna di Seneca, come filosofo, per la suggestione del suo discorso sull’uomo,
sulla sua fragilità e sulla sua grandezza; sui temi del suo rapporto con gli altri e davanti alla morte,
trattati con una sensibilità così intensa, così “moderna” , da colpire fortemente il lettore medievale
e, ancor più, quello moderno. Il pensiero di Seneca sulla vita insiste sul senso della fugacità del
tempo, che va accentuandosi sempre più col trascorrere degli anni, della precarietà dell’esistenza
individuale: tutto è travolto, come in una corsa vertiginosa, noi siamo impegnati in una fuga
incessante. Seneca, il moralista, il politico, espertissimo del mondo, vede gli uomini del suo tempo,
gli uomini, potremmo dire, di ogni tempo: come creature deboli, ignare, vittime di continue, tenaci,
invincibili illusioni, dovute agli impulsi irrazionali, da cui si lasciano dominare. La via per la
salvezza e la felicità è una sola: quella che si percorre frenando le passioni sconvolgenti, portando
ordine nel proprio animo mediante la ragione.
Non a caso, la sua produzione è un classico della letteratura universale, in quanto è diventata un
modello di riferimento e di imitazione. Italo Calvino è forse uno dei pochi ad aver dato una
definizione appropriata ed efficace su cosa sia un classico. “Un classico è un libro che non ha
mai finito di dire quello che ha da dire”, collocandosi sulla scia di Concetto Marchesi che in
particolare di Seneca dice che “tra gli scrittori latini è l’unico che ci parli ancora come fosse
vivo nella lingua morta di Roma”. Egli, infatti, pensatore e artista, prosatore e poeta non creò
nuove dottrine, ma seppe parlare a tutti gli uomini dei casi della vita e della morte.
Il suo incessante richiamo all’interiorità, la sua ostentata indifferenza per le cose esteriori, il suo
senso di solidarietà e di fratellanza verso tutti gli esseri umani, anche i più poveri e disprezzati, per
gli schiavi, per gli stessi malvagi, anch’essi infelici, la sua pietà per i sofferenti, gli infelici, suonano
così nuovi rispetto alla mentalità antica, da aver dato adito alla leggenda, avvalorata da
Sant’Agostino, di un suo rapporto diretto con il nascente Cristianesimo e, in particolare di un
carteggio con l’apostolo San Paolo.
In realtà non si tratta di temi veramente nuovi: nella sua etica non c’è praticamente nulla che non sia
stato già detto dallo stoicismo ed anche da altre correnti filosofiche, ma è nuovo il modo di trattarli
e di esporli.
Con Seneca si svolge il rapporto tra intellettuale e potere dispotico con tutte le contraddizioni,
insolubili e insanabili del caso. Da una parte il narcisismo dell’intellettuale che ambisce a incidere
sulla realtà politica e sociale, presentandosi come il “consigliere del principe”, dall’altra il potere
politico che vuole agire fattivamente sulla realtà, usando la cultura per mantenere il consenso tra
le masse e i ceti intermedi. L’esperimento di Seneca di coniugare i principi filosofici e culturali
degli intellettuali con il potere fu un insuccesso. Con Seneca fallisce la possibilità del ceto
intellettuale di svolgere una funzione organica al potere politico. Dopo di lui i “consiglieri del
principe” saranno libertini e cortigiani e gli intellettuali potranno solo resocontare quanto avviene
(vedi Tacito).
Quanti si meravigliano delle debolezze di quest’uomo, che pure ebbe parte non lieve nel governo
dell’impero, dimenticano che l’attività pubblica richiede assai spesso dei sacrifici morali e
spinge spesso a consentire in cose da cui dissente la coscienza. Non c’è nessun altro filosofo che
1
© 2014 Maria Antonia Carbone, Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS
più di lui sia stato accusato d’ipocrisia, incoerenza, instabilità. In lui, personaggio complesso
s’intrecciano, con luci e ombre, morale e politica, intellettuale e potere: trescava con gli ambienti
imperiali, mentre rivendicava la libertà dell’homo sapiens dalle passioni, faceva speculazioni
economiche spregiudicate, accumulava un ingente patrimonio e praticava addirittura l’usura,
mentre predicava la povertà, il disprezzo delle ricchezze e l’ascetismo, si macchiava di connivenze
e debolezze interessate mentre diceva di voler aiutare gli altri ad essere migliori, si adattò alla
tirannide pur avendo scritto pagine di fuoco contro di essa; insisteva sulla dignità e la coerenza
con se stessi e poi scriveva una consolatio per Polibio, liberto di Claudio, per ottenere il perdono
dell’imperatore e quindi il ritorno dall’esilio in Corsica; consigliava la clemenza ma non si oppose
al matricidio di Nerone e all’assassinio di Britannico; compose una “satira menippea” contro
Claudio e nel frattempo preparava l’elogio funebre dello stesso imperatore; inoltre, come gli altri
stoici, non ammetteva l’immortalità dell’anima, tuttavia con il sentimento aspirava ad un aldilà
che la ragione negava.
A chi gli rimproverava le numerose contraddizioni tra il suo comportamento reale e la moralità
predicata nelle opere obiettando: “tu parli in un modo ma vivi in un altro”, Seneca, mentre era
ancora nel pieno della potenza, rispondeva:”Io parlo della virtù, non di me. Io sono nel profondo
dei vizi. E quando grido contro i vizi, grido prima di tutto contro i miei. A me basta togliere ogni
giorno qualcosa dai miei vizi e castigare i miei errori” (De vita beata, XVII). Quanto ai filosofi
diceva: fanno già molto per il solo fatto che concepiscono e dicono le cose oneste” (De vita beata,
1). Egli non si atteggia a maestro infallibile e non mancò mai di confessare la sua infermità morale e
denunciare che non nella pratica della sua vita bisognava cercare l’esempio del suo precetto, bensì
dallo sforzo incessante che egli compie per “vivere meglio”, anche se non riesce “a vivere
perfettamente”; anzi è il più costante accusatore di se stesso, quando dice: “Ci vuole tutta una vita
per imparare a vivere e tutta una vita per imparare a morire” (De brevitate vitae, 7, 3). Egli ha
l’innegabile torto di non aver compreso a tempo che il suo posto non era più presso Nerone, perché
restare presso un principe quando è vana la speranza di buon principato è sicuramente grave
compromissione morale.
Seneca è riuscito a mantenere nei secoli e in epoche e climi culturali diversi una notevole fama sia
per le sue incoerenze nei confronti del potere (i regimi totalitari e dispotici ne hanno apprezzato i
comportamenti da suddito, mentre gli intellettuali si sono consolati con le sue pose di oppositore,
individualista e narcisista, anche se non pericoloso per il potere; dall’altra per le caratteristiche
del personaggio-Seneca, che ne permettono l’uso in momenti diversi, in quanto i temi da lui trattati
danno l’immagine di un personaggio eterogeneo e contraddittorio, quindi umanissimo. Seneca è un
miscuglio di idealità e realismo. Sostenitore della morale stoica, la piegò alle esigenze della vita
pratica. Visse in un primo tempo da asceta, vegetariano e parco nelle abitudini alimentari e negli
agi, si vantava dicendo di essere un oceano di difetti (De vita beata) e di farsi l’esame di coscienza
ogni sera (De ira, IV, 36); si presenta come modello insuperabile di vita e fa il continuo elogio di
se stesso, ma mentre biasima gli adulatori che esaltano l’innocenza di Nerone, lo appoggia nel
matricidio e in assassini. Solo il suicidio ne riscattò l’immagine: a ragione può affermare che lascia
in eredità agli amici il suo bene più bello: l’immagine della propria vita. Egli, filosofo prestato
alla politica, si è misurato con scienza, filosofia, divino, morale e politica, mandando messaggi
disparati, diventando addirittura un vademecum per i manager (Seneca per i manager) tedeschi che
introducevano con una sua massima le riunioni in club di potenti affaristi Ecco una sua riflessione
su ricchezza (De brevitate vitae, 25, 1): “Mettimi in una casa ricchissima, mettimi dove oro e
argento siano d’uso comune: non insuperbirò per queste cose, che se anche stanno in casa
2
© 2014 Maria Antonia Carbone, Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS
mia, sono al di fuori di me. Trasferiscimi sul ponte Sublicio e gettami tra i bisognosi: non per
questo mi disprezzerò, perché siederò fra coloro che porgono la mano all’elemosina…”
Questa riflessione di Seneca è per ricordarci che il denaro non è un male in sé. È l’uomo che,
divinizzando il denaro, lo rende un male. Il denaro è un mezzo, non un fine; il pericolo nasce
quando si scambia il mezzo per il fine. Seneca legittima l’uso delle ricchezze se queste sono
funzionali al raggiungimento della virtù. Poiché il saggio sa vivere secondo natura, saggezza e
ricchezza non sono necessariamente antitetiche. L’importante non è quindi non possedere ricchezze,
ma non lasciarsi invischiare in esse. Bisogna quindi mantenere il controllo sui beni e non far sì
che possano prendere il controllo su di noi, influenzandoci eccessivamente. Così non rifiuta le
ricchezze, anzi, se ne compiace, ma non dipende mai da esse. A lui è totalmente indifferente se
queste un giorno dovessero svanire: la libertà del saggio consiste nell’uniformare i propri voleri
con quelli del Destino, ma la felicità non dipende da esse.
Nel “De vita beata”, Seneca sostiene infatti che la felicità risiede non nel piacere ma nella virtù,
in una vita conforme alla nostra natura, cioè secondo ragione, ponendosi con coraggio di fronte
al dolore, alle disgrazie, ai mali della vita, alla morte) (in Seneca la virtus romana = valore
militare si sposa con l’a\rethé greca = qualità dell’anima). La felicità è il raggiungimento del
Sommo Bene, attraverso la via della virtù. Solo con la vita contemplativa l’uomo si può liberare
dalla schiavitù dei piaceri e dalle loro ingannevoli gioie. Noi non possiamo cambiare la totalità
delle cose che ci circondano, però possiamo cambiare il nostro animo: se noi volessimo,
potremmo sopportare con coraggio tutto ciò che ci capita e questo significherebbe mettersi in
armonia con la natura. Contro la sorte è impossibile lottare ed è un errore attribuire valore a ciò che
dipende da essa :”siamo tutti schiavi del destino”; l’interiorità è il luogo dove ritirarsi contro
gli attacchi di ciò che è esterno a noi, per questo ogni sera dovremmo fare il “redde rationem”,
una ricognizione fra i sentieri del nostro animo. La felicità inoltre non dipende neppure dal luogo
in cui si vive, infatti non siamo nati per vivere in un solo angolo della terra, ma “la nostra patria
è il mondo”, ma se non riusciamo a liberarci dalle angosce e dai vizi, qualsiasi sia il luogo,
saremmo infelici.
Altri temi fondamentali sono quelli del rapporto uomo-tempo, la morte, la schiavitù, ecc.
E’ nelle Epistulae ad Lucilium che si trova la parte più bella degli scritti di Seneca, la più
proficua e “l’unica opera dell’antichità scritta espressamente per i posteri”. Non è un epistolario
pettegolo o politico, una esibizione di bello spirito, né una finzione letteraria,. ma un vero
epistolario. E’ un dialogo a due, la guida spirituale di un amico filosofo che conosce una dottrina
provvida per portarvi l’amico sensibile ai problemi dell’anima, ma non tanto ciò che Seneca dice
all’altro per l’altro, ma anche ciò che dice di sé e per noi attira in questo epistolario-morale e
letterario. Seneca ci illustra il cammino della saggezza non isolato in poche astratte sentenze,
ma immerso in un’umanità profonda e articolata in cento problemi di condotta, nell’urto con
le circostanze quotidiane e con i temi universali della vita, della morte, della felicità e del
dolore. Seneca non procede mai in modo sistematico, non si propone la stesura di un vero e
proprio trattato di filosofia morale e forse non è neppure in grado di creare un sistema su basi
teoretiche. La filosofia per Seneca era “scienza del vivere”. Nessun filosofo ha elaborato come
Seneca una teoria riguardante tanti aspetti comportamentali dell’uomo. E questo insegnamento gli
servì soprattutto alla fine del suo impegno politico, quando la filosofia assunse un altro ruolo, quello
di “consolatrice” nelle sventure e infine quello di scienza del morire. Seneca era uno stoico, ma
dello stoicismo rifiutò l’eccessivo dogmatismo e soprattutto l’astrattismo teoretico. E questo lo
rendeva aperto ad altre dottrine filosofiche. Infatti, sosteneva che bisogna prendere princìpi da
3
© 2014 Maria Antonia Carbone, Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS
tutte le teorie filosofiche. Egli diceva nel De Brevitate Vitae: “C’è dato di discutere con Socrate, di
dubitare con Carneade, di trovare la pace con Epicuro, di vincere la natura umana con gli stoici”.
Fu un eclettico, dunque e anche un asistematico. È per questo che lo vediamo possedere due
anime, una individualistica, che lo portava all’isolamento come mezzo di difesa nei confronti
della violenza del mondo esterno, l’altra sociale che lo portava a incontrarsi e scontrarsi con la
realtà; Seneca era lontano dal cristianesimo, tuttavia spesso ebbe le stesse posizioni dei cristiani.
Montaigne (1533-1592), grande ammiratore di Seneca, apprezza nelle epistole proprio il fatto che
Seneca tratti la sapienza a “brani scuciti” che non richiedono l’esigenza di un lungo impegno (il
che per lui è un vantaggio). Non occorre una grande impresa per applicarvisi, e le si abbandona
quando piace. Si rovescia il giudizio in negativo di Quintiliano: “Seneca , filosofo poco accurato,
ma insigne persecutore dei vizi”. Eppure queste lettere “scucite” compongono per la vastità delle
materie un “corso quasi completo di morale”. Attraverso uno stile immediato, a volte concettuoso,
imperniato sulla sententia, stringato e nervoso, l’uso frequente di figure della ripetizione (anafora,
epifora), la prevalenza della paratassi, egli diventa l’appassionato comunicatore di ricette per ben
vivere, l’affilatore di armi necessarie per combattere la paura, il vizio nascosto da cui nasce tutta la
nostra infelicità; è nel negativo che cerca di renderci felici; Seneca non mira a mettere ordine nelle
sue parole, ma nelle nostre azioni. Colloquiando con Lucilio, Seneca parla anche con sé. Il
maestro, istruendo l’allievo, arricchisce la propria spiritualità. Le lettere prendono spunto da
fatti o episodi più o meno importanti della vita quotidiana e gli argomenti vengono sviluppati
su basi concrete. Egli indica nei principi generali della filosofia, cioè i decreta (= principi
fondamentali) e nei praecepta (=indicazioni particolari di azioni) la base sicura per la pratica
della virtù e il raggiungimento del sommo bene. Ma i praecepta senza i decreta cadono nel
vuoto, perché manca la determinazione del valore che attribuiamo ad ogni cosa (povertà e
ricchezza, gloria e infamia, patria ed esilio). Ad esempio dei praecepta come “soccorrere il
naufrago, insegnare la strada agli erranti, dividere il pane con chi ha fame, ecc.”, si basano sul
decretum fondamentale: “Siamo membra di un grande corpo (l’universo), la natura ci ha creato
fratelli e quindi dobbiamo essere pronti a prestare aiuto a chi ne ha bisogno (lettera 95, 51-53,
54-59) e quindi “come le foglie non possono inverdire da sé ed hanno bisogno di un ramo a cui
essere attaccate e dal quale trarre la linfa vitale, così questi precetti, se isolati, appassiscono:
debbono innestarsi nella dottrina di una scuola filosofica (decreta). L’arte del ben vivere
s’identifica con l’arte del ben morire. La vita è preparazione alla morte, non intesa come
drammatica conclusione dell’esistenza, ma come nascita in una nuova dimensione. La morte e la
vita sono due momenti che si integrano e si giustificano a vicenda. Seneca però non si ritira nella
torre d’avorio come gli Stoici più osservanti, che con questa posizione estrema, finiscono col negare
l’uomo stesso come individuo e togliergli il piacere e il diritto-dovere della socialità e della dura
conquista della perfezione morale. Gli uomini devono cercare di vivere nel miglior modo possibile,
intensamente, tutto il tempo che viene assegnato loro dalla sorte. Ciò significa che la morte è
davvero un punto fisso stabilitosi sul nostro orizzonte: è a quel punto che tende tutta la nostra
esistenza: ogni uomo deve vivere preparandosi ad accettare la morte. Essa è
un’imprescindibile necessità di natura, inoltre non è temibile per nessuno: essa infatti sia che
costituisca il passaggio ad una vita migliore, sia che ci riporti nel nulla in cui eravamo prima di
nascere è sempre la liberazione dai mali dell’esistenza; e come suprema scelta di libertà può, e
in determinati casi deve, essere ricercata volontariamente dal sapiente. Liberarsi dalla paura
della morte è compito precipuo del filosofo: chi ha realizzato il vero scopo dell’esistenza, ossia
la virtù, è pronto a morire in qualsiasi momento, senza rimpianti e senza timori; egli infatti ha
4
© 2014 Maria Antonia Carbone, Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS
raggiunto la perfetta libertà da ogni condizionamento esteriore, ha conquistato l’au\taérkeia,
l’autosufficienza propria del sapiente. La paura della morte nasce dall’errata valutazione della realtà
e aggiunge “Noi moriamo ogni giorno perché ogni giorno che passa è una parte di vita che ci viene
tolta” (III, 24, 20). Nel suicidio vi è una profonda svalutazione della vita che sta alla base di
tutta la dottrina stoica sul suicidio. Secondo gli Stoici infatti, la vita non ha valore positivo in sé e
per sé, ma lo acquista solo in relazione all’uso che se ne fa, tanto è vero che vivere o morire è
considerato “a\diaéforon” cioè indifferente, senza importanza, rispetto al valore assoluto consistente
nella virtù. Il tema è la virtù eterna, cui bisogna conformarsi. L’unica cosa che conta per Seneca è
imparare, prima ancora che insegnare, come vivere e come morire, il resto è tempo e fiato
sprecato, sottigliezze inutili. Il filosofo deve parlare, scrivere, agire per la nostra vita morale.
RAPPORTO UOMO-TEMPO: Il “ tempo” come concetto filosofico e scientifico era stato da
tempi remoti oggetto di indagine. Seneca scrisse sul tempo pagine che ben si adattano al mondo
moderno. E’ scontata sia l’identificazione dell’uomo contemporaneo fagocitato dalla frenesia
di un tempo mai sufficiente, con gli stolti “occupati” e “affaccendati”, ma anche valido il
monito di Seneca a Paolino e all’umanità intera di “prendere un po’ di tempo per sé” si adatta
all’alienazione del tempo presente. Il tempo ha un aspetto morale-etico, come coefficiente del
fattore di felicità nell’uomo, per cui è importante il valore qualitativo del tempo, l’uso che se ne
fa. Vi è in Seneca una vera dicotomia tra il giusto impiego del tempo, l’esserne padroni nel
vivere e il semplice esse = esistere: non è vissuto a lungo, ma è esistito a lungo, riferendosi a chi
mostri i segni esteriori della vecchiaia, ma non le tracce di un percorso qualitativo verso la virtù.
“Per imparare a vivere ci vuole tutta la vita e – cosa che sorprenderà ancora di più- ci vuole tutta
la vita per imparare a morire” (De brevitate vitae, VII, 3, 10). Perciò è necessario vivere il presente
“vivi senza indugio”, in una condizione “atemporale e assoluta, slegata dall’attesa del futuro e
non dipendente dal passato”: il presente è un punto, un istante, nello spazio e nell’eternità, quello
che noi viviamo è un punto, e ancor meno di un punto:”la vita, se la sai usare, è lunga (vita longa
est, si uti scias)”. La vita dell’uomo non è in sé breve, ma diviene tale in quanto gli uomini la
sprecano in occupazioni e impegni superflui.
Quello di Seneca è un invito a vivere, che non ha niente a che vedere con il carpe diem
oraziano. Egli vuole soltanto spingere l’uomo a fare un’autoanalisi. Egli non vuole cogliere
l’attimo fuggente, ma vuole vivere pienamente tutto il proprio tempo che è poco se gli altri ne
usano e ne abusano, mentre è abbondante se lo si sa utilizzare bene, attraverso lo studio, la
conoscenza e la lettura degli autori del passato. Quello che conta è il presente, perché il tempo
“scorre come un fiume in piena che se non siamo in grado di seguire intensamente ci travolge.”.
La vita è divisa in tre momenti: passato, presente e futuro. Il passato è certo, costituisce
un’acquisizione definitiva, quindi è sicuro, il presente è breve, il futuro è incerto. Gli indaffarati
(occupati) hanno perduto il proprio passato: nessuno ha voglia di volgersi al passato, perché
potrebbe essere spiacevole ricordare cose di cui prova rimorso. L’uomo ha torto a lamentarsi della
brevità della vita: è breve per il cattivo uso che facciamo del tempo che ci è dato. Il tempo è
l’unico vero possesso dell’uomo, ma non ce ne rendiamo conto e lo sciupiamo in mille occupazioni
e passioni. L’errore che compie l’uomo è di non vivere per sé, ma per le ambizioni, gli avversari e
il patrimonio, tutte cose che non gli appartengono, cadendo così nel colossale paradosso: quello
di una persona avara di tutto ciò che non gli appartiene e invece prodiga del suo vero e unico
possesso. Si vive come se si dovesse vivere sempre: “temete tutti di essere mortali, e desiderate
tutto come se foste immortali” . Non conta quanto si vive, ma come si vive. L’unico modo per
misurare la “quantità” della vita è quello che ne misura la “qualità”. Lo stoicismo non ha
5
© 2014 Maria Antonia Carbone, Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS
domani, si chiude nel presente, si difende dal tempo annullando il futuro, l’oggi del sapiens stoico è
atemporale; l’attimo ben vissuto vale un secolo (e, anche in questo caso, l’influenza di Epicuro
su Seneca è evidente). Ma dalla valutazione qualitativa del tempo deriva un’altra conseguenza
che, ancora una volta, accomuna Seneca a Epicuro più che allo stoicismo: il passato, in quanto
ben vissuto, libero da ogni rimpianto, è recuperato dalla memoria; il futuro, libero dall’ansia
del timore e della speranza, è recuperato dalla previsione. Siamo scontenti perché invece di
badare al tempo che è trascorso pensiamo a quello che presumiamo di dover ancora vivere e così lo
lasciamo scorrere. Si vive a lungo se si è consapevoli che ogni attimo ha il suo valore: Seneca ha la
sensazione della fugacità del tempo e bisogna cogliere l’attimo e non rimandare “perché ciò che può
capitare in qualsiasi momento può capitare oggi”.
Riferimento attuale: il buon uso del tempo si ripropone oggi nell’epoca della rivoluzione
informatica e della posta elettronica: Essere bombardati da una valanga di lettere elettroniche al
giorno, secondo Armando Torno, nel saggio “la truffa del tempo” equivale a stritolare la propria
giornata con un lavoro in più che produce poco o niente per noi, il tempo se ne va e nessuno ce lo
restituisce. Anche in Marcel Proust nel libro “Alla ricerca del tempo perduto” i personaggi
sono sostanzialmente dei vinti e a ognuno il tempo ha tolto qualcosa, soltanto le memorie sembrano
sottrarsi alla sua tirannia. Il tempo della coscienza invece è il vivere il presente grazie alla
memoria del passato e all’anticipazione del futuro. Contrariamente ai tempi della scienza, dal
profilo quantitativo, quelli della coscienza sono diversi per qualità (es. un minuto può durare
un’eternità e altri momenti volano via, perciò sono irripetibili e quindi è fallimentare andare “alla
ricerca del tempo perduto” (Proust).
Rapporto con gli uomini: anche su questo aspetto la posizione di Seneca è contraddittoria, Un
primo atteggiamento è di disponibilità ad agire nella storia e nella società secondo un progetto
provvidenziale: agire con la consapevolezza del sapiente, ma uomo accanto ad altri uomini,
estendendo agli altri quanto è stato conquistato individualmente nell’ascesa verticale:
“possedere un bene non ci dà alcuna gioia, senza un amico con cui condividerlo (I, 6,4). Però
talvolta gli uomini sono così carichi di vizi inemendabili che finiscono per contagiare chiunque si
accosti a loro. Perciò gli altri vanno evitati e per loro Seneca ha parola di disprezzo e di condanna:
Mi chiedi che cosa devi ritenere da evitare…), la folla (I, 7). Così inizia questa epistola e sembra un
Seneca epicureo, che predichi il laéje biwésav, non il filosofo che ha fatto dello iuvare alios lo
scopo della sua vita. Ma occorre distinguere: la folla non è il prossimo, nel quale per umile che
sia, il sapiente sa riconoscere la presenza di quella razionalità che è parte del divino. La folla è
qui la massa amorfa e corrotta, incapace di aspirare alla virtù, pronta a scatenarsi, nello spirito
di branco, ebbra di violenza, di sangue e di ignominia. Seneca, esortando a guardarsi dalla folla, si
sente come un convalescente che, appena giunto ai primi gradi della sapienza, può essere risospinto
nella malattia da ogni più piccolo impulso contrario. Il contatto con la massa è pericoloso perché
contagia: “la frequentazione di molte persone è dannosa, quanto maggiore è la folla, tanto più c’è
pericolo ….., dichiara Seneca, ritorno più avido, ambizioso, più bramoso di piaceri, anzi
addirittura più crudele e più inumano per essere stato in mezzo agli uomini. Il contatto con gli
uomini rende inumani, l’esempio trascina e finisce per travolgere le difese dell’io. Un esempio di
questa crudeltà viene offerto con la descrizioni dei giochi gladiatori, durante i quali la folla si esalta
di fronte a un spettacolo sanguinoso. L’unica salvezza, dopo tale spettacolo è il “recede in te ipse”,
che è non un invito a un ritiro egoistico in una torre d’avorio, ma un necessario ristoro di uno spirito
che solo in se stesso può trovare rifugio e salvezza dal male dei tempi. Ma vi sono altri uomini,
occupati, bisognosi di cure, ma immersi nell’errore, e per questo hanno bisogno dell’admonitio del
6
© 2014 Maria Antonia Carbone, Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS
filosofo, che li richiami alla realtà e la li converta alla saggezza. Altri ancora sono i miseri e i
disprezzati come gli schiavi. Verso di loro bisogna essere umani come verso ogni altro uomo. Non è
una generica compassione, ma l’atteggiamento umanitario e filantropico, proprio del sapiente che sa
vedere quello che gli altri non vedono, in questo caso sa vedere l’uomo sotto la condizione
miserevole: “Servi sunt, immo homines”…
LA SCHIAVITU’: nella lettera (V, 47) interamente dedicata alla definizione dei rapporti tra
padroni e schiavi,. distingue due tipi di padroni: gli snob raffinati “turba delicatorum” che
guardano con disgusto gli schiavi non- uomini”, dall’altro i superbi e i quasi “reges” che trattano
crudelmente gli schiavi solo per manifestare il loro potere. La schiavitù è solo una condizione
soggetta al Fato. La schiavitù non è uno status sociale, ma una caratteristica dell’anima,
pertanto in quest’ottica tutti possiamo essere schiavi. Tra liberi e schiavi non vi è alcuna
differenza: anche gli schiavi come i liberi, respirano la stessa aria, vivono e muoiono. In quanto
uomini sono accomunati dalla stessa sorte. Aggiunge: “E poi mostrami un uomo che non sia
schiavo: uno è schiavo della lussuria, uno dell’avidità, uno dell’ambizione; tutti lo sono della
paura... E nessuna schiavitù è più vergognosa di quella volontaria”. Di fronte alla servitù
involontaria, frutto della sventura e dell’ingiustizia, sta la voluntaria servitus, la più devastante,
perché nasce dall’egoismo, dall’istinto di sopraffazione, dal desiderio di vendetta, da quelle
passioni che ci rendono cupidi, ingrati, maligni, vanesi, prepotenti e paurosi.. Tutti ci portiamo
appresso la nostra fragilità, la nostra miseria, l’inclinazione al male. Riconoscerci per quello che
realmente siamo, significa riscoprirci tutti uguali e ugualmente bisognosi di verità e di amore.
È solo l’amore, divenutoforma di esistenza, che può cacciar via la paura (ibid.). Le
considerazioni sulla schiavitù, improntate a sincero umanitarismo non mettono certo in discussione
l’istituto della schiavitù nella società romana, ma sono una testimonianza nobilissima della
sensibilità dello scrittore. Dovranno passare 500 anni prima che i giuristi romani facciano diventare
il principio morale principio giuridico, riconoscendo la schiavitù contraria al diritto di natura
(Institutiones Iustinianeae).
Dai temi trattati si evince in modo chiaro quanto il pensiero di Seneca sia attuale e se alcuni suoi
passi fossero dati da leggere, senza citarne l’autore, sarebbero di una modernità sconcertante. Le
sue descrizioni dei vizi, delle debolezze della società romana sarebbero del tutto simili a molte
pagine del giornalismo contemporaneo, quando descrive con indignazione la corruzione dei
costumi italici di questo inizio di terzo millennio. La riflessione sulla saggezza e sulla capacità di
scegliere una vita retta e ancora di più la disamina del valore del tempo dimostra come Seneca sia
stato in grado di superare il suo tempo per accedere a un pensiero universale staccato dalla storia e
al di sopra della società romana e dal suo tempo. Seneca era inattuale per il suo tempo, ma è qui
la grandezza di tutti i pensatori: essere sempre altrove e stando altrove – nello spazio e nel
tempo- rimanere sempre accanto a noi, ovunque noi siamo.
In un mondo come il nostro, incredulo, così limitato negli orizzonti e incapace di guardare
oltre l’interesse o il piacere, quello di Seneca costituisce come un atto di fede nella convivenza
civile (fratellanza, non violenza, disprezzo della vita mondana e dei beni materiali, universalismo,
ecc.), un atto di fede nelle qualità migliori dell’uomo e una riaffermazione dei valori
fondamentali della vita.
7
© 2014 Maria Antonia Carbone, Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS
Seneca saluta il suo Lucilio (libro I, 7)
Tu vuoi sapere che cosa ritengo si debba principalmente evitare? La folla Non la puoi ancora
frequentare senza pericolo. Io almeno confesserò la mia debolezza: riporto a casa quei costumi che
ho portato fuori. Quel poco che avevo messo in ordine viene turbate, ritorna qualcuno dei vizi che
avevo cacciato. Ciò che succede agli ammalati che una lunga infermità ha afflitto a tal punto che
non possono uscire senza danno, questo stesso succede pure a noi: anche i nostri animi stanno
rimettendosi da una lunga malattia. La dimestichezza con la folla è nociva: ognuno o ci raccomanda
un vizio o ce lo trasmette o ci unge senza che noi ce ne accorgiamo. Ed il pericolo è tanto più
grande quanto più grande è la folla nella quale ci confondiamo. In verità che cosa può esserci di più
dannoso ala virtù che poltrire assistendo ad uno spettacolo? Infatti allora i vizi, favoriti dal piacere
più facilmente si insidiano nell'animo. Che cosa pensi che io dica? Ritorno a casa non solo più
avido di beni materiali, ma anche più crudele più inumano perché sono stato tra gli uomini. Per caso
capitai in uno spettacolo meridiano aspettandomi giochi e facezie e qualcosa di riposante con cui gli
occhi degli uomini si possono riposare dalla vista del sangue umano.
Amicizia con i servi (da Lettera 47)
Sbagli se pensi che io rifiuterò alcuni perché si occupano di un mestiere troppo vile, come ad
esempio quel mulattiere e quel bifolco: li valuterò non in base ai mestieri, ma ai costumi. Ciascuno
provvede a darsi un modo di vita, i mestieri sono assegnati dalla sorte. Alcuni cenino con te perché
ne sono degni, altri perché lo diventino: se, infatti, in essi c'è qualcosa di abietto, derivato dalla
frequentazione di gente vile, il convivere con le persone più oneste lo spazzerà via. Non c'è motivo
che tu, mio Lucilio, cerchi un amico solo al foro o alla curia: se farai bene attenzione, li troverai
anche in casa. Spesso una buona materia perde efficacia senza un artefice: tenta e prova. Tanto è
stolto chi, in procinto di comprare un cavallo, non guarda il cavallo ma la gualdrappa ed i freni, così
è folle chi considera un uomo in base al vestito od alla condizione, che ci avvolge come un vestito.
Testo originale
Erras si existimas me quosdam quasi sordidioris operae reiecturum, ut puta illum mulionem et illum
bubulcum. Non ministeriis illos aestimabo sed moribus: sibi quisque dat mores, ministeria casus
adsignat. Quidam cenent tecum quia digni sunt, quidam ut sint; si quid enim in illis ex sordida
conuersatione seruile est, honestiorum conuictus excutiet. XVI. Non est, mi Lucili, quod amicum
tantum in foro et in curia quaeris: si diligenter adtenderis, et domi inuenies. Saepe bona materia
cessat sine artifice: tempta et experire. Quemadmodum stultus est qui equum empturus non ipsum
inspicit sed stratum eius ac frenos, sic stultissimus est qui hominem aut ex ueste aut ex condicione,
quae uestis modo nobis circumdata est, aestimat.
Siamo tutti servi
"E' uno schiavo" - ma forse è libero nell'animo. "E' uno schiavo" - gli sarà forse di qualche danno?
Mostrami chi non lo è: uno è schiavo delle passioni sfrenate, uno dell'avidità, un altro
dell'ambizione, tutti della speranza, tutti della paura. ti darò l'esempio di un ex-console che si
metteva al servizio di una vecchietta, quello del ricco al servizio di una servetta, ti mostrerò giovani
8
© 2014 Maria Antonia Carbone, Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS
di nobilissima origine ( divenuti ) schiavi dei pantomimi: nessuna schiavitù è più vergognosa di
quella volontaria. Perciò non c'è motivo che questi schifiltosi ti facciano ritrarre dal mostrarti
sorridente e non superbamente superiore ai tuoi schiavi: ti adorino piuttosto che temerti.
Testo originale
XVII. "Seruus est". Sed fortasse liber animo. "Seruus est". Hoc illi nocebit? Ostende quis non sit:
alius libidini seruit, alius auaritiae, alius ambitioni, omnes spei, omnes timori. Dabo consularem
aniculae seruientem, dabo ancillulae diuitem, ostendam nobilissimos iuuenes mancipia
pantomimorum: nulla seruitus turpior est quam uoluntaria. Quare non est quod fastidiosi isti te
deterreant quominus seruis tuis hilarem te praestes et non superbe superiorem: colant potius te quam
timeant.
Servi sunt. Immo homines
Ho appreso volentieri da costoro, che provengono da dove tu ti trovi, che tu vivi in familiarità
con i tuoi schiavi: questo si addice alla tua saggezza ed alla tua educazione. "Sono schiavi" - ma
sono anche uomini. "Sono schiavi" - ma sono anche compagni di tenda. "Sono schiavi" - ma anche
umili amici. "Sono schiavi" - ma anche compagni di schiavitù, se avrai riflettuto che la fortuna ha
egual potere su entrambi. Così rido di costoro, che ritengono disdicevole cenare con il proprio
schiavo: per quale ragione, se non che una consuetudine superba ha fatto sì che la folla degli schiavi
ritti in piedi circondasse il padrone mentre cena? Egli mangia più di quanto può contenere ed
appesantisce con la sua enorme ingordigia il ventre rigonfio ed ormai disavvezzo al suo compito di
ventre, perché espella tutto con maggior sforzo di quanto lo ingoiò: invece agli schiavi sventurati
non è concesso muovere le labbra neppure per parlare. La frusta reprime ogni mormorio e neppure i
rumori fortuiti vengono sottratti alle frustate, la tosse, gli starnuti ed il singhiozzo: il silenzio
interrotto da una qualunque voce viene fatto scontare con un gran male; tutta la notte rimangono in
piedi a digiuno e muti. così accade che parlino (male) del padrone costoro ai quali non è concesso
parlare apertamente al padrone. Invece quelli che non solo potevano parlare ai padroni apertamente,
ma avevano con loro una conversazione amichevole, ai quali non veniva cucita la bocca, erano
pronti a dare la propria testa per il padrone, a deviare verso il proprio capo il pericolo imminente:
parlavano ai banchetti, ma tacevano sotto tortura.
Testo Originale
XLVII. SENECA LVCILIO SVO SALVTEM
I. Libenter ex iis qui a te ueniunt cognoui familiariter te cum seruis tuis uiuere: hoc prudentiam
tuam, hoc eruditionem decet. "Serui sunt". Immo homines. "Serui sunt". Immo contubernales.
"Serui sunt". Immo humiles amici. "Serui sunt". Immo conserui, si cogitaueris tantundem in
utrosque licere fortunae. II. Itaque rideo istos qui turpe existimant cum seruo suo cenare: quare, nisi
quia superbissima consuetudo cenanti domino stantium seruorum turbam circumdedit? Est ille plus
quam capit, et ingenti auiditate onerat distentum uentrem ac desuetum iam uentris officio, ut maiore
opera omnia egerat quam ingessit. III. At infelicibus seruis mouere labra ne in hoc quidem, ut
9
© 2014 Maria Antonia Carbone, Club di Cultura Classica “Ezio Mancino” ONLUS
loquantur, licet; uirga murmur omne conpescitur, et ne fortuita quidem uerberibus excepta sunt,
tussis, sternumenta, singultus; magno malo ulla uoce interpellatum silentium luitur; nocte tota ieiuni
mutique perstant. IV. Sic fit ut isti de domino loquantur quibus coram domino loqui non licet. At illi
quibus non tantum coram dominis sed cum ipsis erat sermo, quorum os non consuebatur, parati
erant pro domino porrigere ceruicem, periculum inminens in caput suum auertere; in conuiuiis
loquebantur, sed in tormentis tacebant.
Ritirati in te stesso quanto puoi; stai insieme con quelli che sono destinati a renderti migliore,
accogli quelli che tu puoi rendere migliori. Queste cose si fanno reciprocamente e le persone mentre
insegnano imparano.
IL TEMPO (dal De brevitate vitae)
Ognuno consuma la propria vita e si tormenta per il desiderio del futuro e per la noia del presente.
Ma quello che sfrutta per se stesso tutto il suo tempo, che programma tutti i giorni come una vita,
non desidera il domani né lo teme. Cosa vi è infatti che alcuna ora di nuovo piacere possa
apportare? Tutto è noto, tutto è stato assaporato a sazietà. Per il resto la buona sorte disponga come
vorrà: la vita è già al sicuro.
Perciò non c’è motivo che tu ritenga che uno sia vissuto a lungo a causa dei capelli bianchi o delle
rughe: costui non è vissuto a lungo, ma è stato in vita a lungo. E così come puoi ritenere che abbia
molto navigato uno che una violenta tempesta ha sorpreso fuori dal porto e lo ha sbattuto di qua e di
là e lo ha fatto girare in tondo entro lo stesso spazio, in balia di venti che soffiano da direzioni
opposte? Non ha navigato molto, ma è stato sballottato molto.
Neppure annovererai tra gli sfaccendati coloro che vanno in giro sulla portantina o sulla lettiga e si
presentano all’ora delle loro passeggiate come se non gli fosse permesso rinunziarvi, e che un altro
deve avvertire quando si devono lavare, quando devono nuotare o cenare: e a tal punto
illanguidiscono in troppa fiacchezza di un animo delicato, da non potersi accorgere da soli se hanno
fame. Sento che uno di questi delicati – se pure si può chiamare delicatezza il disimparare la
vita e la consuetudine umana – , trasportato a mano dal bagno e sistemato su una portantina,
abbia detto chiedendo: “Sono già seduto?”. Tu reputi che costui che ignora se sta seduto
sappia se è vivo, se vede e se è sfaccendato? Non è facile dire se mi fa più pena se non lo sapeva o
se fingeva di non saperlo. Certamente di molte cose soffrono in realtà la dimenticanza, ma di molte
anche la simulano; alcuni vizi li allettano come oggetto di felicità; sembra che il sapere cosa fai sia
tipico dell’uomo umile e disprezzato.
Vi è qualcuno che si consuma a tal punto nelle raffinatezze da chiedere a un altro se è seduto!
Dunque costui non è sfaccendato, dagli un altro nome: è malato, anzi è morto; sfaccendato è quello
che è consapevole del suo tempo libero. Ma questo semivivo, a cui è necessaria una spia che gli
faccia capire lo stato del suo corpo, come può costui essere padrone di alcun momento?
10