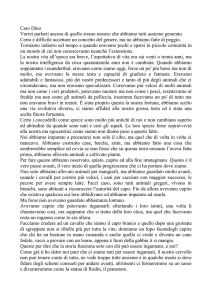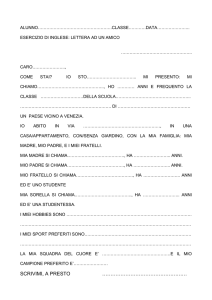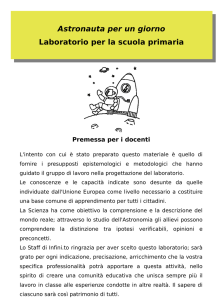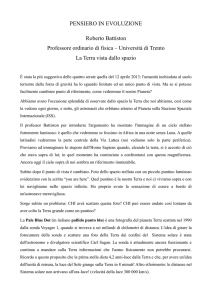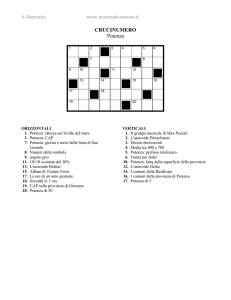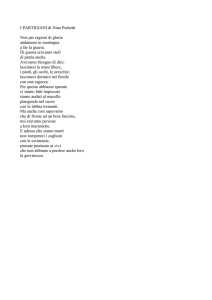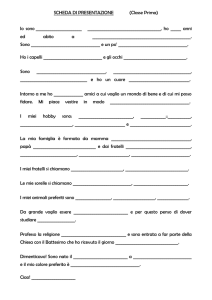Caroline Rougé – 1 scientifico A
“ Astronauta Samantha
Anno 2198, S.R.S.I (Stazione di Ricerca Spaziale Internazionale), 14.000.000.000 km dalla Terra.”,
dettai al mio diario elettronico. Galleggiavo nella mia piccola stanza, il sottile schermo semitrasparente in mano e non sapevo cos’altro scrivere. Erano ormai sedici mesi che la S.R.S.I era
decollata dalla base spaziale di Huston con a bordo quindici astronauti provenienti da paesi diversi. La
nostra missione spaziale comportava una cosa che mai nessun essere umano aveva fatto prima: uscire
dal sistema solare e avventurarsi nello spazio intergalattico. Era un salto nel buio, ma valeva la pena
tentare. Due anni e mezzo fa le sonde spaziali avevano rilevato una massiccia presenza di gravità e gli
scienziati avevano ipotizzato che si dovesse trattare del nucleo morto di una stella. Dentro di esso
avrebbero potuto esserci metalli e materiali che scarseggiavano sulla Terra e le radiazioni residue
avrebbero potuto anche essere una preziosa fonte di energia. Così, eravamo partiti e avevamo superato
Plutone, le “Colonne d’Ercole” del nostro Sistema. Arrivati nel settore dove gli strumenti avevano
registrato l’anomalia gravitazionale, non trovammo nulla. Settimane, mesi, a girare a vuoto e, fallita la
missione, stavamo tornando a casa.
Fu in quel momento che accadde qualcosa di imprevedibile.
Ci fu una brusca scossa, poi si scatenò il finimondo. Un allarme squarciò l’aria immobile e i corridoi in
acciaio furono illuminati di luce purpurea. Aggrappandomi alle maniglie attaccate alle pareti riuscii a
raggiungere il corpo principale della Stazione e, facendomi strada tra gli altri astronauti, mi diressi
verso il centro di comando. Sala di dimensioni enormi, era l’unico luogo ad avere un sistema di gravità
artificiale, per poter meglio lavorare con gli elaborati computer che regolavano il resto della S.R.S.I.
Quando caddi all’interno della sala, mi venne in contro il mio equivalente francese, Nicolas. Era
pallido in volto e la fronte era coperta da uno strato di sudore. Non parlò, si limitò a mostrarmi gli
schermi lampeggianti. Un brivido risalì la mia schiena quando realizzai che qualcosa aveva colpito più
della metà dei motori della Stazione e la stava lentamente aspirando verso sé stesso. Con le mani
tremanti, mi collegai a una delle telecamere esterne. Per un attimo non vidi nulla, neanche le stelle
lontane; poi nel campo visivo apparve una macchia di buio assoluto, circondata da un alone di energia,
luce e materia. In quell’istante uno dei numerosi corpi secondari iniziò a deformarsi. Gli indicatori
gravitazionali lampeggiarono, i metalli iniziarono a vibrare a causa di invisibili campi magnetici e noi
stavamo lentamente andando incontro a morte certa, tra le scure fauci di un Buco Nero. Eppure non era
ancora finita. Addestrati a mantenere il sangue freddo anche nelle situazioni estreme, tentammo di
ristabilire i parametri normali della navicella, invano. Improvvisamente notai che i propulsori ausiliari
del centro di comando erano ancora intatti. I miei colleghi ed io ci capimmo con uno sguardo. Sheila,
l’australiana, chiamò tutti gli astronauti a raccolta nel centro, mentre Chris, inglese, accese i
propulsori. Solo tre astronauti erano riusciti ad entrare quando, con uno schianto, tre degli otto corpi
che componevano la Stazione si staccarono e vennero inghiottiti dal Buco Nero. Fu per pura fortuna
che riuscimmo a sigillare quei corridoi prima che venissero staccati. Ormai non c’era più tempo. Chris
spinse al massimo i propulsori e riuscimmo ad allontanarci dal campo gravitazionale. Tuttavia, altri
due corpi secondari furono lacerati dalle due forze opposte e finirono
nella bocca dell’incubo spaziale. Solo quando fummo abbastanza lontani
ci fermammo a contare i danni. Su quindici astronauti, solo nove erano
sopravissuti all’incidente; gli altri erano stati istantaneamente uccisi dal
freddo dello Spazio. I computer indicavano che ci restavano cibo e
ossigeno per sole tre settimane al massimo; ne erano necessarie quattro
per raggiungere la Terra
“Nous allons jamais y arriver! Moriremo tutti!” esclamò Nicolas, ottimista come al solito. Nella sala
eravamo tutti in preda allo sconforto, solo pochi avevano ancora speranza. Fu Sheila a prendere in
mano la situazione. Prima tirò uno schiaffo, forte, a Nicolas, poi si rivolse a noi altri “Vi pare questo il
modo di reagire, branco di wombats? Costi quel che costi, riusciremo a trovare un modo per tornare
sani e salvi a casa” Mi alzai per prima. “Io sono con te” guardai i miei compagni. Uno alla volta,
lentamente, si alzarono, pronti a combattere. Nicolas si alzò per ultimo. “D’accord. Tanto mor...”
L’occhiataccia che molti gli lanciarono lo zittì. Era così iniziato il nostro viaggio di ritorno, la nostra
Odissea. Avevamo affrontato il mostro dall’occhio solo, il ciclope; quale sarebbe stato il prossimo
ostacolo? Sopratutto, saremmo riusciti a raggiungere la nostra pietosa Itaca?
La prima cosa di cui avevamo bisogno era l’organizzazione. Stabilimmo turni e lavori che ognuno
avrebbe dovuto rispettare. Il cibo e l’acqua furono razionati il più possibile e fu impostata la minima
quantità di ossigeno necessaria per il nostro corpo. Così facendo saremmo probabilmente riusciti a
raggiungere la Terra. Forse. La vita di noi tutti era appesa a un filo e solo con la collaborazione (e
MOLTA fortuna) saremmo riusciti a sopravvivere. Impostate le coordinate sul navigatore spaziale, la
navicella di fortuna si avviò verso il nostro Sole. Passarono i giorni e le parole erano rare e fugaci. Con
il cuore in gola scrutavo a volte lo spazio, a volte i miei compagni, aspettando un segno che spezzasse
l’angoscia e sollevasse la spada di Damocle che avevamo sul capo.
Al quattordicesimo giorno di viaggio qualcosa ruppe la monotonia dello spazio vuoto. Gli schermi
mostrarono la bianca scia di una cometa, nello stesso istante il computer ci informò che avevamo
appena superato l’orbita di Plutone. Un unico, fragoroso applauso riempì la stanza. Eravamo nel
Sistema Solare e, sebbene non fossimo che a metà viaggio, ci sentivamo come se niente potesse più
accaderci. Ci sbagliavamo di grosso e ce ne accorgemmo solo quando era ormai troppo tardi.
Era il diciannovesimo giorno di viaggio ed eravamo nei pressi di Giove. L’impatto con il piccolo
asteroide fu forte e improvviso. Ci fece perdere l’equilibrio; alcuni riuscirono a stare in piedi, altri (tra
cui la sottoscritta) caddero rovinosamente a terra. Alcune lamine di metallo si staccarono ma,
fortunatamente, nessuno era rimasto ferito in modo grave ma molti dei miei compagni avevano
numerosi graffi o lividi su mani e braccia. Mi stavo faticosamente rialzando quando avvenne un
secondo impatto, poi un terzo. Chris, al posto di comando, riuscì ad evitare un quarto asteroide per un
pelo. Eravamo al confine con la pericolosissima “fascia degli asteroidi”, tra Giove e Marte. Di norma
le navicelle erano dotati di computer altamente sofisticati che riuscivano ad evitare gli ostacoli, ma
quella funzione era stata persa dopo il nostro incontro con il Buco Nero. C’era un’unica possibilità:
proseguire. Attraversammo per ore e ore quella pericolosissima zona; scrutando attentamente gli
schermi per evitare impatti che avrebbero potuto essere fatali. La navicella era immersa nuovamente
nel silenzio febbrile di chi è consapevole della morte sempre più probabile. Usciti dalla fascia di
asteroidi, proseguimmo per un paio d’ore, poi i motori si spensero: un microscopico asteroide li aveva
mandati in corto circuito, insieme al dispensatore di ossigeno. A quel punto sembrava che fosse
veramente la fine dell’avventura. Per carenza di ossigeno mi indebolii e iniziai a svenire. Anche gli
altri erano nelle stesse condizioni. Eppure, la nostra buona stella non ci aveva ancora abbandonato:
prima di svenire Nicolas era riuscito a mandare un SoS alle Stazioni di Marte. Mi svegliai qualche
giorno più tardi a bordo dell’Intrepid, in una sala di ricovero insieme a tutti gli altri miei compagni,
vivi. Dalla parete in vetro vidi il più bello degli spettacoli. Un pianeta blu illuminato dal Sole per metà,
pieno di acqua e di vita.
Terra.