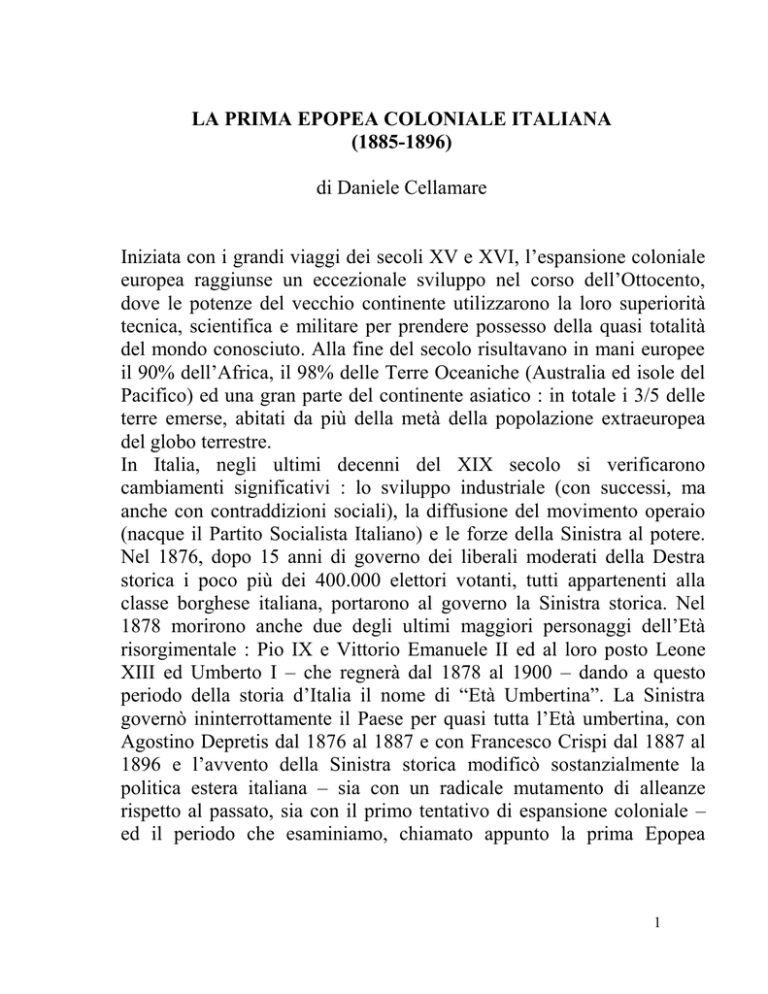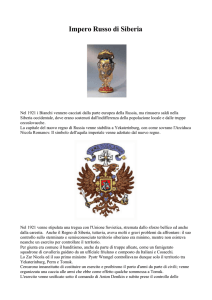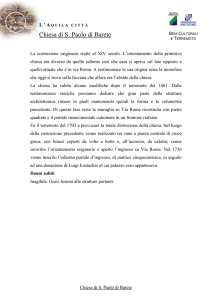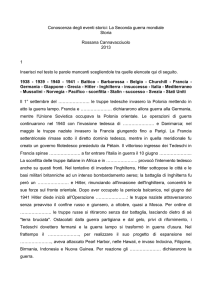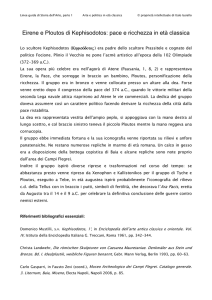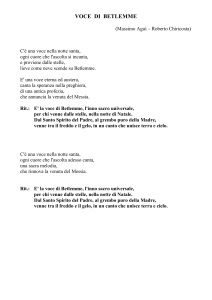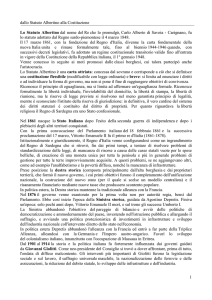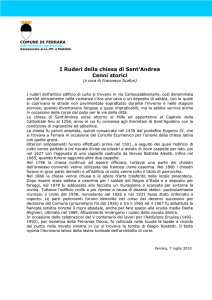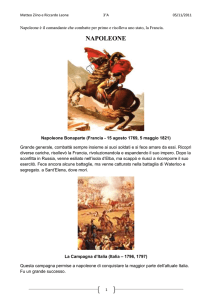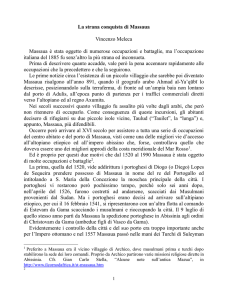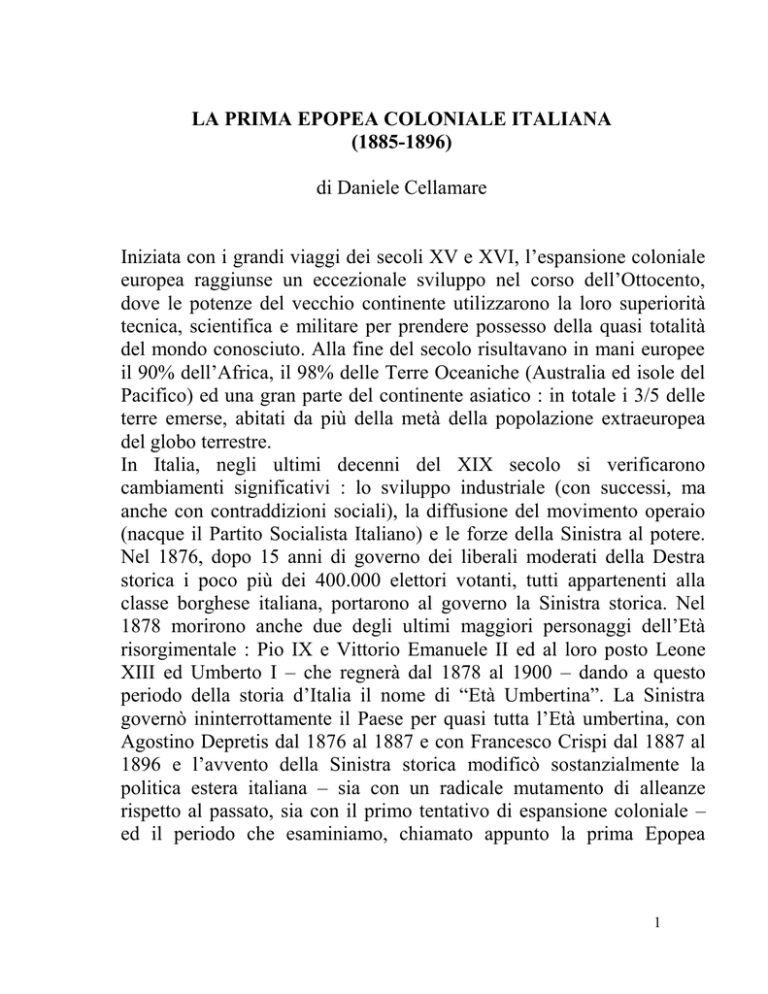
LA PRIMA EPOPEA COLONIALE ITALIANA
(1885-1896)
di Daniele Cellamare
Iniziata con i grandi viaggi dei secoli XV e XVI, l’espansione coloniale
europea raggiunse un eccezionale sviluppo nel corso dell’Ottocento,
dove le potenze del vecchio continente utilizzarono la loro superiorità
tecnica, scientifica e militare per prendere possesso della quasi totalità
del mondo conosciuto. Alla fine del secolo risultavano in mani europee
il 90% dell’Africa, il 98% delle Terre Oceaniche (Australia ed isole del
Pacifico) ed una gran parte del continente asiatico : in totale i 3/5 delle
terre emerse, abitati da più della metà della popolazione extraeuropea
del globo terrestre.
In Italia, negli ultimi decenni del XIX secolo si verificarono
cambiamenti significativi : lo sviluppo industriale (con successi, ma
anche con contraddizioni sociali), la diffusione del movimento operaio
(nacque il Partito Socialista Italiano) e le forze della Sinistra al potere.
Nel 1876, dopo 15 anni di governo dei liberali moderati della Destra
storica i poco più dei 400.000 elettori votanti, tutti appartenenti alla
classe borghese italiana, portarono al governo la Sinistra storica. Nel
1878 morirono anche due degli ultimi maggiori personaggi dell’Età
risorgimentale : Pio IX e Vittorio Emanuele II ed al loro posto Leone
XIII ed Umberto I – che regnerà dal 1878 al 1900 – dando a questo
periodo della storia d’Italia il nome di “Età Umbertina”. La Sinistra
governò ininterrottamente il Paese per quasi tutta l’Età umbertina, con
Agostino Depretis dal 1876 al 1887 e con Francesco Crispi dal 1887 al
1896 e l’avvento della Sinistra storica modificò sostanzialmente la
politica estera italiana – sia con un radicale mutamento di alleanze
rispetto al passato, sia con il primo tentativo di espansione coloniale –
ed il periodo che esaminiamo, chiamato appunto la prima Epopea
1
Coloniale, parte dallo sbarco a Massaua nel 1885, sino alla terribile
disfatta di Adua nel 1896, che determinò la caduta del governo Crispi.
Le premesse storiche, politiche e militari
Nel 1881 la Francia occupò la Tunisia – dove esisteva una forte colonia
siciliana – generando in questo modo una grave tensione nei rapporti
italo-francesi, lì dove esisteva un progetto italiano per imporre il proprio
protettorato coloniale proprio in quella zona del Nord Africa, e nel 1882
l’Italia decise di aderire alla “Triplice Alleanza” (il patto militare
difensivo che impegnava i contraenti a prestarsi reciprocamente aiuto in
caso di aggressione da parte di terzi) con la Germania e con l’Austria,
nonostante il fatto che Vienna fosse ancora considerata, così come dai
tempi di Cavour, il nostro principale nemico. Lo stesso Depretis ed il
Ministro degli Esteri, Mancini, furono contrari a questa alleanza, ma le
forti pressioni esercitate da Umberto I, ammiratore di Bismarck e del
militarismo prussiano, costrinsero il Governo italiano alla firma del
patto, che in ogni caso fece entrare l’Italia, a questo punto a pieno titolo,
nel novero delle grandi potenze.
Sull’esempio di altre nazioni europee, che stavano attuando una politica
di espansione coloniale alla conquista dell’Africa e dell’Asia
(l’Inghilterra stava raggiungendo un vero e proprio impero coloniale,
così come la Francia ed il Belgio si erano lanciate all’accaparramento di
colonie e persino la Germania, nonostante la riluttanza di Bismarck,
stava tentando di conquistare territori liberi in Africa) anche l’Italia si
avventurò sulla strada del Colonialismo ed esplorazioni e missioni in
Africa Orientale vennero effettuate da Guglielmo Massaia, Giuseppe
Sapeto, Orazio Antinori e Romolo Gessi. Nel 1882 il Governo italiano
(sempre con il Ministero Depretis) acquistò da una Compagnia
genovese di navigazione, la “Società Rubattino”, la base marittima di
Assab, in Eritrea, (usata dalla Compagnia come scalo carbonifero per le
proprie navi) con l’obiettivo di farne la testa di ponte per le future
operazioni militari volte alla conquista dell’Abissinia (l’Etiopia di oggi),
2
un paese vastissimo ed impervio, con un ordinamento di tipo feudale su
cui governava una figura di “re imperatore” chiamato Negus.
Il regime politico della regione si era conservato stabile nei secoli,
assumendo appunto un'organizzazione di tipo feudale, con al vertice il
Negus (Imperatore) ed i suoi Ras, ovvero l'aristocrazia terriera e militare
che governava, godendo di molta libertà di azione, le varie province.
Come tutti i regimi feudali, quello del “Leone di Giuda” era
caratterizzato da un assai debole potere centrale e da un equilibrio
alquanto precario, con continue ribellioni e conflitti tra l'imperatore e la
nobiltà, ma in ogni caso capace sempre di rinsaldarsi istantaneamente
quando una minaccia esterna faceva prevalere il fortissimo sentimento
nazionale che accomunava – per tradizione, religione e cultura – popolo
ed aristocrazia terriera. Con il tempo i Ras assunsero una potenza e
un'indipendenza sempre più spiccate finché, nel 1851, deposto
l'imperatore della dinastia salomonica Giovanni V (detto l'Idiota) lo
Stato passò nelle mani di una serie di usurpatori ciascuno dei quali, in
ossequio alla tradizione, reclamava la sua lontana discendenza da
Menelik I, il fondatore. Alle crisi delle endemiche lotte civili interne, si
aggiunsero negli anni Ottanta del secolo i pericoli esterni che
insidiavano la stessa indipendenza etiopica: la calata dei dervisci
musulmani dal Sudan (quello che oggi potremmo definire un
movimento islamico integralista, guidato dal carismatico Mahadi, il
“Profeta”) e la penetrazione coloniale italiana dall'Eritrea.
A questo punto dobbiamo aggiungere che la dinastia imperiale etiopica
affondava le sue radici in un passato talmente remoto da poter essere
definito addirittura "biblico". Secondo la tradizione, il suo fondatore,
Menelik I, sarebbe addirittura nato dagli amori di Salomone e della
regina di Saba, in un periodo che gli storici collocano intorno al 1.000
a.C. (cinque secoli più tardi Erodoto accennò alla presenza di un già
solido impero africano in Etiopia, caratterizzato dalla fiera bellicosità
dei popoli che lo abitavano). La regione fu evangelizzata nel IV secolo
d.C., ma in seguito la Chiesa etiopica seguì l'eresia monofisita di
Eutiche, rompendo così i contatti con Roma e Costantinopoli, per darsi
3
una propria gerarchia ecclesiastica che faceva capo ad una sorta di
pontefice locale detto Labuma. L'adesione alla religione copta rimase
tanto salda e connaturata tra gli etiopi che, pur essendo praticamente
circondati da genti di fede musulmana, si è sempre mantenuta intatta. È
interessante a questo proposito aggiungere anche che lo stesso nome di
Abissinia, con il quale si usò definire il paese, è di origine araba (mentre
Etiopia è di derivazione greca), e derivava dalla tribù yemenita degli
Habashàt, che fusero la propria stirpe semitica con le popolazioni
negroidi originarie.
E quindi le Autorità italiane si trovarono ben presto – come vedremo –
di fronte a due problemi militari: opporsi ai seguaci del Mahadi a NordOvest e penetrare in direzione dell'Abissinia ad Ovest. Il primo
problema sarebbe stato risolto brillantemente nelle quattro successive
vittorie di Agordàt (27 giugno 1890), Serobèti (26 giugno 1892), della
seconda Agordàt (21 dicembre 1893) e di Cassala (17 luglio 1894), ma
l'espansione verso l'entroterra che precedette la campagna contro i
Dervisci portò invece allo scontro fra il più giovane regno d'Europa (35
anni) ed il più antico impero d'Africa (2700 anni). Ma prima di
addentrarci nelle drammatiche vicende della nostra epopea coloniale, è
doveroso aggiungere alcune informazioni sull’esercito che ci inflisse
l’umiliante sconfitta di Adua. Secondo la relazione del Capitano Cecchi
del 1887, l'Impero etiopico era in grado di mettere in campo circa
145.000 guerrieri (estremamente bellicosi) e la chiamata alle armi
avveniva in tutto il paese al suono del “ketit”, che obbligava ogni
gruppo familiare a fornire almeno uno dei propri componenti, che
veniva ripagato durante la campagna militare con derrate alimentari oltre al pasto giornaliero assicurato - lì dove i combattenti più valorosi
potevano anche ricevere donazioni in terre e gradi di maggiore prestigio
nella gerarchia militare. Quindi non esisteva un vero e proprio esercito
nazionale, ma la risultanza di piccoli eserciti locali governati dai
rispettivi Ras, in grado di assumere, all’occorrenza, un’unica e precisa
disposizione tattica, secondo una tradizione – forse arretrata, ma
sicuramente efficace – rimasta inalterata nei secoli. Infatti, durante le
4
marce di spostamento, sia l’esercito nel suo complesso che i singoli
reparti, si muovevano nella stessa formazione che avrebbero
successivamente assunto durante la battaglia, con l’evidente vantaggio
di avere le truppe sempre già “schierate” (ogni singolo uomo occupava
negli spostamenti lo stesso posto a lui destinato nel combattimento) e
pronte quindi a sostenere qualunque scontro in qualunque momento.
Inoltre, l'organizzazione militare degli abissini non prevedeva né
colonne di salmerie né un apparato logistico, ed erano infatti i guerrieri
stessi, con i loro muletti, che si occupavano di trasportare tutto ciò che
occorreva ed oltre ai bagagli, i viveri e le armi, anche tutto il necessario
per la rapida costruzione dell'accampamento imperiale. A tal fine erano
divisi in otto categorie di portatori : dai Kodda, adibiti al trasporto degli
otri per l'acqua, ai Guebbar, per i forni da campo, le lenticchie e la
farina, ai Saten-Ciagn, per il pane già confezionato, sino agli Urari, che
marciavano e combattevano tra le prime file, ed era loro affidata la tenda
dell'imperatore (Adderach) e quella dell'imperatrice (Elfign). Lo
schieramento tipico degli etiopici in battaglia era a croce greca, cioè con
i quattro bracci uguali : il braccio che procedeva in testa, o avanguardia,
era guidato da un alto Ufficiale chiamato Fitaurari, quello che costituiva
l'ala destra era invece comandato dal Cagnazmàcc, quello di sinistra dal
Grazmàcc, ed infine quello posteriore, la retroguardia, dal Mobò. Il
Degiàcc, (Comandante della Porta) era un grado equivalente al nostro
Generale e Ufficiali di grado inferiore erano gli Ieshambél, (Comandanti
dei Mille), i Shambél, (Comandanti dei Duecentocinquanta) ed i
Balambaràs (Capi dei cavalieri armati di corazza). L'esercito abissino
era solito attaccare battaglia all'alba, giudicata l'ora più propizia (e
possibilmente nel giorno di Martedì) ed all’inizio del combattimento il
centro della croce e la retroguardia rimanevano a protezione
dell'Imperatore, dei dignitari e dello”Stato Maggiore”, mentre
l'avanguardia si precipitava all'attacco del nemico, con il contemporaneo
allargamento delle ali per una manovra di avvolgimento.
Il 17 Agosto del 1869, dopo dieci anni di lavori, si inaugurò il Canale di
Suez che mise in comunicazione il Mediterraneo con il Mar Rosso sulle
5
rotte dell' Oriente senza circumnavigare l'Africa. E proprio in quel
periodo, il Prof. Giuseppe Sapeto, Padre Lazzarista ed esploratore,
comprò la baia di Assab in Dancalia per 6.000 talleri austriaci dai locali
capi mussulmani e rientrato in Italia cedette i diritti alla Società di
navigazione Rubattino. Per dieci anni il piccolo presidio dell'attracco
riuscì a convivere pacificamente con le tribù dell'interno senza eccessivi
problemi (eravamo padroni del suolo fisico, ma non del paese politicogeografico) . Da qui partivano le esplorazioni per l'Etiopia e l’Abissinia,
terre ancora sconosciute, dei mercanti alla ricerca di nuovi prodotti da
scambiare. Ma le carovane che si addentravano in questi territori
impervi si scontravano sempre più spesso con bande incontrollate di
predoni. Nel 1882, a seguito dell'ennesimo incidente, il Governo Italiano
decise di assumere oltre che la proprietà, anche la protezione della baia
con l’invio di un plotone di Carabinieri. Ma il 7 Ottobre 1884 i più
importanti giornali dell’epoca, “La Tribuna” (trentamila copie, un vero
successo editoriale), “La Gazzetta di Torino” ed “Il Fischietto”,
riportarono tutti in prima pagina la tragica fine del pioniere esploratore
italiano Gustavo Bianchi che, dopo aver attraversato l’Abissinia da Sud
a Nord ed aver soggiornato nel Tigrè, venne massacrato dalla tribù degli
Aussa sulla via del ritorno (in località Dankali, tra Macallè ed Assab),
mentre marciava con la sua colonna a circa 200 chilometri proprio dal
porto di Assab, dove era diretto.
Tutte le firme più prestigiose inveirono contro l’indifferenza del
Governo chiedendo di vendicare subito l’oltraggio alla bandiera italiana,
con una esemplare punizione ai “selvaggi”, oltre a sventolare
opportunamente anche le argomentazioni politiche adatte a giustificare
l’intervento : “Vedendo che tutte le potenze, anche le secondarie, si
appropriano di qualche grosso boccone di territorio africano senza
render conto a nessuno del loro operato, è ovvio domandare perché la
sola Italia se ne stia con le mani in mano”. Il 1° Gennaio del 1885
apparve sul giornale “Il Diritto”, di ispirazione governativa, un articolo
dove per la prima volta si riportava in maniera diretta la decisione
governativa di intraprendere una precisa politica di espansione
6
coloniale, e fu così che nel mese successivo un esiguo contingente di
soldati italiani sbarcò a Massaua, un piccolo porto nel Mar Rosso, dando
così inizio alla drammatica avventura coloniale italiana, che durerà oltre
mezzo secolo. Contro questa politica espansionistica – sostenuta
principalmente dal freddo ed autoritario Umberto I, dai militari e da una
piccola parte della opinione pubblica borghese – si levarono molte voci
di disapprovazione e di aperta critica. Sella e Minghetti ammonirono il
Governo a non gettare il Paese in pericolose avventure di mero prestigio
e Garibaldi, dalla sua Caprera, espresse la sua avversione contro le
imprese coloniali, dichiarando che “i latifondi e le paludi d’Italia sono i
primi ad aver bisogno di una colonizzazione”. Inoltre, vennero anche
avanzate numerose riserve sull’impiego di denaro e di mezzi necessari
per far fronte alle forti difficoltà dell’impresa, proprio in un periodo in
cui l’Italia non era in grado di permettersi simili dispendi di energie, sia
esse economiche che sociali, ma la spedizione di Massaua venne in ogni
caso approvata con 180 voti a favore e 97 contrari, durante un voto
esplicito di fiducia al Governo chiesto dallo stesso Depretis.
Tra il 1884 ed il 1885, i rappresentanti delle maggiori potenze si
riunirono a Berlino per stabilire le rispettive zone di influenza e le
norme da seguire per l’occupazione dell’intero continente africano,
stabilendo che quando uno Stato avesse occupato una porzione di costa,
era tenuto semplicemente a comunicarlo agli altri, potendo altresì
godere del diritto di penetrare nel territorio interno, fin dove i suoi
interessi non si fossero scontrati con quelli di altri Stati occupanti, e per
questo motivo, e non certo a caso, il Trattato di Berlino venne definito il
“Galateo della Rapina” !
“La potenza che d’ora in poi prenderà possesso di un territorio sulle
coste del continente africano all’infuori dei suoi possedimenti attuali, o
che, non avendone, ancora volesse acquistarne, come pure la potenza
che vi assumerà un protettorato, accompagnerà l’atto relativo con una
notificazione rivolta alle altre potenze firmatarie del presente atto, onde
porle in grado di far valere, se sia il caso, i loro reclami […] le potenze
7
firmatarie dell’atto presente riconoscono l’obbligo di assicurare, nei
territori da esse occupati sulle coste del continente africano, l’esistenza
di una autorità sufficiente a fare rispettare i diritti acquisiti e, ove ne sia
il caso, la libertà di commercio e transito nelle condizioni che fossero
stipulate”. (Articoli 34 e 35)
Alla fine dell’Ottocento la spartizione dell’Africa era ormai compiuta :
l’espansione francese seguì una direttiva orizzontale, da Ovest ad Est
(prima il Senegal, poi il Niger, il lago Ciad ed il Madagascar)
l’espansione inglese seguì invece una direttiva verticale, da Nord a Sud
(Egitto, Rhodesia, Kenia, Uganda, Sudan e Colonia del Capo) la
Germania occupò nel 1884 diverse regioni che andarono a formare i due
nuclei della cosiddetta Africa Tedesca – una occidentale sull’Oceano
Atlantico ed una Orientale sull’Oceano Indiano – i Portoghesi
occuparono l’Angola ed il Mozambico e gli Spagnoli la regione
occidentale del Sahara. L’Italia occupò prima nel 1885 un territorio sul
Mar rosso, poi l’Eritrea, successivamente la Somalia ed infine la Libia
nel 1912, con i tragici risvolti che tutti conosciamo.
Le contraddizioni dello sbarco a Massaua
E fu così che il Colonnello Tancredi Saletta venne raggiunto a Palermo
da un telegramma spedito da Roma alle ore 09.45 del giorno 8 Gennaio
1885 con numero di Protocollo 24 :
“Con lettera spedita ieri a V.S. questo Ministero ha disposto che il
Colonnello Tancredi Saletta si presenti a Roma il 12 corrente essendo
destinato al Comando delle truppe da inviarsi ad Assab. Se ne dà intanto
avviso telegrafico per norma di detto Ufficiale. Pel Ministro Masselli”.
Con questa comunicazione – per certi versi decisamente ambigua –
cominciò l’avventura del nostro colonialismo in Africa, accompagnata
ad un altro telegramma inviato dopo pochi giorni : “[…] gli saranno
somministrati successivamente ordini particolareggiati circa la missione
che gli viene affidata […] con l’aggiunta di non portare cavalli al
seguito, ma solo un attendente ed il bagaglio, in quella misura che
8
reputerà necessaria per il servizio cui è destinato, che potrà essere di non
breve durata”.
In effetti al Colonnello Saletta vennero ufficialmente date istruzioni
affinché venisse assicurato un esito pacifico delle trattative avviate per
la ricerca dei colpevoli dell’eccidio Bianchi – naturalmente con la
salvaguardia del prestigio e della forza dell’autorità italiana – ma in
realtà gli venne affidata l’organizzazione vera e propria di una Colonia :
“Servizio di polizia, un servizio sanitario civile, regolare la questione
della moneta, stabilire l’ordinamento giudiziario amministrativo; i
regolamenti interni e i poteri reciproci sotto il rapporto politico civile,
amministrativo, giudiziario, economico, mantenere una grande
larghezza amministrativa e politica ed una rigorosa tutela dell’ordine,
della sicurezza, della buona fede nei commerci, stabilire la procedura
della giustizia, a seconda delle leggi o musulmane o tradizionali,
mantenere il rispetto alle credenze religiose, ai bisogni, ai rapporti di
famiglia, alle consuetudini non inconciliabili colla moralità universale e
colla piena severa custodia dell’ordine pubblico, definire in maniera
legislativa i rapporti tra gli italiani e gli indigeni, e tra gli indigeni
stessi”.
Assab rappresentava in realtà un caso unico nella storia dell’espansione
coloniale europea : si trattava di una sperduta e desolata baia – nel
territorio dei feroci Dancali – che non era stata conquistata con le armi,
bensì acquistata come abbiamo visto con regolare contratto,
probabilmente con l’intenzione di creare una colonia penale, abbastanza
ampia, per custodire i numerosi, ed altrettanto feroci, briganti del Sud (il
12 Gennaio del 1884, durante una conferenza del “Circolo Africano” di
Napoli, di ispirazione colonialista, si propose di costruire un
penitenziario ad Assab, per affidare ai detenuti i lavori del porto
commerciale, utile per lo sviluppo delle attività italiane in quella zona).
Il testo del contratto, scritto sia in arabo che in italiano, e provvisto di
bolli e ceralacca, così recitava : “Gloria a Dio. Nel giorno nove del mese
dell’heggi dell’anno 1826 secondo l’era musulmana, undici del mese di
marzo 1870 secondo l’era volgare, il sultano Abdallah Sciahim e i
9
sultani Hassam-ben-Ahmad ed Ibrahim-ben-Ahmad da una parte e i
signori Giuseppe Sapeto ed Andrea Ruzzolino, capitano del vapore
“L’Africa”, dall’altra, radunatisi a bordo del vapore medesimo stipulano
il seguente contratto : i suddetti sultani vendono il tratto di paese e di
mare racchiuso fra Rasi Lumah e la gola di mare chiamata Alala e il
monte Gange senza nessun onere di dipendenza da parte dei compratori,
i quali sborsano ai medesimi venditori sopra menzionati il prezzo
convenuto in scudi o talleri di Maria Teresa ottomila e cento”.
Con la prospettiva di un viaggio di 2.000 chilometri e con una
destinazione praticamente ignota, con un Corpo di Spedizione di appena
1.000 soldati (42 Ufficiali e 920 uomini di truppa) e con la prospettiva,
solo intuita, di occupare una località che si trovava sotto la sovranità
dell’Egitto, il Colonnello Saletta scrisse nel suo diario : “Da Sua
Eccellenza il Ministro della Guerra venni a conoscere non essere fuori
da ogni probabilità che cammin facendo per Assab la mia missione non
avesse a mutare obbiettivo e così per esempio avere per iscopo
l’occupazione di Massaua […] ma su questa eventualità non si era in
grado ancora di darmi notizie positive”.
Saletta, che non possedeva nessuna carta topografica della zona, ma
aveva ricevuto la notizia che “risultava che gli egiziani avessero eretto
a Massaua dei forti armati di cannoni Krupp [e pertanto] sbarcando colà
tenesse le artiglierie pronte e alla mano “ commentò che “ conoscendo
io ora soltanto la decisione definitiva presa dal nostro Governo di
occupare Massaua, mi importava di avere le mie artiglierie alla mano.
Pregai per ciò il comandante Delibero del Gottardo di trar profitto dalla
nostra sosta a Suakim per estrarle dalla stiva. Il comandante vi mise la
massima buona volontà e fu presto iniziato il lavoro; ma dopo poco
tempo egli venne costernato da me per dirmi che facevamo un lavoro
inutile, poiché per estrarre le seicento e più tonnellate di carico che
pesavano (imbarcate dopo) sulle artiglierie sarebbero occorsi più di dieci
giorni coi mezzi che si avevano a disposizione “.
10
Anche se le artiglierie risultarono inutilizzabili, in compenso lo Stato
Maggiore, con minuziosa precisione, aveva inviato al Saletta questa
determinazione ministeriale: “Si dispone che gli ufficiali abbiano a
sbarcare con l’uniforme di marcia: elmo completo, cravatta di tessuto
bianco, giubba e pantaloni in tela color bianca, sciabola e sciarpa. È fatta
facoltà agli ufficiali di sostituire al cotone la tela o la flanella bianca. La
giubba sarà ad un sol petto da abbottonarsi nel mezzo, col colletto
diritto, senza mostreggiature e con piccoli taschini sul davanti col
bottoncino centrale all’altezza del terzo bottone. In tutte le altre parti la
foggia della giubba sarà identica a quella prescritta per le varie armi
dell’uniforme di panno conservandone le stellette, i bottoni e i distintivi
di grado”
Le operazioni di imbarco a Napoli si svolsero comunque con regolarità
e un Battaglione di Bersaglieri (800 soldati tratti dal 1°,4°,7° e 8°
Reggimento, al comando del Maggiore Emilio Putti) una Compagnia di
Artiglieria e un Plotone del Genio presero posto sul vapore “Gottardo”,
preso a nolo per l’occasione, che effettuò la traversata molto meglio
della corazzata “Principe Amedeo” che aveva il compito di scortarlo.
Quando alle 22.30 di Martedì 20 Gennaio 1885 il “Gottardo” avvistò il
faro di Damietta, anticamera del Canale di Suez, della nave di scorta si
erano perse le tracce : la “Principe Amedeo” si era ingloriosamente
incagliata davanti al Canale, a Porto Said, e venne precipitosamente
inviata in sostituzione la corazzata “Vespucci”.
Ma alla fine, alle 10.00 del mattino del 5 Febbraio 1885, le nostre navi
approdarono a Massaua. La città – edificata su un’isola corallina vicino
alla costa, e collegata alla terraferma da una lunga diga, appoggiata
anch’essa su un’altra isoletta, di nome Taùlud – contava 5.000 abitanti,
per la maggior parte commercianti arabi e 150 europei, anche se non
tutti in buona salute, ed il numero dei cammelli e degli asini era circa
mille volte superiore a quello della popolazione. Massaua era in
territorio egiziano e l’Egitto (anche se nominalmente ancora sotto la
sovranità dell’impero turco) era anche un protettorato della Corona
11
inglese che a sua volta – considerato il vuoto di potere che si stava
creando nel Mar Rosso e preoccupata dalle intenzioni espansionistiche
della Francia – accettò di buon grado la presenza di una potenza,
considerata “debole” come l’Italia, in un contesto politicamente
complesso e per di più aggravato dalla presenza di truppe e soldati
irregolari di vari paesi.
In ogni caso, nella baia era già alla fonda il vascello inglese “Condor”
ed il comandante Denville, sfoggiando un’ottima conoscenza della
lingua italiana , rese gli onori di casa al nostro Colonnello Saletta. La
prima visita ufficiale venne subito fatta al governatore Izzet Bey e
davanti a lui l’Ammiraglio Caimi – il Comandante della corazzata
“Vespucci” – lesse il telegramma del Governo italiano, dove gli veniva
impartito l’ordine di occupare la città e di alzare la bandiera italiana al
fianco di quella egiziana.
Caimi chiese anche al governatore se avesse ricevuto istruzioni in tal
senso dal suo Governo (?) ma Izzet Bey ammise di non essere a
conoscenza di alcun accordo del genere e si dichiarò pronto ad ordinare
ai suoi soldati di difendere la città. Il diplomatico comandante inglese
Denville, pur di ottenere una soluzione rapida e pacifica, dichiarò che
l’Inghilterra, l’Italia, la Turchia e l’Egitto erano in fase di avanzate
consultazioni, e pertanto sarebbe stato inopportuno e pericoloso far
precipitare la situazione con uno scontro armato. Izzez Bey si ritenne
soddisfatto da tali assicurazioni ed acconsentì a condividere con l’Italia
la sovranità del territorio.
Dopo quattro ore dall’arrivo del “Gottardo” nel porto di Massaua, i
nostri Bersaglieri scesero finalmente a terra per occupare con tutta
tranquillità i punti chiave della città : il forte di Ras Mudur, per il
controllo dei pozzi d’acqua, ed il “Palazzo del Comando”, nel frattempo
evacuato dalle poche truppe egiziane presenti. In questo modo l’Italia
entrò a far parte del novero delle potenze coloniali ed il Colonnello
Saletta non riuscì ad esimersi dal diffondere alla popolazione un solenne
proclama :
12
“Il governo italiano, amico dell’Inghilterra, della Turchia e dell’Egitto,
non meno che dell’Abissinia, mi ha ordinato di procedere
all’occupazione della piazza di Massaua, ciò che avrà effetto oggi. La
bandiera d’Italia sventolerà accanto a quella egiziana; i regi marinai
della flotta e i soldati dell’esercito sbarcati manterranno la più rigorosa
disciplina e pagheranno puntualmente tutti gli acquisti che faranno; i
costumi e la religione vostra saranno da essi scrupolosamente rispettati;
non intralcerò punto i vostri traffici, anzi cercherò di facilitare i
commerci e vi rassicuro circa le benevoli intenzioni del governo
italiano. Trattateci da amici, chè tali siamo, e continuate come per il
passato ad accudire alle vostre usuali occupazioni e ve ne troverete
contenti”.
Nel frattempo Roma, affamata però di successi politici e militari,
consigliò al Colonnello Saletta di avanzare verso l’interno”per far
vedere ai selvaggi la bandiera italiana”.
Al di là delle oggettive perplessità del Comandante Saletta, gli Egiziani
– sempre più allarmati dalla travolgente offensiva del Mahdi in atto in
quei territori – si ritirarono definitivamente dai presidi della colonia e
questo ci obbligò in un certo senso ad allargare la nostra attività
militare, ovvero ad occupare posizioni distanti alcune decine di
chilometri dalla città (i forti di Otumlo e Monkullo, due località
nell'entroterra di Massaua sulla strada di Dogali) per difendere le
carovane dagli assalti dei predoni, non solo provenienti dal Sudan, ma
anche dalla vicina Etiopia (anche se il commercio degli schiavi venne
ufficialmente abolito in Europa con il Congresso di Vienna del 1815,
continuava ad essere ancora praticato in Africa, specialmente ad opera
degli arabi).
Ed in breve tempo ci si rese anche conto che il futuro della Colonia si
sarebbe giocato con questo vicino ingombrante e pericoloso, l’Abissinia,
lo stato più potente e più militarmente organizzato di tutto il continente
africano. Uno stato ambizioso ed arrogante, deciso a preservare la sua
secolare identità cristiana e rodato dalle interminabili lotte contro i
musulmani, che sempre hanno dovuto retrocedere di fronte alle sue
13
immense armate ed alla natura aspra di un territorio capace di
“inghiottire” qualunque invasore.
Solo l’Inghilterra era riuscita a sconfiggere – ma con un dispendio
enorme di uomini, di animali da soma e di risorse economiche per
corrompere le tribù alleate – il Negus Teodoro, che preferì il suicidio
alla resa. Tutto questo, come vedremo più avanti, ingannerà fatalmente
il Governo di Roma.
L’Esercito italiano incontra “Le Teste Matte”
Alle prese con un contingente limitato, e per lo più frammentato lungo
le rotte delle carovane, il comandante Saletta – un soldato sicuramente
dotato di notevole “intuito militare” – il 28 Aprile 1885 inviò un
telegramma al Ministero della Guerra per indicare brillantemente la
soluzione ai problemi militari della spedizione italiana : i 500 BashiBuzuk (la traduzione letterale è “Teste Matte” o “Teste Vuote”) che
risultavano ufficialmente disoccupati dopo il ritiro del presidio egiziano,
sarebbero potuti diventare – anziché un problema – un valido aiuto per
le esigue truppe italiane, gettando così le basi per la creazione del primo
esercito indigeno italiano : “E’ gente fornita di scarso coraggio, che
facilmente può disgregarsi nell’urto di una battaglia […] ma posseggono
talune buone doti delle quali si potrebbe in alcune circostanze trarre
vantaggio. E così per l’abitudine che hanno a resistere al clima, a vivere
di poco, per la conoscenza che molti di loro possiedono della lingua
araba ed anche amarica, per la pratica che essi hanno di queste parti,
potrebbero i migliori tornare a noi utili come guide, esploratori e
interpreti”.
Il basso costo del loro arruolamento – decisamente inferiore a quello
delle truppe italiane – l’ottima conoscenza del territorio (le nostre
mappe erano approssimative ed incomplete), la possibilità di impiego
nei compiti più pesanti e rischiosi e la resistenza alle condizioni
climatiche, convinsero Roma ad accettare questa proposta ed un primo
14
nucleo di 100 “Teste Matte” venne subito reclutato, dopo solo tre mesi
dallo sbarco italiano sulla costa africana, senza sottovalutare il fatto che,
considerando anche il profilo politico dell’operazione, si sarebbe reso
necessario tacitare in Italia chi – avversando l’impresa coloniale –
avrebbe violentemente protestato in caso di perdita di soldati italiani,
prestando invece scarsa attenzione alla sorte riservata a pochi indigeni
“mercenari”.
Anche per la futura campagna di Etiopia, l’Italia arriverà a disporre di
ben 100.000 africani : 60.000 Ascari eritrei, 20.000 Dubat somali e
20.000 Sphais libici.
Il “Contratto” con cui vennero arruolati gli indigeni era quasi identico a
quello stipulato con il precedente Bey, lì dove l’arruolamento, di natura
medioevale, li rendeva immediatamente disponibili ad un passaggio di
padrone. Il governo egiziano forniva loro un fucile ed un cammello e
l’ingaggio era subordinato a una visita medica ed alla presentazione di
un garante, in genere un altro soldato. Il Bey poteva procedere al
licenziamento senza alcuna riserva e senza versare alcuna somma come
buonuscita.
Il Comando italiano procedette al primo arruolamento il 30 Aprile 1885
: concesse l’utilizzo dei vecchi Remington (particolarmente robusti ed
adatti per quella regione) li sottopose alla visita di una commissione
medica (di manica larga) e ne affidò il comando ad un Sangiak che
percepiva uno stipendio di 170 Lire al mese, in cambio della
responsabilità di mantenere l’ordine e di garantire il funzionamento di
quella nuova e turbolenta truppa (il primo comandante fu lo stesso del
Bey egiziano, l’albanese Assan Oga Osman, essendo gli slavi spesso
utilizzati dall’impero ottomano per la loro spartana e bellicosa efficienza
militare).
Nel suo ultimo telegramma, il Colonnello Saletta pose un interessante
interrogativo che Roma preferì però ignorare : “Disprezzo e odio
segreto : parimenti sembrano ammirare l’ordine e la disciplina delle
truppe italiane, ma v’è taluno invece che afferma che al contrario di
quanto all’esterno dimostrano, essi non hanno una grande stima del
15
nostro soldato. Sebbene sia molto difficile scrutare il loro sentimento
sincero sulla nostra occupazione di questa terra, pure è credibile che essi
abbiano in odio la nostra venuta; poiché essi sono musulmani per la
massima parte, sono nemici di chi non professa la religione dell’Islam
ed anzi da alcuni ritenuti partigiani del Mahdi”.
E questo interrogativo – nonostante le continue e ripetute prove di
fedeltà alla nostra Bandiera – accompagnerà mezzo secolo di
convivenza tra le nostre truppe e quelle indigene, durante tutta
l’avventura coloniale italiana. In un primo tempo ai Bashi-Buzuk
vennero affidati compiti di guardia all’ingresso della città e controlli
nelle case di tolleranza (per evitare risse tra i soldati italiani) ma presto
vennero anche utilizzati per le funzioni di scorta alle carovane, compito
ingrato che le nostre truppe regolari non intendevano svolgere :
chilometri da percorrere a piedi e sotto il sole del deserto !
Per questo motivo gli arruolamenti degli “irregolari” aumentarono di
giorno in giorno e le operazioni militari cominciarono lentamente ad
estendersi fuori da Massaua. Fu a questo punto che apparve sulla scena
un personaggio che darà filo da torcere alle truppe italiane, il Ras Alula,
fiduciario del Negus per la regione dell’Hamasen. Dall’alto di Asmara
dominava, come da un nido d’aquila, il bassopiano sottostante e da
tempo scrutava, con crescente sospetto, l’agitarsi dei nuovi intrusi
europei. Alula era un guerriero dotato di grandi qualità, anche se la
memorialistica italiana, ovvero Generali, politici e riviste, rovesciarono
su di lui tonnellate di insulti ed il poeta nazional-popolare di Caltanisetta
– Lizio Bruno – gli dedicò nel 1887, subito dopo la sconfitta di Dogali,
questi versi :
“Ulula Alula, come bestia immane / cui gran rabbia le viscere divora :
ulula Alula, poi che l’ultim’ora / è sonata per te, fetido cane !
Sozzo demone sotto le spoglie umane / Che in notte muti le più belle
aurore
Odi : trafitto il petto avrai fuor fuora / E sarai pasto agli avvoltoi
dimane”
16
Solo Ferdinando Martini, acuto osservatore della nostra avanzata
coloniale, gli dedicò invece un ritratto più problematico, e per certi
aspetti profetico :
“Questo Alula, un tempo falciatore di fieni, oggi Ras e Turk Bascià, che
probabilmente non si curò mai di lasciare traccia di sé nella storia
dell’Etiopia, ne lascerà una nella storia d’Italia”. Intanto a Roma – dopo
la proclamazione dell’annessione di Massaua al Regno d’Italia,
avvenuta ufficialmente il 5 Dicembre 1885 – il nuovo Ministro degli
Esteri, Di Robilant, che cominciava a guardare con fastidio le poche e
timide iniziative militari italiane sul territorio africano, “liquidò” il
Colonnello Saletta trasferendolo senza indugio in India. Al suo posto
arrivò il Generale Genè, decorato con le mostrine di tutte le Campagne
dell’Unità d’Italia e provvisto di una cultura eccezionale, che assunse il
governo civile della Colonia ed avviò la riorganizzazione e la
trasformazione delle nostre prime truppe coloniali, ed il censimento
degli irregolari da lui ordinato, registrò all’attivo oltre un migliaio di
uomini, questo perchè nel frattempo alle “Teste Vuote” si erano
aggiunte due nuove etnie, gli Habab e gli Beni Hamer, tribù del
bassopiano che, pur essendo mussulmane, odiavano anch’essi gli
abissini.
Ora che le truppe indigene sotto la bandiera italiana si erano
numericamente affermate, nacque il problema di sottoporle o meno al
comando di Ufficiali italiani, che ne assicurassero l’inquadramento
tattico ed una ferrea disciplina. Ma il Generale Genè guardò sempre con
diffidenza queste unità che ritenne inaffidabili e pericolose e quindi ne
bocciò l’inquadramento ufficiale proprio in nome delle…buone qualità
dei soggetti (!) “che non hanno certo bisogno di Ufficiali italiani per i
loro compiti ancora essenzialmente esplorativi”.
17
La prima grande ferita: Dogali
Il ministro Di Robilant, puntando sull’appoggio del “vecchio amico”
Menelik, fece forti pressioni sul nostro Generale per una più incisiva
penetrazione militare in Etiopia, dopo che il Generale Giorgio Pozzolini,
inviato dal Governo italiano presso il Negus Giovanni (11 Gennaio
1886) per la “questione Massaua” venne richiamato a fronte dell’ostilità
manifestata dal Negus nei confronti del nostro paese, facendo dirottare
le attenzioni diplomatiche verso il re dello Scioa, Menelik II.
Ma per comprendere meglio la situazione politica che si era venuta a
creare in quella dimentica zona dell’Africa, bisogna ricordare che sin
dall’inizio il Negus Giovanni IV – il successore di Teodoro II, sconfitto
dagli Inglesi a Màgdala nel 1868 – vide con crescente disappunto ed
ostilità l’occupazione italiana di Massaua, anche perché l’Italia, pur
avendo dato assicurazioni formali al Negus circa la sua volontà di non
iniziare una sua espansione in quella zona, di fatto poi aveva proceduto
all’occupazione militare dell’avamposto di Saati. Nel suo intento di
unificare politicamente e religiosamente lo stato, Giovanni IV vide nel
suo maggiore feudatario – il Negus Menelik, che condivideva il titolo
regale con l’Imperatore per l’origine salomonide della dinastia locale –
il suo principale pericolo, a causa dell’amicizia con il missionario
italiano Guglielmo Massaia, tanto da esserne diventato consigliere
personale, e di conseguenza con l’intero Governo italiano.
Nel 1878 Giovanni IV compì una spedizione punitiva contro Menelik,
procedendo anche all’espulsione del missionario Massaia, e legandolo al
suo impero con vincoli di stretto vassallaggio. E fu sempre Giovanni IV
a chiedere, per mezzo del Ras Alula, governatore della regione
dell’Hamasen, confinante con i territori occupati dagli Italiani, lo
sgombero di Saati delle truppe italiane, diffidando al tempo stesso
Menelik dal fiancheggiare in qualunque modo l’occupazione italiana. E
vedendo che gli Italiani, oltre all’occupazione di Saati, perduravano
nella loro avanzata, Ras Alula, dopo aver catturato come prigionieri i
componenti una missione italiana, inviò un ultimatum alle nostre
18
Autorità, iniziando contemporaneamente una marcia verso Saati alla
testa di circa 10.000 uomini. Alula comprese subito che il piccolo
presidio italiano a difesa di Saati aveva rifornimenti sufficienti per
appena due giorni ed attese che una colonna di soccorso, composta da
oltre 500 uomini, si avvicinasse all’avamposto per attaccarla e
distruggerla con 7.000 dei suoi uomini presso la località chiamata
successivamente Dogali : era il 26 Gennaio del 1887 e morirono circa
500 soldati italiani ed altri 82 rimasero feriti, inoltre, per riscattare i
pochi prigionieri fu necessario consegnare in cambio 1000 fucili. Saati
venne subito abbandonata la sera stessa.
Ma vediamo nel dettaglio come si sono svolti gli avvenimenti di Dogali
: gli Italiani, sempre con la scusa di assicurare l’ordine e la tranquillità
delle tribù del bassopiano perseguitate dai “banditi”, occuparono Zula e
Ua-à e scrissero una lettera al Ras giustificando l’operazione come
segno di amicizia verso l’Abissinia, con l’unico scopo di facilitare il
commercio delle carovane. Ma Alula, che gestiva proprio il redditizio
business del saccheggio in quella zona, decise di rapire i membri di una
spedizione italiana che si stava recando dal Negus per portare regali e
giustificazioni. Ed in questa occasione scoprì che due componenti della
delegazione erano militari, e non scienziati, e questo fu sufficiente per
formulare una precisa accusa di spionaggio. Al capo delegazione,
trattenuto in catene, affidò la stesura di un messaggio per il Generale
Genè :
“Tu sei un bell’amico ! Tu porti nel mio paese i soldati per conquistarlo,
tu porti le spie per insegnare la strada ! Da due anni gli Italiani non si
erano mai mossi, appena entrati voi avete occupato Ua-à. Io ti ho detto
di scrivere al Generale Genè perché facesse il piacere di ritirare le
truppe da Ua-à e invece è venuto a occupare anche Saati. Prima di
mozzarvi il capo voglio ancora farvi una grazia. Scrivi al Generale che
se entro tre giorni non si ritira da Saati io taglio la testa a tutti e dopo
vado a fare la guerra contro di lui. Se muoio non me ne importa.”
Ma il Generale Genè rimase convinto che i 3.000 soldati alle sue
dipendenze potessero aver ragione in qualunque momento di un gruppo
19
di predoni e non si preoccupò del pericolo imminente, anche se, a
scanso di ogni preoccupazione, chiese al Ministero l’invio di 600
rinforzi “solo nel caso che dovessero dimostrarsi necessari nel futuro”.
Intanto, nell’avamposto di Saati il Maggiore Boretti rimaneva assestato
con due Compagnie di Fanteria, due cannoni sistemati in piazzole
protette e 300 Bushi-Buzuk, e fu quella la prima volta che truppe
regolari ed indigene si trovarono fianco a fianco in vista di una battaglia
imminente. Vicino al presidio di Saati, a poche ore di marcia, nel forte
di Monkullo, erano accampate altre tre Compagnie di Fanteria, alcuni
pezzi di artiglieria e due “plotoni” di irregolari pronti ad intervenire.
Il 25 Gennaio 1887, Ras Alula decise di iniziare la guerra tra l’Etiopia e
l’Italia ed attaccò il presidio di Saati. Il comandante Boretti riuscì a
tenere la posizione dopo quattro ore di battaglia (decisivo fu l’ordine di
aprire il fuoco a soli 300 metri di distanza dal nemico, che stava
attaccando in formazione compatta) sino a che Alula non decise di
ritirarsi, anche se solo temporaneamente : tra le perdite italiane, il
Tenente Cuomo, due soldati regolari e tre Bashi-Buzuk. Anche se non
conosciamo i nomi dei primi irregolari caduti sotto i vessilli italiani – i
primi di un elenco lunghissimo – in ogni caso, questi soldati dettero
sicuramente una buona prova, resistettero all’urto di truppe
numericamente superiori, non sbandarono sotto il fuoco nemico e, cosa
ancora più importante, non tradirono la nostra Bandiera.
Nel frattempo, il Maggiore Boretti inviò al fortino di Monkullo
un’urgente richiesta di viveri e di munizioni, in previsione di un
imminente nuovo attacco di Alula. Il Ras infatti, non ancora sconfitto,
aleggiava con la sua cavalleria tra le montagne lungo la strada tra
Massaua, Monkullo e Saati. Il mattino seguente, il Colonnello De
Cristoforis, Comandante del forte, organizzò una carovana di cammelli
con i rifornimenti richiesti – e questo comportò in effetti un dispendio di
ore preziose – ma come scorta utilizzò tre Compagnie (500 uomini) di
reclute giovanissime e totalmente inesperte, arrivate da pochi giorni a
Massaua per sostituire le truppe falcidiate dalla dissenteria, dalle febbri
20
malariche e dal tifo. Il Colonnello ignorava anche la geografia del posto
e si avventurò sull’unica pista da lui conosciuta, una stretta gola che
conduceva dal forte a Saati, decidendo di portare con sé, come artiglieria
mobile, due mitragliatrici Gatling, convinto che sarebbero state
sufficienti ad arrestare qualunque impeto nemico. Ma le Gatling,
mitragliatrici “povere”, viaggiavano ancora sulle ruote (come i cannoni)
e raggiungevano al massimo una velocità di tiro di 400 colpi al minuto,
ma solo in dipendenza della rapidità con cui l’artigliere era in grado di
girare la manovella. Circa 40 Bashi-Buzuk completavano la scorta.
La partenza venne decisa all’alba, la pattuglia delle Teste Matte
precedeva di un quarto di chilometro il grosso della colonna e le nostre
truppe, come da regolamento, sfilavano lungo i fianchi dei cammelli e
dei portatori, nelle loro visibilissime divise bianche. Dopo quattro ore di
marcia, torme di abissini comparvero all’improvviso sulle creste delle
colline ed attaccarono la colonna. Il Tenente Comi, a capo degli
Esploratori, ordinò il fuoco per permettere a De Cristoforis di
raggiungere un’altura e piazzare le mitragliatrici in posizione strategica.
Ma i Bashi-Buzuk esaurirono ben presto le poche munizioni in
dotazione e – secondo la ricostruzione della “Commissione di Inchiesta”
istituita dal Generale Genè dopo il disastro – alla loro richiesta di
ulteriori munizioni un Ufficiale italiano rispose che per loro non ce ne
sarebbe state più. In ogni caso, con la copertura del fuoco degli
Esploratori, il Capitano Carlo Michelini, responsabile delle Gatling, ed
il Colonnello De Cristoforis raggiunsero un poggio per verificare la
situazione generale.
Intanto gli abissini – dopo aver imparato la lezione di Saati – non
attaccarono più in maniera compatta, ma realizzano un accerchiamento
sempre più stretto, utilizzando le coperture del terreno e costringendo gli
Italiani a cercare rifugio sopra una collina a fianco del torrente Desset :
il nome di Dogali verrà “rielaborato” in Italia solo successivamente.
Il Colonnello ordinò il fuoco dalla distanza di mille metri con la
speranza di lasciare aperta l’unica via di scampo, la ritirata verso il forte
Monkullo, ma una delle due mitragliatrici si inceppò e nell’altra fu
21
necessario inserire le cartucce a mano una per volta, sino a che si rese
necessario gettarle in un burrone per non lasciarle nelle mani del
nemico. I soldati di Alula, oramai padroni della situazione, sferrarono
l’attacco finale e la strage venne compiuta : i guerrieri del Ras, circa
100.000 uomini (ne perirono un migliaio) lasciarono in vita soltanto
quei soldati che, feriti, furono creduti morti. Il Capitano Michelini, uno
dei pochissimi sopravvissuti, benché ferito in modo grave, così riferì
alla Commissione di Inchiesta : “Appena occupata la nuova posizione,
visto il numero enorme di abissini, circa sette o ottomila, e visto che
eravamo circondati da ogni parte, capimmo perfettamente che per noi
era finita. Durammo più che potemmo e quando moltissimi di noi
furono fuori combattimento, perché morti o feriti, allora Ras Alula battè
il tamburo, segnale dell’attacco, e da tutte le parti si precipitarono con
grandi grida contro di noi che, sopraffatti dal numero, purtroppo
cademmo tutti : 540 di noi ed alcuni Bashi-Buzuk.”
La notizia di Dogali produsse un grande sgomento nell’opinione
pubblica italiana ridestando e diffondendo in vasti ambienti uno stato
d’animo anticolonialista. “Il Corriere della Sera” giudicò una “pazzia”
continuare nell’espansione coloniale e presso il “Consolato Operaio” di
Milano si costituì un comitato per il ritiro delle truppe dall’Africa e
Andrea Costa affermò perentorio che “né un uomo e né un soldo”
doveva ancora essere destinato all’Africa.
In definitiva però Dogali fu un minuscolo, benché tragico, episodio di
guerra coloniale, lì dove Francia ed Inghilterra avevano subito cento
sconfitte analoghe, ma avevano pur sempre proseguito nella loro marcia.
Ma anche se il Risorgimento fu un’epopea esaltante, fu al tempo stesso
privo di importanti successi militari che non fossero dovuti proprio
all’appoggio dell’Inghilterra e della Francia, ed il resto dell’Europa non
ci aveva certo considerato come una grande potenza. Per questi motivi
in Italia la bruciante sconfitta di Dogali (ai caduti venne dedicato a
Roma un Obelisco egiziano commemorativo, di eredità romana, nei
giardini di Via delle Terme di Diocleziano e sempre a Roma venne
intitolata la piazza antistante la Stazione Termini, appunto Piazza dei
22
Cinquecento) venne invece vissuta come uno psicodramma, con la
profonda e usuale frattura tra Destra e Sinistra, tra anticolonialisti –
rassegnazione e rinuncia ad imprese non congeniali ed inutili – e
colonialisti, che nel disastro vedevano una ragione in più per vendicare i
martiri e riprendere la missione civilizzatrice nella selvaggia Africa,
barbara e crudele. Inoltre il Governo non ebbe neppure l'appoggio degli
uomini di cultura: Giosuè Carducci si rifiutò di partecipare ad una
commemorazione dei morti di Dogali e di scrivere un componimento
lirico sui caduti, e D'Annunzio li definì "i quattrocento bruti morti
brutalmente", anche se le solenni messe celebrate nelle Chiese e nelle
Basiliche costituirono uno dei primi segnali di apertura della Chiesa
verso lo Stato italiano. Ma nonostante le accese polemiche, Depretis
chiese ed ottenne dal Parlamento uno stanziamento di 5 milioni di Lire
per inviare soccorsi e uomini in Africa – approvato con 75 voti su 75
presenti – ed il 2 Febbraio 1887 un altro contingente di 800 uomini, a
bordo dell’”Umberto I” salpò per Massaua, ed
un successivo
finanziamento di 20 milioni di Lire venne approvato alla Camera il 30
Giugno successivo (dal Senato l’8 Luglio) con 239 voti favorevoli su
277 deputati presenti, per la costituzione di un Corpo speciale di soldati
volontari da inviare in Africa…la nostra avventura coloniale continuava.
Depretis morì il 29 Luglio del 1887 ed il Re nominò Francesco Crispi,
già forte ed autoritario Ministro dell’ Interno, Presidente del Consiglio.
Crispi rimase in carica, salvo qualche breve interruzione, sino al 1896.
Di carattere duro ed ombroso, fu un ex garibaldino ed un ex
repubblicano, ma diventò monarchico dopo l’Unità d’Italia e la
storiografia moderna gli ha sempre rimproverato un modo
eccessivamente autoritario di governare, spesso con l’accusa di non aver
tenuto in giusta considerazione non solo il Parlamento, ma anche la
stessa opinione pubblica italiana. Ma dopo la strage di Dogali divenne
essenzialmente un tenace sostenitore della politica coloniale, e fece sue
le istanze delle due correnti “africaniste” che premevano sul Governo :
quella dei “militari” che facevano capo al Generale Baratieri e che erano
23
spinti dal problema di salvaguardare il prestigio italiano in Africa ed in
Europa, e quella dei “sociologi” che avevano in Leopoldo Fianchetti la
loro guida, spinti dalla preoccupazione per la sovrappopolazione del
Mezzogiorno e per l’aumento dell’emigrazione, lì dove le colonie
avrebbero potuto rappresentare una speranza di guadagno per molti
italiani colpiti dalla miseria.
Nel 1887 Crispi inviò in Africa il Generale Alessandro Asinari di San
Marzano, con l’incarico di nuovo Comandante delle nostre Forze
militari, con sufficienti uomini ed armi – e grazie al programma di
raddoppiamento della Flotta italiana, promosso dal Ministro della
Marina, Benedetto Brin, anche con cinque nuovi piroscafi –
permettendogli di rioccupare le zone perdute di Dogali e di Saati,
nonostante le proteste del Negus Giovanni che ne reclamava il possesso
in forza di un precedente Trattato stipulato con l’Inghilterra il 3 Giugno
1884. Non accettando quindi la richiesta di riconoscimento del dominio
italiano avanzata dal Generale, le trattative vennero bruscamente
interrotte.
La Colonia Eritrea e la nascita degli Ascari
Il successivo comandante del “Corpo Speciale d’Africa”, giunto a bordo
del piroscafo “Archimede” (come abbiamo visto già nell'Ottobre del
1887 partirono dall'Italia due grossi contingenti, appunto agli ordini del
Generale Di San Marzano, il Corpo Speciale d'Africa ed il Corpo di
Rinforzo – 13.000 uomini e 1.300 quadrupedi – ma pochi mesi dopo il
San Marzano ritornò in patria con buona parte delle truppe e venne
sostituito) fu il Generale Antonio Baldissera, l'unico alto Ufficiale
dell'Esercito che da giovane avesse militato nelle file austriache.
Convinto sostenitore di una maggiore penetrazione italiana in Etiopia –
ristabilì energicamente la situazione militare – entrò subito in contrasto
con il Conte Antonelli, inviato contemporaneamente dal Governo in
“missione speciale” presso Menelik, per cercare solidi punti di
collaborazione politica e militare (Menelik coltivava da anni rapporti di
24
amicizia con le autorità italiane in Eritrea e sembrava il candidato
perfetto per i nostri progetti coloniali) ovvero con l’obiettivo finale di
creare una vera e propria alleanza contro il Negus Giovanni per la
conquista dei territori dell’Etiopia del Nord. E proprio quando l’accordo
sembrava raggiunto (con la cessione di armi e denaro) e Crispi era
pronto a dare il via libera per l’avanzata verso l’Asmara, giunse la
notizia della morte del Negus Giovanni, avvenuta il 10 Marzo 1889 a
Matemma, durante una terribile battaglia - ingaggiata contro i Dervisci,
- che vide anche tutto il suo esercito sconfitto e disperso.
A Giovanni succedette lo stesso Menelik (eletto durante l’assemblea
generale dei Ras, che di solito fondava le proprie decisioni sul potere
militare e sulla capacità di corruzione dei candidati) ed il 2 Maggio del
1889 il Conte Antonelli, con somma soddisfazione, sottoscrisse con il
nuovo Negus il Trattato di Uccialli, firmato a Roma dal Ras Makonnen
– cugino di Menelik – e redatto in due lingue, una aramaica e l’altra
italiana. Oltre al riconoscimento all’Italia del possesso di Cheren e
dell’Asmara, in cambio di un prestito all’Etiopia di 4 milioni di Lire,
l’Articolo 17 del Trattato – articolo di grande importanza politica –
discordava però su un punto fondamentale : mentre nel testo italiano il
Negus affidava esplicitamente all’Italia la rappresentanza del suo Stato
all’estero – il che implicava l’esistenza di un vero e proprio protettorato
italiano – nel testo in aramaico tale rappresentanza rimaneva puramente
facoltativa. In ogni caso, Crispi notificò ai governi stranieri il Trattato,
così come se ci si trovasse in presenza di un effettivo “Protettorato
Italiano”.
Il Generale Baldissera occupò comunque Cheren e l’Asmara il 2 Giugno
1889, senza sparare un solo colpo di fucile e nel frattempo i Sultanati
Somali di Obbia e di Migiurtini accettarono il “Protettorato Italiano” che
venne successivamente esteso anche sulla costa del Benadir. Il successo
italiano, politico diplomatico e militare, sembrò quindi pienamente
raggiunto ed il 5 Gennaio del 1890 un Regio Decreto attribuì ai
possedimenti italiani sul Mar Rosso – un’area vasta circa 110.000 Kmq.
e dopo un certo tergiversare del Governo sui vari appellativi possibili,
25
ed in definitiva il Mar Rosso era chiamato anche Mare Eritreo – il nome
di “Colonia Eritrea”. Posta sotto l’autorità di un Governatore, affiancato
da tre Consiglieri, uno per le finanze, uno per l’agricoltura ed uno per i
lavori pubblici, si stabilì per la Colonia un vero e proprio ordinamento
civile, con un proprio bilancio, ed alle dipendenze del Ministero degli
Esteri con l’esclusione delle competenze previste per i Ministeri della
Guerra e della Marina. Il Comandante superiore dell’Esercito di
Occupazione assunse la carica di Governatore ed il Presidente del
Consiglio dei Ministri – Francesco Crispi – prese personalmente la
guida della politica coloniale.
Intanto il Generale Baldissera, sicuramente consapevole dell’importanza
del nuovo assetto politico nella regione, effettuò riforme fondamentali
nell’Esercito Italiano in terra d’Africa. Per prima cosa gli Ufficiali ed i
Sottufficiali italiani dovevano essere scelti tra coloro che concepivano la
Colonia come un’opportunità di vita e di ascesa professionale, e non più
vecchi Ufficiali senza ambizioni, o peggio ancora giovani Ufficiali
desiderosi di facile “esotismo” (con il nuovo casco in sughero e la fresca
uniforme in tela, erano soliti unirsi con uno pseudo-matrimonio ad una
“madama” del posto) se non addirittura “scarti” di Reggimenti operativi
in Italia. E dopo la scelta, le selezioni severissime, sia sotto il profilo
fisico che culturale, l’obbligo di imparare la lingua araba e la verifica
della capacità di adattamento alla diversa mentalità della popolazione.
Ferma minima di almeno quattro anni e stipendi più elevati per attirare
in Colonia gli elementi migliori. Anche le Teste Matte vennero
trasformate, da irregolari a pagamento, in un effettivo corpo coloniale,
con uniformi e bandiere, denominati da oggi in poi Ascari. I nuovi
arruolati vennero inseriti in Buluk, piccole squadre omogenee, e poi
organizzati in Halai (Battaglioni, formati ciascuno da tre Compagnie)
con la precisa intenzione di formare, e di controllare, una vera e propria
catena di comando. I Sottufficiali italiani diventarono “Istruttori” – e
quindi non dovevano rispondere gerarchicamente al Comandante
26
“indigeno” del Battaglione – e vennero anche esentati dal saluto al
Superiore, pur svolgendo compiti di comando su unità inferiori.
Gli Ascari entrarono ufficialmente a far parte dell’Esercito Italiano con
un Regio Decreto dell’11 Dicembre 1892, agli ordini del Colonnello
Avogadro di Vigliano. L’organico delle truppe comprendeva quattro
Battaglioni di Fanteria che si distinguevano per il colore dei fiocchi
della fascia da cui era avvolta una semplice ed elegante uniforme bianca
: il Primo Reggimento aveva il colore rosso, il Secondo l’azzurro, il
Terzo il cremisi (Maggiore Galliano) ed il Quarto il nero (Maggiore
Toselli). Ai quattro Battaglioni di Fanteria si affiancarono due
Squadroni di Cavalleria, denominati Asmara e Cheren, e due Batterie da
Montagna.
La divisa aveva comunque un suo fascino : la “fascia” svolgeva infinite
funzioni, teneva ferma l’uniforme, permetteva di infilarci pugnali e
pistole, e costituiva una prima garza per le medicazioni delle ferite ed
infine una coperta leggera in caso di necessità. Il “tarbusc”, il copricapo
a forma troncoconica, era rosso, imponente e decorativo, richiamava il
Fez dell’amministrazione egiziana e conferiva prestigio a chi lo indossa,
con conseguente gratificazione personale. La divisa stessa risultava
semplice ed elegante al tempo stesso nel suo colore bianco (e tale resterà
sino all’introduzione della mimetizzazione) composta di materiale
indigeno, abbondante e poco costoso, con il vantaggio di poter essere
cucito e riparato facilmente dalle donne del campo.
La ferma minima era di 1 anno, ma gli Ascari si potevano “raffermare”
sino a 30 anni, a 35 i Caporali ed a 45 i Sergenti. A Massaua venne
anche istituita una “Scuola Allievi Sottufficiali” dove venivano ammessi
ragazzi e giovani tra i 15 ed i 20 anni. L’italiano, naturalmente, era la
lingua obbligatoria. La possibilità di avere al seguito la propria famiglia,
ottenne il risultato di rafforzare la tendenza all’arruolamento. Le donne
provvedevano a tutte le funzioni del campo ed assistevano anche le
truppe durante le marce di spostamento, lasciando ai mariti il solo
compito di fare la guerra e di portare a casa la paga. Tutto questo favorì
ben presto un vero e proprio arruolamento “generazionale”: padri, figli e
27
nipoti si tramandarono il “mestiere” di Ascari, professionisti della
guerra legati ad una tradizione di fedeltà e di coraggio. Nacquero dei
veri e propri campi-famiglia chiamati Senfer, organizzati e suddivisi in
Tukul, un pagliaio largo alla base due metri e mezzo ed alto poco meno
di 2 metri. Il campo era pur sempre un insediamento militare e pertanto
rigorosamente regolamentato : a carico dell’amministrazione militare
italiana c’era la distribuzione del cibo e la cura dell’approvvigionamento
dell’acqua. Le visite dei parenti più lontani erano limitate negli orari e
nella durata, al fine di evitare la tendenza ad una permanenza stabile di
un enorme nucleo familiare. Un soldato semplice guadagnava una 1 Lira
e 60 Centesimi al giorno, un Caporale 2 Lire e 70 ed un Sergente
arrivava sino a 5 Lire al giorno. Inoltre, ogni soldato riceveva come
premio di ingaggio 50 Lire per il corredo, ma per il graduato il premio
arriva a 150 Lire perché rimaneva a suo carico la cavalcatura, sia stata
essa un cavallo o un muletto.
Abbiamo accennato ai due Squadroni di Cavalleria, Asmara e Cheren,
ovvero alle “Penne di falco” (il nome deriva dalla vistosa penna di falco
che ornava il tarbusc rosso, impreziosito anche da un importante fregio
metallico applicato sopra una fascia ornamentale multicolore) che sono
rimaste, nella nostra Storia militare, il più famoso Corpo di Cavalleria
indigena italiana. Anche se nel 1885 venne inviato a Massaua un
plotone del 17° Reggimento di Cavalleria “Caserta” e due anni più tardi
vennero costituiti – alle dipendenze del Comando Truppe d’Africa – il
1° Squadrone di Cavalleria ”Africa” ed uno Squadrone di “Cacciatori a
Cavallo”, il Comando italiano in Eritrea non ebbe mai a disposizione
consistenti truppe montate. Il reparto delle “Penne di falco” venne
inizialmente arruolato (Generale Di San Marzano, 1887) con limitati
compiti di esplorazione a causa del suo carattere irregolare – una vera e
propria “banda a cavallo” – sino a che nell’anno successivo, con la
formazione di una truppa indigena al comando di Ufficiali italiani, non
assunse la tipica fisionomia delle Unità coloniali dell’epoca, e raggiunse
nel 1890 un tale aumento di organici da comportare la divisione in due
Squadroni, appunto il Cheren e l’Asmara, anche se quest’ultimo venne
28
sciolto quattro anni più tardi. Anche qui è interessante notare
l’equipaggiamento eterogeneo del Cavaliere indigeno : sciabola locale
(“guradè”), coltello a lama larga e ricurva (combattimento ravvicinato) e
lancia in bambù di tipo egiziano (solo per cerimonie e parate). I primi
fucili assegnati furono le carabine Wetterly, successivamente sostituite
dal Moschetto 91, con fodero di cuoio e portato sul lato destro della
cavalcatura, insieme al revolver italiano d’ordinanza, Modello 1874 con
calibro da 10,35 mm. L’uniforme, anch’essa bianca, prevedeva la
tradizionale ed ampia fascia da portare in vita (di colore rosso per il
Cheren e scozzese per l’Asmara) per accogliere le munizioni in
dotazione ed il pugnale. Anche se la bandoliera e le giberne in cuoio
erano quelle in dotazione alla Cavalleria italiana, rimanevano elementi
fortemente caratterizzanti i gambali di cuoio con abbottonatura laterale –
portati senza calzature (!) – ed i gradi molto vistosi cuciti sulle maniche.
Durante la battaglia di Agordat (1894) le “Penne di falco” si distinsero
nei combattimenti e contribuirono valorosamente alla vittoria italiana
contro i Dervisci. Nel successivo scontro di Cassala (in Sudan) lo
Squadrone Cheren, al comando del Capitano Carchidio, venne
accerchiato da un gruppo di Cavalieri dervisci, di numero decisamente
superiore, e la carica effettuata dai nostri indigeni, con la copertura di un
plotone smontato, riuscì a mettere in fugo il nemico, ma al costo di 27
perdite, tra cui lo stesso Comandante che – trafitto da undici colpi di
lancia – ottenne alla memoria la Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Le complesse vicende di Amba Alagi e Macallè
Il successore di Baldissera, il Generale Orero, era fermamente deciso ad
agguantare un obiettivo di prestigio, e le sue mire si concentrarono su
Adua, la capitale del Tigrè. Nonostante le forti perplessità di Crispi (il
Ras Alula aleggiava sempre con le sue truppe sull’altopiano) Orero
occupò la città – centro di una fitta rete di commerci e forte di una
popolazione di oltre 10.000 abitanti – senza incontrare alcuna resistenza.
29
Ma nel frattempo tutto l’Islam era in subbuglio. Il “profeta” Mohamed
Ahmed predicava a milioni di fedeli dalla sua isola di Abba, sul Nilo,
240 chilometri a sud di Khartum, spiegando che i popoli del vero
Profeta erano stati ridotti in miseria per colpa delle potenze occidentali e
del “traditore” Egitto, mussulmano a parole, ma di fatto amico dei
Cristiani, i veri nemici di Allah. Anche lui era un Dervish, ovvero un
mendicante (la parola persiana indica un ordine religioso, anche se
totalmente privo di regole) ed anche lui vestiva una toga bianca, simbolo
di povertà, a cui venivano applicate pezze di stoffa colorata, a volte per
seguire un ordine simbolico, a volte per semplice vezzo. In ogni caso, il
nuovo Mahdi acquistò rapidamente potere e prestigio, nel Sudan e nel
resto del mondo islamico.
Come se non bastasse, l’equivoco del Trattato di Uccialli non tardò a
venire alla ribalta : Menelik, incoronato Imperatore, aveva notificato
l’avvenimento ai governi europei senza servirsi della mediazione
italiana e dichiarando espressamente di non accettare il protettorato
italiano. Inutili risultarono anche le proteste e i tentativi di mediazione
di Antonelli : Menelik era realmente intenzionato a ridimensionare i
confini dei possedimenti italiani e le trattative vennero bruscamente
interrotte con l’invito alla delegazione italiana di lasciare
immediatamente il paese. Roma intuì subito le insidie ed i pericoli del
nuovo contesto politico (non erano neanche da escludere possibili
finanziamenti russi e francesi a Menelik per indebolire la Triplice
Alleanza con una sconfitta italiana in Africa) ed il Generale Oreste
Baratieri venne nominato nel 1892 Governatore dell’Eritrea,
concentrando nelle sue mani – insieme al Maggiore Salsa, suo
“onnipotente” Capo di Stato Maggiore – tutto il potere politico e
militare. A loro spettò il compito di prepararsi alla grande “partita” da
giocare con il Re dei Re, il Negus Menelik, a capo di un esercito
immenso e ben motivato, con oltre 100.000 uomini, gran parte dei quali
armati con buoni fucili ed artiglieria leggera. Per contro, le forze italiane
risultavano decisamente insufficienti : 150 Ufficiali e poco meno di
mille soldati nazionali, 35 Ufficiali e meno di settemila Ascari, 1.500
30
uomini delle truppe irregolari, 1.200 muletti e 200 cammelli. Gli altri
soldati italiani (2.000 nazionali e 3.000 indigeni) erano impegnati nel
presidio del Nord (Cassala e Cheren) per fronteggiare le numerose e
pericolose incursioni dei Dervisci.
In realtà, l’Eritrea era diventata troppo grande per le nostre forze : da
Cassala ad Adua la frontiera correva lungo 600 chilometri di montagne
e solo la regione del Tigrè era stimata quattro volte più grande
dell’Italia. Come se non bastasse, un telegramma di Crispi (5 Aprile
1895) informò il Generale Baratieri che il Ministro del Tesoro, Sidney
Sonnino, aveva rifiutato di affrontare nuove spese militari, in vista delle
prossime elezioni politiche del 26 Maggio, limitando il “bilancio”
dell’Eritrea agli iniziali 9 milioni di Lire.
Il ritorno di Baratieri in Italia – rieletto alla Camera – venne accolto con
grandi festeggiamenti il 25 Luglio nel porto di Brindisi e prima del suo
rientro in Africa il 26 Settembre, Il Governatore dell’Eritrea riuscì ad
ottenere un aumento di 3 milioni di Lire sul bilancio della sua
Colonia…ma l’anno 1895 non era ancora concluso.
Amba Alagi, 7 Dicembre 1895. Il Maggiore Toselli, comandante del
Quarto Ascari – quelli con la fascia nera – era schierato sulla rupe
dell’Amba Alagi con 2.300 uomini. Gli erano giunte voci che non
lontano dalla sua postazione si stava concentrando il grosso delle truppe
abissine e decise di inviare i suoi Ascari per una ricognizione
esplorativa.
Travestendosi da mendicanti, le nostre forze indigene entrarono in un
accampamento di avanguardia e riuscirono ad apprendere che proprio lì
era in arrivo l’esercito del Ras Makonnen, con 40.000 uomini, tra i più
disciplinati ed efficienti di tutto l’esercito abissino. Toselli decise di
iniziare freneticamente le fortificazioni (si trovava a 74 chilometri da
Adigrat) per assicurarsi la strada della ritirata, convinto che presto
sarebbe arrivato l’ordine di sganciarsi dall’avamposto e di unirsi al
grosso delle truppe, accampato appunto ad Adigrat, sotto il comando del
Colonnello Arimondi, anche lui convinto sostenitore di un’avanzata
31
militare diretta contro Menelik, ed in ampio e perenne disaccordo con
Baratieri. Toselli comprese subito che rimanere fermo con i suoi pochi
uomini, mentre i fuochi sempre più numerosi degli accampamenti del
nemico brillavano a poco più di mezz’ora di marcia, voleva dire morte
sicura. Inviò numerosi messaggi ad Arimondi, l’ultimo dei quali fu un
vero e proprio appello disperato : o l’arrivo dei rinforzi subito o l’ordine
di ritirare le truppe lungo una retrovia, per il momento ancora libera.
Arimondi, benché abbia già ricevuto l’ordine di Barattieri di concentrare
le truppe (e quindi anche gli uomini di Toselli) per prepararsi ad una
difesa compatta, decise di effettuare un’azione limitata in soccorso di
Toselli, con il possibile, e tragico, risultato di disperdere ancora di più le
sue forze, già piuttosto esigue. Telegrafando al suo Superiore le sue
intenzioni, ricevette un secco rifiuto e l’ordine di trasmettere subito a
Toselli la ritirata immediata da Macallè. Ma il Generale non trasmise
subito l’ordine a Toselli e attraverso un furioso conversare telegrafico
con Barattieri, continuò ad insistere sul suo progetto di un’avanzata
generale. Barattieri si lasciò convincere ed alla fine autorizzò l’avanzata
solo sino ad una posizione intermedia tra Macallè ed Amba Alagi al solo
fine di sostenere la ritirata di Toselli : ma il Generale non seppe che
quest’ordine non venne mai impartito ! E fu così che passarono 12 ore,
ore importanti che permisero agli Abissini di avvicinarsi e circondare
con tutta tranquillità gli Ascari del Maggiore Toselli. Arimondi, pur
avendo dichiarato al Governatore di essere pronto a partire all’alba, si
mosse in realtà soltanto alle 23.30 (in piena notte) con 3.000 uomini ed
una sola sezione di artiglieria : questo ritardo condannerà
definitivamente Toselli ed i suoi uomini.
Il massacro iniziò alle 6.30 del mattino : il primo assalto venne portato
da 12.000 uomini. Toselli, ancora convinto dell’arrivo di Arimondi,
inviò tre volte il suo Aiutante di Campo, Capitano Bodrero, a controllare
se si fosse vista, almeno in lontananza, la colonna dei soldati italiani. La
successiva testimonianza di Bodrero al proposito fu molto chiara :
“Toselli si impegnò nel combattimento credendo di essere soccorso. Gli
avvisi di retrocedere del Generale Arimondi non pervennero […] dopo
32
le 11.00 il Maggiore dubitò che la colonna potesse arrivare in tempo
[…] deve essere stata attaccata per via – mi disse”. Dopo oltre sei ore di
dura battaglia, la situazione era ormai completamente compromessa e la
strage venne perpetrata. Ancora il Capitano Bodrero :
“Il nemico si era avvicinato a pochi passi e sparava su di noi senza posa.
Il Capitano Angherà, colpito al petto, cadde e più non si rialzò. Poco
dopo cadevano Persico e Canovetti. Il fuoco continuava senza respiro.
Giungemmo ai piedi del colle sfiniti. Ma Toselli non era ancora vinto.
Perdiamo in questo momento - mi diceva - quando un po’ di resistenza
potrebbe dar tempo al Generale Arimondi di prendere i nemici alle
spalle o al fianco. Tu Bodrero và incontro al Generale e digli di prendere
posizione a Bet Mariam. In questo modo potremo salvare un buon
numero di soldati. Ormai non ci resta più che diminuire il disastro – “.
Un’altra testimonianza, quella di un capo al seguito del Ras Makonnen,
ci ha fatto comprendere l’eroismo ed il sacrificio di Toselli :
“Trovammo il Maggiore Toselli a poca distanza dallo strettissimo
sentiero che conduce nella valle del Togorà; era colpito da una palla che
gli aveva trapassato il torace da parte a parte, da una sciabolata alla
guancia destra e da un’altra al collo dalla parte sinistra, e nel corpo
aveva molte ferite di arma bianca : era già stato denudato e mutilato, ma
aveva ancora i guanti alle mani. Il Maggiore, per ordine di Ras
Makonnen, fu trasportato sopra una lettiga di frasche nella vicina chiesa
di Beil Mariam. E al mattino seguente fu sepolto. Io stesso portai il mio
pugno di terra e la mia pietra per colmare la bara e così fecero tutti i Ras
sull’esempio di Makonnen”.
Il Tenente Pagella, il Tenente Bazzani ed il Capitano Bodrero furono gli
unici Ufficiali superstiti, oltre ad un esiguo pugno di Ascari.
Intanto la colonna di Arimondi venne effettivamente attaccata dalla
Cavalleria del Ras, comandata personalmente da Alula – sempre l’ex
signore di Asmara che voleva riprendersi la rivincita per la capitale
rubata dagli Italiani. Arimondi, anche se a fatica, riuscì a ripiegare e
dopo 4 giorni di marcia decise di assestarsi temporaneamente nel
33
presidio di Macallè. Lasciò come guarnigione tre Compagnie di indigeni
al comando del Maggiore Galliano e si ritirò verso Adigrat.
Per affrontare la marea dilagante di 30.000 abissini in marcia verso
Macallè, ancora eccitati dopo le feste selvagge per la vittoria di Amba
Alagi, rimasero soltanto 21 Ufficiali, 170 soldati italiani e circa 1.000
Ascari.
Galliano capì subito la situazione e l’annotò sul suo diario : “Sono certo
che il Generale Arimondi quando mi ha lasciato qui, oltre che sul
soldato, ha contato molto sull’amico, poiché egli sapeva benissimo in
quali condizioni mi lasciava, e sapeva anche che io non avrei opposto
difficoltà per quanto conoscessi perfettamente tutta la gravità della mia
posizione. Era necessario che Macallè arrestasse per qualche tempo
l’orda inseguente a costo di sacrificarsi, e ho accettato serenamente
l’incarico, fidente nelle mie buone idee di soldato, nella buona stella
d’Italia, che continua a rifulgere di splendida luce e nella cooperazione
di splendidi Ufficiali che accettarono con entusiasmo il loro destino, e
mi fanno orgoglioso di comandarli”. Un’altra Amba Alagi sembrava
delinearsi all’orizzonte.
Le truppe di Makonnen – che costituivano pur sempre l’avanguardia
dell’immenso esercito di Menelik – arrivarono sotto le fortificazioni di
Macallè ed il Ras iniziò una serie di trattative con Galliani, che accettò
naturalmente di buon grado : scambi di plenipotenziari, invio di
proposte e controproposte. In ogni caso, giorni che trascorsero senza
combattere, e con la speranza di avere nel frattempo da Adigrat notizie o
rinforzi, che però non giunsero mai. Poiché le linee telegrafiche erano
state tagliate, Galliano fu costretto ad utilizzare corrieri Ascari per
inviare messaggi ad Arimondi, ma Adigrat distava ben 200 chilometri
(!) lungo una strada tortuosa e controllata dagli uomini di Makonnen. In
realtà il Ras stava solo aspettando l’arrivo del Re dei Re, ed appena la
grande tenda rossa del Negus Menelik venne issata, inviò un biglietto a
Galliano : “Non sono venuto a fare la guerra ad un piccolo forte come
quello che tu comandi; noi siamo in molti e non abbiamo paura dei
vostri cannoni. Ricordatevi di Amba Alagi, non spargiamo altro sangue
34
inutilmente; io penserò a farti accompagnare fino a Massaua e a
mandare colà i tuoi bagagli.”
Galliano, sospinto da sano orgoglio militare e forse ancora illuso sui
soccorsi di Arimondi, rispose con fermezza : “Io resto dove sono, se
vuoi avere il forte e i bagagli vieni a prenderli che sarai ricevuto a
cannonate”. Makonnen reagì iniziando l’assalto con 60.000 uomini,
equipaggiati con buoni fucili Remington e con quattro cannoni provvisti
di una gittata di oltre 4 chilometri, superiore a quella degli italiani. Il
primo assalto venne faticosamente respinto, ma gli Etiopi riuscirono ad
avere la meglio sul presidio che difendeva l’unica fonte di
approvvigionamento idrico, distante 500 metri fuori dalla cintura
fortificata di Macallè. Galliano non aveva uomini sufficienti per tentare
una riconquista disperata dell’acqua e la situazione precipitò
drammaticamente : le razioni furono ridotte ad un litro ogni sette soldati
e per risparmiare ogni goccia si praticò un foro nel turacciolo della
borraccia, da dove attingere con molta parsimonia. Intanto gli Abissini
si limitarono a pochi attacchi, in genere notturni, forse con lo scopo di
fiaccare ulteriormente il morale degli uomini, mentre Galliano
continuava ad inviare messaggi disperati con richieste di aiuto : ma né
Baratieri, che nel frattempo aveva sgomberato frettolosamente Adua, e
né Arimondi risposero ad una sola di queste richieste di soccorso.
A questo punto entrò in scena – in un contesto politico rimasto ancora
oggi non chiarito – un personaggio ambiguo, Pietro Felter, un trafficante
amico del Ras Makonnen e del Negus Menelik. Dopo un mese di
assedio e di sofferenze dovute alle sete, alle ferite di arma da fuoco e
dalle malattie, Galliano ricevette un parlamentare italiano che gli
recapitò una lettera a firma del Governatore Baratieri : “D’ordine di Sua
Maestà il Re d’Italia, vostra signoria cederà il forte di Macallè al Negus
di Abissinia. Il cavaliere Pietro Felter è incaricato di trattare con il
Negus le modalità dell’evacuazione. Il presidio uscirà con gli onori
militari, con armi e bagaglio e con quell’altro che la signoria vostra
crederà di trasportare”. Sembra che Galliano mormorasse “Povera
Italia” e gli altri Ufficiali tra le lacrime non riuscirono a comprendere il
35
motivo di quella umiliazione, ovvero di quella inspiegabile motivazione
: il capitolo finale avrebbe dovuto essere o l’apoteosi della liberazione o
la celebrazione del sacrificio collettivo, ma non una umiliante resa, per
altro anche “ordinata”.
Non esistono documenti ufficiali, ma sembra che la libertà del presidio
sia stata comprata a suon di milioni di Lire da Felter, su ordine del Re
Umberto che non intendeva più tollerare ulteriori umiliazioni
all’Esercito Italiano.
In ogni caso, la bandiera italiana venne ammainata ed al suo posto
sventolò la bandiera di Makonnen : gialla, azzurra e rossa.
Era il 20 Gennaio del 1896 e mancano solo quaranta giorni ad Adua !
L’errore fatale: la battaglia di Adua
Il 28 febbraio 1896 giunse al Governatore Baratieri un telegramma di
Crispi :
“Codesta è una tisi militare, non una guerra; piccole scaramucce nelle
quali ci troviamo sempre inferiori di numero al nemico; sciupio di
eroismo senza successo. Non ho consigli da dare, perché non sono sul
posto, ma constato che la campagna è condotta senza alcun piano
prestabilito, e io vorrei che ve ne fosse uno. Siamo pronti ad ogni
sacrificio per salvare l’onore dell’esercito e il prestigio della
monarchia”.
Quindi la posta in gioco era importante: l’Esercito e la Monarchia! E
Crispi, senza indugiare alla diplomazia, aveva ordinato una vittoria da
conseguire a tutti i costi. La decisone da prendere era effettivamente
difficile : dare in ogni caso una risposta “esauriente”. A questo punto è
doveroso aggiungere che non è stato mai chiarito se Baratieri fosse al
corrente della sua sostituzione, avvenuta quattro giorni prima, con il
nuovo Governatore Baldissera, che già si era imbarcato sotto falso nome
su un piroscafo inglese in partenza da Brindisi. In ogni caso, Baratieri
era in quel periodo un uomo molto malato : aveva febbri continue e non
riusciva a mangiare, e molto spesso era costretto a cedere il Comando
36
per giorni interi. Su di lui gravava comunque la responsabilità di 20.000
uomini, Italiani ed Ascari, accampati sui colli di Sauria, ed inoltre una
serie di “pubblici” rimproveri : la fine di Toselli, il rischio corso con
Galliano e la paura di affrontare Menelik (per questi motivi venne
effettivamente vietato negli accampamenti la diffusione dei giornali,
perché pieni di articoli incendiari contro il Baratieri ed il Governo che lo
appoggiava). In questo stato di prostrazione, Baratieri decise di adottare
una procedura militare senza precedenti, e forse anche al di fuori del
Regolamento, chiese consiglio ai suoi Generali : il Governatore di
Eritrea, Tenente Generale Oreste Baratieri, il Capo di Stato Maggiore,
Tenente Colonnello Gioacchino Valenzano, il Sottocapo di Stato
Maggiore, Maggiore Tommaso Salsa, il Generale Giuseppe Arimondi
(1° Brigata Fanteria), il Generale Vittorio Dabormida (2° Brigata
Fanteria), il Generale Giuseppe Ellena (3° Brigata Fanteria) ed il
Generale Matteo Francesco Albertone (Brigata Indigeni).
Ma lo Stato Maggiore di Baratieri era composto da Ufficiali giunti da
poco in Colonia e sicuramente privi di quell’esperienza necessaria per
muoversi in una situazione così difficile e delicata, ed inoltre i veleni,
anche all’interno del gruppo, non mancano di certo. Il Generale
Arimondi – tenacemente convinto della necessità di attaccare sempre ed
a qualunque costo – riuscì ad entusiasmare, con un discorso
appassionato, gli altri Ufficiali sulla necessità dell’intervento diretto,
sopravvalutando le nostre capacità e sottovalutando quelle del nemico.
Baratieri decise quindi per una “ricognizione offensiva” (!), una sorta di
compromesso tra un atteggiamento offensivo ed uno difensivo. Alla
fine, Baratieri decise di effettuare un limitato balzo in avanti, una
dimostrazione di forza che implicasse il minor rischio possibile. Il
Corpo d'Operazione avrebbe occupato la linea delle alture dominanti la
conca di Adua, dove si sapeva accampato l'esercito del Negus, per
provocarlo a battaglia. Se il nemico avesse “abboccato all’amo”, il suo
attacco era destinato a fallire contro il fuoco concentrato dei nostri
cannoni e dei nostri fucili. Se invece non si fosse mosso, era sempre
possibile ripiegare sulle posizioni di partenza. E’ doveroso però
37
aggiungere che presumibilmente lo stesso Menelik, dopo Amba Alagi e
Macallè, preferì non saggiare la capacità di resistenza italiana e scelse di
marciare verso Adua. Questa manovra, erroneamente interpretata come
un segno di debolezza, accompagnata dalle notizie che l'esercito
imperiale era in difficoltà di approvvigionamenti generò purtroppo un
facile ottimismo nel Comando italiano: così, mentre gli abissini ci
stimavano giustamente dei forti avversari ed applicavano la classica
tattica dilazionatoria di attirarci in profondità nei loro territori per
allontanarci dai rifornimenti e dalla posizioni fortificate, governo e
militari credettero invece che fosse giunto il momento di far conoscere
al Negus la superiorità delle armi e dei soldati italiani. Nel Gennaio
1896 Baratieri, nonostante la lamentata scarsità di truppe a sua
disposizione, cominciò dunque ad avanzare con un Corpo d'Operazione
alla ricerca del Negus e dei suoi "camisun", come erano definiti dai
nostri soldati i guerrieri abissini per via dei bianchi mantelli che
indossavano. A fine Febbraio, dopo una marcia di 450 chilometri da
Massaua, gli italiani si accamparono nella conca di Enticciò, a 30
chilometri da quella di Adua, dove stazionava l'esercito di Menelik. Alle
5 del pomeriggio del 29 Febbraio venne emanato da Baratieri l'Ordine n.
87, che prevedeva per le ore 21,00 la partenza verso Adua avendo come
"primo obiettivo" i colli di Chidane Meret e Rebbi Arienni. Il Corpo
d'Operazione venne diviso in tre colonne che dovevano marciare
separatamente lungo tre diverse strade per ricongiungersi alla fine del
percorso : Colonna di destra: 2ª Brigata Dabormida, Colonna di centro:
1ª Brigata Arimondi, seguita, ad un'ora di marcia, dalla 3ª Brigata Ellena
di Riserva, Colonna di sinistra : Brigata indigena Albertone. Il Corpo
italiano era infatti composto da 4 Brigate, Brigata Indigeni (Gen.
Albertone ) 4.076 uomini e 14 cannoni ; 1ª Brigata Fanteria (Gen.
Arimondi) 2.493 uomini e 12 cannoni ; 2ª Brigata Fanteria (Gen.
Dabormida) 3.800 e 18 cannoni ; 3ª Brigata Fanteria (Gen. Ellena) 4.150
uomini e 12 cannoni, per un totale di 14.527 uomini e 56 cannoni.
L'esercito imperiale vero e proprio contava fra i 34.000 e i 38.000
guerrieri e le forze che i vari Ras avevano portato con sé ad Adua
38
facevano salire la cifra degli Abissini a 110.000-123.000 combattenti.
Le batterie furono divise tra le varie Colonne, ma per scarsità di animali
da soma vennero assegnati soltanto 90 colpi a pezzo in luogo dei 130
previsti, limitando in questo modo l'efficienza dell'unica arma in grado
di contrapporsi all'enorme superiorità numerica del nemico ; inoltre uno
spostamento notturno – che separava le già scarse forze e procedeva per
vie sconosciute, senza l’ausilio di carte militari, ma soltanto di carte
topografiche appena abbozzate – espose presumibilmente l’impresa a
gravi rischi, senza contare che per il collegamento notturno si dovevano
necessariamente usare le staffette (per il giorno erano previsti degli
eliografi, in realtà semplici specchi solari). L'arrivo del Corpo
d'Operazione italiano avrebbe dovuto quindi costituire una sorpresa per
l'esercito abissino, ed invece si risolse in una sorpresa per le nostre
truppe (quello che oggi potremmo definire un servizio di “intelligence”,
sicuramente più efficiente da parte etiopica, al di là della presunta
leggerezza delle Autorità italiane nell’utilizzo di guide e spie locali) e la
battaglia che si svolse in quella terribile giornata del 1° marzo 1896 –
secondo la ricostruzione di molti storici – era praticamente già perduta
in partenza: il Corpo d'Operazione era già atteso, e per giunta affluiva
sul terreno dello scontro in disordine, alla spicciolata e lungo itinerari
che seguivano valli e sentieri separati da alture; da qui la grave difficoltà
a comunicare tra le colonne, la mancanza da parte del Comando centrale
di una visione chiara degli avvenimenti, e la pratica impossibilità di far
pervenire tempestivamente gli ordini necessari (il teatro della battaglia
aveva una profondità di 28 km e una larghezza di 14) senza l’ausilio
della nostra Cavalleria.
Le tre Brigate dei Generali Albertone, Dabormida e Arimondi si
mossero quindi alle 20.00 in direzione di Adua, con l’ordine di marciare
su strade parallele – sia per rimanere in contatto, e sia per non rompere
la compattezza dello schieramento. Ma a Baratieri arrivò quasi subito un
biglietto di Arimondi che lo informava di aver dovuto fermare
l’avanzata perché le sue truppe avevano cozzato contro le truppe
indigene di Albertone, ed era quindi costretto a farsi da parte per lasciar
39
avanzare gli Ascari. Ma nessun segnale di allarme scattò in Baratieri :
come mai due Brigate che devono marciare parallele finiscono sulla
stessa strada ? Ma soprattutto, questo voleva dire che le Brigate non
erano più compatte e che Alberatone si stava pericolosamente
sbilanciando in avanti senza copertura. Il primo errore della giornata era
ormai compiuto : Baratieri perse di vista una Brigata (ovvero un terzo
del suo esercito) e non fece nulla per riprendere il controllo. Inoltre,
Albertone stava avanzando con un’avanguardia sproporzionata (4.000
uomini) composta da tutte le sue Bande, un Battaglione e una Batteria,
proprio come una gran testa che si trascina dietro un corpo esiguo. Oltre
a questo, permise alla sua avanguardia un distacco di oltre tre
chilometri. Dopo 8 ore di marcia, le Brigate non si erano più compattate
e Albertone si era perso tra le gole ed i monti intorno ad Adua : il resto
dell’Armata non era più in grado raggiungerlo semplicemente perché
non sapeva dove si trovasse. Alle 06.00 del mattino del 1° Marzo 1896
gli Ascari, dall’alto di una collina, scorsero in direzione di Adua un
immenso accampamento con almeno 40.000 uomini ed altri 10.000 in
marcia proprio verso la Brigata di Albertone. Il potente esercito del
Negus era pronto ad abbattersi sugli Italiani : Menelik, perfettamente a
conoscenza di tutti i movimenti del nostro esercito, scelse proprio il
Chidane Meret, il colle dove si trova la punta più avanzata – ed isolata –
dell’esercito di Baratieri, per sferrare il primo attacco. In realtà furono
20.000 i guerrieri che, avanzando a semicerchio ed incuranti delle
cannonate, stavano travolgendo i nostri uomini, mentre altri 10.000
uomini spuntarono dalle colline circostanti e la strage ebbe inizio. Alle
08.30 le 142 cartucce in dotazione agli Ascari stavano per esaurirsi, ed
al Generale Albertone arrivò finalmente un biglietto di Baratieri, dove
gli si chiedeva di mettersi in contatto con le altri ali dello schieramento
italiano, ma ormai era troppo tardi. Albertone ha potuto solo
rispondergli che ha bisogno urgente di rinforzi. Nel frattempo la Regina
Taitù (Taitù Zeetiopia Berean, moglie di Menelik) incitava
personalmente i suoi uomini invocando San Giorgio (è proprio il giorno
della festa del Santo guerriero) al comando della Guardia Imperiale, il
40
reparto scelto composto da 20.000 uomini, che stava marciando a
supporto della prima linea abissina. Albertone perse presto il controllo
tattico della battaglia e dovette solo subire le mosse aggressive
dell’avversario. L’ordine fu quello dei momenti estremi : “Resistenza ad
oltranza e consumare fino all’ultima cartuccia”. La mancanza di
comunicazioni impedì a Baratieri di intervenire in soccorso : morirono
molti Ufficiali (in prima linea, con la divisa bianca) ed i nostri
Battaglioni furono scompaginati. Il Generale Albertone, ferito, venne
portato via dagli Abissini trascinato in terra con la sua stessa sciarpa.
Baratieri non era ancora al corrente di quello che stava succedendo e si
trovava a soli 8 chilometri dalla battaglia, anche se la distanza era
costituita da montagne, picchi e gole insidiose. Poco dopo Baratieri vide
gruppi di Ascari in fuga dirigersi disordinatamente verso le sue truppe
ed inseguiti dagli Abissini : l’iniziale confusione e la mancanza di
coesione tra i reparti innestarono una inarrestabile reazione a catena e la
ritirata non potè neanche essere ordinata perché Baratieri non aveva dato
disposizioni per le modalità di ripiegamento, facilitando in questo modo
il compito degli inseguitori (quando in Maggio le nostre truppe
arrivarono sui luoghi dell’eccidio per seppellire i cadaveri, ben oltre
mille corpi, degli oltre tremila trovati, giacevano fuori dell’area della
battaglia, uccisi durante la ritirata). Il primo urto venne sostenuto dal
Generale Arimondi che, appoggiato ad una montagna, si rese subito
conto di non avere forze sufficienti e chiese l’aiuto del Terzo Indigeni di
Galliano – gli epici difensori di Macallè – che si disposero all’ala
estrema dello schieramento a fianco dei Bersaglieri e dei Cacciatori
d’Africa, il Corpo di Fanteria appositamente creato per le campagne
coloniali, anche se completamente privo di addestramento specifico per
le torride ed insidiose zone africane. Gli Abissini, sfruttando
l’opportunità di essere mescolati agli Ascari in fuga – e questo significa
che la nostra artiglieria non fu in grado aprire il fuoco – occuparono le
posizioni dominanti del monte Rajo, dove era stato fissato proprio
l’estremo fronte della difesa italiana. Alle 15.30 erano già caduti 10
Ufficiali – tra di loro il Maggiore Galliano : “Signori, si dispongano con
41
la loro gente e vedano di finir bene” – ed oltre 1.000 Ascari. Il crollo
della Brigata di Arimondi (che rimase ucciso o si uccise, secondo
diverse testimonianze) trascinò con sé nel gorgo anche le truppe del
Generale Ellena. Il Generale Dabormida, commettendo un altro errore,
finì isolato in una valle laterale dove la sua colonna venne facilmente
sterminata (al suo seguito, morì anche il giovane Luigi Bocconi, figlio
del cavaliere Ferdinando Bocconi, proprietario dei Magazzini Bocconi
di Milano, che fece di tutto per partire per l’Africa dopo la sconfitta
dell’Amba Alagi, scomodando persino Crispi, e raggiunse il Corpo di
Spedizione giusto in tempo per la battaglia di Adua, accompagnato dal
fotografo Pippo Ledru. Il padre volle dedicargli un’iniziativa benefica,
oggi universalmente riconosciuta, appunto l’Università Bocconi. E’
doveroso aggiungere che nella battaglia morì anche l’amico fotografo,
così come quasi tutti i fotografi presenti, ed è questo il motivo per cui
non abbiamo fotografie degli scontri, ma solo disegni ed illustrazioni
fatti sulla base dei racconti dei superstiti). Baratieri si ritirò penosamente
con quanto restava dei suoi Reparti e solo il ritardo nell’inseguimento da
parte della Cavalleria nemica (la temuta ed implacabile Cavalleria
Galla) lo salvò dall’annientamento totale. Oltre a 46 cannoni a tiro
rapido Hotchkiss, che per inesperienza non vennero usati al meglio, e
alle mitragliere Maxim, gli abissini utilizzarono ad Adua non meno di
120 mila fucili, per la maggior parte Remington e Gras (i moderni
Remington a ripetizione, di fabbricazione americana, risultarono di
proprietà dello Stato del Vaticano , donati dal clero americano con una
colletta all'epoca di Mentana), ma anche Mauser, Berdan, WetterlyVitali (gli stessi in dotazione alle nostre truppe), Winchester, Peabody,
Martini-Henry, Chassepot e Kropatschek (trafficanti da tutto il mondo,
tra i quali anche il poeta Arthur Rimbaud, mercante di schiavi, facevano
la fila per vendere armi a Menelik), mentre alle nostre truppe in Colonia
non era stato ancora distribuito il nuovo Modello 91 – usato durante
l’addestramento in Patria ed in dotazione in Eritrea al solo Battaglione
Alpini – molto più arretrato rispetto al Modello 70, ma necessario per
omogeneità di munizionamento con i Battaglioni indigeni, oltre a pochi
42
Wetterly 87 con caricatore. Sul terreno restarono circa 8.000 cadaveri
sui quali si scatenò la furia dei vincitori, mentre i prigionieri, circa
1.500, vennero avviati in lunghe file verso il campo del Negus. La
Regina Taitù considerò gli Ascari dei traditori e li rimandò a Massaua
dopo aver tagliato loro la mano destra ed il piede sinistro, e lo stesso
trattamento – anche se molti storici esprimono opinioni diverse al
riguardo – venne applicato anche ad alcuni dei nostri soldati.
In quel tragico 1° marzo 1896 i caduti italiani furono oltre il 40%
dell'intero Corpo d'Operazione, una cifra spaventosa rispetto alle guerre
risorgimentali che fino ad allora l’Italia aveva combattuto. Le Medaglie
d'Oro alla memoria concesse ai caduti di quella battaglia furono 14, un
numero elevatissimo se confrontato a quello dei combattenti. Baratieri
ed Ellena furono tra i pochi superstiti. Anche se i dati non sono certi,
sembra che gli abissini contarono 7.000 morti e 10.000 feriti. Adua, o
Abba Garima, dal nome del Convento sul monte omonimo dei pressi del
quale fu combattuta, rimase la più sanguinosa battaglia delle guerre
coloniali del XIX secolo, e fu un tale eccidio da lasciare inorridito lo
stesso Negus : quando i suoi uomini gli chiesero di poter festeggiare la
vittoria, egli vietò loro ogni manifestazione di esultanza poiché” erano
morti cristiani da una parte e dall'altra”. Adua è però rimasta ancor oggi,
nella memoria degli abissini, "la Battaglia dei Leoni contro i Leoni" e
secondo il complicato calendario copto (23 Yekatit) quella ricorrenza è
festa nazionale.
Il 18 maggio avvenne lo scambio dei prigionieri, dopo che avevano
prestato servizio presso alti notabili abissini svolgendo i più umili e
disparati mestieri (l’incaricato a negoziare fu il Maggiore Salsa) e due
Compagnie del Genio poterono iniziare il riconoscimento e la sepoltura
dei resti dei caduti. La pace fu firmata a Addis Abeba il 15 Ottobre 1896
e il Negus per l'occasione fece pervenire ad Umberto I questo
telegramma: "Sono lieto di far conoscere a Vostra Maestà che il Trattato
di pace è stato oggi sottoscritto. Iddio ci mantenga sempre amici".
Con la sconfitta di Adua, l’Italia abbandonò completamente il suo
progetto di occupazione dell’Abissinia e fu costretta a riconoscere
43
l’assoluta indipendenza dell’Etiopia, ritirando ogni suo presidio dalla
zona del Tigrè (la regione occidentale del paese) limitando la sua
presenza militare con distaccamenti dislocati solo lungo i confini della
Colonia Eritrea.
Quella di Adua fu però anche per Menelik una vittoria sterile di risultati:
poco dopo la battaglia, il 20 marzo, dovette ritirarsi dalla regione,
sciogliere l'esercito e lasciare l'iniziativa agli italiani (in Etiopia il potere
passò in diverse mani per finire poi a Zaiditù, la figlia dell'imperatrice
Taitù, ed alla sua morte Tafari Maconnen, figlio del ras dell'Harrar,
venne incoronato Negus Neghesti (re dei re) con il più famoso nome di
Hailè Selassiè). Baldissera sbarcò il 4 Marzo, soltanto tre giorni dopo
l'eccidio, con gli aiuti tanto invocati da Baratieri, ed il Tricolore fu
ammainato nel forte di Adigrat che il Generale Baldissera aveva
riconquistato, benché non ci fosse alcun nemico a minacciarlo; ed anche
Cassala, luogo di una nostra splendida vittoria contro i Dervisci, fu
ceduta agli inglesi (Colonnello Pearson). Il Generale Domenico
Primerano, Capo di Stato Maggiore, commentò sulla Nuova Antologia :
"Adua fu un doloroso episodio militare, ma non dell'importanza che gli
si volle attribuire, e sarebbe stato riparabile all'indomani, se avessimo
avuto la calma, la serenità e la fermezza di propositi che erano richieste
in quel momento" (identica fu l'opinione del Times, che osservò : "Adua
è un disastro militarmente inferiore all’apparenza, ma politicamente
gravissimo”).
In patria, le reazioni dei partiti, dei giornali e degli uomini politici
furono scomposte ed esagitate : i socialisti esultarono perché era venuta
in terra d'Africa la "batosta risolutiva", sui muri della caserma
Sant'Ambrogio di Milano una mano scrisse: "Soldati, non andate al
macello! Viva la bandiera rossa, viva Menelik!" ed esultarono anche i
cattolici dalle pagine de “L'Osservatore Romano” e della “Civiltà
Cattolica”. Felice Cavallotti fece pressioni sul Governo perché Baratieri
non fosse giudicato da un Tribunale Militare, ma da un'Alta Corte di
Giustizia formata da nove deputati, ed Andrea Costa di rimando gridava
in piena Aula: "Neanche più un soldo per l'Eritrea! Neanche più un
44
soldo per l'Africa!". Ma Umberto I inviò a Menelik venti milioni di Lire
oro come rimborso spese di guerra – offerta che il Negus commentò
come un atto di sudditanza – e lo Stato Maggiore congedò le classi di
riserva che stavano per partire per l'Africa. È però anche vero che
“l'onore” non fu affatto perduto, poiché dalle inchieste successive ad
Adua emerse il comportamento assolutamente coraggioso e impavido
(per altro riconosciuto dallo stesso nemico) dei nostri soldati e dei nostri
Ufficiali. E l'onore, tutto sommato, non fu perduto neppure dall'Italia nel
suo complesso : la proposta parlamentare di abbandonare l'Eritrea fu
respinta dalla Camera con centoventisei voti contrari e solo ventisei
favorevoli, ed un prestito nazionale aperto dal Governo per le spese
sostenute nella guerra in Africa fu coperto ventidue volte più del
richiesto.
Il Generale Oreste Baratieri fu processato davanti al Tribunale Speciale
Militare, che lo assolse dall'accusa di aver attaccato il nemico con
certezza di insuccesso e di avere abbandonato il posto durante la ritirata,
e pertanto non accolse la richiesta del Sostituto Avvocato Generale
Bacci di una pena di dieci anni di reclusione militare. Tuttavia, nella
sentenza si legge: "Il Tribunale non può astenersi dal deplorare che la
somma del Comando, in una lotta così disuguale e in circostanze tanto
difficili, fosse affidata ad un Generale che si dimostrò tanto al di sotto
delle esigenze della situazione". Nonostante i meriti di guerra che
Baratieri aveva colto nelle campagne contro i Dervisci, e la grande
popolarità che per le sue vittorie lo aveva circondato negli anni recenti,
venne allontanato dall'Esercito. Il 5 Marzo 1896 Crispi venne costretto
alle dimissioni.
Perché un colonialismo così difficile?
Fu una partita decisamente rischiosa e Francesco Crispi, anche se non fu
lui ad iniziarla, non abbandonò mai il gioco perché rimase sempre un
convinto sostenitore del consolidamento del giovane Stato italiano nel
novero delle grandi potenze europee, ed in questo contesto una politica
45
coloniale coronata da successi militari e diplomatici venne perseguita
con volontà e determinazione. Ma è anche vero che il governo del nostro
Regno fu afflitto da pressanti incombenze di diversa natura, dai
tempestosi rapporti con la Chiesa, dagli scandali politici e dal
drammatico deficit del Bilancio – oltre ai gravi e pericolosi problemi
sociali – e tutto questo generò probabilmente la difficoltà di impartire
direttive strategiche chiare e precise alle autorità della nuova Colonia,
senza contare l’oggettiva impossibilità di ottenere conquiste politiche e
territoriali coniugate con limitazioni, o meglio restrizioni, dei
finanziamenti necessari. Anche sotto il profilo militare, la politica
coloniale perseguita non fu in grado di affrontare con una visione
completa ed innovativa – le circostanze lo richiedevano – la gestione
militare necessaria a consolidare e ad espandere la presenza italiana nel
Corno d’Africa. Le stesse vittorie militari, alcune valorosamente
conquistate ed altre soltanto agognate, dovettero fare i conti con
l’assenza di servizi cartografici adeguati e con l’arretratezza e la
disorganizzazione dei servizi logistici, oltre alla mancanza di decise
linee operative, sia strategiche che tattiche, alle quali si è accompagnata
un’attività diplomatica spesso ingenua, se non addirittura ambigua.
Anche se l’esercito abissino si rivelò un avversario coraggioso ed
intraprendente – proprio il contrario di quelle bande indisciplinate che i
nostri militari pensarono di poter mettere facilmente in fuga con la
superiorità tecnica dell’addestramento e delle armi – è doveroso
sottolineare che gli eserciti, e le stesse classi dirigenti, di tutte le potenze
coloniali dell’epoca erano intimamente persuasi che la supremazia dei
soldati europei – qualità morale, armamento e disciplina – avrebbe
sicuramente avuto ragione sul nemico che erano chiamati ad affrontare,
specialmente se questo nemico, come nel nostro caso, si trovava in una
delle aree più marginali e povere di tutto il continente africano. Altri
paesi furono in grado di assorbire le inevitabili battute d’arresto che
questo tipo di guerra comportava a cadenze quasi regolari, ma il Regno
d’Italia, ancora fragile a causa dei numerosi problemi interni e con una
classe politica non del tutto formata, stava tentando un’impresa
46
coloniale di grande respiro decisamente superiore alle sue possibilità, ed
inoltre condotta in ritardo rispetto agli altri Stati, lì dove le altre potenze
europee avevano intrapreso la strada dell’espansione coloniale dopo
secoli di unità politica e sociale e dopo aver raggiunto una forte e stabile
coesione militare.
Ma anche se tardiva, e spesso contraddistinta da un ordito retorico che
continuamente cercava di legittimare il proprio operato, l’avventura
coloniale italiana in Africa ebbe però nel suo intrinseco sviluppo una
forte ed elevata carica ideologica. Ai richiami delle allettanti possibilità
strategiche o economiche del nuovo mondo, l’Italia di fine secolo aveva
risposto, forse con eccessiva baldanza, con lo spirito mazziniano che
aveva marcato il nostro Risorgimento, così avaro di trionfali stendardi di
vittoria, e quindi con il riscatto di una ipotesi di sviluppo nazionale e
sociale che incontrò adesioni diffuse in tutto l’arco dell’Età umbertina.
Anche se furono comunque pagine amare di storia patria, che solo una
recente storiografia ha ridisegnato – marcandone i contorni sociali,
politici e militari – nel debito tentativo di restituire dignità concettuale
ad avvenimenti e vicende umane, rimane innegabile il valore che i
nostri soldati hanno dimostrato tra le sperdute ed assolate ambe
africane, sotto l’ombra del nostro Tricolore.
47
Oreste Baratieri (1841-1901) iniziò la sua carriera militare nel 1872 con
il grado di Capitano, dopo la lunga militanza nelle “camicie rosse” di
Garibaldi dal 1860 al 1867 (fu tra i volontari nella spedizione dei Mille).
Oltre a ricoprire la carica di deputato per sei legislature (eletto a Breno,
Brescia) comandò con il grado di Colonnello prima il 4° Bersaglieri a
Cremona (1886), e poi il 1° Reggimento Bersaglieri d’Africa al seguito
della spedizione in Africa comandata dal Generale Di San Marzano. Nel
1892 venne nominato Governatore della Colonia Eritrea e Comandante in
capo delle truppe con il grado di Generale. Dopo le vittoriose campagne
del Tigrè e di Cassala, venne processato ed assolto per la tenuta durante
la battaglia di Adua.
Antonio Baldissera (1838-1917) nato da famiglia povera, venne affidato
dalla madre vedova al Vescovo di Udine che lo iscrisse all’Accademia
Militare di Vienna con i fondi di un’Istituzione benefica retta
dall’Imperatrice Elisabetta (più conosciuta come Sissi). Nel 1857,
raggiunto il grado di Sottotenente, rifiutò l’invito a passare nel Regio
Esercito e combattè nel 1866 con il grado di Capitano sul fronte boemo
contro la Prussia. All’atto della cessione del Veneto all’Italia, venne
esentato dal giuramento di fedeltà all’Imperatore Francesco Giuseppe e
fu libero di scegliere il ritorno in Italia. Con il grado di Colonnello
comandò nel 1886 il 7° Reggimento Bersaglieri a Firenze e raggiunse la
terra d’Africa al seguito del Generale Di San Marzano e con il successivo
grado di Generale ebbe l’incarico di riorganizzare la Colonia. Rientrato
in Italia, nel 1896 ebbe l’ordine di sostituire il Generale Baratieri e gli
subentrò nel Comando all’indomani della battaglia di Adua, con la carica
di Governatore Generale. Fu nominato senatore ed insignito della
onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia,
dopo essere già stato decorato in Austria dell'Ordine di Maria Teresa.
Giuseppe Galliano (1846-1896) entrò giovanissimo nel Collegio Militare
di Asti per passare nel 1864 nella Scuola Militare di Fanteria. Nel 1866
fu Sottotenente al 24° Reggimento Como e partecipò alla guerra contro
l'Austria-Ungheria. Alla costituzione del Corpo degli Alpini transitò in
questa nuova specialità (1873) per rimanervi 10 anni. Promosso Capitano
partì per l’Africa nel 1887. Dopo una breve ritorno in patria, chiese di
essere destinato nuovamente all’Eritrea. Nel 1893 ad Agordat il suo III
Battaglione Indigeni riuscì a riprendersi i cannoni persi alcune ore prima,
48
insieme a tutte le armi degli Abissini, conservati oggi al Museo di
Artiglieria di Torino. Alla notizia che Umberto I gli aveva assegnato la
Medaglia d'Oro al Valor Militare, Galliano così scrisse al fratello: « ...
una sola cosa disturba la mia gioia per tanta onorificenza, ed è che si
discosta troppo da quella data ai miei ufficiali che me l' hanno
guadagnata e per i quali il Ministero non fu largo come per me » La sua
promozione a Maggiore venne assegnata sul campo per meriti di guerra. I
combattimenti di Coatit prima e di Makallè dopo, gli valsero il
nomignolo di Leone presso gli Abissini, e gli venne anche conferita una
Medaglia d'Argento. Sempre per tali valorose azioni ebbe in premio
anche la Croce di Cavaliere dell'Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro per
« motu proprio » del Sovrano e la promozione per Merito di Guerra a
Tenente Colonnello (1896). Ad Adua nel 1896 i nemici lo trovarono
ferito e lo riconobbero per la Medaglia d'Oro che gli luccicava sul petto.
Menelik, informato della cattura, gli mandò in segno di rispetto un
muletto per trasportarlo al suo campo. Galliano lo rifiutò per ben due
volte accompagnando gli epiteti rivolti al Negus con la parola "chenzir”,
porco : nel campo di Menelik arrivò la sola testa. Per l’eroico
comportamento in battaglia gli venne assegnata alla memoria una
seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Menelik II (1844-1913) Ras del regno di Shoa (Abissinia centrale) dal
1865 al 1889, sconfisse gli Oromo annettendosi il loro territorio
(Abissinia meridionale) ed alla morte di Giovanni IV venne eletto
Imperatore d’Abissinia dal 1889 al 1909 e perseguì l’unificazione del
paese attraverso l’annessione di piccoli stati governati dai Ras locali.
Durante il suo regno cercò di abolire la tratta degli schiavi e fondò la città
di Addis Abeba.
49