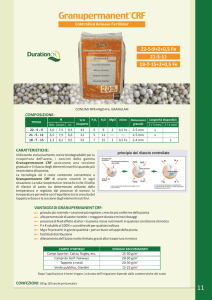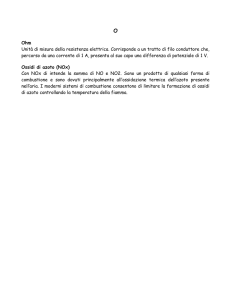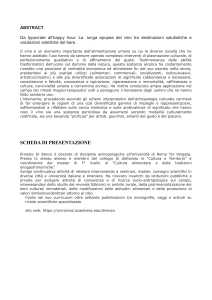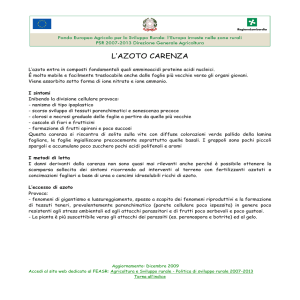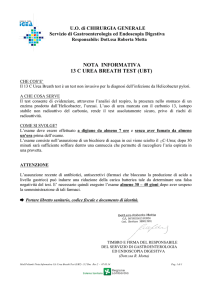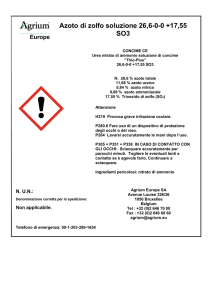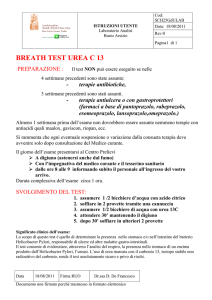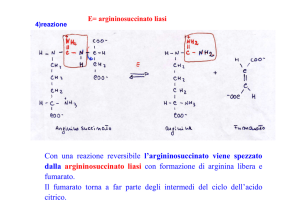IL PERICOLO LEGATO ALLA PRESENZA DI URETANO NEL VINO
L'etil-carbammato (uretano) è un composto cancerogeno che si produce nel vino a partire principalmente dall'urea
prodotta dal lievito durante la fermentazione alcolica, tramite una reazione chimica con l'alcool favorita dalle alte
temperature. Il principale precursore quindi dell’uretano è l’urea che si forma durante la fermentazione alcolica
come metabolita dell’arginina, uno dei più abbondanti aminoacidi contenuti nel mosto ed è utilizzato dai lieviti come
nutriente. La concentrazione di urea nel vino non è una determinazione di routine nei laboratori, ma la sostanza
derivata dal metabolismo del lievito, è stata studiata in relazione alla formazione di etilcarbammato.
USA e Canada sono i due paesi che per primi hanno sollevato la questione dell'uretano nel vino: dopo parecchi studi,
le autorità hanno deciso di non fissare un limite ma di controllare il suo contenuto nei vini al consumo con
l'obiettivo di mantenerlo a livelli inferiori a 15-30 microgrammi/l secondo i casi.
Il limite massimo più restrittivo di carbammato di etile previsto dai paesi extracomunitari è 15 µg/l (ppb).
Le principali regole per prevenire la formazione di eccessive quantità di uretano nel vino sono:
1. Evitare una fertilizzazione eccessiva della vigna con azoto, controllare il livello dell'azoto nel terreno,
controllare il livello dell'azoto nella vite
2. Non usare leguminose invernali come coltura di protezione se la quantità di azoto nel suolo è già elevata
3. Tenere presente che l'assorbimento dell'azoto varia molto a seconda delle varie viti e specialmente in base ai
portainnesti
4. Controllare il livello d'azoto nel succo, non aggiungere eccessive di azoto su base continua, non aggiungere
regolarmente integrazioni di azoto, non aggiungere urea come integrazione di azoto, evitare livelli d'arginina nel
succo superiori ai 1.000 mg per litro.
5. Quando si scelgono ceppi di lieviti per vino, evitare quelli che hanno un livello elevato di escrezione d'urea
6. Usare batteri malo-lattici con caratteristiche conosciute
7. Tenere presente che l'uso di preparati ureasi non puo' eliminare completamente la formazione di uretano
8. Tenere presente che la fortificazione del mosto può aggravare il problema dell'escrezione di urea dai fermenti
9. Controllare i livelli di uretano nell'alcool per la fortificazione
10. Evitare che il vino sia esposto ad alte temperature durante la sua conservazione e il trasporto
In vigneto
1) Fertilizzazione della vigna. La fertilizzazione con azoto (N) nella vigna ha un' influenza diretta sul contenuto
d'azoto nei chicchi d'uva e nel mosto. Una fertilizzazione eccessiva nel passato con urea, ammoniaca e altri
fertilizzanti con azoto e' ritenuta una delle cause dei livelli elevati di uretano nei vini provenienti da paesi che
tradizionalmente producono vino
2) Inerbimento del sottovigneto. I viticoltori devono tenere presente che è probabile aggiungano una quantita'
significativa di azoto alle loro vigne quando sotterrano leguminose invernali utilizzate come colture di protezione
per le vigne. L' uso di queste colture di protezione puo' portare l'azoto nella vite a livelli eccessivi. Se le
leguminose sono usate come colture di protezione, e' necessario controllare l'azoto nel terreno e nella vite per
evitare livelli eccessivi di arginina nei succhi. Se è necessaria una fertilizzazione aggiuntiva con azoto, non si
devono sotterrare leguminose invernali.
3) Varietà di viti e portainnesti. Diverse varietà d'uva presentano variazioni nell'assorbimento d'azoto, con alcune
varietà che hanno generalmente valori più bassi di arginina rispetto ad altre. Un livello però basso di azoto nelle
varie viti è strettamente connesso alle caratteristiche delle proprie radici e cambia con l'utilizzo di portainnesti
differenti. Al momento della fioritura l'azoto totale nel picciolo può variare più del 40% in media, mentre l'azoto
nitrico puo' addirittura variare 10-12 volte a seconda della combinazione usata portainnesti -marza. Pertanto, i
portainnesti possono avere un’influenza notevole sui livelli d'azoto e sui processi di fertilizzazione. I consulenti
locali per i centri di produzione vinicola possono fornire informazioni sull'assorbimento dell'azoto dei vari
portainnesti.
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2013
Accedi al sito web dedicato al FEASR: Agricoltura e Sviluppo rurale - Politica di sviluppo
In cantina
4) Nutrienti nel succo/aggiunte. Per stabilire con esattezza il valore nutritivo di uno specifico succo d'uva, può
rendersi necessario misurare il livello dei composti d'azoto effettivamente utilizzabili dai lieviti per l'attività
metabolica. I livelli d'azoto nell'uva variano molto a seconda del luogo in cui si trova il vigneto, in base al terreno,
l'irrigazione, il tipo di fertilizzazione, il tempo al momento della vendemmia, la marza e il portainnesto, e la
maturazione dell'uva. Le due fonti principali d'azoto nel mosto sono l'ammoniaca e gli amminoacidi con l'eccezione
della prolina. La prolina non può essere utilizzata come fonte d'azoto dai lieviti senza ossigeno molecolare, che non
è presente nella fermentazione anaerobica del succo d'uva. Entrambe le fonti di azoto presenti possono essere
analizzate in un laboratorio di un'azienda vinicola o in laboratori esterni. Controlli dell'ammoniaca includono test
enzimatici/fotometrici o l'uso di un elettrodo per ammoniaca. Gli amminoacidi utilizzabili dai lieviti possono essere
misurati rapidamente tramite test colorimetrico che richiede uno spettrofotometro. L'analisi con HPLC individua
tutte le fonti d'azoto simultaneamente ma richiede personale altamente specializzato e dà risultati in tempi lenti
durante la produzione del vino. E' necessario ottenere risultati analitici entro poche ore dall'inserimento dei lieviti
per potere decidere se è necessario aggiungere integrazioni nutritive a mosti carenti.
I produttori di vino devono conoscere i livelli d' azoto dei propri succhi e non devono integrarli eccessivamente con
fosfato biammonio.
5) Lieviti. I lieviti vinari differiscono nella loro capacita di catabolizzare rapidamente l'urea durante la
fermentazione. Quando un eccesso d'urea si accumula nel citoplasma della cellula, viene rilevata nel suo ambiente, il
mosto. Lieviti che producono molta urea sono quelli che hanno un'alta capacita di degradare l'arginina in urea, ma
una capacità limitata di metabolizzare l'urea. Tale limitata capacità di metabolizzare l'urea può derivare da una
bassa attività dell'amidoliasi, inibita dalla presenza di livelli elevati di ammoniaca, da carenze di fattori
concomitanti necessari all' amidoliasi o, apparentemente, da bassa attività dovuta ad arginasi iperattiva. Fattori sia
genetici che ambientali influenzano la quantità d'urea emessa dalle cellule. Si e' osservato che alcuni ceppi di
fermenti commerciali producono livelli relativamente bassi d'urea. Le ditte produttrici di lieviti per uso enologico
sono in grado di raccomandare ceppi con una quantità minima di escrezione d'urea per ogni specifico uso nella
produzione di vino; si suggerisce pertanto di consultare queste ditte al riguardo.
La fermentazione spontanea con ceppi non definiti di lieviti richiede controlli dell'arginina nei succhi, dell'urea e
dei livelli di uretano in ogni fermentazione. Non è chiaro che tipo di impatto la fermentazione naturale abbia sui
livelli di uretano, poichè non si hanno ancora studi conclusivi al riguardo. In ogni caso, ci si aspetta che ceppi di
fermento indigeni mostrino una variabilità simile nel catabolismo dell'urea, così come si è osservato nei ceppi
commerciali.
Se il succo ha un contenuto elevato d'arginina, accertarsi che vengano inoculati ceppi di lievito che producono poca
urea nella vinificazione.
6) Batteri lattici. Alcuni batteri dell'acido lattico hanno la capacita' di formare piccole quantità di citrullina, un
precursore del carbammato d'etile, dall'amminoacido arginina, e di secernere questo precursore nel vino. Aggiunte
regolari d'azoto ai succhi con livelli nutritivi sconosciuti possono aumentare la quantità di azoto disponibile per i
batteri dopo la prima fermentazione. Inoltre, anche i ceppi che non hanno la capacità di degradare l'arginina
possono produrre piccoli aumenti di carbammato d'etile, facendo così pensare che possano essere presenti altri
precursori azotati oltre a quelli derivati dall'arginina. I risultati della ricerca indicano che è necessario essere
cauti nel selezionare le colture prima di iniziare la fermentazione malolattica nel vino, poichè la formazione di
citrullina dalla degradazione dell'arginina può produrre livelli elevati di carbammato d'etile, anche a temperature
normali, quando vi è un lungo periodo di conservazione. Inoltre, si deve evitare la fermentazione malolattica
spontanea da ceppi non definiti, poichè si puo' creare la formazione di precursori del carbammato d'etile.
Se si desidera la fermentazione malolattica, i produttori di vino devono usare o un ceppo commerciale che non
produca livelli elevati di citrullina, o devono controllare il contenuto di citrullina dopo la fermentazione.
7) Utilizzo dell’ureasi. Poichè l'urea è il principale precursore dell’uretano nel vino, l'idrolisi enzimatica dell'urea in
ammoniaca e anidride carbonica sembra essere il giusto modo di eliminare formazioni da questa fonte. Preparazioni
a base di enzima ureico sono presenti sul mercato per il trattamento del vino. In ogni caso, l'attività dell'ureasi è
molto limitata in condizioni normali di vinificazione, in modo specifico per quanto riguarda il basso pH e l'etanolo.
L'ureasi è inibita specialmente da elevate concentrazioni di acido malico. Qualsiasi combinazione di questi fattori
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2013
Accedi al sito web dedicato al FEASR: Agricoltura e Sviluppo rurale - Politica di sviluppo
puo' rendere praticamente impossibile raggiungere i bassi livelli di urea voluti in tempi brevi, anche con dosi molto
alte di enzima. Non è possibile eliminare completamente l’uretano.
Se il vino ha molta urea da residui, i produttori di vino possono utilizzare il trattamento dell'ureasi per diminuire i
livelli d'urea. E' necessario pero' valutare l'efficacia dell'aggiunta di ureasi per ogni vino per avere conferma che
l'enzima sia attivo.
8) Maturazione sulle fecce. E' prassi comune nell'industria vinicola stagionare il vino sui sedimenti dopo la prima
fermentazione, in modo tale da influenzare le proprietà organolettiche del vino. La stagionatura sui sedimenti
porta alla liberazione nel vino di composti azotati, amminoacidi e proteine: una secrezione rapida dal pool
intracellulare delle cellule dei lieviti nelle prime settimane di conservazione ed un lento aumento col passare del
tempo di conservazione, a causa dell'autolisi dei fermenti. Si è però trovato che non si verifica un aumento della
concentrazione del carbammato d'etile nei vini fatti con uva a bassa concentrazione di ammionoacidi, dopo contatto
prolungato con i sedimenti; si è anche notato che non vi sono altri precursori di carbammato d'etile emessi dai
fermenti durante un contatto prolungato con i sedimenti. Pertanto, nelle suddette condizioni, la prassi di un
contatto prolungato con i sedimenti non sembra aumentare la possibilita'di carbammato d'etile. Non vi sono dati
che documentino nella maturazione sui sedimenti l'influenza sulla concentrazione d'urea nei vini fatti con uva che
abbia concentrazioni eccessive di azoto assimilabile dai lieviti.
Analogamente, non vi sono dati riguardanti la produzione di vino frizzante e l'evoluzione dei livelli d'urea e altri
precursori dell’uretano durante l'autolisi dei fermenti, cioe' durante una stagionatura prolungata di vini in bottiglie
da stappare.
La stagionatura sui sedimenti non ha mostrato un' influenza significativa sui livelli di carbammato d'etile, ma non
sono state ancora effettuate analisi conclusive al riguardo.
9) Distillazione/alcolizzazione. L’uretano può formarsi dopo la distillazione tramite la reazione di un precursore
volatile, l'isocianato, con l'etanolo, sia a temperatura ambiente che elevata.
I produttori di distillati di vini devono tenere presente altri precursori del carbammato d'etile, i cianuri. La frutta
con noccioli, specialmente ciliegie, albicocche o prugne contiene cianuri combinati con zuccheri nei noccioli che
possono essere emessi durante la fermentazione. E' essenziale togliere i noccioli prima della fermentazione ed e'
altrettanto importante procedere ad una seconda distillazione per evitare concentrazioni elevate di precursori di
uretano volatile in questi tipi di liquori.
I produttori di vini alcolizzati devono tenere presente quanto detto sopra come produttori di vini da tavola, perchè
la fortificazione può aggravare di per sè il problema della secrezione d'urea da parte dei fermenti. L'urea si forma
spesso durante le fasi iniziali o centrali della fermentazione con successiva generazione di lieviti che l'utilizzano
nelle fasi finali del processo. La secrezione massima avviene frequentemente, con qualche eccezione, tra i 12 e 16
Brix. Interrompere la fermentazione a questo punto porta a concentrazioni elevate di urea nei vini fortificati. Si
raccomanda di eseguire una fortificazione di prova nel laboratorio dell'azienda vinicola e di analizzare sia il vino in
fermentazione che il vino da dessert che ne deriva per stabilire il contenuto d'urea.
Inoltre, l'alcool dell'uva usato per alcolizzare può agire come fonti primarie delle tracce di uretano nei vini
alcolizzati e devono essere controllati per verificare la possibilità o la presenza di ureatano.
Poichè gli isocianati si formano dalla disgregazione dell'urea, vale la stessa raccomandazione fatta per il vino da
tavola. Per ora non è possibile dare raccomandazioni sul frazionamento dei distillati, a causa della mancanza di dati
sul comportamento della distillazione dei precursori volatili dell’uretano.
10) Spedizione e conservazione. La reazione chimica tra l'urea e l'etanolo aumenta esponenzialmente con
l'aumentare della temperatura. E' pertanto indispensabile che un vino contenente livelli elevati di urea non sia
esposto ad alte temperature (al di sopra dei 38°C) quando viene spedito o conservato.
Poichè il vino esposto per molto tempo ad alte temperature rovina anche il suo aspetto e le sue qualità, i produttori
di vino dovrebbero educare e incoraggiare lo spedizioniere, il distributore, il grossista e i dettaglianti, a ridurre al
minimo l'esposizione alle alte temperature tramite utilizzo di appositi contenitori isolanti, una programmazione
oculata delle spedizioni e centri d'immagazzinaggio adatti.
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2013
Accedi al sito web dedicato al FEASR: Agricoltura e Sviluppo rurale - Politica di sviluppo