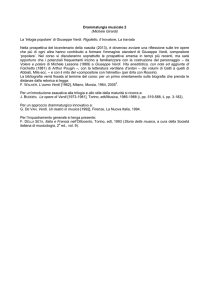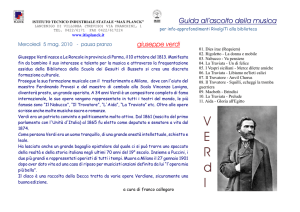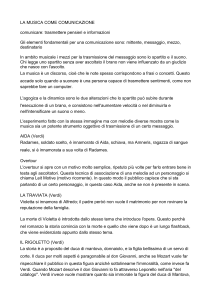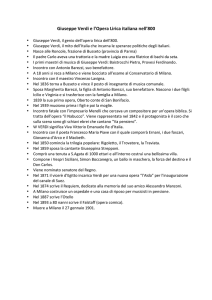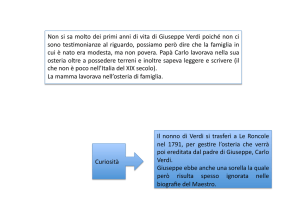PERCORSI DIDATTICI
Giuseppe Verdi
A duecento anni dalla nascita
Lorenzo Bianconi
NELL’IMMAGINARIO POPOLARE GIUSEPPE VERDI (1813-1901) È IL MUSICISTA “NAZIONALE”
PER ANTONOMASIA: PIAZZE, STRADE, TEATRI, SCUOLE DI MUSICA A LUI INTITOLATE LO DIMOSTRANO.
LA SUA ARTE TOCCÒ CORDE PROFONDE DELL’ANIMO COLLETTIVO;
NELL’ODE IN MORTE DI GIUSEPPE VERDI GABRIELE D’ANNUNZIO SEPPE DIRLO CON RARA CONCISIONE:
«DIEDE UNA VOCE ALLE SPERANZE E AI LUTTI. PIANSE ED AMÒ PER TUTTI».
L
a lunga parabola creativa di Verdi
si colloca in una fase cruciale
della storia nazionale: nato nel
Ducato di Parma agli sgoccioli dell’età
napoleonica, si formò, debuttò, incontrò
i primi successi a Milano e a Venezia sotto il governo austriaco; da artista aderì
idealmente ai moti del ’48; intorno al
1859 il suo nome divenne addirittura
uno slogan politico («Viva Vittorio
Emanuele Re D’Italia»); nel 1861 fu eletto al Parlamento del Regno, nel 1874 nominato senatore. Oltralpe, oltremanica,
oltreoceano il nome di Verdi, nella seconda metà dell’Ottocento, fu sinonimo
di musica italiana, di volta in volta in
senso elogiativo o limitativo.
In realtà la qualifica di musicista a Verdi
stava stretta. «No, no, lasci andare il gran
musicista, io sono un uomo di teatro!»,
avrebbe pubblicamente protestato nel
1893. Il grosso della sua produzione consiste nei 27 melodrammi composti tra
il 1839 e il 1893. Come operista – ossia
come compositore dedito a una forma
di produzione multiforme, cooperativa
e dispendiosa – Verdi si trovò a lavorare
entro i vincoli obbliganti di un sistema
produttivo ben rodato: un sistema teatrale che sull’arco di mezzo secolo subì
notevoli sviluppi e al tempo stesso manifestò una ragguardevole tenacia.
Nuova Secondaria - n. 2 2013 - Anno XXXI
Giuseppe Verdi, incisione di E. Mancastroppa dalla fotografia di A. Ferrario
nel numero speciale de «L’Illustrazione italiana» dedicato a Falstaff (1893).
53
PERCORSI DIDATTICI
I ritmi di produzione
Uno sviluppo significativo nel sistema
teatrale riguardò i ritmi di produzione:
negli anni ’40 Verdi scrive mediamente
due opere all’anno, negli anni ’50 una
ogni due anni (ma Il trovatore e La traviata, due capolavori assoluti, furono varati a un mese e mezzo di distanza, in
due città lontane come Roma e Venezia),
da vecchio una a decennio: è evidente
che l’impegno creativo profuso nel progettare, stendere, realizzare il singolo melodramma muta radicalmente. Nel 1858
Verdi – ormai all’acme della fama nazionale e mondiale, proprietario terriero padrone della propria vita – dichiara: «Da
Nabucco in poi non ho avuto, si può
dire, un’ora di quiete. Sedici anni di galera!!».
Ma fin dai primi anni Verdi, artista dotato di una smagliante chiarezza ideativa
e uomo dal temperamento imperioso,
aveva preteso da impresari, librettisti,
editori il rispetto rigoroso delle proprie
intenzioni. Così facendo aveva dato un
impulso notevole all’ammodernamento
del sistema teatrale italiano, accentrando
sul compositore una responsabilità ben
maggiore che per il passato.
Il sistema delle voci: il triangolo
soprano-tenore-basso
Una costante tenace del sistema operistico italiano consiste nella preponderanza del canto. Per dirla con una formula
coniata dal critico Fedele d’Amico, «il
personaggio, nell’opera lirica, è la sua
voce»: non si dà drammaturgia se non
attraverso il risalto dato al cantante, o per
meglio dire ai cantanti, alla costellazione
dei personaggi che s’incarna nella costellazione delle loro voci. Nel melodramma
romantico italiano questa costellazione
– la metafora astronomica rende bene
l’idea d’un insieme di corpi assoggettati
a una forza di gravitazione che li tiene
in continuo movimento – è codificata,
standardizzata. Nella battuta di un
54
critico fiorentino del 1852, nelle opere
italiane inesorabilmente «il tenore ama
un soprano, di cui il baritono è geloso».
Questo triangolo – su di esso si fondano
tutte le opere serie di Verdi, dall’Oberto
conte di San Bonifacio (1839) all’Otello
(1887) – preesiste a Verdi e sopravvive
a Verdi. Lo slancio del tenore, una voce
giovane innaturalmente spinta verso
l’acuto, è idealmente proteso ad abbracciare il registro femminile del soprano,
mentre il timbro più scuro e pieno del
baritono – la voce dell’uomo adulto, coi
piedi per terra, di volta in volta pugnace
o disincantato – è fatalmente eccentrico
rispetto agli altri due vertici del triangolo
canoro. A margine stanno i personaggi
complementari, le voci di contorno:
quasi sempre un basso (di solito una figura vetusta, vuoi severa e benigna,
vuoi minacciosa e feroce), spesso una seconda donna. A ciascun cantante, alle
prime parti come alle seconde, spetta un
certo numero di pezzi – arie e romanze
assolo, duetti, terzetti, ecc. – secondo una
gerarchia che corrisponde al peso e al
ruolo del personaggio nell’intreccio.
Altri triangoli
In Verdi la triade soprano-tenorebaritono, che per Bellini e Donizetti è essenzialmente un triangolo erotico, subisce volentieri una torsione generazionale. Non mancano i baritoni giovani e
focosi, rivali del tenore per la conquista
del soprano: il Conte di Luna è un
ventenne, a mala pena più adulto di
Manrico, l’eroe del Trovatore (1853). Ma
spesso la gelosia del baritono promana
da un padre nobile, come Germont
che nella Traviata (1853) si oppone al sodalizio del figlio Alfredo con la prostituta
Violetta. Addirittura – novità sensazionale – il baritono può ergersi a protagonista, a vettore del conflitto drammatico:
è il caso del protagonista di Rigoletto
(1851), personaggio turpe nell’aspetto
e nel ruolo (gobbo, buffone di corte) ma
genitore tenerissimo, infine vittima della
vendetta ch’egli trama contro il seduttore
della figlia; è il caso del protagonista di
Simon Boccanegra (1857), il corsaro
eletto doge di Genova che all’apogeo della gloria riabbraccia la figlia rapitagli ventiquattr’anni prima, nel giorno stesso in
cui muore avvelenato da colui che l’aveva
spinto al trono.
Sul triangolo amoroso si innestano talvolta triangoli supplementari, che arricchiscono la costellazione dei personaggi
e delle voci e complicano l’intreccio. Il
trovatore ha due primedonne di pari
peso: a Leonora (soprano) desiderata da
Manrico (tenore) e da Luna (baritono)
si contrappone Azucena (mezzosoprano), madre dello stesso tenore perseguitata dallo stesso baritono.
In Aida (1871) il soprano (Aida) e il tenore (Radamès) sono sotto il tiro di ben
tre antagonisti: il baritono (Amonasro,
genitore di Aida) è rivale del tenore in
guerra, il mezzosoprano (la principessa
Amneris) è rivale del soprano in amore,
il basso (il gran sacerdote Ramfis) è rivale
del tenore in politica. Ma per quante
complicazioni subisca lo schema di base,
permane inalterata la legge che assegna
ruoli drammatici prestabiliti ai diversi registri vocali e distribuisce i pezzi musicali
in base ai rapporti di attrazione e repulsione tra i personaggi.
Convenzione e invenzione
Già questi dati ci dicono che la posizione
di Verdi nella storia dell’opera in musica
non si comprende se non entro la dialettica convenzione/invenzione. Le convenzioni invalse nel sistema teatrale garantiscono l’efficacia e la rapidità della produzione, assicurando nondimeno un
sufficiente tasso di libertà inventiva (e di
rischio artistico). Il concetto di convenzione, inviso a un’estetica fondata sull’originalità e l’individualità dell’opera
d’arte, va inteso qui in un’accezione
neutra, denotativa: il termine, di origine
Nuova Secondaria - n. 2 2013 - Anno XXXI
legale, designa un accordo stipulato tra
due contraenti. In teatro, la convenzione
è il tacito patto stabilito tra il palcoscenico e la sala, tra gli autori ed esecutori
e gli spettatori. Senza convenzioni condivise dai produttori e dai destinatari,
semplicemente non si dà comunicazione.
Lo spettatore, che nell’Ottocento va a
teatro tutte le sere che c’è spettacolo, porta con sé, magari senza rendersene pienamente conto, aspettative cementate
dalla consuetudine, dalla ricorrenza di
certi moduli musicali, di certi schemi
formali, di certe situazioni drammatiche
più o meno ripetitive. Soddisfare queste
aspettative inconsapevoli, ma anche
giocarci a rimpiattino depistando a
bella posta l’ascoltatore per sorprenderlo
e colpirlo, è il compito del musicista teatrale: l’aspettativa fuorviata non nega la
norma, la presuppone nel momento
stesso in cui ne deroga.
Perché scocchi la scintilla dell’invenzione
artistica – anche la più incendiaria – non
è detto che si debbano trasgredire o sovvertire le convenzioni: essa si può accendere anche entro la griglia di aspettative
consuetudinarie. La ribellione contro le
regole tramandate, «la completa obliterazione della “formula”», è lo stendardo
sventolato dagli Scapigliati capitanati dal
giovane Arrigo Boito (1842-1918). Verdi
è invece un genio eminentemente pragmatico, unisce il vigore dell’ideazione
teatrale al saldo possesso delle regole del
mestiere: usa le convenzioni disponibili,
le osserva o le manipola o le scavalca secondo quanto gli detta la situazione scenica, l’idea o (come diceva lui) la «tinta»
del dramma.
I numeri chiusi
Tra le convenzioni che Verdi eredita dal
sistema operistico italiano e sostanzialmente mantiene fino alla fine ve n’è una
che tra il 1839 e il 1893 mutò profonda-
Nuova Secondaria - n. 2 2013 - Anno XXXI
G. Verdi, Otello, indice nello spartito
Ricordi n. 51023 (Milano, 1887).
mente: la costruzione a numeri chiusi.
L’opera italiana risulta dalla concatenazione di una serie di pezzi staccati,
dotati ciascuno di un inizio, uno svolgimento, una fine. Alla fine di ciascun pezzo il pubblico, se ha gradito, applaude.
Letteralmente, gli autografi di Verdi
constano di fascicoli numerati (p.es.
nel Trovatore sono 14); e gli editori
musicali pubblicavano e smerciavano gli
spartiti in tanti pezzi staccati, acquistabili
anche singolarmente.
Orbene, questa che fino agli anni ’60 è
un’ovvietà, un dato scontato e pacifico
della forma opera (e non soltanto in Italia), con l’avvento di Richard Wagner –
a metà secolo in Germania, dal 1871 in
Italia – viene contestata in radice: il
dramma musicale durchkomponiert (a
tessuto continuo), basato sull’idea che un
conflitto drammatico credibile esiga
un discorso unitario, una «melodia infinita» insofferente di schemi formali
prestabiliti, entra in attrito con le convenzioni vigenti nell’opera italiana.
Anche Verdi asseconda a modo suo
55
PERCORSI DIDATTICI
questa evoluzione, si mette al passo:
nell’atto III di Aida, per dire – un capolavoro di suspense teatrale –, non c’è spazio per gli applausi a scena aperta. Ma
il contrasto tra le due concezioni è in
buona parte fittizio. Da un lato, gli stessi
drammi musicali di Wagner sono di fatto articolati in scene e quadri ben riconoscibili, per quanto collegati nel tessuto
orchestrale. Dall’altro lato, sotto l’apparenza di un flusso continuo anche
un’opera modernissima come Otello
(1887), cui molti critici rinfacciarono un
eccesso di wagnerismo, presenta una trasparente articolazione in pezzi chiusi, dichiarata fin nell’indice dello spartito (cfr.
fig. a p. 55). La distribuzione di questi
pezzi chiusi virtuali tra i personaggi conferma la logica di fondo del sistema: il
rovinoso conflitto che irretisce l’eroe iracondo (il tenore Otello), la candida vittima (il soprano Desdemona), il sobillatore invidioso (il baritono Jago) si manifesta in una sequenza di folgoranti,
icastici quadri canori a solo, a due, a tre.
La «solita forma»
Anche l’organizzazione interna dei numeri chiusi ha le sue regole e convenzioni. Il critico musicale Abramo Basevi,
nella primissima monografia su Verdi
(1859), ha descritto en passant, dandola
per cosa ovvia e risaputa, «la solita
forma de’ duetti»: di norma, dice, dopo
una scena in recitativo abbiamo «un
tempo d’attacco, l’adagio, il tempo di
mezzo, e la cabaletta». Il tempo d’attacco
è un dialogo, via via più eccitato, tra i
due personaggi che si attraggono o si respingono. Nell’adagio i due rimuginano
tra sé, sfogano sentimenti vuoi concordi
vuoi discordi. Il tempo di mezzo arreca
qualche incidente nell’azione, l’arrivo di
una notizia dirompente, il suono d’una
campana o d’una fanfara o d’un coro
che da fuori scena annuncia un evento
incombente.
Al che i due personaggi in scena inne-
56
scano un movimento agitato e impetuoso, la cabaletta (l’etimo della parola è incerto). Ciascuno dei quattro tempi contiene almeno una grande, distesa melodia (di sedici o più battute): sono,
queste melodie che s’imprimono nella
memoria dell’ascoltatore, la stoffa più
pregiata del dramma cantato, i motivi
che poi si canticchiano per strada riandando con la mente alle situazioni
drammatiche che le hanno suscitate.
Ora, è improbabile che ogni melomane
sapesse descrivere per filo e per segno la
«solita forma de’ duetti», coi quattro tempi elencati da Basevi; o la forma delle arie
(dove di solito manca il tempo d’attacco),
delle romanze (dove manca la cabaletta),
dei finali d’atto (dove al posto dell’adagio
scatta il largo concertato, l’attimo di sbigottimento generale causato da un colpo
di scena). Ma ogni habitué del teatro
d’opera sente e segue con precisione il
decorso della forma, sa con esattezza
quando trattenere il fiato, quando abbandonarsi al piacere dell’ascolto e quando,
al termine della frenetica cabaletta, mentre rullano i timpani e rumoreggia il tutti
orchestrale, sfogare nell’applauso la tensione accumulata.
Verdi, ma prima di lui già Bellini e Donizetti, non è certo lo schiavo di questa
«solita forma»: d’intesa col librettista, che
nel dialogo gli predispone il tracciato
della musica, il compositore si vale di
questa forma standard per suscitare
«effetti» esaltanti, sorprendenti, frappanti. È libero di ricombinarne i tempi, di
ometterne qualcuno, di dilatarli, di
comprimerli: sarà la situazione drammatica, la ricerca di un «effetto» particolare,
a dettarglielo; ma ogniqualvolta l’osservanza dello schema risponde alla legge
dell’«effetto» teatrale, non ha motivo di
derogarne.
Un solo esempio. Nell’atto III di Aida il
feroce Amonasro (baritono) e l’accorata
protagonista intonano un vasto tempo
d’attacco e uno struggente adagio; il
duetto s’interrompe però al sopraggiungere di Radamès, il tenore, mentre
Amonasro «si nasconde fra i palmizi» a
origliare il dialogo dei due innamorati.
Il tenore, ignaro della presenza del suo
nemico, avvia da capo un duetto in
piena regola col soprano. Aida, col cuore
in tumulto, non può che stare al gioco:
il dialogo scorre tutti e quattro i tempi
regolamentari, culminando in un’estatica
cabaletta. Ora, l’impeto delle cabalette era
venuto in uggia ai critici, che le consideravano di cattivo gusto. Scrive Verdi al
suo librettista, Antonio Ghislanzoni:
«Io sono sempre d’opinione che le cabalette bisogna farle quando la situazione
lo domanda». E qui, appunto, la situazione lo domandava.
Lorenzo Bianconi
Università di Bologna
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI
A. Basevi, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi (1859), a cura di U. Piovano, Rugginenti, Milano 2001.
J. Budden, Le opere di Giuseppe Verdi, 3 voll., EDT, Torino 1985-1988.
F. Della Seta, voce Giuseppe Verdi, in Dizionario enciclopedico universale della musica
e dei musicisti. Le biografie, a cura di A. Basso, UTET, Torino 1988.
G. de Van, Verdi: un teatro in musica, La Nuova Italia, Scandicci 1994.
J. Rosselli, The Life of Verdi, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
F. d’Amico, Forma divina. Saggi sull’opera lirica e sul balletto, a cura di N. Badolato e L.
Bianconi, Olschki, Firenze 2012.
R. Mellace, «Con moltissima passione»: ritratto di Verdi, Carocci, Roma 2013.
Nuova Secondaria - n. 2 2013 - Anno XXXI