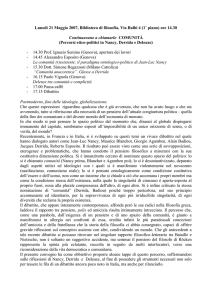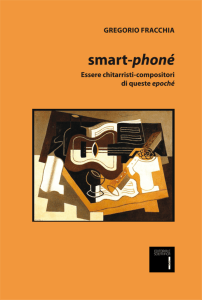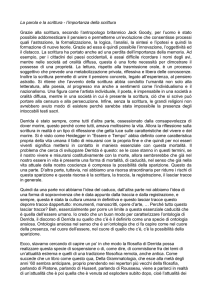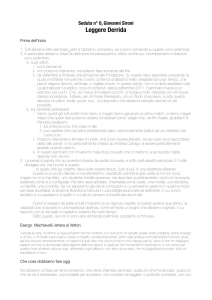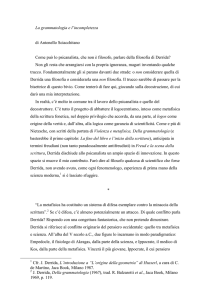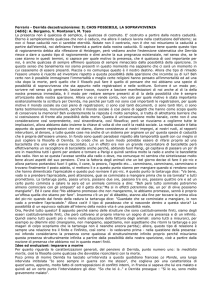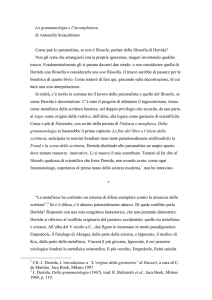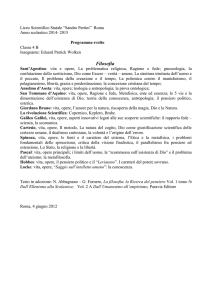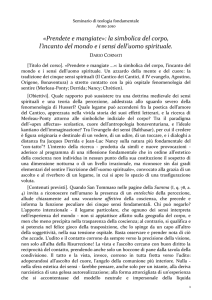Della Grammatologia di Jacques Derrida
a cura di
Roberto Terzi
Università degli Studi di Torino
Della grammatologia, pubblicata nel 1967, è uno dei
primi testi di Derrida, ma anche uno dei più celebri ed
importanti, sia per la fortuna che ha avuto, sia per il posto
particolare che occupa all’interno della produzione
derridiana: si tratta infatti di uno dei pochi testi in cui
Derrida, anziché mettere in opera la propria strategia di
pensiero a proposito di un determinato testo o di un
determinato concetto, illustra esplicitamente l’orizzonte
complessivo nel quale si colloca il suo pensiero e nel quale
assumono senso i suoi singoli saggi. Si tratta di un orizzonte storico e teorico insieme:
collocati al termine di una tradizione che si sta chiudendo (la metafisica, intesa come
insieme della storia della filosofia occidentale), ci si può volgere ad essa per individuarne
i limiti e avviarne la decostruzione; in particolare bisogna mostrare la determinatezza
storica dei concetti di parola e scrittura su cui questa tradizione si è fondata e il ruolo
che essi hanno svolto nella costruzione del suo edificio concettuale. Tutto ciò avviene nel
momento stesso in cui quella potente tradizione (occidentale) è sul punto di imporsi al
mondo intero con i suoi concetti di parola e scrittura, di ragione e logica. L’opera si
divide in due parti: nella prima viene delineato questo orizzonte complessivo del
progetto derridiano, nella seconda viene fornita un’esemplificazione delle tesi esposte
precedentemente. Nella prima parte possono inoltre essere individuate tre componenti:
l’interpretazione derridiana della storia della metafisica, il confronto con la linguistica
contemporanea,
l’elaborazione
dei
concetti
fondamentali
del
“programma”
grammatologico.
Nella lettura che Derrida compie della storia della metafisica emergono i primi concetti
fondamentali dell’opera: la tradizione si caratterizza, per Derrida, come logocentrismo e
fonocentrismo. Logocentrismo, perché la filosofia ha sempre attribuito un privilegio al
logos come sede della verità, cioè all’intelligibile piuttosto che al sensibile, all’interiorità
dell’anima piuttosto che all’esteriorità, fondandosi, in questa operazione, su determinati
concetti di “ragione”, “scientificità”, “logica”. Fonocentrismo, perché il luogo proprio di
questo logos viene individuato nella phoné, nella voce, in contrapposizione alla scrittura.
Come mostra il Fedro platonico, l’istituzione della filosofia come scienza e della verità
come suo oggetto va di pari passo con l’esaltazione della parola viva (il logos dell’anima)
contro la scrittura. Nell’ambito della distinzione tra significante e significato
(rispettivamente, il lato sensibile e il lato intelligibile di un segno), il fenomeno della
voce mostra alcuni caratteri particolari che, secondo Derrida, spiegano il privilegio
storico che essa ha ricevuto: a) la voce significativa, la lingua parlata, sembra
rispecchiare fedelmente, senza alterazioni e quindi nel modo migliore possibile i
significati intelligibili dell’anima o del soggetto: essa si dà quindi come un significante
peculiare, la cui funzione è quella di cancellarsi di fronte al significato come se fosse un
medium “trasparente”; b) inoltre io traggo questo significante non dall’esteriorità
sensibile del mondo, ma da me stesso, sono io stesso che parlo e mi trovo quindi in
relazione con un significante privilegiato in quanto non-mondano e non-empirico; c)
questo carattere essenziale della voce diventa visibile in quella che Derrida chiama
l’esperienza dell’“intendersi-parlare” (secondo il duplice senso del francese entendre):
parlando io mi sento parlare e mi capisco, sento e capisco ciò che dico e mantengo il
controllo di ciò che esprimo. Rispetto alla parola e a queste sue proprietà la scrittura,
per la tradizione metafisica inaugurata da Platone, è una duplicazione esteriore, che
sfugge al controllo dell’autore ed è capace di circolare in assenza di questo:
contrariamente al logos vivo dell’anima, al pensiero e alla parola con i quali il soggetto è
presso se stesso, la scrittura si presenta come qualcosa di fisso, morto ed esteriore. La
1
scrittura rappresenta l’istanza della morte e dell’assenza rispetto al logos vivo e
presente: per questo la filosofia l’ha relegata al ruolo di “segno di segno”, segno che
rimanda a quel segno che è a sua volta la parola, immagine esteriore di quest’ultima,
non essenziale e persino pericolosa. Questa dicotomia tra parola e scrittura non è un
tratto tra gli altri della filosofia, ma riguarda il suo senso complessivo: infatti secondo
Derrida, che su questo punto riprende una tesi fondamentale di Heidegger, il
fonocentrismo corrisponde al privilegio dell’essere come presenza, che ha caratterizzato
la storia della metafisica determinandone l’intero sistema concettuale. Il privilegio della
voce e la svalutazione della scrittura sono correlativi alla volontà di salvaguardare
l’essere come presenza stabile, che si tratti della presenza della cosa e della sua
sostanza o della presenza a sé della soggettività come autocoscienza; la voce viene
privilegiata in quanto significante che si cancella nel rispecchiamento del significato, ma
questo significa che ciò che si vuole salvaguardare è, in ultima analisi, la presenza pura
del significato, anteriore e indipendente rispetto a ogni segno e rimando. Da questa
presenza piena e dalla sua identità a sé bisognava rimuovere ogni traccia di assenza e di
differenza, delle quali la scrittura era il simbolo.
Da queste premesse diventa chiaro che lo stesso concetto di segno (unione di
significante e significato) non solo non è neutrale, ma è anzi solidale con la tradizione
metafisica nella quale è nato. Questo concetto implica infatti la distinzione di una faccia
sensibile e di una faccia intelligibile, nonché l’idea di un’interiorità (i significati dell’anima
o del soggetto) che si esprime nell’esteriorità di un significante; ma intelligibilesensibile, interiore-esteriore, soggettivo-oggettivo sono le coppie concettuali fondanti
della metafisica greca e moderna. Finché si mantiene la distinzione tra le due facce del
segno, resta aperta la possibilità di principio di pensare quello che Derrida chiama
“significato trascendentale”, cioè un significato pienamente presente, puro, indipendente
da qualsiasi significante. È a partire da questa consapevolezza che Derrida si volge ad
un confronto critico con la linguistica contemporanea e in particolare con il suo
fondatore, Ferdinand de Saussure, il cui testo viene sottoposto ad una doppia lettura.
Da una parte Saussure si mostra dipendente dalla metafisica logocentrica: utilizza il
concetto di segno senza consapevolezza dei suoi legami con la concettualità
tradizionale; determina la lingua parlata come unico oggetto della linguistica e
quest’ultima come modello di tutta la semiologia; svaluta la scrittura come immagine
esteriore della parola e rappresentazione derivata. Dall’altra parte certe descrizioni di
Saussure permettono di aprire una breccia nella chiusura metafisica, in particolare in
virtù del carattere arbitrario e differenziale che viene riconosciuto al segno; è a partire
da uno scavo progressivo di queste analisi saussuriane che Derrida fa emergere una
nuova concezione del rapporto tra parola e scrittura. In primo luogo, ogni sistema di
segni è caratterizzato dall’arbitrarietà e dalla convenzionalità; ma allora, argomenta
Derrida, non è possibile stabilire una gerarchia “naturale” tra parola e scrittura;
l’istituzione non-naturale di un segno è comune alla parola e alla scrittura. In secondo
luogo, se nella lingua (come in ogni sistema segnico) non ci sono termini “pieni”, perché
questi si costituiscono solo a partire dai rapporti di differenza che intrattengono
reciprocamente, l’attenzione dovrà concentrarsi non tanto su un determinato sistema
considerato come privilegiato (la lingua parlata) quanto sul movimento della differenza
che costituisce ogni sistema (lingua e scrittura nel loro senso comune). Inoltre, afferma
Derrida, la definizione di “segno di segno”, che la tradizione aveva riservato alla
scrittura, vale in realtà per ogni segno: ogni segno rimanda ad altri segni, senza che ci
sia un termine finale, puro e pienamente presente, in cui questo rimando si possa
arrestare. Tutta l’argomentazione derridiana mira a mostrare che, ad un’analisi più
profonda, alcuni caratteri che la metafisica aveva considerato propri della scrittura sono
in realtà comuni a questa e al linguaggio: entrambi mostrano un rapporto essenziale
con l’assenza e con la differenza.
I concetti fondamentali che Derrida a questo punto introduce e su cui lavora non sono
qualcosa di fisso e definitivo, ma hanno esplicitamente un valore “strategico” e sono
accompagnati da una particolare cautela metodologica, che consiste innanzitutto
nell’evitare nuove ricadute in quella tradizione che si vuole decostruire: 1)
l’archiscrittura indica quella “scrittura originaria” (arché= origine, principio) che sta al
2
fondo di ogni linguaggio e di ogni scrittura comunemente intesi, in virtù di quei caratteri
comuni mostrati in precedenza; questo concetto indica come per Derrida non si tratti
semplicemente di rovesciare il rapporto tra i termini di un’opposizione tradizionale
(privilegiando ad esempio la scrittura rispetto alla parola, il significante rispetto al
significato nell’accezione tradizionale di questi termini), perché questo rovesciamento
rimarrebbe all’interno della concettualità metafisica; piuttosto all’interno di
un’opposizione (lingua e scrittura) si tratta di assumere il termine che era stato
svalutato (la scrittura) e mostrarne la rimozione, rovesciare in un primo momento la
gerarchia, per poi produrre un nuovo concetto che non rientra più nell’opposizione
precedente (l’archiscrittura come movimento della differenza che sta al fondo tanto della
lingua quanto della scrittura nel loro senso tradizionale); 2) a partire da questa
rielaborazione concettuale Derrida avanza l’ipotesi di una nuova “scienza”, la
grammatologia, della quale sottolinea al tempo stesso l’importanza e i limiti: da un lato
essa risponderebbe all’esigenza di tematizzare il nuovo concetto di scrittura distinto da
quello tradizionale e la linguistica tradizionale ne sarebbe semplicemente una parte non
più dominante; dall’altro lato il progetto di una “grammatologia” è, in ultima analisi,
contraddittorio e impossibile: non ci può essere infatti una scienza che abbia come
proprio oggetto la scrittura, perché i valori occidentali di scientificità e di oggettività
sono stati resi possibili proprio dalla scrittura; l’archiscrittura, inoltre, non è un ente
presente che possa essere sottoposto allo sguardo teorico di una scienza. Il testo di
Derrida non è dunque semplicemente la proposta di una nuova disciplina, ma anche e
innanzitutto la problematizzazione dei suoi limiti intrinseci; 3) il concetto di traccia
rinvia, da un altro punto di vista, allo stesso ambito problematico dell’archiscrittura
(oltre che del famoso concetto di différance, esposto nell’omonima conferenza): nella
presenza c’è già sempre la traccia dell’assenza, nell’identità a sé la traccia dell’altro, nel
presente la traccia delle altre dimensioni temporali, nel linguaggio la traccia della
scrittura (in quanto archiscrittura), in un significato la traccia degli altri significati (per
cui non c’è significato puro, perché un significato rimanda agli altri ed è quindi anche
sempre significante); con il termine “traccia” Derrida indica proprio l’impossibilità di
stabilire una separazione netta e pura tra questi ambiti differenti, la contaminazione tra
un termine dell’opposizione e l’altro. Le conseguenze si estendono così all’intero campo
dell’esperienza: si tratta di pensare l’ente e la presenza a partire dalla traccia e dalla
differenza e non viceversa, come ha sempre preteso di fare la metafisica. La traccia e la
différance non sono qualcosa di aggiunto rispetto a quelle coppie di opposti, ma indicano
il movimento attivo di differenziazione che le costituisce originariamente. Per questo
Derrida utilizza anche l’espressione “architraccia”. In un primo momento è necessario
parlare di “architraccia”, cioè di una traccia “originaria”, per contrastare la strategia
metafisica che subordina la traccia e la differenza alla presenza e per affermare la
priorità di quelle rispetto a questa; ma affermare che “la traccia è l’origine assoluta del
senso in generale” equivale a dire in realtà che “non c’è origine assoluta del senso in
generale”, perché “origine” ha sempre voluto dire presenza piena e semplice, non
intaccata dalla traccia. Il concetto di “architraccia” ha quindi in realtà una funzione
strategica e provvisoria e deve essere superato perché in ultima analisi contraddittorio:
il suo vero scopo è proprio quello di condurre alla critica del concetto di “origine” in
generale.
Nella seconda parte della Grammatologia Derrida “esemplifica” le proprie tesi attraverso
la lettura decostruttiva dei testi dedicati alla scrittura da Lévi-Strauss e Rousseau. Le tesi
che Lévi-Strauss presenta come frutto di “lavoro sul campo” sono in realtà, per Derrida,
pesantemente condizionate dall’eredità metafisica logocentrica, nella loro pretesa di
indicare la scrittura come fonte di corruzione e di malvagità nelle comunità selvagge.
Lévi-Strauss, mantenendo la distinzione tra natura e cultura, vagheggia un ideale di
società pura, una presenza non ancora contaminata dalla violenza della storia e della
scrittura. Le tesi dell’antropologo francese mostrano forti analogie con quelle di
Rousseau, di cui Derrida prende in esame numerosi passi delle Confessioni e soprattutto
il Saggio sull’origine delle lingue, testi nei quali si trova un’analoga condanna della
scrittura. Derrida concentra la sua attenzione in particolare sul concetto di supplemento
e sulle molteplici figure che assume nel testo di Rousseau: la scrittura come
3
supplemento rispetto alla parola, la società rispetto alla natura, l’autoerotismo rispetto
all’erotismo “normale”. Da una parte Rousseau cerca costantemente di individuare una
presenza piena e originaria, rispetto alla quale i vari supplementi sarebbero
semplicemente un’aggiunta esteriore, non essenziale e spesso pericolosa. Dall’altra
parte, tuttavia, nelle sue descrizioni non può fare a meno di riconoscere che la presenza
è già sempre venuta a mancare a se stessa, che il supplemento è essenziale e
necessario, che non è quindi possibile stabilire opposizioni concettuali nette e pure tra il
dentro e il fuori: se il “fuori” può influenzare il “dentro” è perché è interiore al “dentro” e
contribuisce a costituirlo. Derrida delinea così il compito di pensare un “supplemento
originario”, idea contraddittoria e inconcepibile per la logica classica dell’identità.
<http://lgxserver.uniba.it/lei/filosofi/schedeopere/derrida.htm>
Scheda su Jacques Derrida a cura di Vincenzo Costa
Jacques Derrida nasce il 15 luglio 1930 a El Biar, presso Algeri, da una famiglia
ebraica. Proprio per questo, durante gli anni della Seconda guerra mondiale conoscerà le
discriminazioni derivanti dalle leggi razziali emanate dal regime di Pétain. In gioventù
entra in contatto con le correnti più vive della cultura francese e con le esperienze
politiche dell’estrema sinistra non comunista. L’impegno politico resterà una costante
della sua personalità, e lo porterà negli anni seguenti a impegnarsi a favore del dissenso
nella ex Cecoslovacchia comunista o a favore del movimento antirazzista in Sudafrica.
Derrida prende senza dubbio le mosse dalla fenomenologia trascendentale di Husserl,
riflettendo sulla quale fa emergere la propria originale posizione1[1]. Tuttavia, che il
suo pensiero possa ancora essere inquadrato anche solo in senso lato all’interno della
fenomenologia non è per niente ovvio. Derrida, infatti, ha costantemente cercato di
mostrare come la ragione sia il risultato di un insieme di forze e come essa sia radicata
in certi idiomi, in certe strutture segniche determinate e circoscritte, poiché a suo parere
non vi è alcun significato puro, cioè indipendente dal significante attraverso cui noi ci
possiamo rapportare ad esso. L’idea di un significato puro, che esiste prima e fuori del
tempo, dunque di una verità stabile, è un’idea caratteristica della metafisica occidentale
che Derrida, seguendo Heidegger, determina come una metafisica della presenza. Proprio
perché crede in una struttura pura del significato e dunque della ragione, la filosofia
appartiene a ciò che Derrida chiama “logocentrismo”, il cui carattere consisterebbe
appunto nel rivendicare il privilegio del logos rispetto ad altre forme di produzione del
senso, invece di interrogarsi sulle origini “non logiche” della stessa logica, e dunque
della razionalità.
Opponendosi a questa metafisica, che ha sempre considerato il segno come qualcosa
che sopraggiunge ai significati, Derrida, utilizzando la lezione dello strutturalismo, ha
messo in luce che il significato non può darsi senza segni, e che dunque non vi sono
significati in sé, ma solo tracce di tracce2[2]. Per questo, questa metafisica deve essere
decostruita. Occorre cioè fare emergere ciò che essa ha dovuto emarginare e occultare
per poter fare stabilire l’idea di un puro significato che esiste indipendentemente dal
segno. Ed in questa direzione emerge che il logocentrismo è solidale con il
fonocentrismo. La metafisica ha cioè pensato che dapprima vi è un significato puro, poi
una sua espressione con la voce, che viene considerata un segno naturale, e poi una
sua trascrizione attraverso la scrittura, che viene considerata dalla tradizione metafisica
un segno innaturale, perché mentre nella voce il significato non si allontana da chi parla,
con la scrittura il segno può essere iterato in nuovi contesti, esponendosi così al
fraintendimento e alla perdita. L’idea della metafisica è in altri termini che vi sia un
significato puro, e che l’incomprensione, lo slittamento di significato sia colpa del
significante, ed in particolare del significante scritto. Al contrario, Derrida intende
4
mostrare che il segno scritto non è qualcosa in cui viene depositato un significato che
esiste già, ma è proprio ciò che costituisce il significato, il quale dipende dunque da un
certo di scrittura. E questo significa che non vi è una ragione universale, perché la
ragione è legata al grafema e alle differenze che strutturano le catene grafiche.
Liberarsi dal logocentrismo significa però anche abbandonare l’idea che la storia sia una
teleologia, un percorso attraverso cui ci avviciniamo alla verità. Al contrario, la nozione
di teleologia deve essere sostituito da quello di disseminazione. Non vi è un
avvicinamento alla verità perché non c’è niente da raggiungere. Esistono solo contesti
circoscritti determinati da certi tipi di scrittura, dunque universi di discorso. E noi
viviamo in un contesto determinato dalla scrittura alfabetica, che ha prodotto quelle idee
che sono caratteristiche dell’Occidente: l’idea di verità, la sua logica basata sulle leggi di
conseguenza tra premessa e conseguenza, che si basano sulla linearità di questa
scrittura etc. In questo modo, la decostruzione avvia una critica che mira a dissolvere
l’eurocentrismo, e cioè l’idea secondo la quale la cultura occidentale è superiore alle
altre, perché è depositaria dell’idea di ragione. Di questo modo di pensare Derrida ha
poi denunciato le implicazioni filosofiche e politiche, segnalando quella confusione che fa
si che l'occidente rappresenti se stesso come la punta avanzata, il modello guida di
un’umanità autentica3[3].
4[1] Cfr. in particolare J. Derrida, Il problema della genesi nella filosofia di Husserl, tr.
it. di V. Costa, Jjaca Book, Milano 1992, Introduzione a “L’origine della geometria” di
Husserl, tr. it. di C. Di Martino, Jaca Book, Milano 1987, La voce e il fenomeno.
Introduzione al problema del segno nella fenomenologia di Husserl, tr. it. di G.
Dalmasso, Jaca Book, Milano 1997. Per un’analisi più ampia dei rapporti che Derrida
intrattiene con la fenomenologia trascendentale d Husserl si veda V. Costa, La
generazione della forma. La fenomenologia e il problema della genesi in Husserl e in
Derrida, Jaca Book, Milano 1996.
<http://www.swif.uniba.it/lei/filosofi/autori/derrida-scheda.htm>
5[2] Cfr. su ciò J. Derrida, Della grammatologia, tr. it. di G. Dalmasso e altri, Jaca Book,
Milano 1998.
6[3] J. Derrida, Oggi l'Europa, trad. it. di M. Ferraris, Garzanti 1991, p. 22.
5