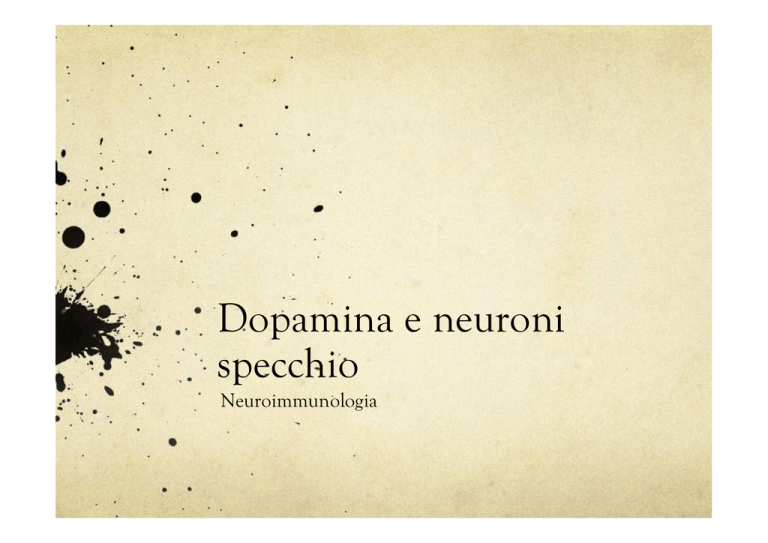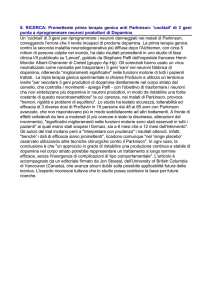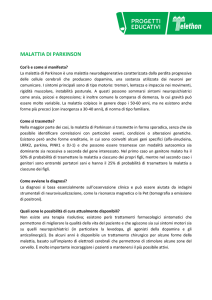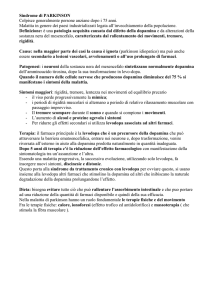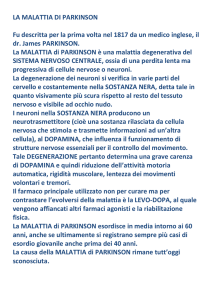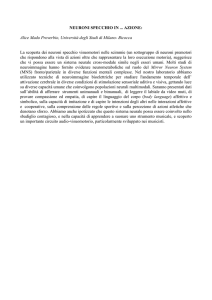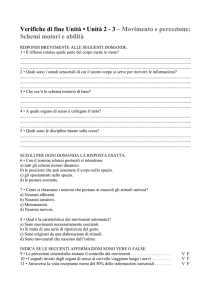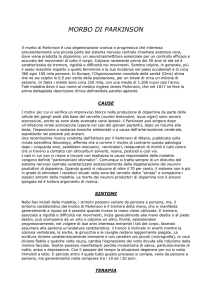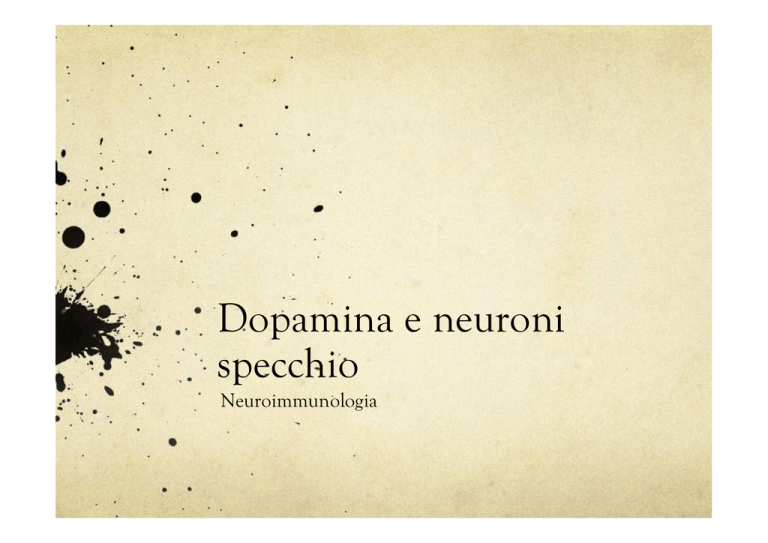
Dopamina e neuroni
specchio
Neuroimmunologia
Recettori dopaminergici
La dopamina si lega a recettori metabotropici
associati
alla
proteina
G,
espressi
prevalentemente nel sistema nervoso centrale.
Tali recettori sono implicati in molti processi
neurologici: motivazione, piacere, cognitività,
memoria, memoria spaziale, emozioni,
apprendimento, controllo motorio fine e
modulazione del segnale neuroendocrino.
I recettori per la dopamina
I due principali tipi di recettori per la dopamina sono il recettore D1 ed il
recettore D2.
La famiglia dei recettori D1 comprende i recettori D1 e D5, mentre la
famiglia D2 comprende i tipi D2, D3 e D4.
La funzione di modulazione delle via diretta ed indiretta del circuito
motorio extrapiramidale esercitato dalla dopamina, si estrinseca mediante
l’interazione con i recettori D1 e D2.
I recettori per la dopamina sono legati a proteine G a formare un complesso
che interagisce con l’adenilciclasi per controllare del secondo messaggero,
l’AMP ciclico.
I recettori della famiglia D1 provocano l’aumento dell’AMP ciclico, mentre
quelli appartenenti alla famiglia D2 ne comportano la riduzione.
L’attivazione dei recettori D2 è importante nella risposta antiparkinsoniana
ai farmaci agonisti della dopamina. Il ruolo dell’attivazione dei memore D2
nella risposta alla terapia medica non è completamente noto.
Ruolo recettoriale
Una delle funzioni più importanti di queste
molecole trasduttrici è il controllo del
comportamento.
I molteplici ruoli sono il riflesso della loro
diversa struttura (sono classificati da D1 a D7)
e della particolare densità nelle aree cerebrali.
I farmaci antagonisti della dopamina sono
utilizzati come anti-psicotici, mentre gli agonisti
agiscono come psico-stimolanti.
Dopamina extra-cerebrale
Fuori del SNC i recettori della dopamina svolgono
importanti funzioni nel sistema cardiopolmonare. Le
arterie polmonari, ad esempio, esprimono i sub-tipi
D1, D2, D4 e D5, i quali permettono l’effetto di
vasodilatazione della dopamina nel sangue.
I D4 sono stati osservati negli atri e sono associati alla
contrattilità del cuore e della frequenza cardiaca. Una
densità alta è stata, inoltre, dimostrata nei tubuli
prossimali, nei glomeruli e nelle fibre simpatiche dei
reni, con segnali che influenzano la diuresi e la
natriuresi.
Patologia
In patologia il recettore D4 è stato associato al deficit
di attenzione e iperattività (ADHD) e anche alla
schizofrenia, anche se le opinioni, al riguardo, non
sono uniformi. La teoria di una amplificata trasduzione
del segnale dopaminergico, nella psicosi delirante
mantiene, tuttavia, una larga considerazione.
Droghe, quali amfetamina e cocaina inducono
drammatiche stimolazioni del recettore e, qualora le
dosi siano eccessive, i sintomi che ne derivano sono
molto simili a quelli della schizofrenia.
Patologia
I recettori della dopamina sono stabili.
Tuttavia, i diversi farmaci possono attenuare o
amplificare la loro espressione funzionale. La
sotto-regolazione, dovuta agli psico-stimolanti si
associa a perdita di interesse nelle attività
altrimenti piacevoli e attenzione diminuita.
Gli anti-psicotici, invece, sovra-esprimono i
recettori e inducono tardiva discinesia, con
contrazioni involontarie.
Parkinsonismo
La sindrome extrapiramidale è una della più
importanti conseguenze dell’uso di neurolettici.
Inizialmente si manifesta rigidità muscolare e acinesia,
che arriva, in un trattamento prolungato, a una
discinesia irreversibile.
Tale condizione è molto simile alla perdita di recettori
e dopamina nel Parkinsonismo, nell’area cerebrale più
rappresentata del sistema dopaminergico, ossia la
substantia nigra dei gangli basali.
Dopamina
Prodotta dai neuroni dopaminergici a partire dal precursore
tirosina.
Recettore D2
Se stimolato:
Se bloccato:
Cura per il
Parkinson
Cura per la
Schizofrenia
Circuiti dopaminergici
Mesolimbico
Nigrostriatale
Mesocorticale
Tuberoinfundinbolare
Circuiti dopaminergici
1.
Nigrostriatale: controlla i movimenti.
2.
Mesolimbico: coinvolto nelle sensazioni di piacere,
euforia e nei sintomi positivi (deliri, allucinazioni).
3.
Mesocorticale: coinvolto nei sintomi positivi,
negativi e in quelli cognitivi.
4.
Tubero-infundimbolare: controlla secrezione di
prolattina (PRL).
Schizofrenia
disintegrazione dell’identità,
dissociazione fra i processi di pensiero,
dissociazione fra pensiero e affettività,
dissociazione fra pensiero, affettività e volizione.
La schizofrenia comporta sempre:
1)
Alterazione dell’identità dell’Io;
2)
Disturbo dei processi di pensiero;
3)
Incoerenza affettiva secondo i criteri del buon senso comune.
Schizofrenia
Sintomi positivi
Deliri
Allucinazioni
Distorsioni nel linguaggio e nella comunicazione
Eloquio disorganizzato
Comportamento disorganizzato
Comportamento catatonico
Agitazione
Schizofrenia s. negativi
Appiattimento affettivo; ritiro emotivo
Povertà di relazione; ritiro sociale
Perdita di spontaneità
Pensiero stereotipato; alogia
Avolizione; anedonia
Compromissione attentiva
Schizofrenia
Sintomi cognitivi
Incoerenza
Perdita dei nessi associativi
Neologismi
Ridotta attenzione
Schizofrenia
Sintomi di aggressività
Ostilità
Abuso verbale
Abuso fisico
Comportamento autolesivo
Impulsività
Acting out sessuale
Schizofrenia
Sintomi depressivi/ansiosi
Umore deflesso
Senso di colpa
Tensione
Irritabilità
Preoccupazione
Antipsicotici tradizionali
Haldol, Serenase (aloperidolo)
Largactil (clorpromazina)
Moditen Depot (flufenazina)
Orap (pimozide)
Leponex (clozapina)
Sulamid, Soliam (amisulpiride)
Antipsicotici atipici
Risperdal (risperdone)
Zyprexa (olanzapina)
Seroquel (quetiapina)
Abilify (aripiprazolo)
Aloperidolo
(Haldol, Serenase)
Indicazioni
Trattamento della schizofrenia.
Meccanismo d’azione
Blocca recettori D2: sintomi positivi e
comportamenti reattivi.
Aloperidolo
(Haldol, Serenase)
Effetti collaterali
Sintomi extrapiramidali, parkinsonismo,
discinesia tardiva;
Sedazione;
Aumento ponderale;
Galatorrea;
Secchezza delle fauci, stipsi, ritenzione urinaria;
Ipotensione, tachicardia.
Deniban, Sulamid, Solian
(amisulpiride)
Indicazioni
Schizofrenia acuta e cronica.
Distimia.
Meccanismo d’azione
A bassi dosaggi blocca D2 presinaptici; a alti dosaggi
blocca D2 postsinaptici.
sintomi positivi e comportamenti reattivi.
Può migliore i sintomi negativi.
Largactil
(clorpromazina)
Indicazioni
Schizofrenia acuta a cronica.
Mania acuta.
Nausea, vomito.
Singhiozzo intrattabile.
Disturbi aggressivi e/o esplosivi nei bambini e adolescenti.
Disturbi associati a problemi di controllo degli impulsi.
Meccanismo d’azione
Agonismo parziale dei
comportamenti reattivi.
D2:
Blocco H1 e M: vomito e nausea.
sintomi
positivi
e
Leponex
(clozapina)
Indicazioni
Schizofrenia resistente al trattamento.
Disturbo bipolare resistente al trattamento.
Pazienti aggressivi e violenti.
Meccanismo d’azione
Blocco dei D2: sintomi positivi e
comportamenti reattivi.
Zyprexa
(olanzapina)
Indicazioni
Schizofrenia acuta a cronica.
Mania acuta.
Disturbi aggressivi e/o esplosivi nei bambini e
adolescenti.
Disturbi associati a problemi di controllo degli
impulsi.
Meccanismo d’azione
Blocco dei D2: sintomi positivi e comportamenti
reattivi.
Seroquel
(quetiapina)
Indicazioni
Schizofrenia acuta a cronica.
Mania acuta.
Disturbi aggressivi e/o esplosivi nei bambini e adolescenti.
Disturbi associati a problemi di controllo degli impulsi.
Meccanismo d’azione
Blocco dei D2: sintomi positivi e comportamenti reattivi.
Risperdal
(risperidone)
Indicazioni
Schizofrenia acuta a cronica.
Mania acuta.
Disturbi aggressivi e/o esplosivi nei bambini e adolescenti.
Disturbi associati a problemi di controllo degli impulsi.
Meccanismo d’azione
Blocco dei D2: sintomi positivi e comportamenti reattivi.
Effetti collaterali: meccanismi
Recettori D2
Blocco dei D2 nello striato: sintomi motori
extrapiramidali.
Blocco dei D2 nell ’ ipofisi: aumento della
prolattina.
Blocco dei D2 nei circuiti mesocorticale e
mesolimbico: peggioramento dei sintomi cognitivi
e negativi.
Gli psicofarmaci agiscono sul sistema nervoso e modificano il
comportamento
n I farmaci psicoattivi: sono quelli che agiscono sul sistema nervoso centrale, interferendo con i processi
connessi alla trasmissione sinaptica quali la sintesi enzimatica del neurotrasmettitore, il suo immagazzinamento nelle
vescicole sinaptiche, il suo rilascio nella fessura sinaptica, la sua interazione con i recettori post-sinaptici, la conseguente
apertura dei canali ionici nella membrana post-sinaptica, la ricaptazione del neurotrasmettitore nella membrana presinaptica e la deattivazione di esso da parte di enzimi specifici
Fig. 4.6 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003
Farmaci con azione agonista o antagonista a quella dei
neurotrasmettitori
nAzione dei farmaci: può
essere agonista (azione simile) o
antagonista (opposta) rispetto
all’azione del neurotrasmettitore
nI
farmaci ad azione
agonista: possono aumentare la
disponibilità del precursore del
neurotrasmettitore, stimolare
l’enzima che attua la biosintesi del
neurotrasmettitore, aumentare
l’immagazzinamento del
neurotrasmettitore nelle vescicole
sinaptiche, stimolare o il rilascio
del neurotrasmettitore, ritardare la
ricaptazione, oppure deattivare gli
enzimi che degradano il
neurotrasmettitore
nI
farmaci ad azione
antagonista: hanno un’azione
opposta e riducono la disponibilità
del neurotrasmettitore a livello del
suo sito d’azione
Fig. 4.5 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003
Neurotrasmissione mediante glutammato (eccitatoria) e
GABA-glicina (inibitoria)
n Tipi di neurotrasmettitori: vi sono molti neurotrasmettitori, ognuno dei quali interagisce con un recettore
specializzato Neurotrasmissione tra neuroni: è principalmente svolta mediante un neurotrasmettitore
eccitatorio (glutammato) e due neurotrasmettitori inibitori (GABA in tutto il cervello; glicina nel tronco dell’encefalo e
nel midollo spinale)
Figg. 12.13 e 4.12 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003
Neuromodulazione
n I neuromodulatori: hanno effetti su interi circuiti neurali che sovrintendono specifiche funzioni
nVisione funzionale d’insieme dei principali neuromodulatori: l’acetilcolina è un
neurotrasmettitore che facilita l’apprendimento di informazioni che sono trasmesse tramite il glutammato e il GABA. La
noradrenalina (o norepinefrina) aumenta lo stato attentivo, definito come prontezza nel percepire e rispondere. La
serotonina riduce le possibilità di risposte impulsive e aggressive. La dopamina agisce su alcune parti del cervello che
facilitano lo svolgimento di movimenti, in altre parti del cervello rinforza i movimenti che hanno determinato un premio
o eliminato uno stimolo disturbante
nClassificazioni. Catecolamine: dopamina, adrenalina e noradrenalina. Monoammine: dopamina, l’adrenalina, la
noradrenalina, e la serotonina (indolamine). Monoamisossidasi (MAO):enzimi che disattivano le monoammine all’interno del
bottone sinaptico e nel sangue. Gli inibitori della MAO aumentano la disponibilità delle monoammine
Tab..4.2 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003
L’Acetilcolina favorisce i processi di apprendimento e
memorizzazione
n Acetilcolina: è il neurotrasmettitore usato dai
motoneuroni spinali e dai neuroni spinali pregangliari e postgangliari (sola divisione parasimpatica) del sistema nervoso
autonomo. Induce sulla membrana potenziali post-sinaptici
eccitatori o inibitori a seconda del tipo di recettore. Nel cervello
i neuroni acetilcolinergici originano nel ponte del
troncoencefalo (neuroni “on” che iniziano le fasi REM del
sonno, quello con i sogni più vividi), nel proencefalo basale del
tronco dell’encefalo (neuroni che facilitano l’apprendimento) e
nel setto del sistema limbico (neuroni che facilitano la
memorizzazione)
nAgonisti dell’acetilcolina: il veleno della vedova
nera stimola un eccesso di rilascio. Altre sostanze inibiscono
l’enzima (acetilcolinesterasi) che degrada l’acetilcolina sulla
membrana post-sinaptica, aumentando gli effetti
dell’acetilcolina. Vi sono due tipi di recettori per l’acetilcolina.
Il recettore nicotinico (ad esempio, quello presente sui muscoli
volontari) è stimolato dalla nicotina. Il recettore muscarinico
(ad esempio, quello presente sui neuroni post-gangliari del
sistema autonomo) è stimolato da un fungo velenoso
nAntagonisti dell’acetilcolina: la tossina botulinica
impedisce il rilascio di acetilcolina. Il farmaco atropina blocca i
recettori muscarinici. Il curaro blocca i recettori nicotinici
Tab. 4.1 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003
La dopamina facilita funzioni motorie, di gratificazione e
di motivazione
n Dopamina: è un neuromodulatore usato in circuiti motori, dell’attenzione, dell’apprendimento legato al successo
o all’insuccesso dell’azione (stimolo di rinforzo)
n I neuroni “motori”: originano nel nucleo della sostanza nera del mesencefalo e inviano assoni a nuclei dei
gangli della base
nI neuroni “della gratificazione”: originano nel sistema mesolimbico dall’area tegmentale del mesencefalo e
terminano nel nucleo accumbens dei gangli della base, nell’amigdala e nell’ippocampo
nI neuroni “della motivazione-memoria-pianificazione”: originano nel sistema mesocorticale
dall’area tegmentale del mesencefalo e terminano nella regione prefrontale della corteccia cerebrale
Tab. 4.3 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003
I farmaci che agiscono sul sistema dopaminergico influenzano
movimento e comportamento finalizzato
n Morbo di Parkinson e dopamina: il Morbo di Parkinson (sintomi:
rigidità muscolare, tremore, lentezza nei movimenti e difficoltà ad
iniziare il movimento) è dovuto ad una ridotta produzione di
dopamina da parte del sistema sostanza nera mesencefalica-gangli della
base
n L-dopa: è un farmaco precursore della dopamina (agonista) che
allevia i sintomi del Morbo di Parkinson
n Schizofrenia e dopamina: la Schizofrenia (allucinazioni, manie,
irrazionalità del pensiero) è dovuta ad una eccessiva disponibilità di
dopamina da parte del sistema mesocorticale (tegmento mesencefalicocorteccia prefrontale)
n Clorpromazina e clozapina: sono farmaci (antagonisti) che bloccano i
recettori della dopamina e alleviano i sintomi della Schizofrenia
I farmaci agonisti e antagonisti della dopamina
n Agonisti della dopamina: anfetamina, cocaina e metilfenidato inibiscono la ricaptazione della dopamina
(e/o noradrenalina) lasciando più neuromodulatori nella sinapsi (effetto: eccitante-motivante, gratificazione, dipendenza)
nAntagonisti della dopamina: il farmaco reserpina impedisce il riempimento di dopamina (noradrenalina e
serotonina) nelle vescicole sinpatiche e quindi riduce la quantità dei neuromodulatori nella sinapsi (effetto calmante,
depressivo)
Tab. 4.4 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003
I farmaci che agiscono sul sistema noradrenergico
influenzano lo stato generale di attivazione cerebrale
n Noradrenalina (o norepinefrina): è il neurotrasmettitore usato da neuroni i cui corpi si trovano in 7
nuclei di midollo, ponte e talamo. Il nucleo più importante è il locus ceruleus nel ponte del tronco dell’encefalo. E’ usato
anche dai neuroni post-gangliari (divisione simpatica) del sistema nervoso autonomo. Induce sulla membrana neuronale
potenziali post-sinaptici eccitatori o inibitori a seconda del tipo di recettore. La noradrenalina è usata in circuiti neurali
correlati all’attenzione e all’attivazione cerebrale
n Agonisti della noradrenalina: anfetamina e cocaina (inibisce la ricaptazione del neurotrasmettitore); la
clonidina (stimola i recettori noradrenergici). Gli effetti sono simili a quelli dell’attivazione simpatica e al senso di risveglio
ed euforia
n Antagonisti della noradrenalina: la reserpina impedisce l’immagazzinamento di noradrenalina (serotonina
e dopamina) nelle vescicole sinaptiche (effetto calmante, depressivo)
Tab. 4.5 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003
I farmaci che agiscono sul sistema serotoninergico
influenzano lo stato generale di attivazione cerebrale
n Serotonina (5-HTP): è un neuromodulatore usato nel controllo dell’umore, dell’appetito, del sonno,
dell’attivazione cerebrale (arousal) e del dolore. Nel cervello i neuroni serotoninergici originano nei nuclei della linea
mediana del tronco dell’encefalo (rafe) a livello di mesencefalo, ponte e bulbo (neuroni che inviano assoni alla corteccia
cerebrale, ai gangli della base e all’ippocampo)
n Agonisti della serotonina: la fluoxetina (Prozac) inibisce la ricaptazione e aumenta la disponibilità della
serotonina. E’ usata per il trattamento della depressione, dell’ansia e dei disturbi ossessivo-compulsivi. La fenfluramina
causa il rilascio di serotonina e ne inibisce la ricaptazione: e’ usato come soppressore dell’appetito negli obesi.
Antagonisti della serotonina: la reserpina inibisce l’immagazzinamento della serotonina (noradrenalina e
dopamina) nelle vescicole sinaptiche, riducendone la disponibilità (effetto calmante, depressivo). La dietilamide dell’Acido
lisergico (LSD) e’ un potente allucinogeno con effetti simili a quelli dei funghi allucinogeni messicani; stimola recettori
pre-sinaptici che inibiscono il sistema serotoninergico. L’inibizione del sistema serotoninergico induce il pensiero onirico
che è simile a quello indotto da allucinogeni
Tabella 4.6 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003
Neuroni specchio
Letteratura
Curr Dir Psychol Sci. Author manuscript; available in
PMC 2008 May 5.
Published in final edited form as:
Curr Dir Psychol Sci. 2008 April; 17(2): 136–141.
Adele Diamond1 and Dima Amso2
Neurotrasmettitori mirror
Alcune testimonianze convergono sulla possibilità che i
neuroni specchio utilizzino, principalmente la
dopamina, come neurotrasmettitore.
Fenomeno delle “associazioni non cognitive”.
Autismo, ADHD, schizofrenia, parkinsonismo.
Correlazione con la sostanza P nella diffusione del
segnale tra substantia nigra e corpo striato e corteccia
pre-frontale.
INTRODUZIONE
Dati
raccolti
negli
ultimi
decenni
sull’osservazione
dell’INTERAZIONE MADRE-BAMBINO nella prima infanzia
sostengono l’idea che il bambino sia dotato già in uno stadio precoce
di
un’
INNATA
CAPACITA’
DI
IMPEGNO
INTERSOGGETTIVO
IL SISTEMA DEI NEURONI
sostenimento neuronale a questa
“EMBODIED SIMULATION” che
l’IMITAZIONE
e
di
RAPPRESENTAZIONALI
A SPECCHIO costituisce il
capacità che viene chiamata
ha la funzione di permettere
generare
CONTENUTI
Ciò costituisce un punto di rottura con l’eredità Piagetiana e
Freudiana ancorata ad una concezione egocentrica
Circa
10 anni fa Rizzolatti e Colleghi scoprirono una
CLASSE DI NEURONI VISUOMOTORI PREMOTORI:
I MIRROR NEURONS (neuroni a specchio)
I primi ad essere scoperti furono i M.N. collegati all’azione
della mano
I M.N. si attivano:
quando la scimmia esegue AZIONI-META della mano
(es. afferare un oggetto)
quando OSSERVA ALTRI individui fare le stesse azioni
I M.N. si collocano in una sezione della CORTECCIA
PARIETALE POSTERIORE connessa con l’AREA F5 (parte
rostrale della corteccia ventrale premotrice delle scimmie)
LA PIU’ INTERESSANTE PROPRIETA’ DEI M.N.: una buona
congruenza tra le AZIONI OSSERVATE e quelle ESEGUITE nella
loro attivazione
IPOTESI DERIVANTE: i M.N., dalla combinazione dell’azione
osservata con quella eseguita, permettono la comprensione delle
azioni prodotte dagli altri
CAPACITA’ DERIVANTE: riconoscimento di
1) MODELLI MOTORI OSSERVATI
2) META INTENZIONALE DELL’ AZIONE OSSERVATA
Siamo in grado di comprendere la meta dell’azione eseguita da un
altro perché vi è una combinazione di:
AZIONE OSSERVATA
+
INTERNA RAPPRESENTAZIONE DI ESSA
dotata della conoscenza della meta
Ulteriori studi mostrarono:
Gli F5 M.N. si attivano anche quando la parte finale
dell’azione osservata è nascosta
Una classe di F5 M.N. “audio-visual mirror neurons”
possono essere attivati anche dal suono prodotto da
una stessa azione eseguita o osservata in precedenza
Esiste dunque uno STESSO SUBSTRATO
NEURONALE all’interno del quale vengono rilegati
differenti eventi e il loro differente modo di presentarsi
UN MECCANISMO FUNZIONALE AD UN LIVELLO
ASTRATTO, GENERALE (a form of conceptualitation)
In un recente studio s’è visto che i M.N. possono generalizzare la
meta di un’azione
motorio delle scimmie
ad azioni che non sono nel repertorio
Ciò che viene CODIFICATO ad un livello molto astratto, è la meta di
un’azione anche se la scimmia non è capace di riprodurla
Supporta l’idea che la descrizione sensoria degli stimoli sociali
osservati è strettamente relazionata con la conoscenza sensoria
motoria dell’osservatore
La CAPACITA’ DEI M.N. di connettere
l’ OSSERVATO INDIVIDUALE
implica:
con
l’ OSSERVATORE
LA COMPRENSIONE/RICONOSCIMENTO DELLE AZIONI
non implica: UN’INTERAZIONE DIRETTA CON ALTRI INDIVIDUI
Il
sistema dei M.N. si arricchisce e si complica di un
ulteriore scoperta: UNA NUOVA CATEGORIA DI M.N. che
vengono
associati
al
sistema
combinatorio
osservazione/esecuzione PER L’AZIONE DELLA BOCCA
La maggior parte di questi MOUTH MIRROR NEURONS
rispondono/si attivano all’osservazione di azioni ingestive
(es: mordere, strappare coi denti, leccare, etc)
Questi mostrano la stessa SPECIFICITA’ DEI M.N. per
l’azione della mano
non rispondono alla semplice presentazione dell’oggetto o
alle azioni mimate della bocca ma
SOLO AD UNA SPECIFICA AZIONE FINALIZZATA
Una
piccola percentuale dei M.M.N. invece si attivano
solo durante l’osservazione delle AZIONI FACCIALI
COMUNICATIVE
(es: schiocco delle labbra, labbra protese, lingua protesa)
Molti
di
questi
rispondono
all’esecuzione delle azioni ingestive
comunque
anche
E’ stato ipotizzato che:
la presenza dei M.M.N. è indicativa per l’esistenza di un
sistema originato per comprendere I MOVIMENTI DELLA
BOCCA
E successivamente è stato utilizzato per sviluppare un
SISTEMA
COMUNICATIVO
complesso ed evoluto
ORO-FACCIALE
più
LA PROPRIETA’ DEI M.M.N. e in particolare di quelli di TIPO
COMUNICATIVO: permettere un accesso più completo verso l’altrui
esperienza
Ciò avviene grazie all’ampliamento della stessa conoscenza del corpo
relazionato dell’osservatore (observer’s own body related knowledge) verso le
azioni oro facciali
PUO’ IMPLICARE LA PARTECIPAZIONE DIRETTA DELL’OSSERVATORE
IN UNA COMUNICAZIONE DIADICA
VI E’ DUNQUE UNA NUOVA PROPRIETA’ DEL SISTEMA M.N.:
Il corso delle informazioni sociali non è solo unidirezionale
(dall’agente osservato all’osservatore)
ma CIRCOLARE
Ciò comporta UN RECIPROCO SCAMBIO BI-DIREZIONALE:
UNA MATRICE DI INTERSOGGETTIVITA’ (Stern)
Diversi studi dimostrano l’esistenza anche nel CERVELLO UMANO
DI UN SISTEMA DI M.N
basato sulla combinazione azione percepita e azione eseguita
Durante l’osservazione dell’azione vi è una forte attivazione
dell’AREA PARIETALE E PREMOTRICE (un’area omologa
all’area delle scimmie in cui sono presenti i M.N)
Il SISTEMA DI COMBINAZIONE M.N PER LE AZIONI UMANE
è organizzato in DISTINTE REGIONI CORTICALI all’interno della
CORTECCIA PREMOTRICE E PARIETALE POSTERIORE
Esse vengono attivate in modo dipendente dalla combinazione
osservazione/esecuzione delle azioni relazionate alla bocca,
mano, piede.
OSSERVAZIONE/ESECUZIONE DI PARTI DIVERSE DEL CORPO
ATTIVAZIONE DI DIVERSE ZONE CORTICALI
Un recente studio nel quale i partecipanti umani osservavano azioni
comunicative della bocca eseguite da uomini, scimmie e cani mostra che:
L’OSSERVAZIONE DELLE AZIONI COMUNICATIVE DELLA BOCCA
DI DIFFERENTI SPECIE OSSERVATE
ATTIVAZIONE
DI
DIFFERENTI
CENTRI
CORTICALI
DISCORSO UMANO
Parte operculare del giro
frontale inferiore sx
(regione di Broca)
SCHIOCCO LABBRA
SCIMMIE
L’ABBAIARE
DEL CANE
Piccola parte della
regione di Broca
Area visuale
extra-striata
CIO’ IMPLICA CHE:
1 Le AZIONI COMUNICATIVE APPARTENENTI AL REPERTORIO
MOTORIO dell’uomo osservatore (es: mordere,leggere)o molto vicino
ad esso (es: lo schiocco delle labbra) sono tracciate all’ INTERNO DEL
SISTEMA MOTORIO DELL’OSSERVATORE
2 Le AZIONI CHE NON APPARTENGONO AL REPERTORIO MOTORIO
dell’osservatore sono tracciate e categorizzate alla base delle loro
PROPRIETA’ VISUALI.
IL COINVOLGIMENTO DEL SISTEMA MOTORIO durante
l’osservazione delle azioni comunicative della bocca è stato verificato
anche dagli
studi di Watkins
tale tipo di osservazione facilita L’ECCITABILITA’
DEL SISTEMA MOTORIO coinvolto nella produzione
delle stesse azioni
IPOTESI: vi è una correlazione tra:
SISTEMA NEURONALE (M.N)
INTERSOGGETTIVITA’
L’INTERSOGGETTIVITA’
principalmente da:
è
caratterizzata
LA SINCRONIA che emerge in una relazione tra
due persone.
La sincronia si basa sulla COMPRENSIONE
DELLE AZIONI DEGLI ALTRI.
COME AVVIENE LA COMPRENSIONE DELLE ALTRUI AZIONI?
La comprensione delle azioni degli altri avviene grazie al:
“MIRROR MECHANISM”
(meccanismo a specchio)
Esso si basa su di un MECCANISMO DI RISONANZA in cui:
Il sistema motorio dell’osservatore si attiva ( attivazione dei neuroni
a specchio) ogni volta che un appropriato stimolo visuale e/o acustico
viene presentato.
CIO’ NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PRODUZIONE DI
UN ESPLICITO MOVIMENTO
RIZZOLATTI ET AL propongono che:
esiste una RAPPRESENTAZIONE MOTORIA INTERNA di
azione specifica
essa si attiva nel momento dell’osservazione dell’azione
e può essere utilizzata come
“RESPONSE FACILITATION”(risposta facilitata)
aziona la RIPETIZIONE DI UN’AZIONE SPECIFICA
già presente nel repertorio motorio dell’osservatore
Tutto ciò avviene solo quando UN APPROPRIATO STIMOLO
VIENE PRESENTATO (
meccanismo di risonanza)
Queste ipotesi vengono testate in ESPERIMENTI CON LE SCIMMIE
utilizzando come OGGETTO SERIMENTALE un comportamento
particolarmente sensibile allo stimolo sociale
“EATING BEHAVIOR” (assunzione di cibo)
L’osservazione e l’ascolto di azioni riguardanti l’assunzione di cibo
ATTIVA
i programmi motori di azioni simili
facilitando così la loro esecuzione
(FUNZIONE DEL SISTEMA A SPECCHIO)
Il comportamento di nutrimento delle scimmie aumentava quando
queste osservavano o solo sentivano altri individui mangiare
(SINCRONIA DELCOMPORTAMENTO)
Il suono invece dello strappare della carta non comporta nella scimmia
ascoltatrice nessun comportamento connesso.
Un’ ALTRA FORMA DI INTERSOGGETTIVITA’ è l’
“EARLY IMITATION” (imitazione precoce) studiata
primariamente negli uomini
E’ stato notato che il bambino piccolo riesce ad imitare i
gesti facciali fatti da un adulto:
aprire la bocca
la protrusione della
lingua
la protusione delle labbra
GLI INTERROGATIVI che gli studiosi si pongono sono:
1) Com’è possibile imitare gesti facciali se lui/lei non può
vedere la propria faccia?
2) Come può il bambino adattare la propria espressione
facciale a quella del modello di imitazione?
Ciò che accade è il trasferimento della PROSPETTIVA
PERSONALE del dimostratore
all’interno della
PROSPETTIVA DEL CORPO DEL BAMBINO (lo fa
proprio, diventa suo)
Lo stesso ragionamento lo possiamo applicare all’interno
del MECCANISMO DI RISONANZA DEL SISTEMA
MOTORIO SOSTENUTO DAL FUNZIONAMENTO DEI
NEURONI A SPECCHIO
Nell’imitazione precoce dei neonati i sistemi motori
possono
INNATAMENTE
RISPONDERE
SPECIFICATAMENTE ai gesti dello sperimentatore senza
avere un visuale feedback della loro stessa faccia
AZIONE
OSSERVATA
AZIONE
ESEGUITA
DIRETTO
COLLEGAMENTO
Stabilito nel SISTEMA
NEURONALE A
SPECCHIO
Importante implicazione per lo SVILUPPO DELL’INTERSOGGETTIVITA’
Infatti l’ IMITAZIONE PRECOCE può essere un importante
STRUMENTO
.
per comprendere le persone, l’identità di
queste, gli oggetti
.
per entrare ed instaurare una relazione
con gli altri
L’”EARLY IMITATION” è stata studiata anche nei primati
Per comprendere meglio la sua funzione
Per tracciare una possibile linea evolutiva verso la comparsa di
questo comportamento
Questi studi sembrano suggerire che l’imitazione neonatale negli
scimpanzè sia orientata preferenzialmente verso FACCE CON
PARTICOLARI ESPRESSIONI
Esperimento: è stata osservata la RISPOSTA COMPORTAMENTALE
di un piccolo macaco di una settimana di fronte a gesti umani della
faccia e delle mani
Apertura della bocca
STIMOLI
Labbra protese
Lingua protesa
Gesti delle mani
Il piccolo macaco sembrò imitare solamente la
protrusione della lingua, delle labbra e l’apertura della
bocca
Venne scoperto che tale capacità oltre ad apparire
molto presto dopo la nascita ha la tendenza a
scomparire altrettanto velocemente (dura circa 2 mesi)
Nonostante ciò, sappiamo che l’”EARLY IMITATION”
non è l’unica caratteristica dell’essere umano; essa si è
evoluta nel tempo
Il fatto che i TIPI DI GESTI IMITATI abbiano un
SIGNIFICATO ASSOCIATIVO
Suggerisce che:
Nei primati il BISOGNO DI STABILIRE UNA RELAZIONE
PROFONDA TRA DUE INDIVIDUI (madre-bambino)
non solo di attaccamento
ma anche differenti forme
di intersoggettività
Può rappresentare UNA FORZA EVOLUTIVA CRUCIALE
I dati sull’”EARLY IMITATIONS” sembrano suggerire che in
alcune specie di primati il NEONATO E’ CAPACE DI
SINTONIZZARE IL SUO COMPORTAMENTO con quello
osservato da altri individui
IL SISTEMA SENSORIO-MOTORIO È GIÀ PRE-STABILITO
PER ESSERE COORDINATO CON L’ESPERIENZA DI
QUALCUN ALTRO IN SENSO PARTECIPATORIO
“ALTERO CENTERED PARTECIPATION” è una delle
caratteristiche alla base dell’INTERSOGGETTIVITA’ PRIMARIA
I bambini possegono un’intera gamma di capacità:
per sintonizzare le loro menti con quelle degli altri
per condividere l’esperienza della 1°e 3°persona
E’ stato ipotizzato:
CAPACITA’ INNATA DI CONDIVIDERE L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI
(potrebbe essere assegnata)
Da UN MECCANISMO NEURONALE
I NEURONI A SPECCHIO
Un aspetto che le neuroscienze dovrebbero approfondire di più è:
Se il SISTEMA COMBINATORIO dei M.N. è:
Confinato a
comprendere le
azioni
oppure
Utilizzato anche
all’interno dell’”alterocentered partecipation”
Prima di diventare verbale e simbolico
IL BAMBINO ACQUISTA FORME PIU’ COMPLESSE DI
INTERSOGGETTIVITA’
Una di queste e la piu’importante nello sviluppo della
capacità di interazione e condivisione dell’esperienza con
gli altri è
“UNDERSTANDING INTENTIONS”
(comprensione delle intenzioni)
In
una
SEQUENZA
DI
AZIONI
(es. raccogliere una penna per scrivere)
MOTORIE
la META FINALE dell’intera azione (es: scrivere su un
pezzo di carta)
è sempre presente nella MENTE dell’agente
essa (LA META) si riflette in ogni azione motoria della
sequenza
L’INTENZIONE DELL’AZIONE E’ STABILITA PRIMA
DELL’INIZIO DEI MOVIMENTI
(quando noi stiamo per compiere un’azione prediciamo
anche la sua conseguenza)
Le evidenze raccolte dagli studi sulle scimmie suggeriscono che
queste utilizzano IL SISTEMA DEI M.N PER OTTIMIZZARE LE LORO
INTERAZIONI SOCIALI
Perciò si può supporre che
IL SISTEMA DEI M.N SIA UTILIZZATO PER PROPOSITI SOCIALI
Venne inoltre notato che i neuroni nella corteccia dorsale premotrice
possono velatamente simulare i comportamenti osservati dagli altri
ciò avviene anche quando la RELAZIONE TRA:
EVENTO OSSERVATO
IL COMPORTAMENTO
MOTORIO PRODOTTO
è appresa attraverso le associazioni stimolo/risposta
Una data azione può essere prodotta dalle piu’svariate intenzioni
SUPPONIAMO: una persona osserva un’altra afferrare una tazza
I M.N specifici per l’azione “afferrare” si attivano nel cervello
dell’osservatore
Ciò che avviene è:
una semplice EQUIVALENZA MOTORIA tra:
AZIONE OSSERVATA
e
LA SUA RAPPRESENTAZIONE
MOTORIA nel cervello dell’osservatore
Cio’ ci può informare sul “CHE COSA” è tale azione ma non sul
“PERCHÉ” l’azione è accaduta
Determinare il “perché” = DETERMINARE L’INTENZIONE
scoprire la meta non ancora eseguita
L’OPINIONE TRADIZIONALE: i M.N codificano il “che cosa” e non il
“perché” di un’azione sembra essere rovesciata da recenti dati
elettrofisiologici
Nel LOBO PARIETALE INFERIORE delle scimmie sono stati scoperti
M.N con interessanti proprietà.
I M.N nel IPL si ATTIVANO in associazione ad azioni motorie delle
scimmie solo quando questi sono coinvolti in UNA SPECIFICA AZIONE
INDIRIZZATA VERSO SPECIFICHE METE
Es: alcuni tipi di neuroni si attiveranno solamente se la scimmia afferra
un pezzo di cibo per portarlo alla bocca e non per riporlo in un contenitore
I M.N NEL IPL CODIFICANO LA STESSA AZIONE MOTORIA IN
MODO DIFFERENTE IN BASE ALLA META FINALE DELL’AZIONE
percio’
ESSI SI ATTIVERANNO ANCHE IN TEMPI DIFFERENTI
PROPRIETA’ DEI M.N PARIETALI
RICONOSCERE LA META DELL’AZIONE MOTORIA
OSSERVATA
DISCRIMINARE AZIONI MOTORIE IDENTICHE IN BASE ALLA
SEQUENZA DELL’AZIONE NELLA QUALE QUESTE SONO
COLLOCATE
PERMETTE ALLE SCIMMIE DI PREDIRE QUAL’E’ IL RISULTATO
DELL’AZIONE OSSERVATA
PERMETTE DI INDIVIDUARE L’INTENZIONE DELL’AZIONE
INDIVIDUALE
MECCANISMO DI COMPRENSIONE DELLE INTENZIONI
si basa su
L’ATTIVAZIONE DI UNA SPECIFICA CATENA MOTORIA
che porterà
UNA RAPPRESENTAZIONE INTERNA DI CIO’ NELL’OSSERVATORE
L’AZIONE CHE L’ AGENTE ANDRA’ A COMPIERE
LA FREQUENZA DELLA SEQUENZA DI UN’AZIONE
(osservate o eseguite nell’ambiente sociale)
crea
PERCORSI PREFERENZIALI DI INFERENZE/PREDIZIONI
prodotti dal
CONCATENAMENTO DI DIFFERENTI M.N. CHE CODIFICANO:
AZIONE MOTORIA
OSSERVATA
ATTRIBUIRE INTENZIONI
L’AZIONE IN CUI IN
QUEL CONTESTO
DOVREBBE SEGUIRE
PREDIRE UNA NUOVA IMMINENTE META
(scoprire l’intenzione di un’azione A = predire la sua lontana meta; della successiva azione B
SI DEDUCE CHE:
L’organizzazione del sistema motorio può fornire un SUBSTRATO PER
PERCEPIRE/DEDURRE LE INTENZIONI
Per lo sviluppo di un SISTEMA MOTORIO ADATTATO è intrinsecamente
necessario possedere un
CONCETTO DI INTENZIONE
Per guidare il corpo nello spazio verso un fine
LE EMOZIONI
FUNZIONE IMPORTANTE per
Acquisire conoscenza
individuale
Riorganizzare la conoscenza
di sé in base al risultato delle
relazioni con gli altri
L’ATTIVITA’ COORDINATA DEI SISTEMI NEURONALI
sensorio-motorio
+
affettivo
nell’automatizzazione
delle risposte comportamentali
degli organismi viventi
E’ IMPORTANTE PER LA SOPPRAVVIVENZA
L’INTEGRITA’ DEL SISTEMA SENSORIO-MOTORIO
appare critica nel
RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI MANIFESTATE DAGLI ALTRI
IL SISTEMA S-M SOSTIENE LA RICOSTRUZIONE DI CIO’ CHE ESSO
PUO’ SENTIRE/PROVARE
attraverso
SIMULAZIONE DELLA CONDIZIONE DEL CORPO
POSTO IN RELAZIONE
EMPATIA
UN RECENTE STUDIO mostra che:
l’esperienza di disgusto
ATTIVA LA STESSA
e
STESSA STRUTTURA
la stessa sensazione espressa
dalla mimica facciale di qualcun altro
NEURONALE (nella
stessa collocazione)
L’INSULA ANTERIORE
L’essere toccato
ATTIVA LA STESSA
STRUTTURA NEURONALE
e
l’osservazione di qualcuno
che viene toccato
S II-PV
(una regione corticale
multimodale)
Neurotrasmettitori mirror
Alcune testimonianze convergono sulla possibilità che i
neuroni specchio utilizzino, principalmente la
dopamina, come neurotrasmettitore.
Fenomeno delle “associazioni non cognitive”.
Autismo, ADHD, schizofrenia, parkinsonismo.
Correlazione con la sostanza P nella diffusione del
segnale tra substantia nigra e corpo striato e corteccia
pre-frontale.
Parkinsonismo
Predisposizione immunogenetica e inneschi infettivi
Storia
Descritta per primo da James Parkinson, nel 1817,
come “paralisi agitante”
Incidenza di 228 malati su una popolazione di 100.000
Di solito comincia tra i 50 e 65 anni (talvolta l’età è
inferiore a 40)
Sintomi primari
Esordio lento
Tremore
Rigidità
Bradicinesia
Disturbo dell’andatura
Perdita di equilibrio
Tremore
Insorge in modo lieve, talvolta a una mano, poi braccia
e gambe
Maggiore a riposo e con una tensione emotiva
Di solito è peggiore da un lato
Alcuni pazienti non presentano tale sintomo
Rigidità
Rigidità e diminuito tono muscolare comportano un
aumento della resistenza al movimento passivo delle
articolazioni (gomiti, polsi, collo)
Bradicinesia
Lentezza dei movimenti
Sopratutto all’inizio di questi
Scarsa capacità di scrivere, di abbottonare e
alzarsi da sedie basse
Espressione amimica, per la bradicinesia dei
muscoli facciali
Linguaggio lento e ridotto di tono
Andatura
Deambulazione con piccoli passi corti
Corpo proteso in avanti
Uso dell’alluce per la deambulazione
Alcuni malati stentano a fermarsi
Instabilità posturale
Perdita di equilibrio, per riduzione dei riflessi posturali
Postura piegata in avanti e ginocchia flesse camminando
Ridotta eccitazione della corteccia
Normal
e
PD
Gangli della base
Importanti nel controllo della motricità e della
cognitività
Gangli della base
caudato, putamen, nucleus accumbens, globus pallidus,
substantia nigra, nucleo subtalamico
Disfunzione dei nuclei della
base
Tremori – movimenti oscillatori involontari
Atetosi – movimenti lenti delle dita e mani
Chorea – bruschi movimenti dei muscoli facciali e
degli arti
Ballismo – violenti movimenti
Distonia – persistente postura anomala
Parkinson’s & Huntington’s Disease
Sintomi secondari
Alterazioni linguaggio
Depressione
Espressione amimica
Paura o ansia
Micrografia
Difficultà a deglutire
Sbavatura
Dolori e parestesie
Difficoltà di memoria e
pensiero rallentato
Alterata funzione sessuale
Demenza o confusione
Disturbi urinari di vario
tipo, ma soprattutto poliuria
Disturbi del sonno
Affaticamento
Constipazione
Lesioni cutanee
Anosmia
Mancanza di energia e
debolezza muscolare
Processo patogenetico
Accumulo neuronale di una proteina pre-sinaptica,
denominata α-sinucleina
Accumulo di altre proteine tossiche (corpi di Lewy, fibrille e
neuriti)
Riduzione della trasmissione dopaminergica nei gangli della
base
Forme autosomiche dominanti e recessive in circa 5% dei
casi
Mutazioni genetiche da fattori ambientali negli altri casi
Oppure danni mitocondriali
Sesso maschile, esposizione a pesticidi, FANS ed estrogeni
dopo la menopausa
Molecular mimicry
Neurology. 2000 Nov 14;55(9):1398-401
Monoclonal antibodies against Epstein-Barr virus cross-react with alphasynuclein in human brain.
Woulfe J, Hoogendoorn H, Tarnopolsky M, Munoz DG.
Using antibodies generated against the latent membrane protein 1 of
Epstein-Barr virus, intense immunoreactivity of Lewy bodies (in PD and
dementia with Lewy bodies) and glial cytoplasmic inclusions (in multiple
system atrophy) was demonstrated. ELISA and Western blotting
techniques confirmed that this immunolabeling was due to cross-reactivity
of the antiviral antibody with alpha-synuclein, a neuronal protein
implicated in the pathogenesis of PD. This example of cross-reactivity
between Epstein-Barr virus and alpha-synuclein may bear implications for
further elucidating infectious or autoimmune mechanisms in PD.
Alzheimer e Parkinson
Arch Neurol. 2001 Nov;58(11):1817-20
Alpha-synuclein in familial Alzheimer disease: epitope mapping parallels
dementia with Lewy bodies and Parkinson disease.
Lippa CF, Schmidt ML, Lee VM, Trojanowski JQ.
BACKGROUND: Alpha-synuclein is a major component of Lewy bodies (LBs) in
Parkinson disease and dementia with LBs and of glial cytoplasmic inclusions in
multiple system atrophy. However, epitope mapping for alpha-synuclein is
distinctive in different neurodegenerative diseases. The reasons for this are poorly
understood but may reflect fundamental differences in disease mechanisms.
OBJECTIVE: To investigate the alpha-synuclein epitope mapping properties of
LBs in familial Alzheimer disease. RESULTS: The brains of persons with familial
Alzheimer disease showed consistent staining of LBs with all antibodies, similar to
Parkinson disease and dementia with LBs but different from alpha-synuclein
aggregates that occurred in multiple system atrophy. CONCLUSIONS: These data
suggest that the epitope profiles of alpha-synuclein in LBs are similar, regardless of
whether the biological trigger is related to synuclein or a different genetic pathway.
These findings support the hypothesis that the mechanism of alpha-synuclein
aggregation is the same within cell types but distinctive between cell types.
La progressione dei sintomi
Sintomi principali
(bradicinesia)
(acinesia): difficile inizio del
movimento
Rigidità muscolare
Patologia
I neuroni della
substantia nigra (SN),
muoiono.
Tali neuroni
producono, di norma,
un neurotrasmettitore,
la dopamina
Le cellule che
producono dopamina
inviano il segnale alle
cellule del nucleo
caudato, putamen, e
globus pallidus dei
gangli della base, nel
telencefalo
Corpi di Lewy
mesencefalo
Demenza correlata al
Parkinson
Le allucinazioni sono pronunciate
Farmaci dopaminergici e anticolinergici hanno un
effetto allucinogeno
Corpi di Lewy diffusi
Cambiamenti tipo Alzheimer nell’anziano
Efficacia di anti-esterasi
Immunogenetica
Il parkinsonismo idiopatico (definito, in modo non del
tutto appropriato, come malattia di Parkinson) è un
disturbo neurodegenerativo a etiologia sconosciuta, ma
che è stato associato a una patogenesi immunomediata.
Analizzando 45 pazienti tedeschi (tutti caucasici) è stata
notata una frequenza maggiore, statisticamente
significativa, rispetto ai controlli, di DQB1*06.
Studio importante
L’aspetto patologico del parkinsonismo è rappresentato dalla
perdita dei neuroni dopaminergici nel circuito nigro-striato, in
associazione a un processo immunitario e infiammatorio, nel
quale il sistema di istocompatibilità gioca un ruolo centrale.
Per valutare la eventuale predisposizione immunogenetica, sono
stati messi a confronto 528 pazienti, con 3430 controlli, nel
Regno Unito.
Da tale confronto emerge una suscettibilità alla malattia, che
poggia sulla presenza di DRB1*03, tale da suggerire un supporto
patogenetico al processo flogistico, che accompagna e promuove la
perdita dei neuroni dopaminergici.
Autoimmunità anti-GM1
L’autoimmunità, nel parkinsonismo, è stata da tempo
ipotizzata. Tale condizione sarebbe rivolta nei
confronti di alcune componenti strutturali dei neuroni
dopaminergici, quali i gangliosidi.
Sotto questo aspetto, il confronto tra 147 pazienti e
186 controlli sani, ha permesso di verificare la presenza
significativa di anti-GM1, prevalentemente di tipo IgM
e soprattutto nella forma con tremore dominante.
α-sinucleina
La risposta adattativa anti-GM1 si accompagna a un’altra
specifica autoimmunità, la quale riguarda l’α-sinucleina.
Gli aggregati intraneuronici denominati corpi di Lewy sono
presenti in numerose patologie del sistema nervoso centrale.
Essi rappresentano un marcatore istologico caratteristico del
parkinsonismo.
In tali corpi inclusi, è stato rilevato che la serina in posizione
129 dell’α-sinucleina è fosforilata.
EBV
La fosforilazione di questa proteina può
comportare una danno e può indurre
una risposta autoreattiva, soprattutto in
presenza di una risposta linfocitaria nei
confronti del virus di Epstein-Barr, per
mimetismo molecolare con la proteina 1
di envelope dell’agente infettivo.
Caso clinico
A sostegno di questa osservazione, è stato
riportato il caso di un ragazzo di 16 anni, il
quale, a seguito di una encefalite da EBV,
documentata con indagine sierologica, ha
manifestato un parkinsonismo secondario,
regredito dopo 60 giorni, in presenza di
anticorpi anti-neuronali del peso di 130 Kda.
Infezioni e risposte
Le
caratteristiche
immunologiche
del
parkinsonismo sono state, dunque, osservate
con linfociti T specifici e autoanticorpi (antiGM1 e anti-α-sinucleina), sia nel sangue
periferico, sia nel sistema nervoso centrale,
ipotizzando un processo integrato tra la
suscettibilità immunogenetica e un innesco
infettivo.
Influenza virus
In un altro caso descritto, una giovane di 22 anni è
colpita da una encefalopatia, a seguito di infezione
H1N1, con diverse disfunzioni ipotalamiche, insonnia
e parkinsonismo.
Nella cosiddetta pandemia del 2009, sono stati
osservati alcuni casi di encefalite, anche se un reale
neurotropismo del virus influenzale non è ancora
ammesso da tutti i ricercatori.
Rna HN
Tuttavia, già nel 1974 furono dimostrati
antigeni influenzali in alcuni neuroni
ipotalamici e nella substantia nigra, nel
cervello di pazienti con parkinsonismo
post-encefalitico.
In altri casi, è stato individuato Rna
virale nel liquido cerebrospinale.
Corpi di Lewy
Oggi si è arrivati a considerare la possibilità,
che alcuni ceppi del virus A possono infettare i
neuroni, soprattutto a livello di sub stantia
nigra, cerebellum e ippocampo, sia nell’uomo,
sia nei modelli sperimentali.
Alcuni autori, pertanto, hanno ipotizzato il
neurotropismo di tale virus, che può essere
responsabile della formazione di corpi di Lewy.
Helicobacter
È stato condotto un interessante studio sulla possibile
associazione tra helicobacter pylori e parkinsonismo.
Su 30 pazienti, controllati con placebo, nei quali il
disturbo neurologico si accompagnava alla persistenza
della infezione gastrica, è stata somministrata una
terapia eradicante.
Tutti coloro che hanno ricevuto la terapia antibiotica
hanno ottenuto dei risultati molto interessanti, sia per
la bradi/ipocinesia, sia per la rigidità muscolare.
HP e immunogenetica
Altri lavori convergono sulla capacità dell’helicobacter
di incidere sulla progressione della malattia,
innescando un circuito patogenetico riferito,
essenzialmente, al mimetismo molecolare.
In altri studi si propone, addirittura uno schema
patogenetico, nel quale l’infezione si associa alla
predisposizione immunogenetica, proprio in quelle
forme definite, per lungo tempo idiopatiche.
VacA e GM1
L’autoimmunità anti-GM1, nel parkinsonismo, può essere
spiegata mediante il mimetismo molecolare.
I gangliosidi sono in gradi di legare molti agenti infettivi.
È stato elegantemente dimostrato che la citotossina
vacuolizzante VacA di helicobacter pylori si lega all’epitelio
della mucosa gastrica, mediante il GM1.
In questo modo, una risposta anti-VacA, può coinvolgere
anche il ganglioside, generando il presupposto patogenetico
del parkinsonismo.
Adesine HP
Molto convincente è anche l’osservazione, per la quale,
in persistenza di helicobacter pylori, nei pazienti con
parkinsonismo, influenza l’assorbimento della
levodopa, riducendone i livelli plasmatici.
Infatti, incubando il batterio con varie soluzioni
contenenti il farmaco, la quantità libera di levodopa si
riduce.
Tale fenomeno, in vivo, sarebbe dovuto al legame tra
adesine batteriche e la stessa levodopa.
Streptococcus
È stato riportato il caso di un giovane, che
presentava un grave disturbo acinetico, con
rigidità, due settimane dopo un episodio di
faringite.
La RMN cerebrale evidenziava alterazioni
localizzate nei gangli della base, associate a un
alto titolo anti-streptococcico e anche antigangli basali.
Caso clinico
In un altro caso riportato in letteratura, un
ragazzo di 16 anni manifestava un lieve
parkinsonismo rigido/acinetico, poco dopo
una infezione streptococcica.
Dopo la sospensione dei cortisonici, ebbe un
rapido deterioramento neurologico, dall’esito
fatale, per una encefalite simil-letargica. Il titolo
anti-streptolisinico era molto elevato.
Neuropatologia
comportamentale
Lo spettro dei disturbi neurologici post-streptococcici è
piuttosto ampio e include, oltre la corea, anche la
sindrome di Tourette, la distonia e il parkinsonismo,
per quanto attiene le disfunzioni del movimento.
A queste osservazioni si aggiungano anche le forme
psichiatriche (in particolare i disturbi emotivi) e le
alterazioni nel ritmo del sonno.
In tutti questi casi è stata proposta una genesi
autoimmune, per mimetismo molecolare con strutture
nervose.
Anti-CD46
L’adesina di streptococco pyogenes interagisce con la
fibronectina, una delle molecole di adesione, che
permette il legame delle cellule alla matrice.
Tuttavia, uno dei legami più importanti dello
streptococco pyogenes è dato da una molecola
ubiquitaria, che regola il complemento, denominata
CD46, la quale funziona da recettore anche per due
virus, quello del morbillo e HHV-6.
M protein
Il legame recettoriale di tale molecola si verifica
con le proteina M batteriche.
Mediante questo legame lo streptococco evade
l’azione del complemento e riesce a penetrare
all’interno dell’epitelio faringeo, oppure
interagire con i cheratinociti, mediante il
dominio C delle proteine M stesse.
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori è un batterio gram-, munito
di 4-6 flagelli, ricurvo o spiraliforme, isolato per
la prima volta da Marshall e Goodwin nel 1987
dalla mucosa gastrica dei primati.
Possiede un glicocalice (mucopolisaccaride), il
quale funziona da importante mediatore nel
fenomeno di adesione alla mucosa gastrica.
Localizzazione
Si localizza a livello dello stomaco e in aree di
metaplasia gastrica duodenali o esofagee.
Insinuandosi nello strato mucoso, dal quale
risulta protetto dall'acido, anche per la
costituzione entro il muco di nicchie
ecologiche ad alto pH, legate alla formazione di
ioni ammonio attraverso una fortissima attività
ureasica sull'urea ambientale.
Antro e altrove
HP si trasmette in maniera endemica in tutto il
mondo.
Quando si esaminano soggetti asintomatici,
ogni volta che si evidenzia HP, si osserva una
gastrite istologica.
La ricerca di HP è spesso positiva a livello
dell'antro, ma può essere evidenziato nelle zone
di metaplasia (esofago, fondo e duodeno).
Caratteristiche e
funzioni dei principali
fattori di patogenicità
Batterio
Gram-,
spiraliforme,
flagellato
CagA
Il Gene CagA è presente nel 60% dei ceppi e
rappresenta il primo gene non conservato;
esprime una proteina di superficie di circa 130
kDa,
considerata
tra
i
principali
immunodominanti del batterio.
Gli anticorpi anti-CagA sono presenti nel
100% dei sieri di pazienti infetti da HP, che
presentano l'ulcera peptica e solo nel 62% dei
pazienti sofferenti di gastrite.
Effetti CagA
La proteina è associata a comparsa di
ulcera duodenale, gastrite cronica
atrofica, adenocarcinoma gastrico.
Stimola la produzione di IL8, importante
fattore chemiotattico per i linfociti
impegnati nell'evoluzione del processo
infiammatorio.
VacA
Il Gene VacA codifica una citotossina di 87
kDa; la citossina altera il normale traffico di
vescicole del compartimento endosomiale
profondo che, fondendosi tra loro, formano le
caratteristiche vacuolizzazioni.
L'ammoniaca prodotta dall'attività ureasica
dell'HP diffonde negli endosomi, all'interno
dei quali, protonandosi, vi rimane sequestrata.
Tipologia
Tipo I : ceppo citotossico caratterizzato
dalla presenza del gene CagA;
Tipo II: ceppo non citotossico
caratterizzato dalla mancanza del gene
CagA.
Danno tissutale
adesività, ossia la capacità di adesione all'epitelio gastrico;
endocitosi, ossia la penetrazione di HP nelle cellule dell'epitelio
gastrico, come fattore di lesione, rendendo difficile l'eradicazione
con chemioterapici;
attività ureasica, con lesione, dovuta a liberazione di NH4+;
enzimi istolesivi, quali lipasi, fosfolipasi e proteasi, con
modificazione della mucosa;
flagelli, il cui ruolo va ancora chiarito;
citotossina, per la quale la virulenza varia a seconda della capacità
di esprimere e produrre la tossina vacuolizzante (VacA) e la
proteina associata (CagA).
Effetti
In considerazione degli effetti prodotti e delle
patologie che si realizzano come conseguenza
della presenza di HP, è opportuno analizzare i
fattori di virulenza grazie ai quali il
microrganismo riesce a manifestare il suo
potere patogeno.
Questi fattori possono essere classificati in
diretti e indiretti.
Effetti diretti e indiretti
Quelli diretti sono rappresentati dagli elementi
strutturali del batterio, come la motilità,
l’adesività, l’invasività, e la produzione di
sostanze lesive (tossine, ureasi, proteasi,
mucinasi, lipasi e fosfolipasi, fattore
d’inibizione acida, alcooldeidrogenasi).
Quelli indiretti, invece sono rappresentati dai
mediatori della flogosi come il PAF, i
leucotrieni, le citochine (es. a-TNF).
Colonizzazione
Il batterio, una volta penetrato nel tubo
digerente attraverso la via orale, raggiunge
l’epitelio gastrico, che rappresenta il suo
habitat naturale
Per far ciò deve contrastare quella che
rappresenta fisiologicamente la prima barriera
alla colonizzazione di qualsiasi germe, cioè
l’acido cloridrico prodotto dallo stomaco.
Ureasi
Proprietà fondamentale, per quanto riguarda
questa prima fase di colonizzazione della
mucosa gastrica, è rappresentata dalla capacità
di sintesi di un enzima molto attivo sulla
superficie batterica, l’ureasi, che rappresenta il
6% delle proteine di HP.
L’ureasi idrolizza l’urea, che è normalmente
presente nelle secrezioni gastriche, dando luogo
alla produzione di ammoniaca e bicarbonati.
Cocchi
Proprietà fondamentale, per quanto riguarda
questa prima fase di colonizzazione della
mucosa gastrica, è rappresentata dalla capacità
di sintesi di un enzima molto attivo sulla
superficie batterica, l’ureasi, che rappresenta il
6% delle proteine di HP.
L’ureasi idrolizza l’urea, che è normalmente
presente nelle secrezioni gastriche, dando luogo
alla produzione di ammoniaca e bicarbonati.
Ammoniaca
Inoltre, l’ammonio così prodotto, favorisce la
penetrazione del batterio intervenendo nell’idrolisi e
nella rottura dello strato mucoso.
Dunque HP è avvolto da una nube chimica, alcalina,
che riesce a neutralizzare l’aggressione dell’acido e, così
protetto, procede, sospinto dai flagelli e favorito dalla
forma a spirale, verso l’epitelio gastrico.
L’ureasi è anche il candidato più promettente per la
realizzazione di un vaccino contro HP.
Internalizzazione
Il batterio riesce a oltrepassare lo strato di
muco vischioso, che protegge la mucosa,
utilizzando anche altri enzimi quali le proteasi
e le fosfolipasi A2 e C, i quali permettono di
rompere le catene fosfolipidiche della porzione
idrofobica del muco.
Questo determina una perdita graduale della
viscosità del muco stesso e un aumento della
retrodiffusione degli ioni H+.
Flagelli
Una caratteristica importante posseduta da
tutti gli Helicobacter è quella di muoversi
rapidamente entro il muco, in modo tale da
sfuggire all’acidità gastrica.
Questa proprietà è da riferire alla forma a
spirale e alla presenza di quattro-sette flagelli
unipolari.
Flagelline
I geni (flaA, flaB, flbA) codificanti per le
proteine che compongono il filamento dei
flagelli,
sono
stati
clonati.
Tramite
l’inattivazione di questi geni è stato possibile
produrre anche dei mutanti immobili di HP.
Gli esperimenti finora condotti su modelli
animali hanno mostrato che ceppi di HP resi
immobili, possiedono anche un minore
potenziale di colonizzazione.
VacA
Non appena i batteri lasciano il lume gastrico e penetrano
nello strato di muco, cominciano a moltiplicarsi, ponendosi
in contatto diretto con le cellule epiteliali gastriche.
Questo è possibile in quanto HP sembra possedere, sulla sua
superficie, delle adesine complesse, capaci di riconoscere
specifici recettori espressi dalle cellule gastriche.
La citotossina vacuolizzante (VacA), prodotta solo da alcuni
ceppi di HP è una tossina di natura proteica che sembra
potenziare l’effetto patogeno del microrganismo.
VacA
La presenza di ceppi produttori di citotossina
vacuolizzante si riscontra maggiormente in pazienti con
ulcera peptica, rispetto a quelli con solo gastrite
cronica antrale.
Sebbene il gene CagA sia presente nella maggior parte
dei ceppi ulcerogenici, non è necessario per
l’espressione e l’azione della citotossina vacuolizzante.
Invece, per la sua espressione e funzione è importante
la presenza del gene VacA .
Azione combinata
A questo proposito è stato osservato che i ceppi di HP che
possiedono i geni CagA e VacA inducono nelle cellule gastriche
una più alta secrezione del mediatore flogistico interleuchina 8,
che
è
un
potente
fattore
chemiotattico
dei
polimorfonucleati(PMN).
L’attivazione e la stimolazione dei PMN e degli altri mediatori
immunologici, innescata dall’interleuchina 8 e dai fattori di
virulenza batterica quale l’ureasi, l’ammoniaca, i lipopolisaccaridi,
e le citotossine, induce la produzione di leucotrieni e gammainterferon, tutti fattori citotossici.
Quindi, la risposta immunologica, nata per limitare il processo
flogistico, finisce per dare un contribuito allo sviluppo
dell’infezione da HP.
Predisposizione non HLA
La predisposizione genetica dell’ospite è considerata un
cofattore nello sviluppo dell’ulcera peptica. Infatti la
predisposizione ad ammalare è diversa da soggetto a soggetto
in rapporto al gruppo sanguigno.
Soggetti con gruppo sanguigno 0 hanno un rischio maggiore
di ammalare rispetto a soggetti con altri gruppi.
Questo potrebbe essere legato al fatto che l’HP possiede una
maggiore capacità di aderire alle cellule portatrici
dell’antigene Lewis, espresso anche dalle cellule della
mucosa gastrica di pazienti con gruppo sanguigno 0.
Linfoma
L'infezione da HP è stata associata con linfoma
gastrico non-Hodkin e con altri disordini
linfoproliferativi quali il MALT (Tessuto
Linfoide Associato alla Mucosa gastrica) e il
linfoma (MALToma )
Nel 92% dei campioni ottenuti da pazienti
con linfoma gastrico, è stata accertata la
presenza di HP.
Anti-CD49d
La fibronectina è una proteina di 250 kDa della
matrice extracellulare, che gioca un ruolo
fondamentale nella adesione e comunicazione tra
cellule, oltre che nello sviluppo di malattie.
La citotossina CagA, localizzata sulla superficie di
helicobacter pylori, mostra un mimetismo molecolare
con la fibronectina, mediante il quale il batterio riesce
a diffondersi all’interno dell’organismo ospite.
Anti-CD49d
Uno dei recettori più importanti della fibronectina è una
molecola di adesione, denominata α4 integrina, o CD49d,
la quale riveste un ruolo fondamentale nella linfopoiesi e
nel reclutamento infiammatorio dei leucociti. L’antiCD49d, pertanto, è il simile molecolare di HP, per la CagA.
La laminina, una delle glicoproteine maggiori della lamina
basale, che permette l’adesione e la differenziazione delle
cellule, è un importante recettore di helicobacter pylori.
Anche l’altra importante citotossina vacuolizzante,
denominata VacA, la quale provoca effetti sulla funzione e
la morfologia delle cellule epiteliali gastriche, è in grado di
legare la fibronectina, tanto quanto la laminina. AntiCD49d, pertanto è pure il simile molecolare di VacA.