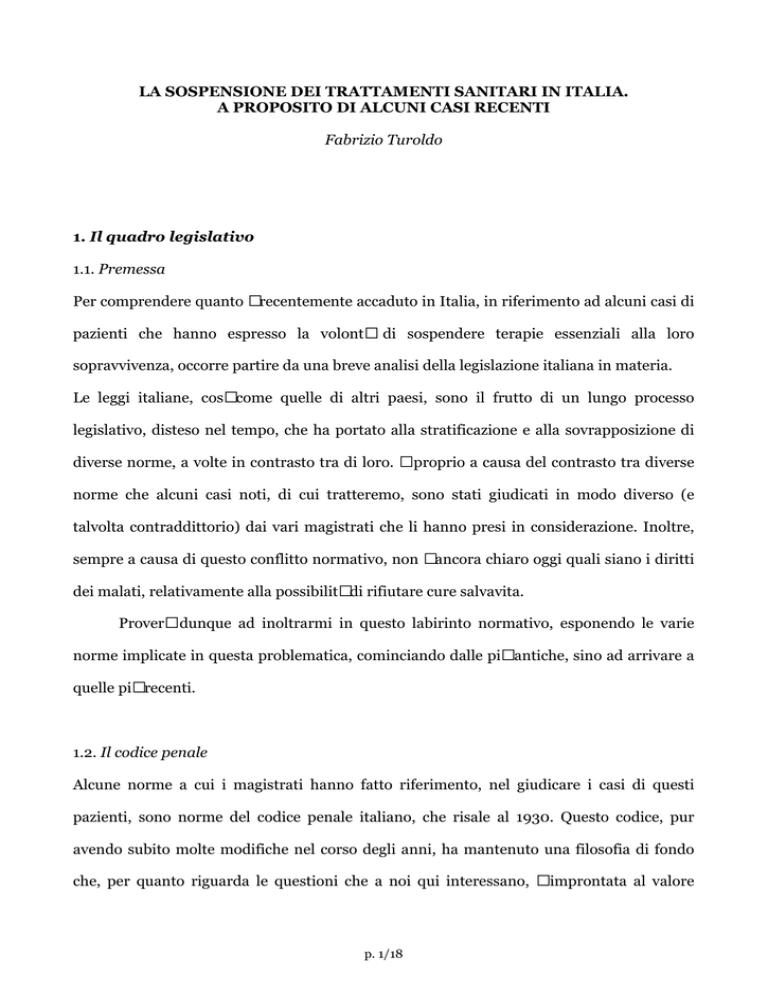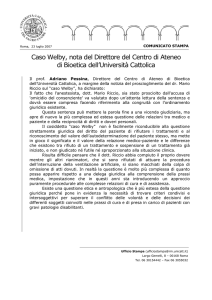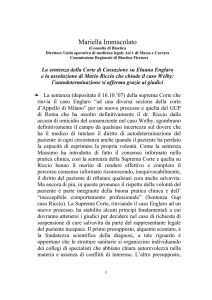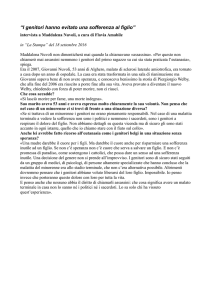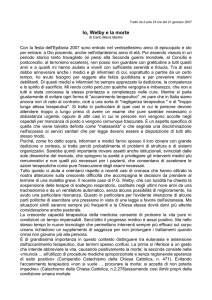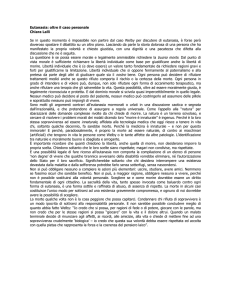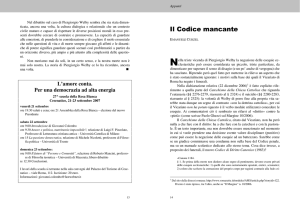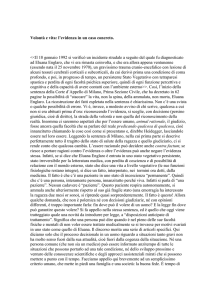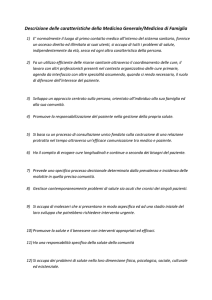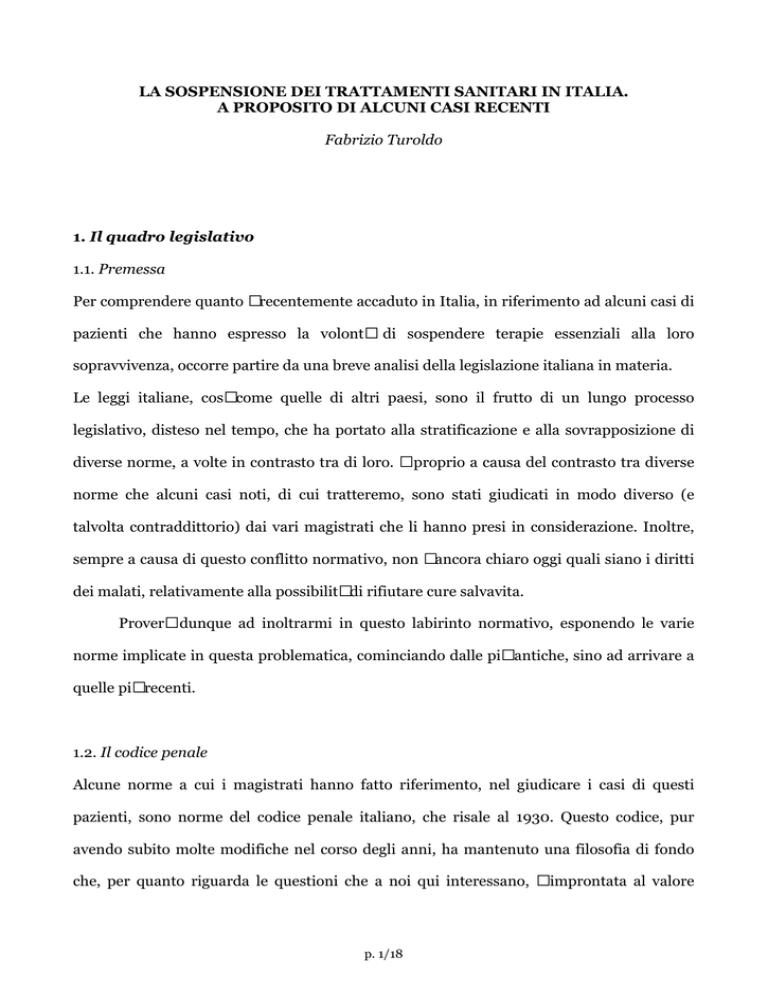
LA SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI SANITARI IN ITALIA.
A PROPOSITO DI ALCUNI CASI RECENTI
Fabrizio Turoldo
1. Il quadro legislativo
1.1. Premessa
Per comprendere quanto è recentemente accaduto in Italia, in riferimento ad alcuni casi di
pazienti che hanno espresso la volontà di sospendere terapie essenziali alla loro
sopravvivenza, occorre partire da una breve analisi della legislazione italiana in materia.
Le leggi italiane, così come quelle di altri paesi, sono il frutto di un lungo processo
legislativo, disteso nel tempo, che ha portato alla stratificazione e alla sovrapposizione di
diverse norme, a volte in contrasto tra di loro. È proprio a causa del contrasto tra diverse
norme che alcuni casi noti, di cui tratteremo, sono stati giudicati in modo diverso (e
talvolta contraddittorio) dai vari magistrati che li hanno presi in considerazione. Inoltre,
sempre a causa di questo conflitto normativo, non è ancora chiaro oggi quali siano i diritti
dei malati, relativamente alla possibilità di rifiutare cure salvavita.
Proverò dunque ad inoltrarmi in questo labirinto normativo, esponendo le varie
norme implicate in questa problematica, cominciando dalle più antiche, sino ad arrivare a
quelle più recenti.
1.2. Il codice penale
Alcune norme a cui i magistrati hanno fatto riferimento, nel giudicare i casi di questi
pazienti, sono norme del codice penale italiano, che risale al 1930. Questo codice, pur
avendo subito molte modifiche nel corso degli anni, ha mantenuto una filosofia di fondo
che, per quanto riguarda le questioni che a noi qui interessano, è improntata al valore
p. 1/18
dell’indisponibilità della vita, valore che prevale rispetto ad altri principi, quali quelli
relativi all’autodeterminazione individuale.
Sono molti infatti gli articoli del codice penale che possono entrare in gioco nella
valutazione delle decisioni mediche di fine vita. L’articolo 40, ad esempio, stabilisce che
“non impedire un evento, che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”. In base a
questo articolo, e considerato il fatto che il dovere professionale del medico è quello di
salvare la vita ai pazienti, ne conseguirebbe dunque che, quando il medico lascia morire un
paziente, su richiesta del paziente stesso, è come se lo uccidesse. Un tale medico dovrebbe
dunque essere accusato, in base a questo articolo, del reato di omicidio. L’articolo 54
stabilisce inoltre che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”:
questo articolo viene spesso invocato per giustificare il mancato rispetto della volontà di
pazienti in pericolo di vita, che vengono sottoposti a terapie d’emergenza contro al loro
volontà (ad esempio Testimoni di Geova sottoposti a trasfusioni di sangue). Vi sono poi gli
articoli 575-576-577-579-580, che si riferiscono al reato di omicidio nelle sue varie
tipologie e circostanze aggravanti. Qui mi preme citare in particolare l’articolo 579, che
condanna “l’omicidio del consenziente” (nella cui fattispecie rientra l’eutanasia) e l’articolo
580, che punisce “l’istigazione o l’aiuto al suicidio” (nella cui fattispecie rientra il suicidio
assistito). L’articolo 593, infine, condanna “l’omissione di soccorso”, reato nel quale può
incorrere il medico che assiste, senza intervenire, alla morte di un paziente a cui, per
esempio, è stato staccato il respiratore automatico, oppure il sondino nasogastrico per
l’alimentazione artificiale.
1.3. Il codice civile
Il codice civile, approvato nel 1942, è solo di poco più recente, e risente anch’esso dello
stesso tipo di impostazione. Per averne una dimostrazione, basterebbe fare riferimento
p. 2/18
all’art. 5, che stabilisce che “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando
cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”. Secondo questo articolo,
dunque, non solo non ci si può lasciar morire, ma non ci si può nemmeno menomare, tanto
che, per rendere operativa la legge sulla donazione da vivente (in particolare del rene) si è
dovuta fare un’eccezione all’articolo 5 del c.c. (visto che privarsi di un rene significa,
appunto, menomarsi).
1.4. La Costituzione
La svolta più importante nella normativa italiana in materia avviene nel 1948, quando,
dopo la caduta del regime fascista, viene approvata la nuova Costituzione repubblicana.
Nella nuova Costituzione, infatti, il principio dell’assoluta indisponibilità della vita si
ammorbidisce, per diventare un principio di tutela del diritto alla salute e di promozione
della salute come interesse della collettività. Il primo comma dell’articolo 32 infatti
stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Ma la novità più grande è che il diritto al rifiuto delle cure viene sancito dalla stessa
Costituzione, al secondo comma dell’articolo 32, che stabilisce che “nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”,
precisando che “la legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto per la
dignità umana”. La svolta è di grande rilievo, perché si passa da un impianto normativo
improntato essenzialmente al principio di indisponibilità della vita, ad un nuovo impianto,
maggiormente volontaristico e capace dunque di accogliere le istanze del principio
dell’autodeterminazione individuale.
Il motivo per cui l’Assemblea Costituente è giunta a queste conclusioni è dovuto, tra
le altre cose, anche al fatto che, negli stessi anni in cui l’Assemblea svolgeva il proprio
p. 3/18
lavoro (1946-1948), veniva celebrato, con grande risalto mediatico, il Processo di
Norimberga contro i criminali nazisti e contro alcuni medici che avevano operato nei
campi di sterminio. Durante questo processo venne infatti approvato il cosiddetto “Codice
di Norimberga”, che riconosce, al primo punto, il diritto imprescindibile del paziente al
rifiuto della cure.
Spesso il secondo comma dell’articolo 32 viene accostato all’articolo 13 della
Costituzione, che non riguarda in modo così specifico le cure mediche ma che, in linea più
generale, tutela la libertà delle persone: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e solo
nei casi e modi previsti dalla legge. (…)”. Tale articolo, tuttavia, può essere invocato anche
nel caso in cui una persona venga forzatamente sottoposta ad una cura medica contro la
sua volontà perché, per fare ciò, è necessario privarla della libertà, detenerla a forza in un
luogo di cura, manipolare forzatamente il suo corpo, ecc.
1.5. La Convenzione di Oviedo
Nel 1997 il governo italiano, assieme ai governi degli altri paesi facenti parte del Consiglio
d’Europa, ha firmato la cosiddetta “Convenzione di Oviedo” (Convenzione sui diritti
dell’uomo e la biomedicina) che, all’articolo 5, conferma ulteriormente il diritto dei
pazienti al rifiuto delle cure1. Tale Convenzione è stata in seguito ratificata dal Parlamento
nel 2001, tramite la legge n. 145. Tuttavia, essendo la Convenzione di Oviedo un trattato
internazionale, ad essa non bastano, per entrare in vigore, la sottoscrizione da parte del
Governo e la ratifica da parte del Parlamento, ma è necessario un terzo passo: il deposito
dello strumento di ratifica da parte del Governo, che in questo caso deve avvenire presso il
Art. 5: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia
dato consenso libero ed informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla
natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e sui suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento,
liberamente ritirare il proprio consenso.”
1
p. 4/18
Consiglio d’Europa (organo promotore della Convenzione). Dunque, allo stato attuale,
dopo 12 anni dalla sottoscrizione e 8 anni dalla ratifica parlamentare, la Convenzione di
Oviedo non è ancora entrata in vigore nell’ordinamento italiano.
1.6. Le fonti secondarie di diritto
Oltre alle norme che abbiamo sinora citato, esistono anche le cosiddette “fonti secondarie
di diritto”: esse sono norme che non hanno valore di legge in quanto tali, ma che possono
tuttavia essere tenute in considerazione dai magistrati, nella formulazione di una sentenza,
anche se ad un livello diverso rispetto alle altre. Di queste “fonti secondarie”, nel nostro
caso, possono essere chiamate a far parte anche le norme del codice deontologico dei
medici che, in Italia, presenta delle caratteristiche piuttosto interessanti, se confrontato
con il contesto legislativo corrente. La riflessione sulle tematiche di fine vita ha infatti
molto impegnato la classe medica italiana ed è sfociata nell’elaborazione di un nuovo
codice di deontologia medica, approvato il 15 dicembre 2006, pochi giorni prima della
morte di Piergiorgio Welby (uno dei casi di cui discuteremo in seguito). In questo nuovo
codice si è compiuta una sorta di fuga in avanti rispetto ai lavori parlamentari in corso:
mentre infatti la classe politica si divideva (e si divide ancora) sull’opportunità di
approvare una legge sulle direttive anticipate di trattamento, nel nuovo codice
deontologico veniva inserito un nuovo articolo (il n. 38) intitolato “Diritti del cittadino e
direttive anticipate”. L’ultimo comma dell’articolo obbliga il medico, se il malato non è in
grado di esprimere la sua volontà, di “tenere conto nelle proprie scelte di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”. Il codice
deontologico, inoltre, già nella sua precedente versione del 1998, all’art. 34 stabiliva che “il
medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del
consenso informato del paziente”.
p. 5/18
2. I casi
2.1.1. Il caso Welby
A Piergiorgio Welby nel 1963, all’età di 18 anni, viene diagnosticata una “distrofia facioscapolo-omerale”, patologia classificata dalla letteratura medica come degenerativa dei
muscoli scheletrici, ereditaria e lentamente progressiva. A partire dal 1980 cominciano, per
Welby, gli anni più difficili: la malattia si aggrava e non riesce più a camminare.
Conoscendo bene la possibile evoluzione della sua malattia, Welby stringe un patto con la
moglie Mina: se ci dovesse essere una crisi respiratoria, Mina non dovrà chiamare il pronto
soccorso. Welby, infatti, non vuole essere sottoposto ad una tracheotomia, che lo
renderebbe schiavo di un ventilatore polmonare. La moglie, però, quando si presenta
l’urgenza non trova la forza per rispettare il patto. Il 14 luglio del 1997, a causa di una grave
insufficienza respiratoria, Welby perde i sensi e va in coma, viene tracheotomizzato, contro
la sua volontà, e collegato ad un ventilatore polmonare.
Nel settembre del 2006, quando sono ormai trascorsi nove anni dalla tracheotomia, Welby
scrive un’accorata lettera al Presidente della Repubblica, nella quale descrive
dettagliatamente la sua situazione e chiede di poter porre fine alle sue sofferenze.
Poco tempo dopo aver scritto la lettera al Presidente della Repubblica, Welby chiede al suo
medico curante, il dott. Giuseppe Casale, di cessare la ventilazione artificiale e di essere
staccato dal respiratore automatico. Il medico, però, si oppone, motivando il suo rifiuto
con un testo scritto datato 25 novembre 2006.
A questo punto Welby chiama in causa la magistratura, attraverso un “ricorso d’urgenza
volto ad ottenere il distacco del respiratore artificiale sotto sedazione terminale” (28
novembre 2006). Nel ricorso i legali di Welby evitano di usare il termine “eutanasia”, che
Welby aveva utilizzato nella lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, in modo tale
che la richiesta assuma i connotati di un semplice rifiuto delle cure, fondato sull’articolo 32
della Costituzione italiana. Il giudice, dott.ssa Angela Salvio, con ordinanza depositata il
p. 6/18
16.12.2006, dichiara però il ricorso di Welby integralmente inammissibile in quanto, pur
riconoscendo l’esistenza di un diritto soggettivo, garantito dall’articolo 32 della
Costituzione, di richiedere l’interruzione della terapia medica, lo ritiene privo di tutela
giuridica. La legislazione positiva, osserva infatti la dott.ssa Salvio, è orientata in senso
contrario (il riferimento è all’articolo 5 del codice civile, che vieta gli atti di disposizione del
proprio corpo tali da determinare un danno permanente e gli articoli 575, 576, 577 n.3,
579, 580 del codice penale, che puniscono in particolare, l’omicidio del consenziente e
l’aiuto al suicidio) e manca nel sistema giuridico italiano, scrive ancora il magistrato, una
normativa specifica atta a regolamentare le decisioni di fine vita in un contesto clinico.
Data l’impossibilità di staccare il respiratore con l’assenso del giudice, Welby decide
di procedere comunque, avendo trovato un medico anestesista disponibile a venir incontro
alle sue esigenze. Il medico è il dott. Mario Riccio, che si reca presso l’abitazione di Welby il
giorno 18 dicembre 2006, per accertare l’evoluzione della patologia e per raccogliere le
volontà del paziente, che conferma, ancora una volta, di voler essere sedato e staccato dal
respiratore. Due giorni dopo, alla presenza dei familiari di Welby e delle persone che lo
hanno sostenuto nella battaglia per il riconoscimento della sua decisione finale, il dott.
Riccio procede prima alla sedazione del paziente e, subito dopo, al distacco del ventilatore
automatico. La morte, come afferma il referto medico-legale, sopraggiunge nell’arco di
mezz’ora, per arresto cardiocircolatorio dovuto ad una grave insufficienza respiratoria,
causata dalla malattia da cui Welby era da tempo affetto: una distrofia scapolo-omerale
progressiva.
Dopo la morte di Welby l’attenzione nei confronti della sua vicenda continua a
crescere, anche in seguito alle indagini condotte nei confronti del dott. Riccio. Un primo
esame del comportamento del dott. Riccio viene condotto sotto il profilo deontologico
dall’ordine dei medici di Cremona, a cui il dott. Riccio appartiene. Gli elementi presi in
considerazione sono due: da un lato la volontà (“chiara, decisa e non equivocabile”) del
p. 7/18
paziente (“perfettamente in grado di intendere e volere e di esprimersi”, “pienamente
consapevole della conseguenza del sopraggiungere della morte”); dall’altro il fatto che
l’anestesista “non ha somministrato farmaci o altre sostanze atte a determinare la morte” e
che la sedazione terminale è risultata “per posologia di farmaci, modalità e tempi di
somministrazione, in linea con i normali protocolli”. Per questi motivi la Commissione
disciplinare dell’ordine dei medici di Cremona dispone l’archiviazione del caso, tramite un
provvedimento datato 1 febbraio 2007.
Un secondo esame viene condotto, in sede penale, dalla Procura della Repubblica di
Roma, con un esito molto simile a quello dell’ordine dei medici, ovvero la richiesta di
archiviazione (5 marzo 2007). Tale conclusione si basa sull’esito della consulenza medicolegale, che esclude qualsiasi rilievo causale della sedazione in ordine al decesso, indicando
quale unica causa di morte l’insufficienza respiratoria relativa alla malattia. Ma la richiesta
di archiviazione, avanzata dal sostituto procuratore Gustavo de Marinis, viene
prontamente respinta il 4 aprile dal giudice per le indagini preliminari di Roma Renato La
Viola che, invitando la procura di Roma a formulare un capo di imputazione coatto,
sollecita il rinvio a giudizio, iscrivendo il medico nel registro delle notizie di reato con
l’ipotesi di “omicidio del consenziente” (reato previsto dall’articolo 579 del codice penale,
che contempla la reclusione fino a 15 anni).
Il procedimento si conclude infine il 23 luglio 2007 con una sentenza di non luogo a
procedere nei confronti del medico. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma, Zaira
Secchi, in questo caso, fa riferimento all’articolo 32 della Costituzione italiana, che dice in
maniera chiara che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge” e, all’articolo 13, che stabilisce che “la libertà personale è
inviolabile”. La sentenza di assoluzione rileva inoltre che il diritto al rifiuto delle cure è
confermato anche dall’articolo 5 della Convenzione di Oviedo, che, “sebbene non ancora in
vigore nel nostro ordinamento, vale comunque quale criterio interpretativo per il giudice,
p. 8/18
in quanto enuncia principi conformi alla nostra Costituzione”. La sentenza rileva infine che
l’affermazione di un diritto al rifiuto delle cure trova dei precedenti nella giurisprudenza
della Corte Costituzionale (Co. Cost. n. 45/65, n. 161/85, n. 471/90, n. 238/96), dove si
afferma che il diritto al rifiuto delle cure è un “diritto inviolabile della persona,
immediatamente precettivo ed efficace nel nostro ordinamento, rientrante tra i valori
supremi tutelati a favore dell’individuo”. Il giudice riconosce che il comportamento del
dott. Riccio rientra nella norma che punisce l’omicidio del consenziente (art. 579 del codice
penale), ma osserva anche che, in questo specifico caso, la condotta del dott. Riccio si è
realizzata nel contesto di una relazione terapeutica e, quindi, sotto la copertura
costituzionale del diritto del paziente di rifiutare trattamenti sanitari non voluti. La
condotta del dott. Riccio risulta dunque non perseguibile, secondo la sentenza, perché si
configura come adempimento ad un dovere e, in quanto tale, rientra nella causa di non
punibilità, così come stabilisce l’articolo 51 del codice penale.
2.1.2. Osservazioni su caso Welby
La dialettica tra le norme del codice penale e l’articolo 32 della Costituzione emerge
chiaramente dalla vicenda giudiziaria di Piergiorgio Welby e del dott. Riccio. Su questo
caso ci sono stati infatti tre diversi pronunciamenti da parte di diversi magistrati, in
diverse sedi, e questo dimostra chiaramente la difficoltà del problema. I tre
pronunciamenti coprono l’intero ventaglio delle scelte possibili: 1)Un primo magistrato, il
giudice Angela Salvio, sostiene che la magistratura non è in grado di decidere, perché le
norme sono tra di loro incoerenti ed invoca, di conseguenza, l’intervento del legislatore,
per fare chiarezza e consentire così ai magistrati di prendere delle decisioni sulla base di
normative certe e non contraddittorie; 2)Un secondo magistrato, il giudice Renato La
Viola, sollecita il rinvio a giudizio, richiedendo l’imputazione per “omicidio del
consenziente”. Questo secondo magistrato, dunque, fa prevalere la norma penale,
p. 9/18
attribuendo all’articolo 32 della Costituzione un valore puramente programmatico; 3)Un
terzo magistrato, il giudice Zaira Secchi, chiede l’archiviazione del caso in base all’articolo
32 della Costituzione, che lei ritiene avere un valore immediatamente precettivo.
2.2.1. Il caso Nuvoli
Nella serata di lunedì 23 luglio 2007 (lo stesso giorno in cui il dott. Mario Riccio veniva
prosciolto dall’accusa di “omicidio del consenziente”), ad Alghero, in Sardegna, moriva
Giovanni Nuvoli, 53 anni, ex arbitro di calcio. Nuvoli, come Welby, era affetto da sclerosi
laterale amiotrofica, con conseguente paralisi progressiva dei quattro arti e dei muscoli
deputati alla deglutizione e alla parola. Nuvoli aveva chiesto a più riprese che i medici
staccassero l'apparecchio che gli consentiva di respirare e lo teneva in vita. Tale desiderio
però, al contrario di quanto successo con Welby, non aveva trovato qualcuno che lo
esaudisse, anche perché i riflettori, che da tempo si erano accesi sul suo caso, avevano fatto
sì che le autorità prestassero una "discreta" ma costante vigilanza, per evitare che si
verificasse un secondo caso Welby. Secondo alcune rivelazioni del leader radicale Marco
Pannella, un tentativo per raccogliere l'appello di Giovanni Nuvoli era stato fatto l'11 luglio,
quando un anestesista, pronto a staccare il respiratore, era stato bloccato dall'intervento
dei carabinieri, inviati dalla procura di Sassari. Di conseguenza, a partire dal 16 luglio,
secondo la testimonianza della moglie, Nuvoli, non avendo altre possibilità, iniziava a
rifiutare acqua e cibo, finendo per morire di inedia, aiutato solo da alcuni sedativi e con il
respiratore attaccato.
2.2.2. Osservazioni sul caso Nuvoli
La vicenda di Giovanni Nuvoli non è stata caratterizzata da un lungo iter giudiziario come è
invece avvenuto nei casi di Piergiorgio Welby e di Eluana Englaro. Tuttavia la sua vicenda
ci permette di mettere in evidenza un aspetto importante, che forse poteva sfuggire
p. 10/18
nell’analisi del caso Welby: Welby non ha avuto il permesso di staccare il respiratore e la
sua decisione è stata presa nonostante il parere del magistrato. Tuttavia, come dimostra il
caso Nuvoli, la magistratura, con l’aiuto delle forze di polizia, è in grado di evitare che una
decisione come quella di Welby possa essere messa in atto. Dunque, il proscioglimento del
dott. Riccio non deve consentire delle conclusioni troppo affrettate, come se, con quel
proscioglimento, si fosse messa la parola fine alla tormentata questione giuridica della
sospensione dei trattamenti sanitari.
2.3. Il caso Englaro
Nel febbraio del 1992, dopo un incidente d’auto, Eluana Englaro, una ragazza di 20 anni,
cade in stato vegetativo. Ricoverata a Lecco, è alimentata con un sondino nasogastrico. La
ragazza respira autonomamente. Nel 1994 Eluana entra in una casa di cura privata
cattolica di Lecco e viene assistita dalle suore. Nel 1999 il padre, Beppino Englaro, chiede
al tribunale di Lecco di poter sospendere l’alimentazione artificiale della figlia, ma i giudici
respingono la richiesta. In questo caso, diversamente dal caso Welby, è in discussione
persino la possibile applicabilità dell’articolo 32 della Costituzione, a prescindere dal fatto
che ad esso venga attribuito valore precettivo (come aveva fatto il giudice Zaira Secchi nel
caso Welby) o puramente programmatico (come aveva fatto il giudice Renato La Viola,
sempre nel caso Welby). L’articolo 32 fa infatti espressamente riferimento al diritto di
rifiutare delle cure mediche, mentre nel caso Englaro è in discussione, secondo i giudici, il
fatto che alimentazione e nutrizione possano essere classificabili come “terapie mediche”.
Alcuni, infatti, le classificano come “pure forme di sostegno vitale”, assistenza di tipo
infermieristico, e così via. Questo problema ha fatto molto discutere: nel 2004 lo stesso
Comitato Nazionale di Bioetica si è spaccato in due, con un documento di stretta
maggioranza che considera l’alimentazione e l’idratazione come assistenza e un documento
di minoranza che le giudica invece come cure mediche a tutti gli effetti.
p. 11/18
Nel 2003 Beppino Englaro ripresenta ancora la richiesta di lasciar morire la figlia
Eluana, ma la Corte d’Appello la respinge un’altra volta. Il 16 ottobre 2007 la Cassazione,
tramite la sentenza numero 21748/2007, rinvia di nuovo la decisione alla Corte d’Appello
di Milano, sostenendo che il giudice può autorizzare l’interruzione in presenza di due
circostanze concorrenti:
1)
Occorre che “la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso
apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo
gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la
benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e
di ritorno ad una percezione del mondo esterno”.
2)
Occorre altresì “che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di
prova chiari, univoci e convincenti, della volontà del paziente medesimo, tratta dalle
sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai
suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in
stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona”.
Il 9 luglio 2008 la Corte d’appello di Milano riesamina la vicenda e autorizza il padre
Beppino Englaro, in qualità di tutore, ad interrompere il trattamento di idratazione ed
alimentazione forzata che mantiene in vita la figlia Eluana.
Il 16 luglio 2008 Camera e Senato sollevano un conflitto di attribuzione contro la
Cassazione,
ritenendo
che
la
sentenza
dell'ottobre
2007
costituisca
“un
atto
sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento normativo vigente”. Ricordiamo
infatti che l’ordinamento giuridico italiano non si basa, così come quello inglese, sul
cosiddetto “common law” e che le sentenze della magistratura debbono basarsi sempre
sulla rigorosa applicazione delle leggi esistenti.
p. 12/18
Un tale conflitto di attribuzioni tra potere legislativo e potere giudiziario non si era mai
verificato prima nella storia della Repubblica italiana. Per dirimerlo viene chiamata in
causa la Corte Costituzionale che, il giorno 8 ottobre 2008, si pronuncia a favore della
Cassazione e della Corte d’Appello, non giudicando la sentenza della Cassazione innovativa
rispetto all’ordinamento vigente.
Il mattino del 6 febbraio 2009 l'equipe di volontari che assiste Eluana Englaro
annuncia l'avvio della progressiva riduzione dell'alimentazione. Alle ore 14 il Consiglio dei
Ministri
approva
urgentemente
un
decreto
legge,
per
vietare
la
sospensione
dell'alimentazione e dell'idratazione dei pazienti in stato vegetativo. Il Presidente della
Repubblica rifiuta di firmare il decreto, considerandolo incostituzionale. Alle ore 20 il
Consiglio dei Ministri, riunito in sessione straordinaria, approva un disegno di legge con gli
stessi contenuti del decreto rifiutato in precedenza. Tale disegno di legge viene
immediatamente trasmesso al Senato, che si riunisce per discuterne in sessione
straordinaria già lunedì 9 febbraio 2009 (normalmente il lunedì l’aula del Senato è chiusa).
La morte di Eluana Englaro sopravviene alle 19:35 del 9 febbraio 2009. La notizia
giunge in Senato mentre si discute il DDL n° 1369 in materia di alimentazione e
idratazione. Il governo, di concerto con la presidenza del Senato e i gruppi parlamentari, in
conseguenza di ciò, decide di ritirare il disegno di legge, in cambio dell'immediata
discussione del testo più articolato relativo al testamento biologico e alla disciplina dei casi
di fine vita. Nonostante l’accordo preso in Parlamento per discutere con urgenza di questo
testo più articolato sul testamento biologico, una legge è oggi ancora lontana dal vedere la
luce, a causa delle forti divisioni suscitate da questa tematica.
p. 13/18
3. La Costituzione italiana e il principio di responsabilità
Come abbiamo visto nella parte iniziale, i valori in gioco in questi casi sono due: 1)da un
lato l’interesse collettivo per la salute e la vita di ciascun membro della società; 2)dall’altro
lato il diritto di ciascuno di scegliere liberamente se sottoporsi o meno a determinate cure.
La Costituzione italiana cerca di tenere assieme questi valori, mentre il codice penale ed il
codice civile sembrano sbilanciati da uno dei due lati. Dunque, se si deve trovare un via
italiana alla soluzione giuridica delle questioni di fine vita, è necessario che si parta proprio
dalla nostra Carta costituzionale. La Costituzione, infatti, rappresenta un grande
patrimonio per la nostra società, perché essa non è stata concepita in modo
proceduralistico, come se dovesse semplicemente indicare delle regole formali, che
consentano la convivenza tra individui che si percepiscono rispettivamente come “stranieri
morali”. Al contrario, la prima parte della Costituzione afferma dei valori sostanziali
condivisi ed enuclea i contorni di una vera e propria “etica civile”. Fatto questo del tutto
straordinario, se pensiamo che le forze politiche di allora rappresentavano universi
culturali profondamente distanti: da un lato un Partito comunista fortemente influenzato
da un’ideologia materialista, dall’altro lato un altro partito, la Democrazia cristiana, che
faceva riferimento ad un mondo cattolico che non aveva ancora vissuto la stagione
conciliare ed, in mezzo, ancora altri partiti, alcuni dei quali assumevano come riferimento
una prospettiva di tipo liberale che si differenziava da entrambe le precedenti. Che tra tali
mondi si sia istituito un dialogo così fecondo da dar vita ad una etica civile condivisa,
codificata nella prima parte della nostra Costituzione, mi sembra un fatto straordinario,
soprattutto se pensiamo che oggi, all’interno di un paesaggio politico in cui le differenza
risultano molto più sfumate, prevale, soprattutto sui temi etici, la più aspra
contrapposizione. Ritorniamo allora agli articoli della prima parte della Costituzione che
p. 14/18
più interessano le nostre problematiche, ossia l’articolo 32 e l’articolo 13, per cercare in essi
elementi utili alla costruzione di un’etica civile condivisa sulla fine della vita.
Il primo comma dell’articolo 32 afferma, come abbiamo visto, che esiste un
interesse collettivo della società per la salute di ciascuno dei suoi membri. Questo interesse
collettivo viene espresso nel vivere sociale e nelle leggi in molteplici modi: attraverso le
leggi volte a prevenire gli infortuni sul lavoro, che obbligano ad adottare particolari
precauzioni; attraverso l’obbligo imposto agli automobilisti e ai motociclisti di indossare la
cintura di sicurezza ed il casco; attraverso le limitazioni imposte all’uso di droghe; ecc., ecc.
Tutte queste norme limitano, a qualche livello, la libertà personale, ma lo fanno in nome di
un valore importante: il valore della vita e della salute. Noi, sino ad un certo limite, siamo
disposti ad accettare queste interferenze dello Stato rispetto alla nostra libertà personale,
perché non le giudichiamo troppo intrusive e le riteniamo motivate da un valore positivo.
L’affermazione di questo valore, nel primo comma dell’articolo 32, è decisiva, perché in
questo modo si viene ad affermare che non è indifferente, per la comunità, che un
individuo viva o muoia. Secondo quanto risulta dal resoconto stenografico dei lavori
dell’Assemblea costituente, i nostri padri costituenti consideravano infatti la cura della
propria salute come un valore importante, che ogni individuo dovrebbe perseguire, al
punto tale da prefigurare quasi una sorta di “dovere di curarsi”2. Affermando che la salute è
un interesse della collettività si vuole sostenere infatti che la vita di ciascuno di noi non
riguarda solo ed esclusivamente se stesso: un giovane padre di famiglia che rifiutasse una
cura salvavita, lascerebbe senza la sua cura dei figli minorenni; il titolare di un impresa
totalmente dipendente dalle sue capacità imprenditoriali, metterebbe economicamente a
repentaglio i suoi dipendenti; un giovane ricercatore su cui l’università avesse fortemente
“L’onorevole Merighi propose infatti un emendamento aggiuntivo al primo comma dell’articolo 32, in modo che la
declaratoria della salute come interesse della collettività fosse seguita dal dovere dell’individuo di “tutelare la propria
sanità fisica, anche per il rispetto della stessa collettività”. L’onorevole Tupini osservò che tale principio si poteva
considerare implicito nella formula che poi è stata approvata e così l’onorevole Merighi rinunciò all’emendamento” (V.
Falzone, F. Palermo, F. Casentino, La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano
1976, p. 114).
2
p. 15/18
investito in formazione, lascerebbe la società senza il suo prezioso contributo, ecc., ecc. Gli
esempi in questo senso si possono sprecare, ma tutti convergono verso un'unica
conclusione: la nostra salute non è un fatto esclusivamente privato ed individuale, che
riguarda solamente noi stessi. Da questa considerazione scaturisce il riferimento al “dovere
di curarsi”, che compare nel dibattito parlamentare relativo al primo comma dell’articolo
32 della Costituzione.
Il secondo comma dell’articolo 32, che afferma il diritto di rifiutare delle cure, non è
tuttavia in contrasto con il primo. Se, infatti, è un dovere civico curarsi, perché la salute è
un interesse della collettività, ciononostante obbligare una persona a sottoporsi
forzatamente a delle cure, mettendo le mani sul suo corpo e facendole così violenza, è
certamente qualcosa che offende la sua dignità umana, costituendo un trattamento
disumano e degradante. Una tale intrusione avrebbe infatti un grado di invasività della
sfera personale del soggetto assolutamente non paragonabile alle limitazioni imposte, ad
esempio, dall’obbligo di usare il casco o le cinture di sicurezza. Il secondo comma
dell’articolo 32 e l’articolo 13 della Costituzione tutelano dunque un diritto fondamentale
dei cittadini, che è diventato uno dei capisaldi delle costituzioni liberali e che risale
all’“Habeas corpus”, un privilegio che i baroni inglesi sono riusciti a strappare a Giovanni
Senzaterra nel 1215, quando hanno ottenuto la Magna Charta Libertatum, uno dei pilastri
della civiltà giuridica occidentale. “Habeas corpus” significa letteralmente “che tu abbia la
disponibilità del tuo corpo”, ossia che il tuo corpo è tuo e che nessuno può fare di te quello
che vuole, senza il tuo consenso. Nessuno, salvo un giudice, se ritiene che una legge sia
stata violata, può privare un cittadino del potere sul suo corpo. Qualsiasi potere che, in
assenza di un reato, voglia esercitare potere sul nostro corpo, senza il nostro consenso, esce
dallo stato di diritto e diventa “tiranno”. L’”Habeas corpus” diventa così il presidio della
libertà individuale contro l’arbitrio dello Stato. Un tale diritto è dunque irrinunciabile, così
come lo sono il valore della vita e della salute. Come possiamo dunque armonizzarli?
p. 16/18
Il tentativo di armonizzare questi due principi dovrebbe essere l’obiettivo principale
di una legge in materia di fine vita in Italia. Che tale legge sia necessaria è reso evidente dal
fatto che, nell’attuale caos normativo, ciascun giudice giudica in modo diverso uno stesso
caso, oppure casi analoghi. Quando però la legge non è uguale per tutti, si è di fronte alla
suprema ingiustizia ed è, appunto, a questa suprema ingiustizia, che la legge dovrebbe
rimediare. Ma, chiediamo ancora, come potrebbe una legge ordinaria armonizzare i due
principi contenuti nell’articolo 32 della Costituzione?
La risposta forse potrebbe essere la seguente. Il principio dell’interesse collettivo per
la salute potrebbe essere tutelato cercando di offrire delle vie alternative alle persone che
chiedono di morire. Le domande eutanasiche, infatti, hanno spesso bisogno di essere
decodificate. Se si scopre che un malato chiede di morire perché teme di soffrire, occorre
far conoscere a questo malato tutte le possibilità offerte dalle cure palliative. Se il malato
chiede di morire a causa di uno stato depressivo causato dalla malattia o dallo stato di
abbandono in cui si trova, occorre offrire lui un supporto psicologico, e così via. Insomma,
direi che la tutela del principio dell’interesse collettivo per la salute può evitare al medico
di diventare un puro e passivo esecutore delle volontà del malato e alla medicina di
diventare cinica. Il medico non può limitarsi ad eseguire passivamente qualsiasi richiesta,
come se lui fosse un semplice tecnico, obbediente ai fini indicati dal malato. Il medico, al
contrario, è in primo luogo il depositario dei valori della sua disciplina (che ha come fine
quello di promuovere la salute e di salvare la vita delle persone) ed è, in secondo luogo, il
portavoce della società, che ha interesse a salvaguardare la salute di ciascuno dei suoi
membri. Dunque, il medico deve mettere a confronto questi suoi valori, in un colloquio
franco ed approfondito, con la richiesta del malato di lasciarsi morire. Tuttavia, se la
richiesta del malato persistesse, il medico dovrebbe astenersi dall’usare violenza su di lui,
imponendo una cura che il paziente rifiuta, anche se il paziente dovesse essere incapace di
opporsi attivamente alla somministrazione della terapia (come nei casi Welby e Nuvoli),
p. 17/18
oppure se il paziente non fosse più in grado di intendere e volere, ma avesse lasciato una
chiara e documentata richiesta in tal senso. Per quest’ultimo motivo, molto probabilmente,
la legge sul testamento biologico, se verrà approvata, non consentirà che la volontà del
paziente venga ricostruita attraverso delle testimonianze (come accaduto nel caso di
Eluana Englaro), ma richiederà che i pazienti lascino un testo scritto, attestante le loro
volontà, presso il loro medico di base, oppure presso un notaio. Su questo punto, almeno,
l’accordo sembra essere generale.
p. 18/18